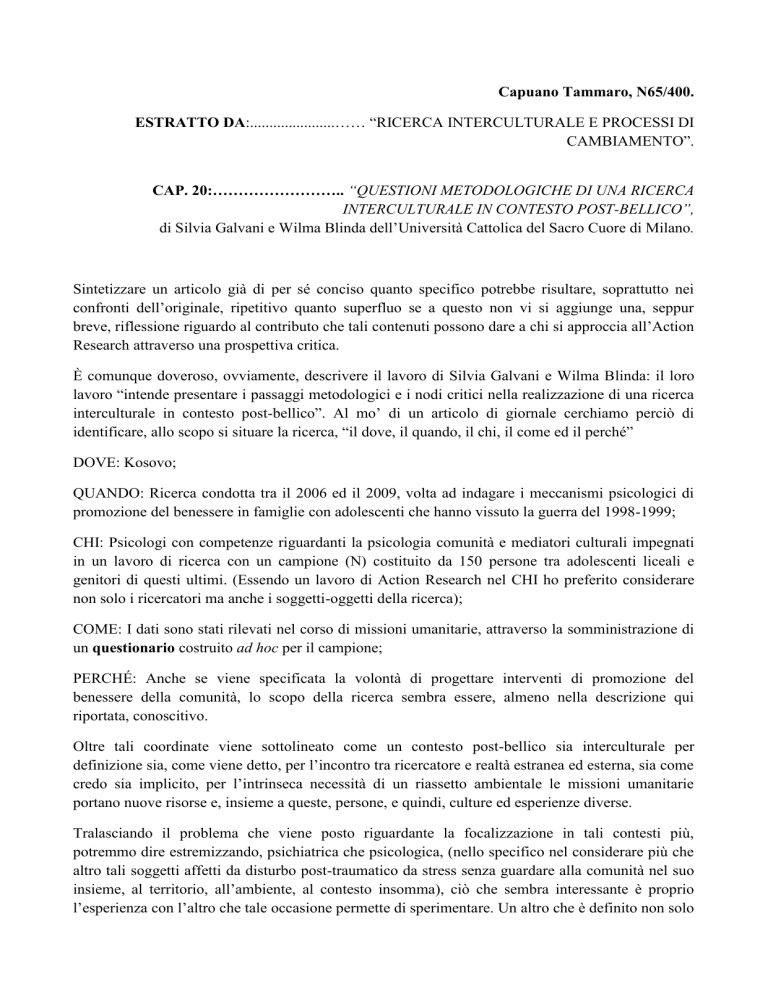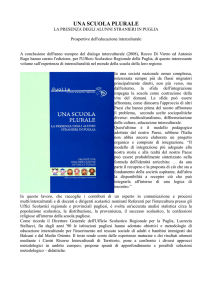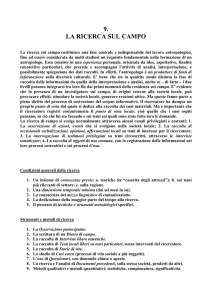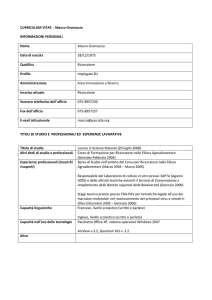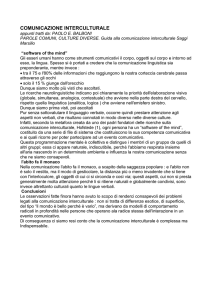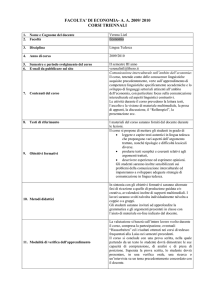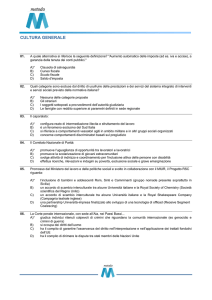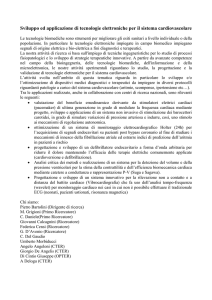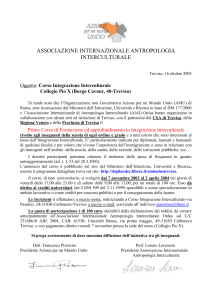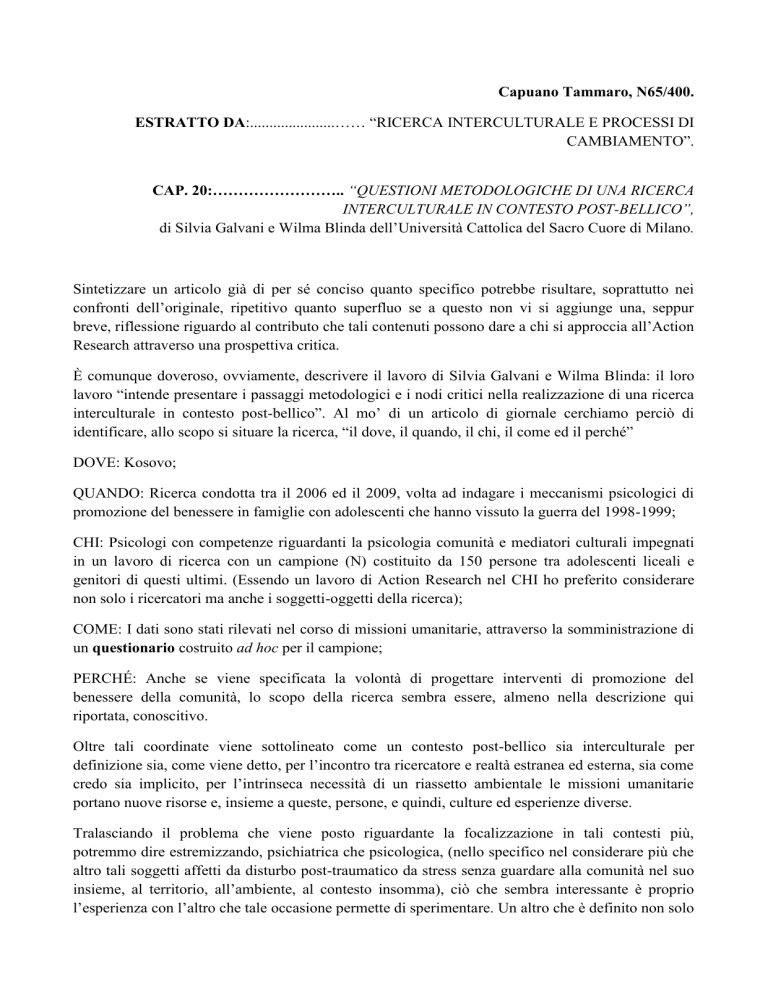
Capuano Tammaro, N65/400.
ESTRATTO DA:......................…… “RICERCA INTERCULTURALE E PROCESSI DI
CAMBIAMENTO”.
CAP. 20:…………………….. “QUESTIONI METODOLOGICHE DI UNA RICERCA
INTERCULTURALE IN CONTESTO POST-BELLICO”,
di Silvia Galvani e Wilma Blinda dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Sintetizzare un articolo già di per sé conciso quanto specifico potrebbe risultare, soprattutto nei
confronti dell’originale, ripetitivo quanto superfluo se a questo non vi si aggiunge una, seppur
breve, riflessione riguardo al contributo che tali contenuti possono dare a chi si approccia all’Action
Research attraverso una prospettiva critica.
È comunque doveroso, ovviamente, descrivere il lavoro di Silvia Galvani e Wilma Blinda: il loro
lavoro “intende presentare i passaggi metodologici e i nodi critici nella realizzazione di una ricerca
interculturale in contesto post-bellico”. Al mo’ di un articolo di giornale cerchiamo perciò di
identificare, allo scopo si situare la ricerca, “il dove, il quando, il chi, il come ed il perché”
DOVE: Kosovo;
QUANDO: Ricerca condotta tra il 2006 ed il 2009, volta ad indagare i meccanismi psicologici di
promozione del benessere in famiglie con adolescenti che hanno vissuto la guerra del 1998-1999;
CHI: Psicologi con competenze riguardanti la psicologia comunità e mediatori culturali impegnati
in un lavoro di ricerca con un campione (N) costituito da 150 persone tra adolescenti liceali e
genitori di questi ultimi. (Essendo un lavoro di Action Research nel CHI ho preferito considerare
non solo i ricercatori ma anche i soggetti-oggetti della ricerca);
COME: I dati sono stati rilevati nel corso di missioni umanitarie, attraverso la somministrazione di
un questionario costruito ad hoc per il campione;
PERCHÉ: Anche se viene specificata la volontà di progettare interventi di promozione del
benessere della comunità, lo scopo della ricerca sembra essere, almeno nella descrizione qui
riportata, conoscitivo.
Oltre tali coordinate viene sottolineato come un contesto post-bellico sia interculturale per
definizione sia, come viene detto, per l’incontro tra ricercatore e realtà estranea ed esterna, sia come
credo sia implicito, per l’intrinseca necessità di un riassetto ambientale le missioni umanitarie
portano nuove risorse e, insieme a queste, persone, e quindi, culture ed esperienze diverse.
Tralasciando il problema che viene posto riguardante la focalizzazione in tali contesti più,
potremmo dire estremizzando, psichiatrica che psicologica, (nello specifico nel considerare più che
altro tali soggetti affetti da disturbo post-traumatico da stress senza guardare alla comunità nel suo
insieme, al territorio, all’ambiente, al contesto insomma), ciò che sembra interessante è proprio
l’esperienza con l’altro che tale occasione permette di sperimentare. Un altro che è definito non solo
estraneo alla vicenda, vicenda bellica, ma anche straniero, con una lingua ed una cultura diversa.
Sarà forse proprio questa sensazione vissuta dai ricercatori che li avrà spinti alla scelta di
somministrare questionari al fine di rilevare dati quantitativi? O, come è “raccontato” nell’articolo
tale scelta è motivata dal fatto di evitare di far alzare una difesa troppo massiccia da parte dei
soggetti intervistati nel momento in cui si tende a toccare temi più caldi? Inoltre le figure dei
mediatori culturali, se da un lato possono favorire lo scambio col contesto, dall’altro potrebbero,
nella loro funzione, interferire con questo processo di comunicazione che si viene a creare tra
ricercatore e contesto. Fatto sta che se uno psicologo non sa parlare serbo non può non assumersi un
compito chiudendosi immediatamente e a tal proposito la figura del mediatore può essere
considerato una risorsa.
Tutto ciò per sottolineare che la competenza psicologica, che sia clinica, che sia di comunità, ha
sempre a che fare con una riflessione. Riflessione non fine a se stessa, ma tesa a strutturare un
intervento in un contesto di cui non si conoscono le coordinate: non chiudendosi, ma partendo dalla
condizione di accettazione di tale condizione, (perché no, frustrazione?) lo psicologo di comunità
mette in moto un pensiero che connette, quasi come un puzzle, elementi di cui prima non sapeva
nemmeno, forse, l’esistenza. Ed è proprio a partire da questo pensiero, contenuto ed allo stesso
tempo orientante una che sarà possibile intervenire costruendo, dando senso, significato, struttura
all’esperienza che, in tal caso, non è mai di una sola persona ma diventa della comunità. Quale
potrebbe essere poi la peculiarità di un ricercatore in azione se non quella di agire facendo passare
tale azione attraverso il pensiero che tiene conto, che sa, che conosce perché ricerca?
È proprio tale concetto che mi porterei da questo lavoro. L’apertura, che rende possibile ed è resa
possibile da capacità che passano attraverso conoscenze e competenze.
Sebbene si accenni al problema della situatività della ricerca azione, problema in quanto non
estendibile in generale ai contesti, ho preferito non discuterne qui per un semplice motivo: La
situatività di tale modello non è secondo me una debolezza ma un punto di forza perché, attraverso
un metodo ed una teoria forte, l’Action Research riesce ad entrare nei più disparati contesti
operando attraverso la specificità. Il problema della creazione di leggi generali per un intervento
psicologico lo lasciamo a chi vorrebbe già bello, pronto e preparato il suo lavoro senza sporcarsi le
mani, applicando delle tecniche. Ma a chi gioverebbe? Forse semplificherebbe il lavoro del
ricercatore, ma cosa potrebbe dare al contesto?