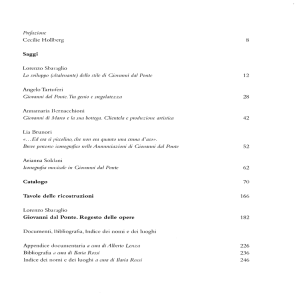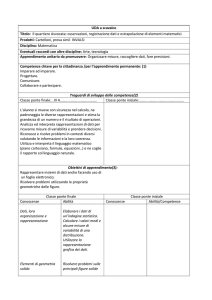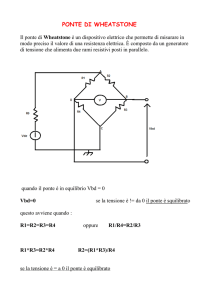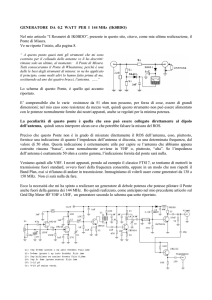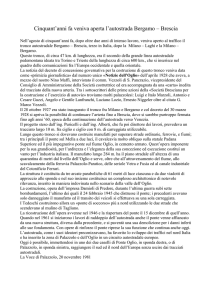PER UNA “ANTROPOLOGIA DEL LIMITE”
Paolo Chiozzi e Kamela Guza
Premessa (P.C.)
Il limite è l'essenza stessa dell'antropologia: il limite come linea di confine fra luoghi (non
necessariamente fisici) contigui o comunque vicini, ma la cui vicinanza è ambigua.
Etimologicamente la parola latina li(c)mes significa via traversa, alludendo cioè ad un procedere di
traverso, e dunque obliquus – composto da ob (verso) e la radice lic- che ha appunto il senso di
piegare, che va di traverso. Insomma abbiamo a che fare con due parole che richiamano l'errare,
l'erranza, metafora principe dell'antropologia come già ho avuto modo di sottolineare (Chiozzi,
1999). In questa prospettiva il gruppo interdisciplinare di ricerca che coordino ha scelto il ponte
come archetipo, facendone il fil rouge di una ricerca sui paesaggi antropici: infatti la parola latina
pons, secondo Giacomo Devoto, si collega ad una “antichissima parola indoeuropea” che indicava
un luogo di passaggio, un sentiero o una strada. Per i Greci il mare era pòntos: la via per
eccellenza. Non a caso dunque Karl Popper situa l'alba della “società aperta” nella Grecia antica
quando gli uomini, come l'Ulisse dantesco, “dei remi <fecero> ali al folle volo”:
attraversamento/superamento dei limiti è sempre atto di intrinseca umana follia – il rifiuto di limiti
imposti alla ricerca della conoscenza.
Nelle righe che seguono Kamela Guza, l'anima “architettonica” del nostro gruppo di ricerca,
delinea con maggiore chiarezza di quanto potrei fare io le ipotesi di sviluppo del nostro errare alla
ricerca di un metodo realmente poli-disciplinare: per parafrasare un vecchio compagno di strada –
Massimo Canevacci – quando si affronta lo studio della contemporaneità ci si accorge ben presto
che questa (ed in particolare la sua “forma” più visibile, la metropoli) è polifonica, e che la
polifonia è tanto nell'oggetto quanto nel metodo (Canevacci, 1993). Il ponte, quasi confermando la
sua essenza demoniaca (ma in realtà luciferina), si svela chiave di lettura – non solo antropologica –
della stessa realtà metropolitana, per il semplice fatto che i flussi (visuali) comunicativi della città
“sono caratterizzati da una estrema confusione, da una estrema ambivalenza emotiva (e quindi
anche scientifica).... Lo strumento principale da raffinare ed utilizzare è lo sguardo. Saper guardare
è già un momento fondamentale della interpretazione”.
Inconsapevolmente quanto significativamente, al termine del suo viaggio, Guza giunge alla
medesima conclusione a cui era giunto Canevacci: L'ermeneutica urbana è visiva. Lo sguardo
obliquo. Ed ecco che l'antropologia della comunicazione visuale rivela tutta la sua potenzialità
euristica, e le immagini (scattate dal sociologo-fotografo Giona Pretazzini) del Ponte del Diavolo di
Borgo a Mozzano in Lucchesia, come quelle delle cave dismesse sulle Alpi Apuane, prime fasi
della nostra ricerca, ci offrono esempi particolarmente significativi della obliquità dello sguardo
antropologico.
Lo sguardo obliquo (K.G.)
L’opportunità di scrivere dei ponti visitati e conosciuti “vagando” per le terre della Lunigiana e
della Garfagnana ha prodotto in me una spontanea associazione con un testo di Franco Rella che mi
è molto caro (Rella, 1987). I due nomi incontrati in questo testo che mi hanno accompagnato a
lungo in questi anni sono: Confine e Limite. Ho spesso cercato di dare un significato giusto per me
a queste due parole, arrivando anche a delle conclusioni che non hanno mai concluso niente, in
realtà, ma che hanno conferito una qualche forma al mio desiderio di sapere come rapportarmi al
Confine e al Limite. L’opportunità di “usare” il ponte come mezzo di narrazione mi sembra quella
giusta, quella in grado di mostrare il significato di Confine e Limite su un piano anche concreto,
visibile, tangibile oltre che concettuale, e soprattutto attraversabile.
Rella parla del confine come linea fisica, come perimetro che individua l’estensione di un luogo,
una linea che rimane comunque all’esterno. Il limite, invece, è riferito ad una frontiera interna, è
quella linea in cui si toccano il visibile con l’invisibile, l’idea e l’immagine percepibile dai sensi; è
nello stesso tempo la linea che separa e mette in relazione l’io all’altro.
A mio parere tutte queste parole e le immagini da loro prodotte vengono evocate quando ci si
relaziona ad un elemento del paesaggio quale si mostra essere un ponte. Proverò a raccontare questo
viaggio, perché è proprio ciò di cui si tratta, un vero viaggio che si svolge muovendosi nella
manifestazione fisica-geografica dei luoghi dell’uomo, nei nostri luoghi interiori, e in altri luoghi
che vedremo più avanti. In questa narrazione farò uso di un “personaggio” molto importante a mio
avviso, spesso un po’ trascurato, oppure semplicemente dato per scontato: parlo del corpo, della
presenza fisica che ognuno di noi porta con sé quando si muove.
Il nostro è stato un viaggio per incontrare ponti, parte di un progetto antropologico più ampio che in
questa prima tappa ha attraversato le terre della Garfagnana e della Lunigiana. Luoghi pieni
d’acqua, che scende dal cielo e che scorre sulla terra. Accompagnati dal suono continuo dell’acqua
che scorre in fiumi e torrenti siamo andati alla ricerca dei ponti che li attraversano e rendono
possibile il passaggio da una sponda all’altra. Ci troviamo davanti a dei confini, linee fisiche che
segnano il territorio: le sponde ed il fiume che scorre. In questo caso sono anche linee che dividono.
Ecco che l’uomo sfida l’ordine naturale delle cose e decide di costruire un ponte, linea che passa
oltre la separazione o divisione per collegare, rendere possibile una relazione, che non è soltanto
visiva, ma concreta, attraversabile con il corpo (o i corpi).
Le sponde, il fiume non sono solo confini, però. Sono anche limiti, per coloro che vi si confrontano.
Sono quelle frontiere interne che ci mostrano una impossibilità di procedere, andare avanti. Allora
emergono due ipotesi: una è quella di tornare indietro, lasciare perdere, rinunciare ad attraversare
ciò che la natura ha imposto come limite. L’altra è quella della possibilità, ossia della capacità di
cambiare angolazione e guardare la realtà (il paesaggio) da un punto di vista diverso, usando forse
uno sguardo obliquo, quello più vicino alla stessa parola limite, quello che permette di vedere le
cose anche di traverso (si sa che lo sguardo diretto a volte può accecare e pietrificare, Perseo lo
sapeva bene mentre cercava di uccidere la Medusa); quella angolazione che permette di scorgere la
materia mentre si piega e ci fa vedere che non è poi così dura e rigida come sembra.
Perché non provare a costruire qualcosa che mi permette di andare di là? Essendo l’uomo (e
l’universo intero) per sua natura in costante movimento, perché non provare a superare la barriera
che blocca il movimento? Ad esempio costruendo un ponte.
Attualmente vivo in una città con ponti. Mi capita spesso di attraversare i ponti sull’Arno a Firenze,
ma raramente mi sono fermata a riflettere sull’importanza del ponte. La forza dell’abitudine spesso
toglie spazio alla possibilità di variare il punto di vista. Questo viaggio mi ha dato l’opportunità di
vivere questo elemento che così spesso convive con l’attività edificatoria umana in modo diverso.
Uno dei motivi è appunto il fatto di andare a trovare la natura e i ponti senza uno scopo preciso,
senza la routine quotidiana, ma semplicemente con la pura e chiara intenzione di farlo. Si è venuta a
creare una sorta di sospensione del tempo e del giudizio, che ha lasciato spazio al movimento e al
contatto con l’oggetto fisico, con “l’edificio” che un ponte rappresenta e mi sono resa conto di una
cosa, per me, molto importante: ciò che succede su una sponda è molto diverso da ciò che succede
sull’altra sponda. Non parlo solo di contesti urbanizzati, dove differenze di stile e linguaggio
architettonico rendono più evidente questo fatto. Parlo anche di contesti immersi nella natura,
oppure di luoghi al limite che collegano magari una strada ad un bosco; o anche due parti di un
bosco. Spesso le due sponde “contengono” luoghi con significati molto diversi, ad esempio un
centro storico da un lato e un’area marginale periferica dall’altra. In questo modo diventa chiaro
anche la relazione che intercorre tra il fiume e la città, il senso di discontinuità che la linea d’acqua
impone tra le due sponde, superato quando è ncessario da un ponte, che ne assicura la continuità di
atttraversamento.
Ma il fiume non è l’unico flusso che attraversa la città. Se si pensa alla città contemporanea e alla
con-presenza in essa di varie culture e modi di vivere, di muoversi, di relazionarsi di comunicare,
giunge alla mente il disordine che tali flussi necessariamente comportano; il disagio e la difficoltà
dei cittadini di rapportarsi ai “nuovi arrivati”, disagio che spesso si trasforma in rifiuto e quindi in
fonte di violenza.
Proviamo a dare un colore diverso a quest’immagine: immaginiamo questi flussi disordinati in
movimento come fossero linee che attraversano la città. Queste linee immaginarie (spesso con una
consistenza più dura della stessa materia concreta) rappresentano i limiti che si pongono davanti a
noi. Si ripresentano le solite due ipotesi: tornare indietro o provare a superare il limite.
Invece di tornare indietro, si potrebbe imparare dai ponti, che in questo caso presentano un volto
scolpito dalla metafora. Si potrebbe usare la sospensione o l’epoché (gr. punto di fermata,
sospensione del tempo) che accade quando ci si trova in cima ad un ponte, nel punto di mezzo tra le
due sponde. È il punto in cui si ha la possibilità e l’opportunità di annullare, azzerare le abitudini
dell’una o dell’altra sponda, ci si può sentire liberi di considerare le cose in un modo nuovo. Dopo
tutto (o prima di tutto) la con-sider-azione è pursempre un agire con le stelle, quindi apre alla
possibilità del sogno, e tutti sappiamo che le stelle sono desideri e quindi sogni…
Quando siamo sul ponte e ci fermiamo a riflettere, siamo quindi nell’atopia, riprendendo Rella, nel
senza-luogo, siamo in qualche modo sradicati, perché strappati ai nostri modi abituali di pensare e
vivere. È proprio questo il momento in cui possiamo sentirci liberi di aprirci a nuovi modi di
relazione ed interazione con l’altro, in cui possiamo usare uno sguardo obliquo, ed il ponte ci può
fare da maestro, ci può insegnare come andare oltre al già conosciuto, facendo spazio all’ignoto di
giungere a noi.
Con questo processo emerge un fatto molto importante: le linee immaginarie dei flussi (che
rappresentano limiti) non solo ci mostrano un evento esterno con cui confrontarsi, ma nello stesso
tempo ci attraversano (se lo permettiamo), quindi segnano una discontinuità dentro di noi, cambiano
la nostra forma e ci rendono, in qualche modo, stranieri a noi stessi.
Giunti davanti alla “crisi di identità” sta a ognuno la libertà di scegliere se vedere un’opportunità o
un pericolo.
Bibliografia:
M. Canevacci, La città polifonica. Roma, Edizioni SEAM, 1993
P. Chiozzi, Ebrei e Antropologi. Firenze, CUSL 1999
F. Rella, Limina. Il pensiero e le cose. Feltrinelli, Milano 1987