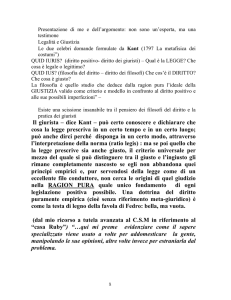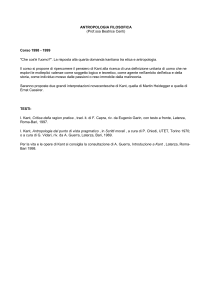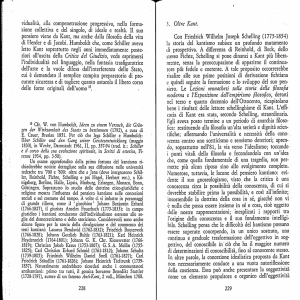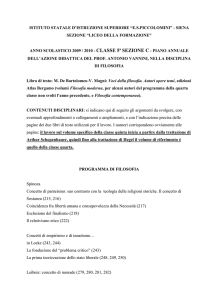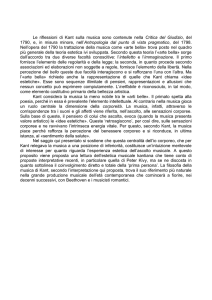Foucault e il presente senza qualità. Appunti per una rivoluzione anti-pastorale
Eleonora de Conciliis
“Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza!”
Immanuel Kant
Grazie alla recente pubblicazione del penultimo corso tenuto al Collège de France1, siamo oggi in grado di
leggere l’intera lezione che Foucault, già malato, dedicò il 5 gennaio dell’‘83 alla famosa risposta data da
Kant al quesito posto nel 1784 dalla “Berlinische Monatsschrift”: che cos’è l’illuminismo?2, lezione che fino
a ieri leggevamo in estratto, accompagnandola spesso con un articolo che porta lo stesso titolo e che ne
riprende alcuni passi, comparso in inglese in un volume collettaneo3. Il tentativo che viene qui presentato
consiste nell’analizzare queste ormai celebri riflessioni di Foucault sull’ontologia dell’attualità, esattamente
come lui ha fatto con il testo kantiano, e cioè attualizzandole, come se esse fornissero una precisa risposta
alla domanda: che cos’è il nostro presente?, ma con una fondamentale differenza4: mentre Foucault, come
vedremo, considerava la risposta di Kant ancora valida per definire il suo presente, si proverà a mostrare che
la risposta di Foucault resta a sua volta valida per il nostro, dopo quasi trent’anni (data l’accelerazione in cui
viviamo essi sembrano corrispondere ai quasi duecento intercorrenti tra i testi dei due filosofi), solo a patto
di trasformarla in una denuncia, in un monito di carattere politico: mentre il presente di Kant e quello di
Foucault sono stati, sebbene a diversi livelli, tempi di significazione storica degli eventi5, il nostro è un
tempo di insignificanza storica dei fatti6. Soltanto prendendo coscienza di tale trasformazione difettiva,
ovvero riformulando radicalmente la “questione della storia” (GSA, 20), si può tentare di rispondere con
precisione alle domande che ci assillano, proprio come hanno assillato Foucault e prima di lui lo stesso Kant:
“cosa accade oggi? Cosa accade ora? Cosa è questo ‘ora’ all’interno del quale stiamo noi, gli uni e gli altri 7?
E qual è il luogo, il punto su cui scrivo? [...] cos’è dunque precisamente questo presente al quale
appartengo?” (GSA, 21). È quando la domanda viene posta in prima persona, che diventa storicamente
leggibile, nel linguaggio di Foucault, ‘la posta in gioco’: sono io, da sola e nella mia insignificante unicità,
che mi sento interpellata dal presente, e proprio nella solitudine virtuale, o meglio inattuale della risposta mi
gioco il senso della mia singolarità.
1.
Immaginiamo che una rivista di filosofia, ad esempio “Kainos”, ponga coraggiosamente ai suoi lettori la
domanda cruciale che Foucault a sua volta immagina implicitamente posta dal periodico berlinese alla fine
del Settecento, “che cos’è la filosofia moderna?”, supponendo circolarmente che la risposta da fornire sia la
sua, e cioè questa: la filosofia moderna cerca ancora (sia nel 1983, anno in cui Foucault scrive, che nel 2010)
di rispondere alla questione posta alla fine del Settecento: “Was ist Aufklärung?”, Che cos’è l’illuminismo?
(cfr. AF3, 217 e sg.).
Quando Kant pubblica sulla “Berlinische Monatsschrift” la sua celebre definizione di illuminismo (i Lumi
sono l’uscita dell’uomo dal suo stato di minorità, il quale è da imputare a lui stesso8), può rivolgersi da
studioso al lettore colto, al pubblico (das Publikum), proprio perché l’illuminismo (nelle sue varie forme, ad
esempio quella dell’Haskala ebraica incarnata da Moses Mendelssohn) è già in atto, perché esistono ormai in
Europa comunità culturalmente evolute, ma non molto ampie, di scrittori e lettori che s’incontrano sulle
riviste, senza tuttavia appartenere alla cerchia ristretta e specialistica delle università, che si formerà solo nel
XIX secolo (cfr. GSA, 17-18). Immaginiamo dunque che “Kainos” sia una rivista di questo tipo, una rivista
‘illuministica’ sopravvissuta agli specialismi accademici dei due secoli passati, e che esista ancora un
pubblico capace di apprezzare la “libertà assoluta”, di coscienza e di espressione (GSA, 19), che lo studioso
esercita nel momento in cui decide di rispondere in prima persona, ma appunto in pubblico, a domande
riguardanti il presente, e in particolare il presente stato della filosofia.
Si tratta di un’ipotesi, che verificheremo sul piano terminologico, relativa alla sopravvivenza di
atteggiamenti “eroicamente” moderni9 nel cosiddetto postmoderno; presuppone infatti che l’illuminismo, pur
senza essersi compiuto (l’uomo moderno, e a maggior ragione quello postmoderno, non sono affatto usciti
dallo stato di minorità), funzioni ancora come concetto politicamente emancipativo nei confronti di ciò che
Foucault chiamava ‘potere pastorale’, un potere che in Occidente, fin dentro la modernità e oltre, continua a
farsi carico del ‘governo dei viventi’10. Ma ad essa va associata un’altra ipotesi, meno ottimistica: mentre
nell’epoca di Kant la Rivoluzione Francese comparve e venne addirittura criticata come segno rimemorativo
(cioè indimenticabile), dimostrativo e prognostico del progresso umano11, suscitando il più forte entusiasmo
proprio nelle menti illuminate di coloro che non vi parteciparono12, e mentre nel tumultuoso presente di
Foucault non mancarono eventi in grado di fargli pensare che fosse giunto il momento di congedarsi
definitivamente dal pastorato, cioè di uscire dallo stato di minorità per iniziare ad auto-governarsi (è in fondo
questo il tema del suoi ultimi corsi al Collège), il nostro presente si caratterizza come privo di quelle qualità
evenemenziali che, imponendosi come segni, o meglio come “virtualità permanente” (GSA, 29) del
progresso della libertà, facciano nascere l’entusiasmo, l’“impazienza” nelle menti dei contemporanei,
formando il ‘noi’ come appartenenza comune ad un’epoca e ad un pensiero capace di comprenderla (cfr.
GSA, 21): se dovessimo chiederci, come ha fatto Foucault, qual è quel certo “elemento del presente che si
tratta di riconoscere, di distinguere, di decifrare tra tutti gli altri. Che cos’è che nel presente, oggi, produce
senso rispetto a una riflessione filosofica?” (GSA 21), ebbene, non troveremmo nulla che sia all’altezza del
compito della filosofia come processo storico di rischiaramento, men che mai potremmo “far vedere in che
cosa e in che modo colui che parla, in quanto pensatore, scienziato, filosofo, faccia parte egli stesso di questo
processo” ed abbia in esso “un certo ruolo da giocare” (GSA, 22).
In altri termini, se con la modernità, e per la prima volta da Kant, il presente è stato messo in questione dalla
filosofia; se, per dirla con Benjamin, all’ordine del giorno è stata posta “la questione del presente come
evento filosofico a cui appartiene il filosofo che ne parla”, e parlando agisce; se così la filosofia della storia è
diventata, contro una certa lettura di Hegel13, “la superficie d’emergenza della propria attualità discorsiva [...]
che essa interroga come un evento a cui deve attribuire senso, valore, singolarità filosofica, e in cui trovare,
al tempo stesso, la propria ragion d’essere e il fondamento di ciò che dice”, il filosofo non trova oggi alcun
‘noi’ “al quale appartiene e in rapporto al quale deve situarsi” (GSA, 22), ed è per questo che, se non
ammutolisce, il suo discorso sul presente non produce alcun effetto, tanto meno quella ‘presa brutale’ che
Benjamin, sul versante teologico-marxista, aveva teorizzato come ri-significazione rivoluzionaria del passato
oppresso nella dimensione del tempo-ora (Jetztzeit)14: espulso da quel processo che faceva dell’attualità un
oggetto dinamico, oltre che discorsivo, col quale ci si poteva dunque rapportare in modo “sagittale” o
“verticale” (GSA, 23), cioè agonico e politico, in vista dell’azione, il filosofo esperisce oggi, in senso
nietzscheano, nuove forme di ‘inattualità’. Nel fare una scrupolosa, quanto feroce “critica permanente del
nostro essere storico” (AF3, 226), egli parla ad altri del presente, lo mette continuamente in questione, ma
non riesce a bucare, con la freccia del pensiero, la superficie opaca e liscia dei troppi eventi di cui parla. Il
sintomo di tale nuova impotenza è una sorta di afasia concettuale, peraltro stigmatizzata dallo stesso
Foucault15 ed emblematicamente manifestata dall’impossibilità di definire il mondo attuale se non a partire
dal moderno, appunto come post-moderno, o anche sur-moderno, iper-moderno, modernità liquida, ecc.16:
terminologicamente imprigionata in quel passato che le ha solo promesso la libertà e l’autonomia, la filosofia
non nomina più in modo univoco né se stessa, né l’epoca in cui vive a partire da se stessa, come hanno
invece fatto Kant e l’illuminismo (cfr. GSA, 23), ma segue una strada per così dire orizzontale, ecumenica,
fin troppo ciarliera e quindi politicamente ineffettuale.
I filosofi, tra cui lo stesso Foucault, hanno sempre avuto un certo pudore nel definirsi tali, ma ormai
esagerano con la sfrontatezza con cui si presentano (!) al pubblico mediatico. D’altra parte, temendo di
essere ridicolizzato, o tacciato di vetusto ideologismo, ognuno di noi, singolarmente preso, rinuncia a dire
“ciò che è e ciò che si deve fare” (GSA, 24), preferendo mettersi all’ombra di ciò che hanno detto e/o fatto,
di ciò che dicono e/o fanno gli altri; tale atteggiamento esibizionistico e al contempo disincantato,
penosamente blasé, rende impossibile sia l’entusiasmo che il giudizio, cioè la critica nei confronti degli
eventi, per non parlare della formazione psico-sociale e culturale di un ‘noi’ capace di comprenderli e di
modificarli.
Ma allora, una volta sollevata la questione del presente, non posso mettermi all’ombra di Foucault e lasciare
a bocca asciutta il pubblico della nostra rivista. Esso ha diritto ad una risposta nietzscheana alla domanda:
“Qual è il campo attuale delle nostre esperienze” non rivoluzionarie? “Qual è il campo attuale delle
esperienze possibili” che confermano l’esistenza, o meglio la sopravvivenza del potere pastorale?
“Non si tratta di un’analitica della verità, ma piuttosto di qualcosa che potremmo definire una
[genealogia] del presente, una [genealogia] della modernità, una [genealogia] di noi stessi” (GSA,
30).
2.
Ho volutamente sostituito il termine ontologia con genealogia: nella seconda ora di lezione del 5 gennaio
1983, dopo aver coscienziosamente dissertato, da professore, sul clima storico-culturale in cui maturò il testo
kantiano sull’Aufklärung, il Foucault ‘nietzscheano’ esce allo scoperto, ed è per questo che lo sovrapporrò
alla posizione anti-pastorale di Kant, per criticarne le residue ingenuità metafisiche (il filosofo di Königsberg
credeva ancora alle “magnifiche sorti e progressive” proprio come i bambini credono a Babbo Natale), ma
per mostrare, allo stesso tempo, in quale misura la posizione ‘ontologica’ di Foucault sull’attualità appaia
‘genealogica’ se riferita al nostro presente.
Per Kant, la minorità da cui l’illuminismo cerca di far uscire l’uomo non equivale all’infanzia biologica, né
alla stupidità vera e propria, cioè al difetto di giudizio senza spirito; non è dunque un’inferiorità oggettiva,
innocente, “un’impotenza naturale” (GSA, 36), ma un vizio soggettivo, una colpevole debolezza della
volontà: “l’uomo vive in una condizione infantile” (ibidem) perché incapace “di servirsi del proprio intelletto
senza la direzione di un altro” (GSA, 33); questa “mancanza di decisione e di coraggio” (ibidem) consegna il
pigro e femmineo intelletto umano (Verstand) al potere della casta sacerdotale, o di una qualunque lobby
politico-religiosa “venata di scaltrezza e astuzia” (GSA, 37), dunque capace di assoggettare le deboli menti
di coloro che (e per Kant sono la maggioranza!) hanno paura di pensare da soli, proprio come i bambini
hanno paura di lasciare il girello (Gängelwachen):
A persuadere la grande maggioranza degli uomini (e con essi tutto il bel sesso) che il passaggio
dallo stato di maggiorità è difficile e anche pericoloso, provvedono già quei tutori che si sono
assunti con tanta benevolenza l’alta sorveglianza sopra i loro simili minorenni. Dopo di averli in un
primo tempo istupiditi come fossero animali domestici e di avere con ogni cura impedito che queste
pacifiche creature osassero muovere un passo fuori della carrozzella da bambini in cui li hanno
imprigionati, in un secondo tempo mostrano ad essi il pericolo che li minaccia qualora cercassero di
camminare da soli [...] È dunque difficile per ogni singolo uomo lavorare per uscire dalla minorità,
che è divenuta per lui una seconda natura. Egli è perfino arrivato ad amarla e per il momento è
realmente incapace di valersi del suo proprio intelletto, non avendolo mai messo alla prova. Regole
e formule, questi strumenti meccanici di un uso razionale, o piuttosto di un abuso delle sue
disposizioni naturali, sono i ceppi di una eterna minorità.17
A parte il facile riferimento profetico alle regole procedurali di un software, tipiche di quello strumento
meccanico (hardware) di cui abusiamo irrazionalmente tutti i giorni (e che infatti sto usando anche adesso),
sembra di essere di fronte a un circolo vizioso: la paura di pensare produce il piacere di obbedire, che a sua
volta genera la paura di uscire dalla minorità.
In effetti, è qui che sorge in Kant un problema teorico, o meglio un paradosso che Foucault non rileva
immediatamente, preoccupato com’è di far notare che, se da un lato il potere pastorale non è stato né preso
con la forza né concesso in forma giuridico-contrattuale (GSA, 37), d’altra parte il presente, l’attualità, è
proprio il tempo in cui si manifesta la forza di compiere l’‘uscita’ (Ausgang) da questo vergognoso stato di
minorità e dipendenza: un nuovo movimento prescrittivo eppure liberatorio, di cui Kant (proprio come farà
Nietzsche con il superuomo, definendolo però ‘inattuale’) non specifica se debba riguardare l’intera umanità,
o alcune società, o alcuni individui (cfr. GSA, 35). Kant mostra inoltre un’indecidibile quanto significativa
oscillazione pedagogica tra natura e cultura, che attraversa, simile ad una faglia, tutta la riflessione politica
sulla modernità come compito, e non come epoca (una riflessione che, da questo punto di vista, Foucault
eredita da Marx contro Freud): benché la minorità sia un fenomeno storico-culturale, e non costituisca,
com’è invece per “l’insocievole socievolezza” (ovvero per l’egoismo competitivo di cui Kant parlerà
nell’Antropologia pragmatica18), una naturale tendenza dell’uomo, tuttavia solo a quei pochi che sono già
illuminati dalle loro qualità, che sono riusciti cioè a camminare da soli, a diventare adulti grazie ad una
straordinaria naturalizzazione della cultura19, sarà possibile condurre un intero “pubblico”, cioè un intero
popolo, a fare altrettanto, a uscire fuori dal gregge scegliendo il “Sapere aude!”, il motto (Wahlspruch, alla
lettera: sentenza deliberata) dell’illuminismo. Pur avendo avuto anch’essi dei maestri, i veri educatori non
sono stati a loro volta educati, ma si sono auto-educati; senz’alcun bisogno di pastori, hanno avuto
semplicemente il coraggio parresiastico20 di usare la propria intelligenza elevandola a ragione criticoautonoma (Vernunft), e quindi a fonte di diritto, mentre i “tutori”, come li chiama Kant, che li giudica
proprio in quanto pensatore critico, hanno semplicemente sfruttato la pigrizia mentale dei più per istupidire e
addomesticare il popolo, suggerendogli con “benevolenza” che cosa può conoscere, che cosa deve fare, e in
cosa può sperare21. Come nota anche Foucault, pur senza mai esplicitarne la funzione pastorale (cfr. GSA,
38-39), costoro rispondono in modo implicito alle tre fondamentali domande del criticismo, impedendo che
gli uomini si governino responsabilmente da soli grazie all’uso pubblico e legittimo della ragione – cioè
grazie al rischiaramento prodotto dalla libera diffusione della cultura. “Governo di sé, governo degli altri: è
proprio in questo rapporto viziato che si caratterizza lo stato di minorità” (GSA, 40), che è la cultura
illuministica a definire come tale, dunque a comprendere per la prima volta, dandosi un compito storicopolitico: “Di conseguenza, ciò che l’Aufklärung dovrà realizzare – ciò che sta realizzando – sarà [...] la
redistribuzione dei rapporti tra governo di sé e governo degli altri” (ibidem).
Ma è a questo punto che, con la resistenza opposta dal pastorato alla redistribuzione dei rapporti di potere, si
ripropone il paradosso che more genealogico giunge fino a noi. Da un lato gli uomini “vili e pigri” (ibidem),
presi humboldtianamente en masse, sono incapaci, da soli, di uscire dal loro stato di minorità; e se qualcuno,
“prendendo coscienza del proprio valore” (GSA, 41), usa coraggiosamente la propria autorità per liberarli da
questo giogo, essi ben presto desiderano ritornarvi; ecco perché spesso le rivoluzioni si rovesciano in
dittature22, oppure (penso soprattutto a quella napoletana del 1799) si concludono con bande di sanfedisti che
danno la caccia ai rivoluzionari. D’altra parte, manifestando una platonica diffidenza verso le masse ancor
prima (1784) che scoppiasse la Rivoluzione Francese, Kant, che conosce il finale del mito della caverna,
sposta il baricentro del suo discorso sulla necessità di separare il nesso perverso tra “obbedienza” e “assenza
di ragionamento” (GSA, 41), che caratterizza lo stato di minorità, grazie ad una sottile distinzione tra “il
privato e il pubblico” (ibidem). Ora, invece di analizzare con la dovuta cattiveria il famoso panegirico di
Federico II di Prussia – unico sovrano europeo talmente illuminato da dire ai suoi sudditi: “Ragionate quanto
volete, e di ciò che volete, ma obbedite!”23 –, mi sembra più utile evidenziare la difficoltà teorica in cui si
muove Kant, quando attribuisce all’educazione dell’uomo due significati toto coelo incompatibili, eppure
storicamente compresenti: se infatti, dal punto di vista politico, educare ha significato (e significa),
infantilizzare per governare, l’illuminismo ha cercato (e cerca) di inventare un’altra pedagogia, fondata sulla
cultura e sulla libertà, che neutralizzi quella basata sulla paura e sull’ignoranza. Solo questa forma di autoeducazione avrebbe infatti il diritto e l’autorevolezza per imporsi sulle menti altrui, senza tuttavia esigere
l’obbedienza: il filosofo moderno è un parresiasta – ha il coraggio della verità – solo quando,
paradossalmente, insegna a non obbedire ma al contempo dice “ciò che è e ciò che si deve fare” (GSA, 24).
Il limite di Kant, anche come pensatore posto storicamente, e per così dire ottimisticamente al di qua del
nichilismo nietzscheano, consiste invece nell’aver concepito una prima volta, all’ombra del dispotismo
illuminato, il compromesso borghese tra obbedienza e ragione24; e una seconda volta, all’ombra della
Rivoluzione Francese, quella sorta di entusiasmo a distanza di sicurezza che ha caratterizzato (e caratterizza)
molti intellettuali sedicenti di sinistra: Scribĕre aude!, ovvero scrivi solo ciò che si può audacemente
diffondere senza correre rischi.25
3.
Possiamo ora riformulare con una maggiore dose di cinismo la domanda posta all’inizio di questo saggio:
qual è lo stato attuale della filosofia e, dunque, che cos’è il nostro presente a confronto con quello di Kant, e
soprattutto con quello di Foucault?
Secondo Foucault, Kant ha concepito l’illuminismo come un’uscita (Ausgang) e il moderno come quel
movimento che, liquidando il passato, può realizzarla pacificamente nel medio della cultura filosofica26;
perciò, in quanto dinamico e illuminato (in termini benjaminiani: non storicizzato) il presente per lui era
davvero ‘nuovo’: né, platonicamente, un’età di decadenza, né un tempo da decifrare perché leibnizianamente
gravido di futuro (o comunque cristianamente escatologico), né una semplice transizione verso un’altra
epoca (cfr. AF3 218). Noi ci troviamo invece a vivere un presente ‘nuovo’ nel senso di inquietante, nel quale
facciamo esperienza, per così dire, di una frenetica ma immobile uscita dall’uscita, cioè di un esito
convulsivo, quasi epilettoide del movimento – il che ci porta a ri-attualizzare proprio i significati che Kant e
Foucault avevano escluso dal moderno: ci sentiamo confusamente prigionieri di un’epoca di decadenza, cioè
un’epoca senza qualità nella quale, cavalcando le mode, cerchiamo invano di decifrare i segni aurorali di
qualcosa che ci possa portare finalmente oltre l’incertezza e la precarietà del passaggio.
Da tale punto di vista etimologico il post-moderno, come del resto l’iper-moderno o il sur-moderno, è una
specie di gioco di continui rinnovamenti a somma zero: una fuga da quell’uscita dallo stato di minorità che il
moderno aveva promesso all’uomo, dunque un ritrovarsi sempre e comunque risospinti in una destinale
“condizione infantile”, eppure imputabile alla nostra pigrizia e alla nostra viltà. Come fallimento o paralisi di
quel delicatissimo processo pedagogico che concepiva (e concepisce) l’uso pubblico della ragione quale
veicolo prescrittivo, ma non autoritario, di emancipazione da ogni forma di potere, il postmoderno è un
presente ‘interno’ che ha mancato il ‘fuori’ – lo stato adulto come uscita dalla caverna o dall’utero –, ed in
cui dunque, dal punto di vista psicoanalitico, la filosofia è restata (resta) bambina. Lo stato attuale della
filosofia è quello in cui essa, molestata e talora sedotta da ogni sorta di sacerdoti, fa un’esperienza
narcisistica della propria inattualità, per non dire della ineseguibilità del proprio compito parresiastico e
virile: dire “ciò che è e ciò che si deve fare” (GSA, 24).
Detto ancora in altri termini: la cultura filosofica non ci ha abbandonato, ci ha anzi saturato, ma per ciò
stesso ha finito coll’indebolirci27. Pur coincidendo, in senso kantiano, con un enorme uso pubblico della
ragione (internet ne è un esempio), il postmoderno non favorisce affatto la “costituzione di se stessi come
soggetto autonomo” (AF3, 225), mostrando invece, sul piano politico, un nesso perverso tra diffusione
eteronoma della cultura (= divulgazione) ed uso privato (o meglio privatistico) della ragione28. Se, infine, la
stessa critica genealogica che abbiamo appreso da Nietzsche e Foucault, ovvero l’“indagine storica attraverso
gli eventi che ci hanno condotto a costituirci e a riconoscerci come soggetti di ciò che facciamo, pensiamo e
diciamo” (AF3, 228), non riesce a cogliere, “nella contingenza che ci ha fatto essere quello che siamo, la
possibilità di non essere più, di non fare o non pensare più quello che siamo, facciamo o pensiamo” (ibidem),
allora scriviamo oggi la genealogia della nostra illusoria uscita dallo stato di minorità – di una fallita, o forse
mai davvero tentata rivoluzione anti-pastorale.
All’inizio degli anni ottanta e dunque al termine di quella stagione che gli aveva fatto intravedere la
possibilità di una riattivazione politica della parrēsia, Foucault ne era già malinconicamente consapevole:
“Non so se raggiungeremo la maggiore età. Molte cose, nella nostra esperienza, creano in noi la convinzione
che l’evento storico della Aufklärung non ci abbia reso maggiorenni; e che non lo siamo ancora” (AF3, 231).
La pervasività delle forme postmoderne assunte dal pastorato – forme consumistiche, populistiche,
terapeutiche, per non parlare di quelle che continuano a vendersi come pre-moderne: la chiesa cattolica e
tutte le confessioni religiose – non lascia dubbi sul carattere penosamente mediocre del nostro presente, che
viene pensato da molti (è l’affollato genitivo oggettivo dell’espressione ‘pensieri del presente’) ma non pensa
con la sua testa (genitivo soggettivo), dunque non esce allo scoperto, non sfonda il muro opaco della ciarla:
ciò che rende impossibile esercitare politicamente la parrēsia è, da un lato, la mancanza di qualità in chi si
sforza di dire il vero, dall’altro la mancanza di interesse in chi lo ascolta.
Tuttavia, se riusciamo a cogliere, o per lo meno a problematizzare (cfr. AF3, 231) una tale impossibilità,
conserviamo un margine di resistenza, che nel mio caso specifico – nella mia singolarità – mi gioco come un
residuo potere pedagogico: insegnare a non obbedire, cioè fabbricare intelligenza là dove invece è stata
coltivata la furbizia – esattamente come, in termini platonici, la mala pianta della tirannide cresce nella
palude della democrazia. Da questo punto di vista, e a patto di abbandonare le cautele kantiane,
l’illuminismo è il nucleo sempre inattuale, ma per ciò stesso ancora virtuale e sempre attualizzabile, di una
rivoluzione anti-pastorale. Nonostante i numerosi tentativi, e i numerosi aborti, forse l’Occidente non l’ha
ancora attraversata, ma soltanto sognata, un po’ come gli adolescenti sognano l’amore. Perciò, per poter
essere almeno pensata, essa dovrà essere necessariamente preceduta da un uso politico dell’insegnamento.
Chi la farà, chi, ormai adulto, uscirà fuori allo scoperto, sotto ciò che Benjamin chiamava “cielo della
storia”29, non si limiterà all’entusiasmo, poiché dovrà avere molto, molto coraggio.
Note
1 Cfr. M. Foucault, Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France 1982-83, a cura di M. Galzigna, Feltrinelli, Milano
2009, d’ora in poi citato tra parentesi nel testo o in nota con la sigla GSA, seguita dal numero di pagina.
2 Cfr. I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, in Id., Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, a cura di
N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, Utet, Torino 1965, pp. 141-148.
3 Cfr. What is Enlightement?, in The Foucault Reader, a cura di P. Rabinow, Pantheon Books, New York 1984, pp. 32-50, trad. it. in
Archivio Foucault 3. 1978-1985. Estetica dell’esistenza, etica, politica, a cura di A. Pandolfi, Feltrinelli, Milano 1998, pp. 217-232,
d’ora in poi citato tra parentesi nel testo o in nota con la sigla AF3, seguita dal numero di pagina. L’estratto della lezione del 5
gennaio si trova nello stesso volume dell’Archivio, alle pagine 253-261.
4 Del resto la cerca anche Foucault nel testo di Kant, il quale a sua volta non cerca di comprendere il presente “a partire: da una
totalità o da un compimento futuro. Cerca una differenza: qual è la differenza che l’oggi introduce rispetto a ieri?” (AF3, 219).
5 Mi riferisco ovviamente alla Rivoluzione Francese nell’interpretazione che ne dà Kant nel Conflitto delle Facoltà (1798), e che
viene analizzata da Foucault (cfr. infra), il quale a sua volta si lanciò nell’interpretazione politico-religiosa, poi rivelatasi un
clamoroso fraintendimento, della rivoluzione iraniana del 1978-79. Su ciò cfr. i famosi articoli comparsi tra l’ottobre del 1978 e
l’aprile del 1979 su “Le Nouvel Observateur”, in Dits et Écrits, vol. III, pp. 688-94 e 780-82, Gallimard, Paris 1994, poi confluiti in
trad. it. nel Taccuino persiano, a cura di R. Guolo e P. Panza, Guerini e Associati, Milano 1998.
6 Mi riferisco in particolare all’attacco terroristico alle Twin Towers dell’11 settembre 2001, che, salutato dagli analisti come il vero
inizio del terzo millennio e per così dire sur-interpretato come evento chiave del rapporto tra Occidente e Oriente (cfr. ad es. J.
Baudrillard, Lo spirito del terrorismo, Cortina, Milano 2002), potrebbe essere considerato il paradigma di un fatto storico
immediatamente mediatizzato, e paradossalmente ridotto all’insignificanza proprio a causa della sua enorme gravità geopolitica.
7 Chi sono, oggi, ‘gli uni e gli altri’ che formano il ‘noi’, come facciamo a definire ‘gli altri’, e soprattutto, esiste ancora un ‘noi’? A
questi interrogativi dobbiamo ormai rispondere senza l’aiuto di Foucault.
8 In questa risposta vi è sicuramente l’eco dell’affermazione di Rousseau, per cui l’uscita dell’uomo dallo stato di natura ha prodotto,
con l’ingresso nella cultura, un “indebolimento delle nostre energie”, a cui l’illuminismo, in quanto “educazione morale” del genere
umano, s’incarica per l’appunto di porre rimedio. Su ciò cfr. I. Kant, Antropologia dal punto di vista pragmatico (1798), in Id., Stato
di diritto e società civile, a cura di N. Merker, Editori Riuniti, Roma 1982, p. 332.
9 Cfr. AF3, 222-225. Qui Foucault sostiene che, se l’Aufklärung è l’età della Critica, cioè un’età che si vuole adulta, la modernità non
è affatto il periodo che la realizza, ma un ethos, dunque un atteggiamento e insieme un compito, una specifica “relazione con
l’attualità”, incarnata a suo giudizio da Baudelaire, nella misura in cui costui cercava, con mortale ironia e contro la moda, che segue
l’effimero, di riafferrare l’eterno, e con esso ciò che vi è di ‘eroico’ (aggiungerei di ‘erotico’), nel momento presente. In quanto
“rapporto che bisogna stabilire con se stessi”, il dandysmo di Baudelaire, la sua luciferina estetizzazione della vita, appaiono molto
vicini all’estetica dell’esistenza e alla cura di sé praticate e teorizzate dall’ultimo Foucault.
10 È questo il titolo di un altro fondamentale corso di Foucault al Collège de France tenuto nel 1979-80 e ancora inedito.
11 Come ricorda Foucault (cfr. GSA 25-26), nel Conflitto delle facoltà, affermando che la moderna contesa tra filosofia e diritto
verte sull’esistenza o meno di un progresso costante per il genere umano, Kant sostiene che la causa permanente di tale progresso sia
da rintracciare in un evento avente un triplice e direi vichiano valore di segno (rimemorativo, dimostrativo e prognostico) che,
nonostante i possibili fallimenti e/o ricadute degli uomini in condizioni, appunto, pre-moderne, garantisca con il suo accadere la
tendenza generale dell’uomo verso la perfettibilità. Cfr. I. Kant, Il conflitto delle facoltà in tre sezioni, in Id., Stato di diritto e società
civile, cit., pp. 315-329. In questo volume si trova anche un’altra trad. it. della Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, pp.
113-120.
12 Foucault ha buon gioco nel dimostrare che, per Kant che ne fu semplice spettatore (non diversamente, aggiungerei, da Fichte e da
Hegel), l’importante non fu partecipare alla Rivoluzione, ché anzi il Terrore avrebbe consigliato di non farla, ma fu pensarla, cioè,
appunto, renderla attuale per la cultura tedesca che si era tenuta distante dall’azione rivoluzionaria: cfr. GSA, 27-28.
13 La filosofia hegeliana della storia, nella sua forma dialettica, si presta tradizionalmente ad una doppia interpretazione: o, come
“nottola di Minerva”, discorso che può comprendere il presente sempre e soltanto dopo che questo si è compiuto, o al contrario, more
marxiano, come “il proprio tempo appreso con il pensiero”, formidabile grimaldello teorico da usare per far saltare le contraddizioni
del presente.
14 Cfr. W. Benjamin, Sul concetto di storia, a cura di G. Bonola e M. Ranchetti, Einaudi, Torino 1997, in part. le tesi XIV e XVIII.
15 Cfr. AF3, 222-223.
16 Mi riferisco in particolare a Zygmunt Bauman e Marc Augé, che più di altri hanno cercato di definire psico-sociologicamente la
dimensione attuale dell’esperienza umana in Occidente.
17 I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, cit., pp. 141-142. Corsivi miei.
18 Cfr. I. Kant, Antropologia dal punto di vista pragmatico (1798), in Id., Stato di diritto e società civile, cit., pp. 330-337.
19 Cfr. I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, cit., p. 142: “solo a pochi è venuto fatto con l’educazione del
proprio spirito, di sciogliersi dalla minorità e camminare poi con passo più sicuro”.
20 Come sappiamo, l’intero corso di Foucault è volto a dimostrare come, a partire da Kant, la filosofia illuministica riproponga in
modo nuovo il compito politico che era stato incarnato dalla parrēsia greca: dire il vero, avere il coraggio della verità nei confronti di
chi esercita il potere e, così, svolgere una funzione critica all’interno della democrazia.
21 “...è così comodo essere minorenni! Se io ho un libro che pensa per me, se ho un direttore spirituale (Seelsorger) che ha coscienza
(Gewissen) per me, se ho un medico che decide per me sul regime che mi conviene, ecc., io non ho più bisogno di darmi pensiero per
me” Ivi, p. 141.
22 Per parafrasare il titolo del corso di Foucault, il piacere di governare se stessi (per cui si paga un prezzo altissimo) è spesso
inferiore al piacere di governare gli altri.
23 Cfr. I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, cit., p. 147-48.
24 Com’è noto e come spiega anche Foucault (cfr. GSA, 41-45, ma anche AF3, 220-221), secondo Kant il potere politico è forte
quando concede un uso pubblico della ragione, ovvero la massima diffusione della cultura illuministica nella comunità degli studiosi
e dei loro lettori, cioè al livello dell’universale, imponendo in cambio al cittadino un’obbedienza ferrea alle norme dello stato quando
svolge in privato, cioè nella dimensione del particolare, le sue funzioni civiche e/o professionali; tale rovesciamento davvero
prussiano del significato che invece noi latini attribuiamo ai termini ‘pubblico’ e ‘privato’, porta Kant a criticare la “tolleranza” come
quella pericolosa e direi guicciardiniana forma di accondiscendenza verso il particolare (ad esempio verso l’evasione fiscale) che
finisce col danneggiare lo stato, cioè l’universale.
25 Non posso dilungarmi in questa sede sull’eccezione che, nella cultura italiana del secondo dopoguerra, è stata incarnata da Pier
Paolo Pasolini: intelligenti pauca.
26 Perché sembrava che solo in questo senso ragione e obbedienza potessero coesistere: se un pubblico colto produce un privato
onesto, “più libertà lascerete al pensiero, più sarete sicuri che lo spirito del popolo sarà addestrato all’obbedienza” (GSA, 45).
27 Come rilevato da quasi tutta la sociologia contemporanea, la cultura non funziona più come valore distintivo capace di definire
‘gli uni e gli altri’ che formano il ‘noi’.
28 Per cui il problema è diventato, secondo lo stesso Foucault: “come disconnettere la crescita delle capacità e l’intensificarsi delle
relazioni di potere?” (AF3, 230).
29 Cfr. W. Benjamin, op. cit., tesi IV, p. 25.