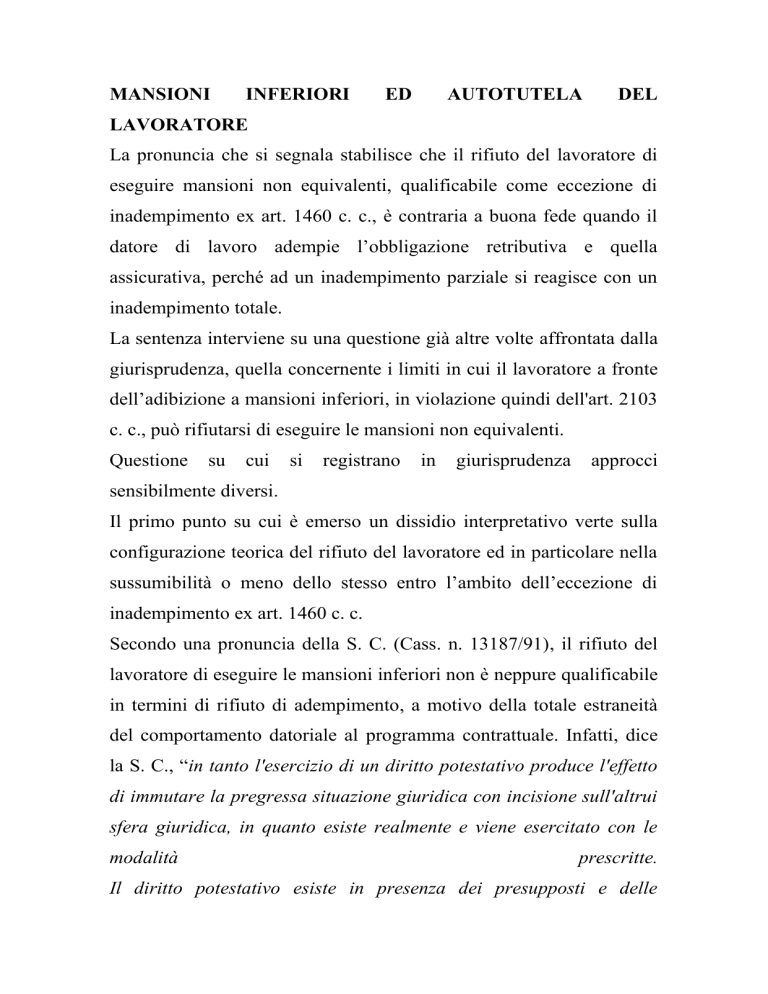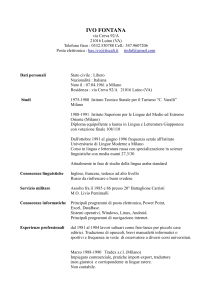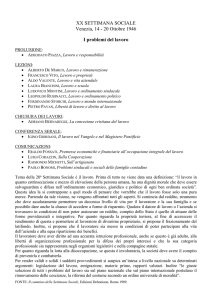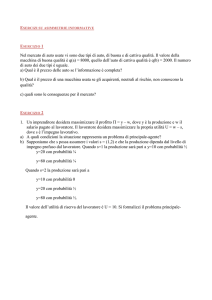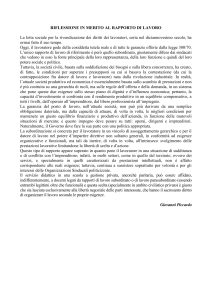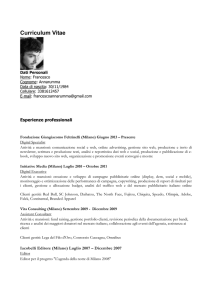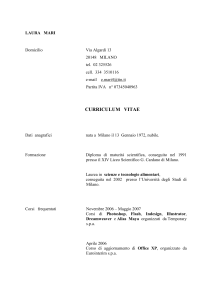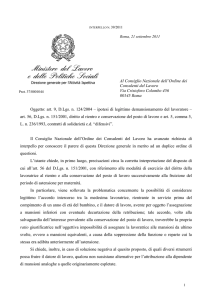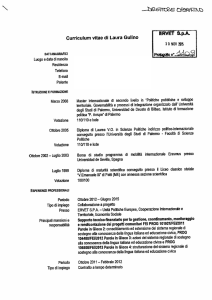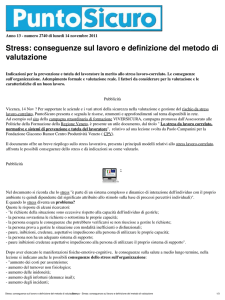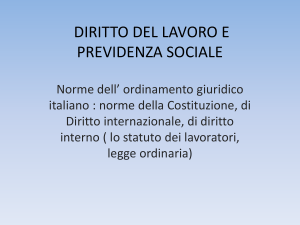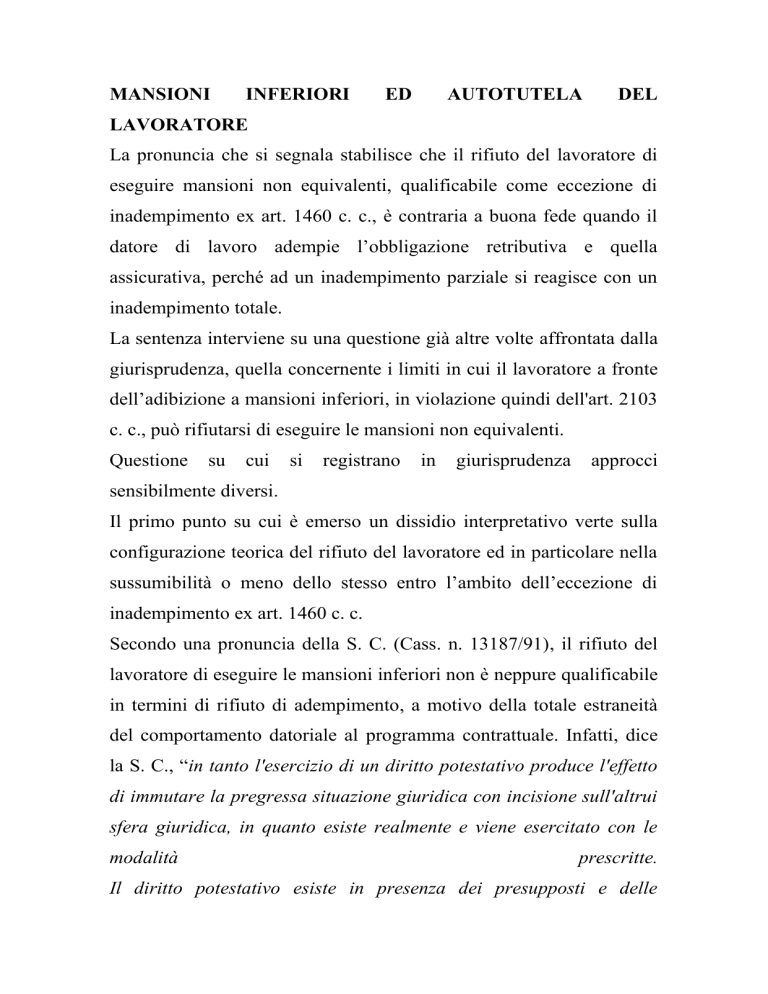
MANSIONI
INFERIORI
ED
AUTOTUTELA
DEL
LAVORATORE
La pronuncia che si segnala stabilisce che il rifiuto del lavoratore di
eseguire mansioni non equivalenti, qualificabile come eccezione di
inadempimento ex art. 1460 c. c., è contraria a buona fede quando il
datore di lavoro adempie l’obbligazione retributiva e quella
assicurativa, perché ad un inadempimento parziale si reagisce con un
inadempimento totale.
La sentenza interviene su una questione già altre volte affrontata dalla
giurisprudenza, quella concernente i limiti in cui il lavoratore a fronte
dell’adibizione a mansioni inferiori, in violazione quindi dell'art. 2103
c. c., può rifiutarsi di eseguire le mansioni non equivalenti.
Questione
su
cui
si
registrano
in
giurisprudenza
approcci
sensibilmente diversi.
Il primo punto su cui è emerso un dissidio interpretativo verte sulla
configurazione teorica del rifiuto del lavoratore ed in particolare nella
sussumibilità o meno dello stesso entro l’ambito dell’eccezione di
inadempimento ex art. 1460 c. c.
Secondo una pronuncia della S. C. (Cass. n. 13187/91), il rifiuto del
lavoratore di eseguire le mansioni inferiori non è neppure qualificabile
in termini di rifiuto di adempimento, a motivo della totale estraneità
del comportamento datoriale al programma contrattuale. Infatti, dice
la S. C., “in tanto l'esercizio di un diritto potestativo produce l'effetto
di immutare la pregressa situazione giuridica con incisione sull'altrui
sfera giuridica, in quanto esiste realmente e viene esercitato con le
modalità
prescritte.
Il diritto potestativo esiste in presenza dei presupposti e delle
condizioni,
stabilite
dalla
legge
o
dal
contratto.
In particolare, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., lo ius variandi è
attribuito all'imprenditore solo nell'ambito delle mansioni equivalenti
a quelle già esercitate dal lavoratore. In difetto, il contratto di lavoro
non subisce alcuna modifica nei contenuti, e l'ordine impartito al
dipendente di svolgere le nuove mansioni si colloca del tutto al di
fuori
L'inottemperanza
del
ad
contenuto
esso,
pertanto,
contrattuale.
non
può
costituire
inadempimento. Diviene a questo punto irrilevante per la decisione
della controversia stabilire, a livello di discorso sistematico, se il
datore di lavoro che tenga simili comportamenti si renda anche
inadempiente all'obbligo contrattuale di organizzare le energie
lavorative messe a disposizione e quindi di consentire lo svolgimento
della prestazione, inadempimento di fronte al quale, il rifiuto opposto
dal lavoratore potrebbe concretare un'eccezione d'inadempimento ai
sensi dell'art. 1460 cod. civ. (come più volte questa Corte ha
giudicato: sentenze n. 6609 del 1988, n. 178 del 1985, n. 2231 del
1984, n. 186 del 1984, ed altre conformi). Si tratta infatti del generale
problema della qualificazione della cooperazione creditoria sempre
come onere, nell'impossibilità di affermare un diritto del debitore ad
adempiere, oppure, con specifico riguardo al complesso contenuto del
contratto di lavoro subordinato, dell'esistenza di un diritto del
lavoratore a svolgere effettivamente l'attività lavorativa, problema
che, come sopra detto, non è necessario risolvere ai fini della
decisione, dal momento che il rifiuto di svolgere mansioni estranee al
contenuto del contratto non è qualificabile in termini di rifiuto di
adempimento”.
Secondo questa impostazione, ciò che unicamente importa è la
legittimità o meno dell’adibizione a mansioni diverse; dunque il fatto
che le mansioni nuove siano equivalenti o meno a quelle da ultimo
svolte.
Questo approccio può ormai dirsi ampiamente superato dalla
successiva giurisprudenza, che non esita a riportare la tematica in
parola entro il paradigma dell’eccezione d'inadempimento ex art.
1460. Di conseguenza, il problema viene articolato nei seguenti
termini: occorre appurare se il rifiuto del lavoratore, che è rifiuto di
adempimento della prestazione lavorativa, sia conforme a buona fede,
così come per l’appunto prescrive l’art. 1460 c.c. Che queste siano le
coordinate entro cui ricondurre la questione in esame è un dato che
può dirsi ormai acquisito.
Entro questa prospettiva di fondo, in ordine alla valutazione della
conformità del rifiuto del lavoratore al canone di buona fede,
schematizzando, si possono individuare sostanzialmente tre soluzioni.
Secondo una prima soluzione, che è quella fatta propria dalla sentenza
in oggetto, il rifiuto di eseguire le mansioni considerate non
equivalenti è contrario a buona fede, a fronte dell’adempimento da
parte del datore di lavoro di tutte le altre fondamentali obbligazioni,
ossia
quella
retributiva
e
quella
contributiva.
In
presenza
dell’adempimento di tali obbligazioni, vi è sproporzione tra
inadempimento del lavoratore e inadempimento datoriale; il primo
essendo totale, il secondo parziale.
Ad esito vistosamente diverso conduce un’altra posizione, quella
secondo cui il rifiuto del lavoratore è conforme a buona fede se vi è
l’offerta a continuare a prestare le mansioni originarie o comunque
altre equivalenti (Cass. n. 8939/96, Cass. n. 2691/77). Se nella prima
impostazione l’accento cade sul comportamento datoriale, in questa
l’accento cade sul comportamento del lavoratore.
Si riscontra poi una terza soluzione, quella fatta propria da Cass. n.
12121/95, che ha riguardo al raffronto tra mansioni rifiutate e
mansioni pregresse. Recita la massima: “L'illegittimo provvedimento
del datore di lavoro di mutamento "in peius" delle mansioni del
lavoratore, può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in
forza dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. Il rifiuto
può considerarsi in buona fede solo se si traduca in un
comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali
della correttezza e della lealtà, risulti oggettivamente ragionevole e
logico, nel senso di trovare concreta giustificazione nel raffronto tra
prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di
corrispettività e contemporaneità delle medesime” (Cassazione civile
, sez. lav., 23 novembre 1995, n. 12121).
Questa soluzione appare a chi scrive la preferibile, in quanto fa
riferimento ad un elemento attinente all’inadempimento di cui si
discute, ed appare più coerente con l’insopprimibile esigenza di
flessibilità nella valutazione propria del canone di buona fede. È
plausibile ritenere che, al fine di valutare la proporzionalità
dell’eccezione di inadempimento, occorre in primo luogo avere
riguardo alla gravità dell’inadempimento, ossia alla gravità del
demansionamento.
Non ogni demansionamento possiede uguale gravità. Potendo variare
molto la concreta gravità del demansionamento, in termini di
incidenza sulla professionalità e di ricadute esistenziali, appare troppo
rigido ed aprioristico - e perciò stesso non congruente rispetto alla
flessibilità del parametro della buona fede - il criterio che stima
decisivo l’adempimento dell’obbligazione retributiva e contributiva.
Non meno aprioristico appare il criterio fondato sulla semplice offerta
da parte del lavoratore dell’esecuzione delle mansioni pregresse o
equivalenti. È preferibile ritenere che questi siano solo elementi, tra
gli altri, di cui tener conto, nella valutazione di conformità a buona
fede, in uno con la gravità del demansionamento.