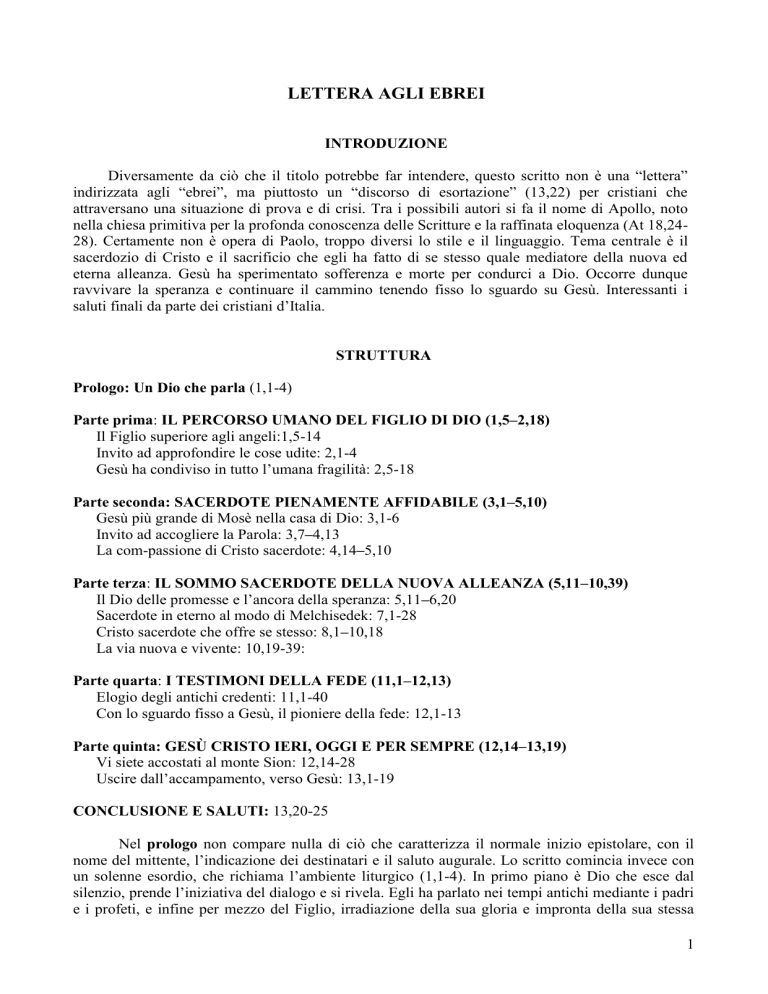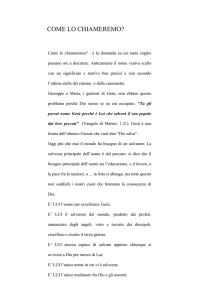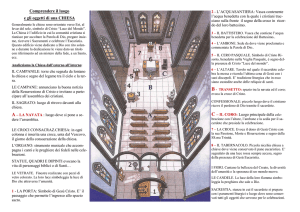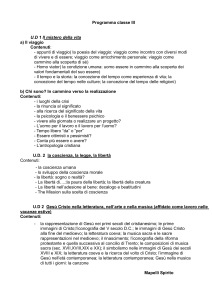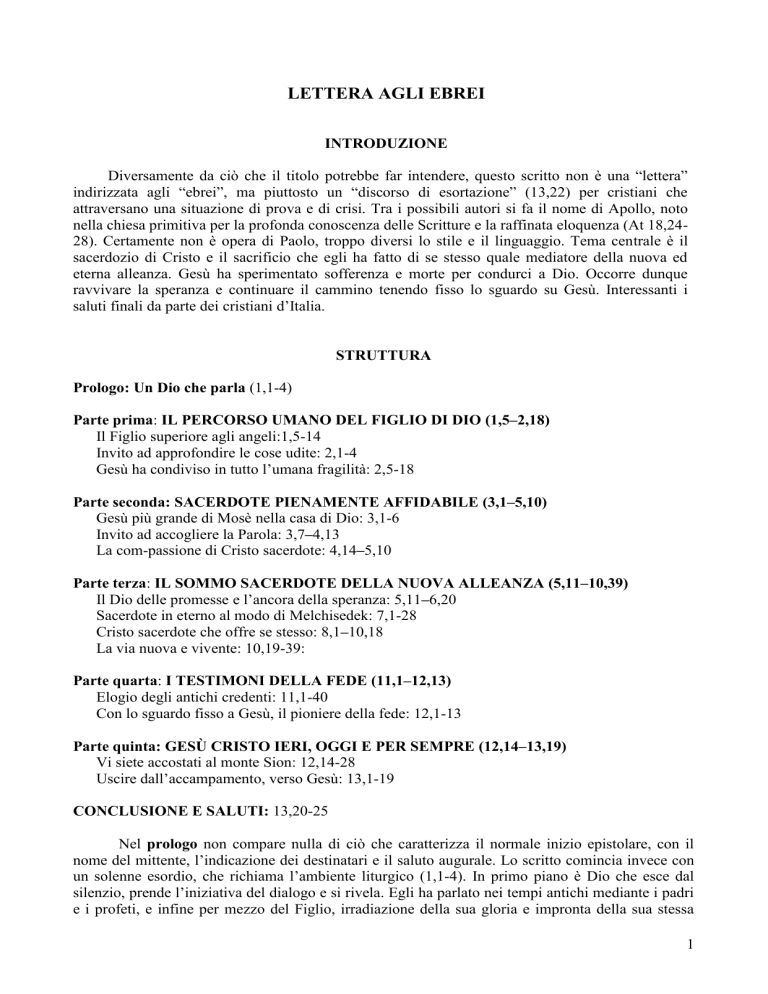
LETTERA AGLI EBREI
INTRODUZIONE
Diversamente da ciò che il titolo potrebbe far intendere, questo scritto non è una “lettera”
indirizzata agli “ebrei”, ma piuttosto un “discorso di esortazione” (13,22) per cristiani che
attraversano una situazione di prova e di crisi. Tra i possibili autori si fa il nome di Apollo, noto
nella chiesa primitiva per la profonda conoscenza delle Scritture e la raffinata eloquenza (At 18,2428). Certamente non è opera di Paolo, troppo diversi lo stile e il linguaggio. Tema centrale è il
sacerdozio di Cristo e il sacrificio che egli ha fatto di se stesso quale mediatore della nuova ed
eterna alleanza. Gesù ha sperimentato sofferenza e morte per condurci a Dio. Occorre dunque
ravvivare la speranza e continuare il cammino tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Interessanti i
saluti finali da parte dei cristiani d’Italia.
STRUTTURA
Prologo: Un Dio che parla (1,1-4)
Parte prima: IL PERCORSO UMANO DEL FIGLIO DI DIO (1,5–2,18)
Il Figlio superiore agli angeli:1,5-14
Invito ad approfondire le cose udite: 2,1-4
Gesù ha condiviso in tutto l’umana fragilità: 2,5-18
Parte seconda: SACERDOTE PIENAMENTE AFFIDABILE (3,1–5,10)
Gesù più grande di Mosè nella casa di Dio: 3,1-6
Invito ad accogliere la Parola: 3,7–4,13
La com-passione di Cristo sacerdote: 4,14–5,10
Parte terza: IL SOMMO SACERDOTE DELLA NUOVA ALLEANZA (5,11–10,39)
Il Dio delle promesse e l’ancora della speranza: 5,11–6,20
Sacerdote in eterno al modo di Melchisedek: 7,1-28
Cristo sacerdote che offre se stesso: 8,1–10,18
La via nuova e vivente: 10,19-39:
Parte quarta: I TESTIMONI DELLA FEDE (11,1–12,13)
Elogio degli antichi credenti: 11,1-40
Con lo sguardo fisso a Gesù, il pioniere della fede: 12,1-13
Parte quinta: GESÙ CRISTO IERI, OGGI E PER SEMPRE (12,14–13,19)
Vi siete accostati al monte Sion: 12,14-28
Uscire dall’accampamento, verso Gesù: 13,1-19
CONCLUSIONE E SALUTI: 13,20-25
Nel prologo non compare nulla di ciò che caratterizza il normale inizio epistolare, con il
nome del mittente, l’indicazione dei destinatari e il saluto augurale. Lo scritto comincia invece con
un solenne esordio, che richiama l’ambiente liturgico (1,1-4). In primo piano è Dio che esce dal
silenzio, prende l’iniziativa del dialogo e si rivela. Egli ha parlato nei tempi antichi mediante i padri
e i profeti, e infine per mezzo del Figlio, irradiazione della sua gloria e impronta della sua stessa
1
divinità, Parola creatrice e artefice della grande salvezza. Dopo aver compiuto la purificazione dei
peccati, il Figlio è stato glorificato alla destra di Dio, erede di un nome che non ha equivalenti.
Partecipa della stessa regalità divina.
La prima parte del discorso presenta l’identità del Figlio di Dio in un duplice rapporto:
anzitutto nei confronti degli angeli (1,5-14) e quindi in relazione con gli uomini (2,5-18). Una breve
e intensa esortazione invita ad applicarsi maggiormente alle “cose udite” (2,1-4), ovvero
all’approfondimento dell’annuncio cristiano.
In dialogo serrato con le Scritture l’autore mostra in primo luogo la superiorità di Gesù sugli
angeli (1,5-14). A nessuno di essi infatti Dio ha mai detto: <<Tu sei mio Figlio, oggi ti ho
generato>>. La citazione è tratta dal Sal 2,7 che la predicazione cristiana primitiva applica al
battesimo di Gesù e alla sua risurrezione. L’intero brano è tessuto di sette citazioni tratte
prevalentemente dai Salmi e collegate ad arte per mostrare, sulla base della parola di Dio, la
suprema dignità del Figlio.
Siamo invitati ad approfondire le cose udite, ovvero la rivelazione di Gesù Cristo (2,1-4):
non semplicemente sul piano dottrinale ma sotto il profilo etico, nell’obbedienza fattiva.
Esortazione e insegnamento sono strettamente collegati in questo discorso poiché la fede interpella
la vita.
Gesù è l’Uomo incoronato di gloria, cui tutto è stato sottoposto, anche se al presente ciò non
appare ancora visibile. Mirabile è il percorso attraverso cui ha raggiunto la gloria: non mediante la
forza e il potere, ma piuttosto attraverso il volontario abbassamento e la piena solidarietà con la
famiglia umana. Il figlio di Dio si è fatto in tutto simile all’uomo e ha sperimentato sofferenza e
morte per aprire il cammino della salvezza e venire in aiuto a quelli che sono nella prova (2,5-18).
La seconda parte si sofferma sul ruolo di Cristo, sacerdote pienamente affidabile (3,1–
5,10). Il sacerdote ha un ruolo di mediazione tra Dio e gli uomini. Per intercedere in modo efficace
deve essere intimo a Dio, a lui gradito, e d’altro canto è necessario che ascolti e comprenda
l’umanità. Cristo, appassionato d’amore, realizza in modo sublime entrambi gli aspetti. In quanto
Figlio di Dio è degno della massima fiducia, ma è anche pienamente in grado di compatire le umane
debolezze, avendo egli stesso sperimentato ogni genere di prove.
L’autore condivide una grande ammirazione per Mosè, servo fedele di Dio (3,1-6). Ma Gesù
è ancora più affidabile, degno di una maggiore gloria e fiducia. Mosè infatti ha pur sempre un ruolo
di servo nella casa di Dio, mentre Gesù è il Signore. La casa del Signore è il suo popolo e quella
casa “siamo noi”, se conserviamo libertà e speranza.
Non basta però avere Cristo come guida e sacerdote. Occorre imparare ad ascoltare la voce
di Dio nell’oggi della storia (3,7–4,13). Ogni giorno è l’oggi di Dio che chiama all’ascolto
obbediente, perché non abbia a ripetersi quanto accadde agli antichi Israeliti: non tutti quelli che
uscirono dall’Egitto entrarono infatti nel “riposo” di Dio, di cui la Terra promessa era simbolo. E
non vi entrarono per mancanza di fede. Ma Dio promette un altro “riposo” nel quale siamo
sollecitati a entrare al seguito del nuovo Giosuè, cioè Gesù. L’esortazione si chiude con un
magnifico elogio della parola di Dio che è viva ed efficace, più tagliente di un coltello a doppia
lama, penetrante fino a dividere l’anima dallo spirito. Nessuno può nascondersi al suo profondo
giudizio.
La nuova articolazione tematica (4,14–5,10) richiama l’attenzione sul punto focale: il Figlio
di Dio è un sommo sacerdote che sa comprendere le umane debolezze. Gesù conosce bene la
fragilità umana avendo sperimentato personalmente sofferenza e morte. Il pensiero corre alla notte
del Getsemani in cui Gesù si rivolge a Dio <<con forte grido e lacrime>> (5,7). Alla scuola della
sofferenza Gesù ha imparato l’obbedienza, ovvero a fidarsi pienamente del Padre. La sua preghiera
è stata un entrare nell’accoglienza incondizionata del volere di Dio, cioè nel progetto salvifico del
Padre. E fu esaudito, annota l’autore. Può sembrare paradossale perché Gesù non fu sottratto alla
morte. Ma Dio ha esaudito la richiesta di Gesù in altro modo, nella risurrezione. Attraversando la
2
morte Gesù divenne, in qualità di risorto, <<sacerdote per sempre>> e causa di salvezza eterna per
tutti coloro che si affidano a lui nell’obbedienza della fede.
La parte centrale (5,11–10,39) del discorso sviluppa il tema del sacerdozio di Cristo, che
costituisce una radicale novità in quanto non si iscrive nei canoni della legge mosaica e non si attua
nell’ambito cultuale del tempio di Gerusalemme, ma nella concretezza della vita e nel sacrificio che
Gesù ha fatto di se stesso in piena obbedienza al Padre. L’autore approfondisce questa novità sulla
base delle Scritture che parlano di un altro sacerdozio, quello di Melchisedek, figura del sacerdozio
eterno del Cristo. Ma non si tratta semplicemente di teologia. Tutto questo interpella la vita.
L’esposizione dottrinale intende infatti incoraggiare il rinnovamento della comunità cristiana. Gesù
coinvolge attivamente i credenti nel suo sacerdozio e nella nuova alleanza. Occorre dunque uscire
da un certo infantilismo spirituale e progredire.
In primo luogo, viene lanciato un messaggio forte alla comunità perché si scuota dalla
pigrizia mentale, impari a nutrirsi di cibo solido, cresca nell’approfondimento e si riprenda da un
modo di vivere piuttosto rilassato (5,11–6,20). Dal latte, alimento dei bambini, bisogna passare a
cibo più adatto a cristiani adulti, che “hanno assaporato la buona parola di Dio”. Rafforza
l’esortazione la parabola della terra, che se produce solo rovi e spine finirà bruciata. Il Dio di
Abramo è il Dio della promessa che pone in atto la dinamica della speranza. E la speranza dei
cristiani è come un’ancora per la nave sul mare in tempesta. Essa però non affonda in basso, in
cerca di terra ferma, ma si ancora in alto, nel santuario del cielo, dove Gesù è entrato come nostro
precursore.
La riflessione si sposta quindi su Aronne, della tribù di Levi, capostipite del sacerdozio
levitico o aronnitico (7,1-28). Gesù però è sacerdote in modo diverso, alla maniera di Melchisedek.
Ma chi è questo misterioso personaggio di cui la Bibbia non precisa l’albero genealogico e tace le
origini? Egli fa la sua prima comparsa nel libro della Genesi (14,18-20). Il patriarca Abramo, reduce
da una vittoria sui nemici, viene accolto e benedetto da Melchisedek, re di Salem e sacerdote del
Dio altissimo, che offrì <<pane e vino>>. Abramo gli diede la decima del bottino. La figura del re
sacerdote Melchisedek assume crescente rilevanza nel giudaismo, come attestano gli scritti di
Qumran. La lettera agli Ebrei evidenzia il significato simbolico del nome, <<re di giustizia e di
pace>>, e il fatto che Melchisedek riscuote la decima da Abramo. La mancanza di genealogia poi
viene interpretata come prefigurazione del sacerdozio eterno del Cristo, nella prospettiva del Sal
110.
In apertura della sezione di Eb 8,1–10,18 l’autore avverte che siamo al punto capitale del
discorso. Si tratta di un sacerdozio nuovo e conseguentemente di un nuovo culto e di un’alleanza
nuova. Gesù esercita il suo sacerdozio nel santuario del cielo dove è entrato in qualità di Risorto. La
sua mediazione sacerdotale è dunque altra e decisamente superiore. Il sacerdozio di Aronne o
levitico si svolge a livello terreno e non è in grado di purificare in modo effettivo e permanente dal
peccato. Il contesto allude chiaramente al rituale ebraico dello Yom Kippur, ovvero al Giorno
dell’espiazione (dei peccati). L’autore ricorda che il sommo sacerdote deve entrare ogni anno nel
santuario con il sangue della vittima, anzitutto per l’espiazione dei peccati propri e quindi per quelli
di tutto il popolo. Cristo invece, che peccato non aveva, offrì stesso per i nostri peccati. E lo ha fatto
una volta per tutte, entrando nel Santuario del cielo con il proprio sangue, mediatore di un’alleanza
eterna. Il testo si muove attorno a realtà simboliche fortemente collegate: sangue-spirito-vita. È lo
Spirito che garantisce l’efficacia salvifica universale del sacrificio di Cristo.
La terza parte si conclude con il brano di Eb 10,19-39: l’appellativo “fratelli” introduce un
nuovo invito al rinnovamento. La cristologia non è mai separata dall’etica nella lettera agli Ebrei. E
dunque l’insegnamento sul sacerdozio di Cristo comporta un nuovo modo di vivere. I cristiani
hanno piena libertà di entrare nel santuario celeste, simbolo della comunione con Dio, attraverso
quella via <<nuova e vivente>> che Gesù ha inaugurato nel suo corpo. Ma abbiamo bisogno di
ravvivare la speranza e di incoraggiarci vicendevolmente nella carità e nella pazienza per compiere
in tutto la volontà di Dio.
3
Eb 11 si apre con una suggestiva descrizione della fede come fondamento della speranza.
Più che di una definizione concettuale si tratta di un’esperienza, di un atteggiamento che
caratterizza il pellegrinante popolo di Dio. Segue una carrellata dei grandi testimoni della fede, una
sorta di carovana che muove da lontano, dal giusto Abele, e passa attraverso Abramo e Sara, il
padre e la madre del popolo di Dio. L’elogio dei credenti prosegue con il ricordo dei patriarchi e
l’esodo di Israele dall’Egitto, dove campeggia la figura di Mosè. Ma non si limita ai giusti della
prima alleanza. Il lungo cammino porta a Gesù, il pioniere e supremo condottiero dei credenti.
La fede costituisce la tensione vitale del pellegrinante popolo di Dio, come attestano i grandi
testimoni di cui l’autore fa memoria (11,1-40). Quindici i personaggi maschili chiamati per nome, a
partire dal giusto Abele, vittima innocente che pur morto parla, anzi il suo sangue grida dalla terra.
La rassegna prosegue con i credenti prima del diluvio, Enoch e Noè, figure universali. Speciale
rilievo ha il ritratto di Abramo, il gigante della fede che non indietreggia neppure davanti al
sacrificio del figlio, convinto che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo riebbe
Isacco, quale simbolo della risurrezione. Di Giacobbe si ricorda che per fede benedisse, morente, i
figli di Giuseppe preannunciando l’esodo dall’Egitto. Esso si compie con Mosè, che alla gloria
preferì la solidarietà con il popolo oppresso e rimase saldo come se vedesse l’invisibile. Due sono i
nomi femminili: Sara, la sterile che riceve la capacità di concepire e fondare una stirpe, e Rahab, la
prostituta ospitale. Si ricordano infine, senza peraltro menzionarle, alcune donne che per la loro
fede riebbero vivi i loro morti. Il pensiero corre alla vedova di Zarepta cui Elia risuscitò il figlio, e
alla storia analoga della Sunammita (1Re 17,17-24; 2Re 4,29-37).
Eb 12 presenta i credenti sono dei camminatori, anzi degli atleti che corrono la gara tenendo
fisso lo sguardo su Gesù. Il corridore si veste il più leggero possibile, niente pesi superflui. E non
basta una buona partenza, occorre giocare la gara fino al raggiungimento della meta. Gesù, il
pioniere della fede, ha percorso la via della croce sopportando irrisione e disprezzo e ora,
glorificato, partecipa della stessa regalità di Dio. La comunità è invitata a leggere la propria
situazione nella stessa luce. Occorre perseverare nella fede, rafforzando le ginocchia vacillanti e
raddrizzando il cammino perché il piede zoppicante non abbia a storpiarsi ma possa guarire.
L’ultima parte del discorso (12,14–13,19) incoraggia i credenti in Gesù Cristo a
perseverare nel cammino intrapreso cercando la pace con tutti e la santificazione. L’autore
contrappone due monti simbolici: il Sinai, al quale si è accostato il popolo dell’antica alleanza, e il
monte Sion, al quale si è avvicinata la comunità cristiana. Su di esso è edificata la città del Dio
vivente, la Gerusalemme celeste.
Eb 12,14-28 rappresenta il vertice del discorso di esortazione, che intende ravvivare e
incoraggiare la vita cristiana. Il linguaggio è fortemente simbolico. I due monti – il Sinai e il Sion –
sono metafore dell’antica e della nuova alleanza. Del primo si tace il nome, ma esso è chiaramente
evocato dalle immagini: fuoco ardente, tenebra e tempesta, spettacolo terrificante. Toccare il sacro
monte era fatale: ogni animale che vi si avventurava era distrutto. La santità di Dio genera un forte
timore perfino in Mosè. Ora la buona notizia è che i cristiani si sono avvicinati al monte Sion. E
cosa troviamo in esso? La salvezza, realtà descritta con immagini positive. Non più timore e paura,
ma la gioia della grande assemblea convocata da Dio e santificata dal sangue di Gesù, il mediatore
dell’alleanza nuova. La Gerusalemme di cui si parla è quella “celeste” che l’apostolo Paolo dichiara
essere “nostra madre” (Gal 4,26) e che l’Apocalisse descrive in tutto il suo fulgore, come la sposa
dell’Agnello (Ap 21). Quanto più forte dunque l’esigenza di santità e di culto vero, gradito a Dio.
Il culto gradito a Dio implica amore fraterno, ospitalità, fedeltà coniugale, onestà, giustizia e
sobrietà (13,1-6). Ancora una volta si allude alla vicenda storica di Gesù che per santificare il
popolo con il suo sangue “patì fuori della porta” (v. 12). Il dettaglio evoca la crocifissione sul
Golgota, che stava fuori dalle mura di Gerusalemme. Ma c’è di più, non si tratta di archeologia ma
di appello alla vita: occorre uscire anche noi “fuori dall’accampamento” (v. 13). Per i cristiani non
c’è un luogo sacro separato dal profano. Come il Cristo essi sono chiamati a vivere il loro
4
sacerdozio nel mondo, offrendo a Dio “un sacrificio di lode” mentre camminano verso la città
futura. Con espressione di matrice liturgica, che riecheggia la rivelazione del nome divino (Es 3,14),
si afferma che Gesù Cristo è lo stesso: ieri, oggi e in eterno.
La solenne conclusione del discorso (13,20-25) presenta Gesù come che il Pastore grande
che il Dio della pace ha fatto risalire dai morti (13,20). Può stupire che dopo aver tanto parlato di
Cristo come sommo sacerdote, si concluda chiamandolo pastore. In realtà questo nuovo titolo evoca
molteplici risonanze, in particolare il tema dell’esodo e il sangue dell’alleanza. Mosè è stato fatto
salire dal mare, ma Gesù è stato fatto salire dai morti, è il pastore grande delle pecore e il mediatore
di un’alleanza eterna nel suo sangue. L’augurio è che il Dio della pace realizzi nella comunità ciò
che gli è gradito. Seguono alcune notizie riguardanti il fratello Timoteo e i saluti da parte dei
cristiani d’Italia.
Soffermiamoci ora in particolare su GESÙ, SOMMO SACERDOTE
In che senso Gesù è sacerdote se non apparteneva alla classe sacerdotale di Aronne e non ha
mai officiato nel Tempio? In un modo decisamente “altro”. Storicamente infatti egli è stato e ha
vissuto l’ebraismo da laico. E tuttavia – è quanto la lettera agli Ebrei intende mostrare – Gesù è
davvero il grande sacerdote della nuova alleanza.
Istituito come mediazione tra Dio e il popolo, particolarmente per offrire sacrifici in
espiazione dei peccati, il sacerdozio di Aronne era legato a una concezione della santità come
separazione dal profano e dall’impuro (cf. Lv 21). Entrare al cospetto del Santo per intercedere per
il perdono dei peccati comportava una serie di progressive “separazioni”. Ma Gesù, quale Figlio di
Dio, era già pienamente accreditato, non aveva bisogno di dar la scalata al cielo. Il suo sacerdozio
pertanto non si attua mediante una progressiva separazione dal mondo impuro e profano, bensì
attraverso un percorso di volontario abbassamento e di piena solidarietà con gli umani, fino a
condividere debolezza, sofferenza e morte. Per diventare un sommo sacerdote <<misericordioso e
affidabile>>, capace di compatire chi sta nella sofferenza, Gesù si è reso in tutto <<simile ai suoi
fratelli>>, eccetto il peccato.
La consacrazione sacerdotale egli la riceve direttamente da Dio: non secondo la prescrizione
mosaica, bensì secondo la promessa e il giuramento di cui parla il Salmo 110,4: «Tu sei sacerdote in
eterno secondo l’ordine di Melchisedek». Il misterioso re sacerdote, introdotto nel racconto della
Genesi (14,18-20) senza alcun riferimento genealogico, è visto come prefigurazione di un
sacerdozio diverso, che dura per sempre. Tale è il sacerdozio eterno del Cristo. Eterno come
l’amore. Non sono infatti i sacrifici che Dio gradisce, ma l’amore (10,5-10). Perciò il Cristo
percorre la via dell’incarnazione fino alle estreme conseguenze. Egli diventa perfettamente
sacerdote sulla croce, “fuori della porta della città”, in ambito impuro e profano (13,12). Ma è
proprio attraverso questa offerta totale nello Spirito eterno che il Cristo raggiunge la gloria,
entrando nel Santuario dei cieli, dove è sempre vivo per intercedere in nostro favore (7,25).
Nella Bibbia è viva la consapevolezza che la relazione con Dio è ostacolata dal peccato.
Allo scopo di espiare i peccati e purificare la coscienza dalle colpe il culto rituale della prima
alleanza prevedeva diversi sacrifici: dal Tamid, l’olocausto quotidiano di due agnelli che venivano
sacrificati uno al mattino e uno alla sera (Es 29,38-42), al grande giorno dell’Espiazione (Yom
Kippur) il 10 di Tisri, una delle feste più sentite del popolo giudaico. In quel giorno – unica volta in
tutto l’anno – il sommo sacerdote entrava nel luogo più sacro del tempio, il “santo dei santi”, per
cospargere col sangue delle vittime il kapporet o espiatorio, cioè la lastra d’oro che stava sopra
5
l’arca dell’alleanza e che era considerata come il trono su cui Dio sedeva invisibile. Il sommo
sacerdote entrava nel santuario due volte: la prima con il sangue di un giovenco per ottenere
l’espiazione dei peccati suoi e della sua casa, e la seconda con il sangue di un capro per ottenere
l’espiazione dei peccati di tutto il popolo.
Come valuta l’autore di Ebrei questi sacrifici? Li ritiene del tutto inadeguati al raggiungimento
dello scopo e vi contrappone l’efficacia del sacrificio di Cristo, unico e definitivo perché in grado di
eliminare il peccato (9,26) e sancire per sempre l’alleanza con Dio. Il nostro Sommo Sacerdote è
entrato nel Santuario del cielo e si è presentato al cospetto di Dio non con il sangue altrui ma con il
proprio, ottenendo una “redenzione eterna” (9,12). È lo Spirito che rende così efficace il sacrificio
del Cristo. Nel dinamismo vitale dello Spirito la morte violenta di Gesù si trasforma in alleanza
nuova e definitiva. È la fine del culto basato sui sacrifici: «Tu non hai voluto né sacrificio né
offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà» (Eb 10,5). Paolo direbbe: <<diede
se stesso per i nostri peccati>> (Gal 1,4). Un’unica oblazione personale sostituisce gli innumerevoli
sacrifici di agnelli o di altre offerte, indefinitivamente ripetuti perché inefficaci.
Gesù si è consegnato al progetto salvifico del Padre con tutta la sua libertà e sensibilità umana,
che raggiunge il vertice in quel <<forte grido e lacrime>> di cui parla Eb 5,7. La storia della
passione di Gesù s’intreccia con la lettura teologica e l’interpretazione salvifica offerta dalle sue
parole: <<questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti in remissione dei peccati>>
(Mt 26,28).
6