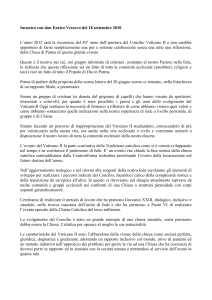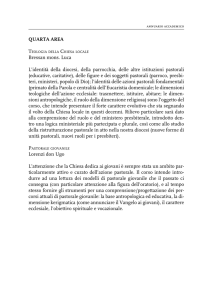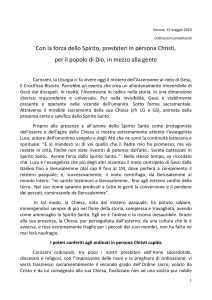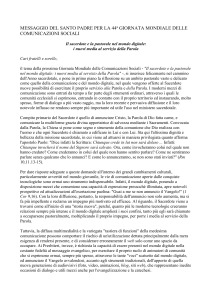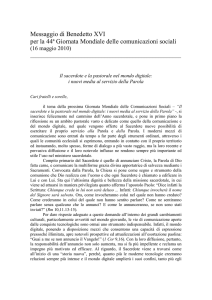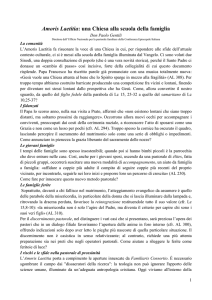“Presbyterorum Ordinis” cinquant’anni dopo.
Genesi, sviluppo, attualità
di
S.E. MONS. ERIO CASTELLUCCI
Convegno alla Pontificia Università Urbaniana, 19.11.15
Ringrazio il sig. Cardinale Beniamino Stella, Prefetto della Congregazione per il
Clero, che mi ha invitato a tenere questa relazione in un contesto così alto e
qualificato e in un’occasione così significativa come la celebrazione dei
cinquant’anni del decreto conciliare Presbyterorum Ordinis. L’invito mi giunse in
tempi “non sospetti”, ben prima del 3 giugno scorso, giorno in cui sono stato
nominato arcivescovo di Modena-Nonantola. Avevo già accettato con piacere,
appartenendo con gioia a quel “presbiterorum ordo” del quale avrei dovuto parlare.
Anzi, appartenendo al “parochorum coetus”, nel quale mi trovavo benissimo: come
ebbi modo di dire a papa Francesco lo scorso 29 giugno in occasione della consegna
del pallio, “ero un parroco felice”. Nella stessa occasione il Card. Stella, incontrato
in San Pietro, mi rinnovò l’invito e, nonostante l’imminente congedo dal
“presbyterorum ordo”, rinnovai di nuovo a mia volta la disponibilità.
Nella consapevolezza che l’argomento è molto vasto, procedo in tre passaggi
successivi: delineando in primo luogo la genesi del decreto, individuandone poi tre
grandi nuclei tematici ed offrendo infine alcuni spunti sulla sua attualità.
1. Genesi del documento
All’apertura dei lavori conciliari non era previsto alcun documento specifico sui
presbiteri. L’unico passaggio di un certo rilievo ad essi riservato si trovava al n. 12
dello Schema De Ecclesia, preparato prima del Concilio, dove in dieci righe veniva
riassunta una dottrina ritenuta assodata: i presbiteri, sebbene non posseggano l’apice
del pontificato proprio dei vescovi, tuttavia in forza dell’ordinazione sono veri
sacerdoti; offrendo il sacrificio della Messa e amministrando i sacramenti agiscono
anch’essi “in persona Christi”; posti in aiuto dei vescovi, dai quali vengono ordinati,
ricevono dal papa o dai vescovi la giurisdizione (cf. AS I, IV, 23).
Sia nelle discussioni in aula (1-7 dicembre 1962), sia nelle osservazioni scritte
inviate nei mesi successivi, i padri rilevarono quasi unanimemente la povertà di
quelle poche righe, e chiesero un approfondimento ed un ampliamento della
trattazione sui presbiteri: parecchi espressero il parere che il Vaticano II avesse
l’intenzione di dire molto e bene dei vescovi, ma poco dei presbiteri; e che nel
ministero dei primi venisse evidenziata giustamente la dimensione missionaria,
mentre i secondi rimanevano racchiusi nell’abilitazione al culto.
Le critiche portarono ad un nuovo paragrafo, sempre dentro allo Schema De
Ecclesia (ma diventato ora il n. 15), elaborato nel marzo 1963. Non possiamo però
seguirne ulteriormente la storia, perché ci porterebbe diritti a LG 28, e non a PO: era
tuttavia necessario accennarvi, in quanto nelle prime due sessioni del Vaticano II –
non avendo ancora deciso di elaborare un documento a parte – gli unici interventi
concernenti il presbiterato furono quelli relativi a questo schema.
Mentre maturava la LG, diveniva sempre più evidente ai padri conciliari come la
rinnovata dottrina sulla Chiesa e sull’episcopato non potesse non riflettersi anche sul
presbiterato. Il modello cultuale di sacerdote, plasmato specialmente nel secondo
millennio, si trovava quasi “schiacciato” tra due ali missionarie che il Vaticano II
stava riscoprendo: la dimensione missionaria della Chiesa intera, con la
rivalutazione del laicato, e la dimensione missionaria dell’episcopato, con la
sottolineatura della sacramentalità e collegialità, che sottraeva il ministero dei
vescovi a quella funzione prevalentemente amministrativa e burocratica alla quale
sembrava relegato da secoli. Il presbiterato così, essendo inquadrato unicamente nei
termini del culto, rischiava di apparire un elemento statico rispetto a questo contesto
ecclesiologico dinamico. Fu questo il motivo fondamentale per cui, nello stesso
marzo 1963 in cui compariva la seconda stesura del De Ecclesia, si decise di
svilupparne il paragrafo sui presbiteri in un vero e proprio testo a parte, di lì a poco
identificato come decreto.
Nei due anni di elaborazione conciliare, il decreto attraversò sette stesure prima
di raggiungere la sua forma definitiva (cf. Schema decreti De clericis: AS III, IV
,825-845; Schema propositionum De sacerdotibus: AS III, IV, 846-849; Schema
propositionum De vita et ministerio sacerdotali: AS III, IV, 227-229; Schema
Decreti de ministerio et vita presbyterorum: AS IV, IV, 833-863; IV, IV, 336-375;
IV, VI, 345-388; IV, VII, 107-190). Gli interventi, tesi a criticare e migliorare la
trattazione furono molto numerosi: da una loro lettura e dal confronto sinottico delle
diverse redazioni del decreto, si evince facilmente l’esistenza di una triplice ottica
tra i padri conciliari, i cui tratti si erano già manifestati in occasione della
discussione sui presbiteri nell’elaborazione del De Ecclesia. Alcuni vescovi africani
e asiatici chiedevano insistentemente di allargare la visione cultuale tridentina
tenendo conto dell’importanza che ha il ministero dell’annuncio, come primo passo
per la diffusione del Vangelo; ad essi si univano poi anche alcuni vescovi della
Francia che già da un ventennio era cosciente di essere un “paese di missione”. Altri
vescovi, specie del Sud Europa, rammentavano però che la dottrina di Trento non si
deve contraddire o superare, ma al massimo integrare, e chiedevano che per nessun
motivo si mettesse in disparte la visione cultuale. Altri padri conciliari di diverse
parti del mondo, specialmente di area italiana e tedesca, chiedevano che anche il
modello fino ad allora piuttosto trascurato, quello pastorale, venisse integrato negli
elementi essenziali del ministero ordinato. Si delineava in tal modo la griglia dei tria
munera, che – come dirò tra poco – venne assunta dal Vaticano II. Il problema era
che all’inizio, però, i tre compiti non venivano intesi come tre aspetti dell’unico
ministero presbiterale, ma – potremmo dire – come tre concezioni diverse di tale
ministero.
Il lavoro dei redattori sfociò in un testo ricco, che cercò per quanto possibile di
accogliere queste diverse ottiche, senza limitarsi ad affiancarle e giustapporle, ma
cercando di integrarle e fonderle. Il risultato dei lavori conciliari, ossia il decreto
Presbyterorum Ordinis, si può apprezzare da almeno tre prospettive, che ne fanno
risaltare ancora oggi, a cinquant’anni di distanza, la grande attualità e forse l’ancora
incompiuta recezione.
2. Tre nuclei tematici del decreto
Il primo nucleo è il passaggio dal modello delle due potestates a quello dei tre
munera. Il testo finale del decreto fa proprio il modello ternario; oltre che nella
struttura (§§ 4-6) esso appare in altri punti: al § 1 stabilisce un rapporto diretto
fra i tre aspetti del ministero presbiterale e la triplice azione di Cristo (il
presbitero partecipa dell’autorità con la quale Cristo stesso «exstruit, sanctificat
et regit» il suo corpo); al § 7 serve a rinsaldare il rapporto tra presbiteri e vescovi
(i presbiteri sono collaboratori e consiglieri dei vescovi «nella funzione di
istruire, santificare e governare il popolo di Dio»); e, infine, il § 13 mostra come
«l’esercizio della triplice funzione sacerdotale esige e favorisce la santità».
Che cosa significa l’adozione del modello ternario rispetto al precedente modello
binario? La concezione delle due potestates, cristallizzata già dall’inizio del secondo
millennio, rispondendo alla figura teologica del sacerdote come “uomo del culto”,
riconduceva il ministero sacerdotale a due diverse origini: il sacramento dell’Ordine,
che abilita all’esercizio degli atti cultuali sacerdotali (potestas ordinis) e la missio
canonica, che abilita alla predicazione e alla guida pastorale (potestas
iurisdictionis). In questo modo il ministero presbiterale era teologicamente
concentrato nel culto, che diventava il suo elemento distintivo. Questa doppia
origine entrò nella visione del sacerdozio del Concilio di Trento, che da una parte
raccolse la concezione medievale di tipo cultuale, consacrata da San Tommaso e
dall’altra lanciò la figura pastorale, interpretata poi da grandi vescovi come Carlo
Borromeo, per cui l’ideale dei ministri divenne quello di “dare la vita” per il gregge.
I due aspetti vennero a Trento affiancati ma non perfettamente fusi. Nei decreti
dogmatici infatti comparve solo la componente cultuale e sacerdotale, mentre nei
decreti di riforma prevalse l’aspetto pastorale e venne richiamato anche il compito
di predicare.
Assumendo il modello dei tre munera, prima per i vescovi e poi anche per i
presbiteri,1 già in LG 28 e poi approfonditamente in PO 4-6, il Vaticano II ha inteso
ricondurre tutti i compiti presbiterali ad un’unica origine, che è l’ordinazione
sacramentale: è Cristo, attraverso il conferimento dell’Ordine, che abilita a
predicare, celebrare, guidare. La Chiesa, “hierarchica communio”, interviene poi a
regolare questa triplice abilitazione, trasformando il munus in potestas. In questo
senso si può dire che il passaggio allo schema ternario non ha cancellato quello
binario, ma lo ha integrato in un contesto teologicamente più ricco. Si pensi ad
esempio alla rilettura neotestamentaria più ampia del tema dell’istituzione del
ministero, prima limitata all’Ultima cena e da PO 2 invece estesa all’intera missione
da Cristo affidata agli apostoli. L’ermeneutica biblica attenta anche alla dimensione
storico-critica, adottata dal Vaticano II al posto dell’uso dei versetti biblici come
“dicta probantia”, molto diffuso prima, ha portato a questa lettura globale
dell’argomento: per il Vaticano II Gesù ha istituito il ministero – articolato poi
lungo i secoli dalla Chiesa – non attraverso una sorta di atto notarile, dicendo una
frase o facendo un gesto, ma nella globalità della missione da lui consegnata a più
1
Tale modello è infatti utilizzato in LG per tutta la Chiesa (cf. nn. 10-13), per i vescovi
(cf. nn. 25-27) e per i laici (cf. nn. 34-36).
riprese ai suoi apostoli; una missione che comprende certamente, come suo
momento culminante, il mandato eucaristico (“fate questo in memoria di me”), ma
include anche il compito di battezzare, rimettere e ritenere i peccati, annunciare il
vangelo, insegnare ad osservare i comandamenti, lavarsi i piedi gli uni gli altri,
pascere il gregge e dare la vita per esso.
I padri conciliari, adeguando la figura dei presbiteri alle acquisizioni che
l’ecclesiologia aveva guadagnato, hanno potuto offrire quindi un’immagine
missionaria e non più solo cultuale dei presbiteri. Essi, come ripete più volte il
decreto, sono consacrati per la missione; la loro origine proviene stessa missione
affidata da Cristo agli apostoli. Essi non sono solo “sacerdoti”, ma anche “profeti” e
“pastori”. Il presbitero non è mediatore tra il cielo e la terra, come si tendeva a dire
prima, e neanche “alter Christus” – due espressioni che, sebbene proposte da alcuni
padri, non entrano mai in alcun testo conciliare riguardante i presbiteri – ma è un
ministro abilitato dal secondo grado del sacramento dell’Ordine ad esercitare il
triplice ministero nella Chiesa – annuncio, celebrazione e guida – in nome e in
persona di Cristo Profeta, Sacerdote e Pastore. In questo modo il Vaticano II ha
integrato quelli che prima erano modelli paralleli o addirittura contrapposti e ha
equilibrato il riferimento cristologico con quello ecclesiale.
Un secondo nucleo tematico riguarda la dimensione comunitaria del ministero
presbiterale, la cui assunzione ad opera di PO è espressa dalla massiccia
introduzione del plurale al posto del singolare: mentre il documento prendeva
forma, si parlava sempre meno di “sacerdote” o “presbitero” e sempre più di
“sacerdoti” e “presbiteri”. PO presenta solo 7 volte “presbitero” al singolare, mentre
le altre 111 ricorrenze sono al plurale. L’approfondimento conciliare
dell’ecclesiologia di comunione e il guadagno della collegialità episcopale hanno
disincagliato la figura presbiterale dall’individualismo di cui soffriva da parecchi
secoli, mettendone in evidenza l’intima natura relazionale (cf. PO 7-9). La teologia
del ministero dei primi secoli era profondamente segnata dalla dimensione
relazionale: dei ministri tra di loro, sotto la guida dell’apostolo (nel Nuovo
Testamento) e del vescovo (da Ignazio in poi); e dei ministri in rapporto alle
comunità, dalle quali sorgono e per le quali si spendono. Il Vaticano II anche in
questo caso ha riletto con maggiore attenzione le antiche fonti, fino a riabilitare il
presbiterio nella sua pregnanza teologica, dopo secoli nei quali sembrava essersi
ridotto a grandezza architettonica (il presbiterio come luogo delimitato dalla
balaustra) o, tutt’al più, sembrava un utile espediente operativo (essere uniti è
meglio che essere divisi). Per il Concilio, il presbiterio è una realtà teologica, che
deriva dalla profonda comunione tra coloro che ricevono lo stesso sacramento
dell’Ordine nella medesima Chiesa particolare. È in forza di questa intima unità,
intrinseca al sacramento stesso, che i presbiteri formano un “corpo” nel quale tutti
insieme, sotto la guida del vescovo, portano la responsabilità ministeriale di quella
determinata Chiesa. PO 8 inizia proprio affermando la specificità del legame che vi
è tra i presbiteri di una medesima diocesi. Essi infatti: “costituiti nell’ordine del
presbiterato mediante l'ordinazione, sono tutti tra loro uniti da intima fraternità
sacramentale; ma in modo speciale (specialiter) essi formano un unico presbiterio
nella diocesi al cui servizio sono assegnati sotto il proprio vescovo”.
Il carattere “speciale” della comunione nel presbiterio rispetto alla comunione tra
tutti i presbiteri del mondo, pure affermato, non viene però motivato, probabilmente
a causa di una insufficiente trasposizione dell’incipiente “teologia della Chiesa
locale/particolare” sulla dottrina riguardante i presbiteri. D’altra parte, il tentativo
avanzato da alcuni padri di stabilire un’analogia tra la collegialità episcopale e il
presbiterio viene regolarmente respinto dai redattori. Un’applicazione va comunque
notata, in PO 8, là dove si auspicano delle forme espressive della comunione
presbiterale: “per far sì che i presbiteri possano reciprocamente aiutarsi a fomentare
la vita spirituale e intellettuale, collaborare più efficacemente nel ministero, ed
eventualmente evitare i pericoli della solitudine, sia incoraggiata fra di essi una certa
vita comune o una qualche comunità di vita, che può naturalmente assumere forme
diverse, in rapporto ai differenti bisogni personali o pastorali: può trattarsi, cioè, di
coabitazione, là dove è possibile, oppure di una mensa comune, o almeno di
frequenti e periodici raduni”. Il problema sarà quello di distinguere quali forme può
legittimamente assumere la fraternità dei presbiteri diocesani, senza confondersi con
la vita comune dei religiosi.
Nonostante alcune incertezze, dunque, il risultato finale è solido: PO afferma
chiaramente quella dimensione comunitaria del ministero presbiterale che era stata
messa in sordina nella teologia e spiritualità precedente. E lo fa mettendo in luce le
tre relazioni fondamentali del presbitero: con il vescovo, il presbiterio e il popolo di
Dio (cf. rispettivamente PO 7, 8 e 9). Dirò tra poco qualche parola sull’attualità di
queste prospettive, ancora non sufficientemente recepite nella prassi.
Un terzo nucleo tematico è simboleggiato dall’inversione nel titolo del testo, nel
passaggio dalla terza alla quarta redazione, quando il de vita et ministerio diventa de
ministerio et vita. A questo ha ovviamente corrisposto il capovolgimento della
trattazione: fino alla terza redazione, si trattava prima della vita spirituale dei
presbiteri e poi dei vari aspetti dell’apostolato; dalla quarta in poi, si tratta prima del
ministero nelle sue tre dimensioni e poi della vita spirituale.
L’impostazione precedente rispondeva all’immagine del serbatoio, per cui era
necessario riempirsi per poter guadagnare un’autonomia sufficiente a svolgere il
ministero; l’attuale impostazione risponde invece all’immagine dei vasi
comunicanti, per cui sono le esigenze stesse del ministero vissuto, a plasmare la vita
interiore dei presbiteri, che a sua volta alimenta l’apostolato stesso. Esercitare il
ministero significa compiere un atto che nutre la spiritualità e quindi santifica i
presbiteri. I presbiteri raggiungeranno la santità nel loro modo proprio se nello
Spirito di Cristo eserciteranno le proprie funzioni con impegno sincero e
instancabile. Il § 13 di PO è un numero spesso trascurato, ma di grande spessore
teologico-spirituale. L’incipit è molto eloquente:”i presbiteri raggiungeranno la
santità nel modo loro proprio se nello Spirito di Cristo eserciteranno le proprie
funzioni con impegni sincero e instancabile”. E questo principio viene declinato per
tutti e tre i munera: come ministri della parola, essi la leggono e l’ascoltano, e
insegnandola ne vengono plasmati essi stessi; come ministri della liturgia, e
specialmente nel sacrificio della Messa, sono invitati a imitare ciò che compiono, e
ripetono l’offerta della loro stessa vita; come pastori, infine, nell’incontro con le
persone loro affidate, rinnovano l’atteggiamento di Cristo Pastore che accompagna
il suo gregge.
Per capire bene questa prospettiva del Vaticano II, che probabilmente costituisce
uno degli aspetti meno recepiti della teologia conciliare del ministero ordinato, è
utile ricordare come veniva prima impostato il discorso sulla spiritualità
presbiterale. Dall’inizio del II millennio, con la riforma gregoriana, la spiritualità
sacerdotale (vescovi e presbiteri) era plasmata sulla tradizione monastica. Gregorio
VII, che proveniva da Cluny, aveva impostato la parte della sua riforma riguardante
i costumi del clero sul modello dei monaci: i sacerdoti si santificavano nella misura
in cui praticano la contemplazione, la preghiera e la lettura della parola di Dio;
devono poi compiere l’apostolato, facendo però attenzione a rifornirsi spesso per
non rimanere privi di nutrimento spirituale. Questa prospettiva si potrebbe definire
con l’immagine del serbatoio: è necessario riempirsi spesso per poter guadagnare
un’autonomia sufficiente a compiere il ministero; l’apostolato è visto come
necessario per i sacerdoti, ma di per sé non entra nell’ambito della loro spiritualità,
che è invece, per così dire, tutto verticale. San Tommaso esprime questa
impostazione, con la sua consueta capacità sintetica, nella formula “contemplata
aliis tradere”.
Il Vaticano II, prendendo ispirazione da alcune riflessioni abbozzate dal Card.
Mercier all’inizio del Novecento a proposito della spiritualità del “clero diocesano”,
integrò dunque lo schema del serbatoio, completandolo con la prospettiva inversa: è
vero che una profonda contemplazione alimenta l’azione dei ministri, ma è anche
vero che l’apostolato stesso incide sulla vita spirituale dei presbiteri. In questa
impostazione, dove la spiritualità si “ricarica” nello svolgimento stesso del
ministero, non è più possibile tratteggiare la vita spirituale prima del ministero,
perché sono proprio le esigenze del ministero vissuto a plasmare la vita spirituale
dei presbiteri. Il Vaticano II ha in tal modo ritenuto superata l’idea che il prete è una
sorta di “monaco” prestato all’apostolato: idea che sottendeva una certa tensione tra
le esigenze della spiritualità e quelle dell’attività. Per il Concilio, come si è visto,
sono le istanze dell’annuncio, della celebrazione e della vita pastorale nei suoi
diversi aspetti a connotare la spiritualità del ministro. In tal modo il Concilio ha
messo in luce che la spiritualità del ministro non ha solo una dimensione verticale
costituita dalla preghiera, dalla contemplazione e dalla meditazione, bensì anche una
inscindibile dimensione orizzontale, costituita dalla trama di relazioni con i fratelli
che sostanzia quotidianamente il suo ministero.
E’ evidente allora in che senso il Vaticano II fa perno sulla “carità pastorale” (cf.
PO 14) come categoria capace di unificare vita e ministero dei presbiteri. Ed è
proprio questa categoria, poi indicata come “perno” del ministero sacerdotale dalla
Pastores dabo vobis di Giovanni Paolo II (1992), che il Vaticano II – come ci verrà
tra poco illustrato da Mons. Lambiasi – declina per i presbiteri il tema dei “consigli
evangelici” (cf. PO 15-17).
3. Spunti sull’attualità del decreto
Il processo della recezione ecclesiale di un documento magisteriale è sempre
molto complesso e difficile da delineare, perché si svolge in un continuo intreccio
tra dottrina e prassi, teologia e pastorale e coinvolge praticamente tutti i soggetti e
gli aspetti della vita ecclesiale. Non pretendo dunque certamente di offrire un
quadro completo, ma cercherò di evidenziare qualche aspetto.
Prendo spunto prima di tutto dal vissuto del presbitero. Non sono in grado di
offrire approfondite analisi sociologiche, psicologiche o pastorali; propongo
piuttosto una sintetica lettura della situazione, ricavata dall’esperienza e soprattutto
dai documenti del Magistero (specialmente Pastores dabo vobis e vari interventi dei
vescovi) e da studi di specialisti. Il vissuto, come generalmente accade, è
attraversato da luci e ombre, opportunità e fatiche. Lo si potrebbe esprimere con una
sola parola? Oggi forse no, ma quarant’anni fa sì: era d’obbligo usare la parola
“crisi” e parlare di “crisi di identità presbiterale”.
L’espressione, assente nei testi del Vaticano II, venne coniata all’inizio degli anni
settanta e caratterizzò il Sinodo dei vescovi del 1971 dedicato (anche) al sacerdozio
ministeriale. Per un ventennio si discusse a fondo su questa crisi – che costituì
dunque l’alveo fondamentale dell’ermeneutica di PO, cercando di capirne i motivi e
di uscirne. Se gli aspetti che colpivano di più l’opinione pubblica, anche molto
lontano dalle mura della Chiesa, erano quelli scandalistici – i non pochi preti che
contestavano e lasciavano rumorosamente il ministero, le comunità che si
opponevano in vari modi ai vescovi, la richiesta massiccia di abolizione del celibato
e di estensione del sacerdozio alle donne – i motivi reali e più profondi erano di
natura propriamente teologica: qual è la ragion d’essere del ministero ordinato nella
Chiesa? E’ proprio necessaria l’esistenza del sacramento dell’Ordine che dà il
carattere o è sufficiente che ogni comunità elegga un suo presidente per un certo
tempo? Al di sotto quindi delle rivendicazioni ecclesiali, delle crisi psicologicoaffettive, degli atteggiamenti pastorali provocatori, e così via, vi erano ragioni
teologiche vere e proprie, riguardanti niente meno che la natura stessa del ministero
ordinato.
Era dunque una ‘crisi’ del sacerdozio paragonabile solo a quella che cinque secoli
prima aveva contrapposto Lutero e il Concilio di Trento; in fondo, pure in un
contesto diversissimo, si trattava del medesimo problema: Lutero, rifacendosi alla
sola Scrittura, aveva negato la legittimità del sacramento dell’Ordine, sostituendo i
sacerdoti con dei ministri eletti dalle comunità per la predicazione della parola e
Trento, leggendo la Scrittura attraverso la Tradizione, aveva reagito diametralmente
riaffermando l’esistenza di un sacerdozio ministeriale fondato sull’Ordine e abilitato
all’offerta del sacrificio eucaristico. Se Lutero aveva interpretato teologicamente il
ministero in chiave unicamente profetica e funzionale, Trento lo imposta in chiave
decisamente cultuale e ontologica anche se, come ho accennato, dal punto di vista
pratico adotta la visione pastorale, ma solo nei decreti di riforma.
Per cinque secoli quindi vengono avanti parallelamente queste tre concezioni del
ministero ordinato: il mondo protestante è caratterizzato, con molte sfumature tra le
varie confessioni, dal ministero inteso come funzione profetica nella comunità,
come predicazione della Scrittura; il mondo cattolico è invece connotato da due
modelli che convivono nella stessa figura di sacerdote: da una parte egli è
configurato ontologicamente a Cristo Sacerdote ed esprime questo suo essere nella
celebrazione del sacrificio eucaristico e dei sacramenti; dall’altra egli deve assumere
lo stile di Cristo Pastore verso il gregge, dando la vita per la Chiesa. Avendo però
solo il primo dei due modelli vera e propria dignità sacramentale, il secondo
rimaneva affidato alla dedizione generosa del prete ma non ne caratterizzava
l’essere.
Se ora torniamo alla “crisi di identità” del ventennio successivo al Vaticano II,
riscontriamo lo stesso aspro confronto tra una visione funzionale e profetica da una
parte ed una ontologica e cultuale dall’altra, con la concezione pastorale ancora in
sordina. Il Concilio, è vero, aveva tracciato una dottrina equilibrata del ministero
ordinato, coniugando i tre modelli attraverso lo schema dei tria munera ricondotti
alla loro radice sacramentale. E questo risultato, come si è appena detto, era stato
raggiunto non come soluzione salomonica, ma come esito di una rilettura ampia
della Scrittura e delle Tradizione a partire dalle istanze di situazioni concrete. Il
Vaticano II aveva potuto quindi offrire, specialmente attraverso PO, un quadro
approfondito, sereno e non polemico, documentato e radicato nelle fonti, della
natura e missione del ministero presbiterale.
Con il Vaticano II sembrava così raggiunta una felice sintesi fra i diversi modelli
che per secoli erano stati contrapposti o giustapposti: eppure sei anni dopo la
chiusura del Concilio papa Paolo VI sentì il bisogno di celebrare un Sinodo sul
sacerdozio ministeriale. Il clima di contestazione e dissenso costituì un nuovo
scenario nel quale ancora una volta veniva interrogata la dottrina, e in maniera –
come abbiamo visto – molto radicale.
Al Sinodo del 1971 più che le teologie del ministero si confrontarono le
ecclesiologie. Da una parte vi era chi – portavoce H. Küng – domandava di portare a
compimento la riforma iniziata dal Vaticano II, accettando una interpretazione
democratica della Chiesa (Küng in un libretto del 1971 sul prete la definiva
comunità di uguaglianza, libertà e fraternità); sul versante opposto, chi aveva mal
digerito l’ecclesiologia conciliare del “popolo di Dio”, reagiva riaffermando quella
visione di Chiesa come “corpo di Cristo” che il Concilio aveva accolto ma
relativizzato, o addirittura quella precedente di Chiesa come societas perfecta, che il
Concilio aveva lasciato da parte, almeno in quei termini. Nella prima concezione
ecclesiologica, il ministero non è altro che espressione della comunità ed ha la
funzione di leadership, coordinando i carismi e presiedendone l’annuncio e le
celebrazioni su delega dal basso; nella seconda concezione, al contrario, il ministero
nasce dall’alto ed ha la funzione di trasmettere la grazia che da Cristo scende verso
la Chiesa; volentieri il sacerdote è qui definito, secondo l’uso preconciliare,
“mediatore” e “alter Christus”.
Il Sinodo del 1971 percorse una via media tra questi due estremi, e – sulle piste
del Concilio – evitò di cadere in una visione di Chiesa come democrazia o come
monarchia assoluta, proponendo invece una concezione ecclesiologica che, pur
tenendo conto di tutte le istanze “dal basso”, riaffermò la natura teandrica della
Chiesa, irriducibile ad ogni schema di tipo civile (democrazia, monarchia...). La
Chiesa dipende essenzialmente da Cristo, suo capo – nel documento sinodale l’idea
della Chiesa come corpo di Cristo ha maggiore spazio rispetto a LG – e la coscienza
di questa radicale dipendenza è condizione essenziale per la sua vita: se la Chiesa
perdesse la consapevolezza di ricevere da Cristo tutto quanto le è necessario per
vivere e operare - la parola, i sacramenti, i doni dello Spirito – perderebbe la sua
stessa natura di “Chiesa”, cioè comunità radunata dall’alto, corpo di Cristo Capo. Il
Sinodo, adottando questa visione ecclesiologica, collocò il sacerdozio ministeriale
nel punto d’unione tra la Chiesa e Cristo: come ministero di Cristo Capo della
Chiesa, è a servizio della sua edificazione, è uno degli strumenti che la mantiene
nella consapevolezza di dipendere dal suo Signore. Ecco dunque la risposta alla crisi
di identità teologica: il ministero ordinato ha come ragion d’essere la testimonianza
efficace della priorità della grazia Cristo Capo, Profeta, Sacerdote e Pastore, che
continua ad edificare il suo corpo che è la Chiesa. La stessa idea fu ripresa vent’anni
dopo da Giovanni Paolo II nell’Esortazione Pastores dabo vobis (in particolare al n.
16), che raccolse e rilanciò quanto emerso nel Sinodo del 1990 sui presbiteri. Questa
è la risposta costante del Magistero post-conciliare alla domanda sulla natura
teologica del ministero sacerdotale.
La Pastores dabo vobis dichiarò conclusa la crisi di identità teologica, e dopo più
di vent’anni le si può dare sostanzialmente ragione. Uno sguardo alla bibliografia
conferma che dopo l’esplosione di studi degli anni settanta e ottanta, la teologia del
ministero raggiunse dagli anni novanta una certa pacificazione. Si è aperto tuttavia
un altro fronte della crisi – quasi un contraccolpo tardivo di quella post-conciliare –
che si potrebbe indicare come crisi di identità “pastorale”. Questo nuovo tornante
non riguarda più tanto le domande radicali sulla ragion d’essere teologica del
ministero, ma ruota attorno alla sua configurazione pastorale. Se la crisi di tre
decenni fa si può paragonare a un’alta montagna che si vede da lontano, questa
sembra piuttosto un iceberg, emergente solo in piccola percentuale, ma presente
sott’acqua in maniera consistente: allora il numero elevato di coloro che lasciavano
il ministero, spesso in maniera provocatoria, faceva notizia e creava un clima
acceso; ora invece il numero di coloro che lasciano il ministero è grazie a Dio molto
più contenuto, la gestione della crisi è più riservata e spesso non conduce
all’abbandono; rimane tuttavia un clima di sottofondo a volte pesante tra i presbiteri,
specialmente giovani, che poco tempo dopo l’ordinazione già sembrano in alcuni
casi pastoralmente rassegnati. Bisognerebbe senza dubbio cercare le cause in
direzioni diverse, come: la fragilità psicologica e affettiva del mondo giovanile, più
capace forse di slanci generosi e meno di donazione costante; la complessità e
frammentarietà della nostra cultura, nella quale è così difficile orientarsi, discernere
il bene dal male e mantenersi fedeli al Vangelo; la fatica di molti Seminari ad
impostare percorsi di formazione che da una parte evitino il ritorno a modelli
cultuali e sacrali e dall’altra parte evitino l’accomodarsi borghese ai venti culturali
più alla moda. Ma forse il perno attorno a cui ruota un certo malessere è una causa
precisamente “pastorale”, che rende oggi più attuale di alcuni decenni fa la dottrina
di PO e ne mostra più chiaramente il carattere equilibrato.
Il quadro pastorale, che ci è stato più volte autorevolmente richiamato dagli
ultimi pontefici e ora con particolare forza da papa Francesco, richiede ormai
decisamente il passaggio da una Chiesa che conserva se stessa a una Chiesa
missionaria. Il passaggio è in atto da decenni, ma non è facile. I presbiteri sentono
tutta la responsabilità di questo passaggio e qualche volta si trovano in grave
difficoltà, fino ad aprire veri e propri spazi di crisi, che sono la porta per la ricerca di
compensazioni e alternative. Il Concilio aveva indicato nella triplice relazione – con
il vescovo, il presbiterio e i laici – la trama adeguata per affrontare le sfide della
missione da parte dei presbiteri. Ora possiamo dire con chiarezza che se un
presbitero va in crisi, non è più normalmente a motivo della confusione o del dubbio
circa la sua identità teologica, ma a motivo del logoramento di alcune relazioni
ecclesiali: incomprensioni o mancanza di relazione con il proprio vescovo, rapporti
di bassa qualità nel presbiterio, tensioni e conflitti con i laici.
Se la qualità delle relazioni con i laici, gli altri presbiteri e il vescovo è buona –
pur nelle inevitabili e per certi aspetti necessarie tensioni – è più difficile che
rimanga aperto uno spazio per una crisi profonda. Sembra quindi che la radice di
quella che anche oggi si può chiamare “crisi” – crisi pastorale – dipenda da qualche
relazione ecclesiale vissuta in modo inadeguato dal presbitero. Se questa analisi è
plausibile, allora l’attenzione si rivolge nuovamente alla dimensione ecclesiologicopastorale del presbiterato, e non tanto su quella cristologico-sacramentale. Ora, la
dimensione ecclesiologica, come si è visto, era stata precisamente messa a fuoco dal
Vaticano II, soprattutto in PO: per questo la dottrina conciliare si presenta oggi
nuovamente come un aiuto per affrontare e superare la crisi. Credo quindi che il
rilancio della visione offerta dal Concilio sui presbiteri sia urgente. Una buona
integrazione tra i ministeri dell’annuncio, della liturgia e della guida pastorale – che
eviti di ridurre il servizio presbiterale ad uno solo di essi – può vincere quel senso di
frammentazione che spesso fa da sottofondo alle crisi. Un’esperienza comunitaria,
che – prendendo o meno la forma della coabitazione – favorisca lo scambio, la
preghiera e l’amicizia, può vincere quel senso di solitudine e autoreferenzialità che
talvolta rappresenta la base per la maturazione delle crisi. E infine un equilibrio tra
contemplazione e azione, che eviti le due sponde estreme dell’intimismo e
dell’attivismo, può vincere quel senso di pesantezza pastorale che può aprire lo
spazio per le crisi. PO, a cinquant’anni dalla sua promulgazione, è dunque un
documento ancora in parte da recepire e anche per questo pienamente attuale.