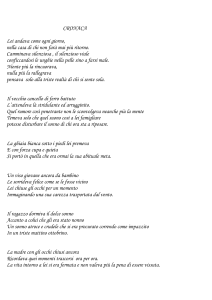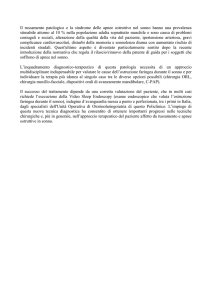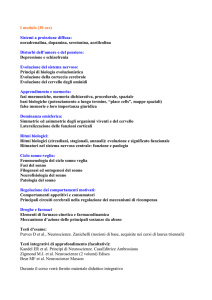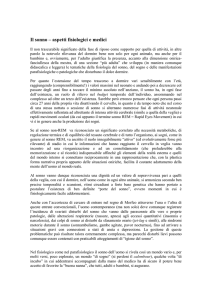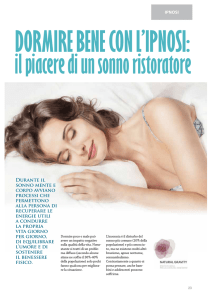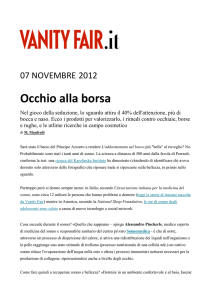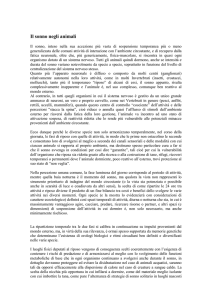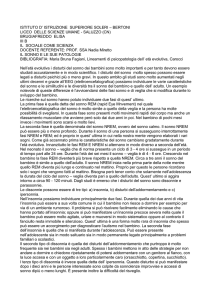LAURA BEANI- in: Sogno e Sogni. Natura, Storia, Immaginazione (a cura di
M.Bresciani). Olschki, 2005: 155-161
Animali che sognano: ipotesi sul valore adattativo dei sogni
Gli animali hanno una vita onirica? Chi ha osservato il cane o il gatto di casa
mugolare nel sonno, fare le fusa, agitare le zampe come se inseguisse una preda o
giocasse con un immaginario gomitolo, certo risponderà di sì. Ma se è difficile
esplorare il mondo dei nostri sogni, che pure abbiamo a disposizione carta e penna
per annotarli al risveglio ed esperti con cui analizzarli, come riuscire a indagare i
sogni degli animali e quindi fare ipotesi su un loro possibile ruolo? Fare domande
agli animali richiede la messa a punto di un contesto sperimentale dove, variando un
parametro, si registrano modificazioni misurabili del comportamento. Ma la variabile
“sogno” non è facile da controllare. Come distinguere sogno da sonno? Come
deprivare dell'uno senza toccare l'altro? Esistono poi evidenze non aneddotiche su
una vita onirica negli animali?
Eppure l’approccio comparato, anche se complesso, deve essere tentato perché
permette di avanzare ipotesi sull’evoluzione dei sogni negli animali e nell’uomo, su
una loro possibile funzione adattativa, se si considera anche l’attività mentale come
possibile oggetto di selezione naturale. La stessa ipotesi non adattativa – il sogno
come residuo dell’intensa attività mentale diurna nel sonno dell’animale culturale
per eccellenza, Homo sapiens – può essere valutata anche in base alla capacità di
sognare rilevata in animali più o meno evoluti.
Ma prima di affrontare la filogenesi del sogno, può essere utile delineare una
grammatica minima del sogno. Henri Pieron (1913) definisce il sonno come un
cambiamento necessario, periodico e ritmico dell’attività del cervello, che nel sonno
interrompe le sue connessioni con l’ambiente. Il sonno era considerato un fenomeno
‘passivo’, una sospensione dello stato di veglia, fino a quando Eugene Asenrinsky e
Nathaniel Kleitman (1953) annunciarono su Science la scoperta del sonno REM
(Rapid Eye Movement). Nei laboratori del sonno, la registrazione del movimento
oculare a palpebre abbassate, combinata con quella del tono muscolare e della
fluttuante attività elettrica di popolazioni di neuroni (EEG=elettroencefalogramma)
rivela nell’uomo, ma anche in altri mammiferi e negli uccelli, una complessa
architettura del sonno. Si alternano periodicamente fasi di sonno nREM (lievi
movimenti del bulbo oculare, movimenti involontari e riflessi della veglia intatti,
EEG con onde lente e ad ampio voltaggio) e REM (ampi movimenti oculari, perdita
del tono muscolare e della capacità di movimento - contrazioni facciali a parte -,
EEG con onde rapide a basso voltaggio, simili allo stato di veglia). Con sogno
s'intende comunemente il sonno REM, con tutte le cautele di questo approccio
volutamente semplificato: una paralisi del corpo accompagnata da un'attivazione del
sistema visivo, in assenza di stimoli esterni.
Nel sonno di rettili, pesci e molti invertebrati non si registrano chiare fasi
1
REM, che si manifestano invece negli endotermi, i cosiddetti animali a sangue
caldo, e si associano ad una corteccia cerebrale sviluppata (Hobson 1989; Jouvet
1975). La proporzione di fasi REM e nREM negli uccelli e nei mammiferi riflette
l’età, lo stile di vita, e la maturità alla nascita, ma non altrettanto chiaramente le
parentele filogenetiche o il processo di encefalizzazione (Siegel 2001). Nidiacei e
cuccioli dormono più degli adulti, soprattutto se nascono immaturi: un gattino di una
settimana trascorre in fase REM il 90% del tempo. Prede facili hanno brevi fasi
REM, dormono a intervalli e complessivamente meno dei carnivori o di animali di
grossa taglia, che presentano fasi consistenti di sonno REM (Siegel 1995). Specie
molto immature alla nascita tendono a conservare anche da adulti lunghe fasi REM.
Tra i mammiferi il campione di sonno REM è l’ornitorinco (8 ore di sonno REM su
un totale di 14), un mammifero primitivo che depone le uova, allatta a lungo i piccoli
e presenta una corteccia cerebrale poco sviluppata. Nell’opossum, un marsupiale che
partorisce piccoli molto immaturi, le fasi REM rappresentano un terzo delle sue 18
ore di sonno.
L'evoluzione di un sistema sociale, di una comunicazione elaborata, di una
capacità a risolvere problemi complessi, non si accompagna ad un aumento del sonno
REM. “Animals with high amounts of REM sleep are not those generally
considered to be the most intelligent” (Siegel 2001). Balene e delfini, che hanno
uno dei più elevati rapporti encefalo/massa corporea, grandi prestazioni intellettive
ma partoriscono piccoli già maturi, hanno fasi REM molto ridotte o assenti: solo 10
minuti su 10 ore di sonno nel delfino naso a bottiglia (Tursiops truncatus), con bassa
frequenza di movimenti oculari e un emisfero per volta in fase REM.
La specie umana, relativamente matura alla nascita, si colloca in una posizione
intermedia tra i sognatori. Presenta 2 ore di sonno REM (in 4-5 intervalli) su 8 ore di
sonno: poco più che una cavia o un babbuino (un’ora di sonno REM su 9-10 ore
complessive). Le fasi REM occupano il 20-25% del sonno di un adulto, più del 35%
del sonno nel neonato e durante la notte aumentano di durata. Se avete trenta anni
(11.000 giorni di vita), dormite otto ore per notte e sognate per due ore, avrete
sognato dalla vostra nascita circa 1000 giorni, cioè due anni e mezzo! E’ abbastanza
logico cercare una spiegazione per questa imponente attività mentale, che non è
prerogativa della nostra specie. Non siamo i soli animali che sognano, se s'identifica
il sogno con il sonno REM.
In una rassegna sul tema comparsa recentemente su Science (2 Novembre 2001,
“Sleep, Dreams & Memory”), alle tradizionali funzioni del sonno come risparmio
energetico (dormendo si consuma meno ossigeno, soprattutto in fase REM),
“rigenerazione” dei tessuti (è più veloce ad esempio la riparazione delle cellule della
pelle), ipometabolismo e termoregolazione, regolazione del sistema endocrino e dei
livelli di neutrasmettitori, si affianca l’ipotesi di un ruolo centrale del sonno – e del
sogno - nell’apprendimento inteso come consolidamento della memoria (Maquet
2001). Le tracce mnemoniche recenti verrebbero riattivate, analizzate e incorporate
nella memoria a lungo termine grazie ad eventi molecolari a cascata che inducono
2
modificazioni sinaptiche durature. L'apprendimento è un processo continuo nella vita
degli animali, uomo incluso, e il suo valore adattativo è evidente. I processi
mnemonici notturni sono un buon candidato per attribuire un valore funzionale ai
sogni.
Una recente tecnica d'indagine è la registrazione in vivo dell'attività
neuronale in stato di veglia e di sonno. Se ad attivarsi - di notte e di giorno - sono i
neuroni deputati ad un comportamento specifico, si apre la possibilità di esplorare il
contenuto stesso dei sogni. Nell'uomo si può visualizzare l'attività di specifiche aree
neurali con la PET (Tomografia a Emissione di Positroni) e altre tecniche non
invasive, e vedere se le stesse aree sono attive nel test e durante il sonno seguente,
nella fase REM e nREM (Maquet 2001). Negli animali si ricorre a microelettrodi che
permettono di registrare a lungo in un tracciato l'attività elettro-chimica di singoli
neuroni .
Il canto in molte specie di uccelli è il risultato di un’interazione tra componenti
genetiche e apprendimento per prove ed errori (Margoliash 2001); proprio perchè è
un modello ben conosciuto (una rete di nuclei telencefalici che mandano impulsi alla
siringe, l’organo fonatorio), può essere utilizzato per studiare cosa avviene nel sonno.
Nel diamante mandarino (Taeniopygia guttata) Dave e Margoliash (2000) hanno
registrato l’attività di singoli neuroni di un nucleo telencefalico del controllo del
canto, il nucleo RA, che si eccitano e inviano impulsi nervosi subito prima di
articolare le singole note (attività premotoria). Durante il sonno questi neuroni si
eccitano spontaneamente: si registra un tracciato sovrapponibile a quello prodotto di
giorno dagli stessi neuroni, durante le prove di canto. Anche il playback del proprio
canto - ascoltato durante il sonno - provoca la ripetizione dello stesso tracciato.
Dunque il sonno influenzerebbe l’attività coerente e sincronizzata di neuroni
nei nuclei del canto: di notte il diamante mandarino ‘si ripassa’ il canto! La
spontanea attività notturna dei neuroni RA suggerisce una possibile "selezione
durante il sonno delle memorie dei canti provati di giorno" (Dave & Margoliash
2000). Non a caso i periodi di rapido apprendimento di nuove melodie avvengono il
giorno successivo all'addestramento, solo dopo che gli uccelli hanno dormito.
L'ipotesi che il sonno REM abbia un ruolo nel programmare il comportamento è
sostenuta dalla sua maggiore durata nelle prime fasi di vita, anche se in questo studio
sul diamante mandarino - come purtroppo in molti altri (Siegel 2001) - non viene
distinto il sonno REM e nREM .
Uno studio simile è stato condotto in ratti di laboratorio addestrati a compiere
un percorso circolare. Neuroni dell'ippocampo attivati da compiti spazio-motori, le
cosiddette place cells, si attivano nella stessa sequenza e con la stessa intensità
mentre il comportamento spaziale viene attuato e nel sonno successivo al test, sia
durante la fase nREM (Wilson & McNaughton 1994) che nella fase REM (Louie &
Wilson 2001). Dormendo, in questo caso si può aggiungere sognando, i ratti
continuano ad aggirarsi nello stesso labirinto, voltando a destra o a sinistra:
ripassano i percorsi appena imparati, proprio come gli uccelli le diverse melodie.
3
Queste registrazioni dell'attività neuronale hanno un’influenza trascurabile sul
comportamento, certo minore della somministrazione di farmaci che sopprimono il
sonno o anche soltanto la fase REM, o rispetto alla tradizionale "tecnica della
piattaforma": poichè solo nel sonno REM si ha la completa atonia muscolare, i ratti
vengono confinati in piccole piattaforme galleggianti, e si svegliano al contatto con
l'acqua solo quando assumono la postura rilassata del sonno REM, con un'inevitabile
interferenza di livelli di stress molto elevati. Ancora più pesante è il ricorso a microlesioni in aree cerebrali coinvolte nei processi del sonno, anche se proprio con questa
tecnica Jouvet, in uno studio pionieristico all'inizio degli anni '60, osservò gatti in
pieno sonno REM fare i movimenti istintivi della caccia al topo, una volta liberati
dalla paralisi motoria associata alla fase REM.
Il disegno sperimentale per valutare l’effetto del sogno sulla memoria è
insomma molto diversificato, ma i risultati rimangono "frammentari" (Maquet 2001),
"deboli e contradditori” (Siegel 2001). Se dopo un'esperienza di studio intensivo
veniamo svegliati mentre stiamo sognando, in meno del 10% dei casi i nostri sogni
conservano traccia di quanto appena imparato (Stickgold et al. 2001), anche se un
apprendimento intensivo si associa a un cambiamento nell’architettura del sonno:
aumenta proprio la fase REM. "I sogni probabilmente riflettono l'attivazione e la
ricombinazione di memorie. Ma quali sistemi di memoria siano attivati rimane
incerto" (Stickgold et al. 2001): vengono elaborate tracce mnemoniche di episodi
recenti o memorie di tipo associativo? Nonostante l'indagine sia arrivata a livello di
singoli neuroni, l'effettivo ruolo della fase REM nel consolidamento della memoria è
ancora materia di dibattito.
Ma allora, a cosa servono i sogni? Una recente panoramica sulle funzioni del
sogno si ritrova nelle pagine di Owen Flanagan (2000), filosofo della mente,
psicologo sperimentale e neurobiologo. Accanto alle ipotesi funzionaliste che
associano sogno e memoria - come stabilizzazione mnemonica delle tracce utili nel
modello di Allan Hobson (1988); come brain-washing, indebolimento di alcune
associazioni per consolidarne altre nel modello di Francis Crick e colleghi (1983,
1985) -, Flanagan ridiscute brevemente la funzione dei sogni in termini di
"psicologia del profondo" ("sogni progettati per esprimere e/o rivelare i nostri
pensieri, sentimenti, desideri e bisogni più profondi") e "teoria della mente", e finisce
poi per aderire all'ipotesi non adattativa: "i sogni sono un rumore di fondo, senza
una specifica funzione evolutiva", che esiste invece nel sonno. "Forse i sogni sono
un prevedibile effetto collaterale della selezione che si verifica in creature
progettate per avere e utilizzare le loro esperienze nello stato di veglia, che
continuano ad avere esperienze anche quando la luce si è spenta, esperienze che, nel
sonno, non accrescono nè diminuiscono le capacità adattative individuali" (p.25).
Contro ogni rischio di adattazionismo, Flanagan riprende la fortunata
immagine di Gould e Lewontin (1978) sui "pennacchi d'arco", quello spazio chiuso
tra archi e chiavi di volta che ha finito per assumere un'altra funzione architettonica,
decorativa oltre che portante. "Ma noi, a differenza degli animali, abbiamo scoperto
4
e inventato delle funzioni per i nostri sogni. Abbiamo fatto con i sogni ciò che
abbiamo fatto con i pennacchi d'arco. Abbiamo imparato a utilizzarli in una varietà
di modi utili, creativi e fantasiosi" (p. 49). I sogni, conclude l'autore, "sono
importanti fattori di auto-espressione, di costruzione della propria identità, sorgenti
di auto-conoscenza" (p. 175) e infine "evolutivamente gratuiti. Questa non è una
cattiva notizia: alcune delle cose migliori della vita sono gratis" (p. 263). Una
visione questa che non esclude un ruolo dei sogni anche nei processi di
apprendimento degli animali!
Bibliografia
Aserinsky E., Kleitman N. Regularly occurring periods of ocular motility and
concomitant phenomena during sleep. "Science" 118: 273-74, 1953.
Crick F., Koch C. Are we aware of neural activity in primary visioual cortex?
"Nature": 121-23, 1995.
Crick F., Koch C., Michison G. The function of dream sleep. "Nature", 304: 111-14,
1983.
Dave A.S., Margoliash D. Song replay during sleep and computational rules for
sensorimotor vocal learning. "Science" 290: 812-816, 1998.
Flanagan O. Dreaming souls: sleep, dream and the evolution of the conscious mind.
New-York, Oxford Univ. Press., 2000 (trad. it. Anime che sognano. Il sonno e
l'evoluzione della coscienza. Roma, Editori Riuniti, 2000).
Gould S.J., Lewontin R.C. The spandrels of San Marco and the Panglossian
paradigm: a critique of the adaptionist programme. "Proc. Royal Soc. Lond.",
205: 581-98, 1978.
Hobson J.A. The dreaming brain. New York, Basic Books, 1988 (trad. it. La
macchina dei sogni. Come si creano nel cervello il senso e il non senso del
sognare. Firenze, Giunti, 1992).
Hobson J.A. Sleep. New York: Scientific American Library, 1989.
Jouvet. M. The function of dreaming: a neurophisiologist's point of view. In:
Gazzaniga M.S., Blackemore C. eds, Handbook of psychobiology. NewYork:
Academic Press, 499-527, 1975.
Louie K., Wilson M.A. Temporally structured replay of awake hippocampal
ensemble activity during Rapid Eye Movement sleep. "Neuron", 29: 145-156,
2001.
Margoliash D., You say tomato and I say to-mah-to. "Science", 291: 2559-61, 2001.
Maquet P. The role of sleep in learning and memory. "Science", 294: 1048-52, 2001.
Pieron H., Le problem physiologique du sommeil. Paris, Masson, 1913
R.Stickgold, J.A.Hobson, R.Fosse, M.Fosse. Sleep, learning and dreams: off-line
memory reprocessing. "Science", 294: 1052-57, 2001.
Siegel J.M., Phylogeny and the function of REM sleep. "Behav. Brain Res.", 69: 2934, 1995.
5
Siegel J.M., The REM sleep-memory consolidation hypothesis. "Science", 294: 105863, 2001.
Wilson M.A., Mc Naughton B.L. Reactivation of hippocampal ensemble memories
during sleep. "Science", 265: 676-79, 1994.
6