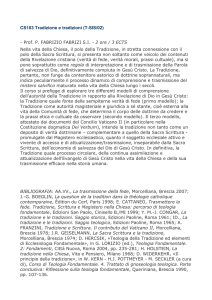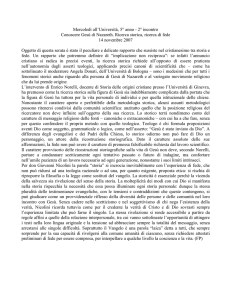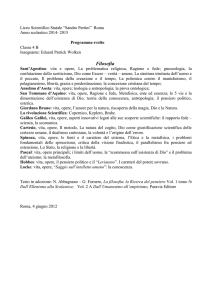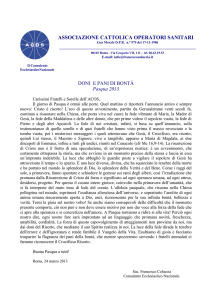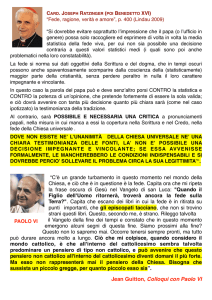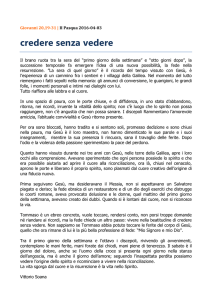1
10 aprile 2008
HANS URS VON BALTHASAR E LA SEMPLICITÀ DELLA FEDE
Il testo si presenta nella versione originale e provvisoria.
Sarà rivisto e annotato per la successiva pubblicazione.
Partiremo dall’occhio – il semplice occhio o, meglio, l’ “occhio semplice” – per parlare di un
teologo che incute spontaneo timore quando lo si affronta. Se si guarda la mole dei suoi scritti (30 i
volumi previsti per l’Opera omnia pubblicata dalla Jaca Book, che lascia fuori, peraltro, non pochi
lavori), se si considera con un colpo d’occhio l’organizzazione della sua trilogia (Gloria,
Teodrammatica, Teologica), se si scorre l’indice di qualcuno di questi tomi (per esempio il primo
volume di Gloria. Una estetica teologica, intitolato Percezione della forma), se si legge un
qualunque capitolo, si rimane impressionati dalla lucidità del disegno, dalla vastità degli orizzonti,
mentre si è come sommersi dal fiume in piena della sua prosa (la prosa di un teologo che proviene
da studi letterari, un teologo che coltiva la passione per la poesia e per la musica), si è quasi travolti
dalla cultura sconfinata di questo studioso, realmente enciclopedico, che sa passare con accorta
disinvoltura dalla Bibbia a Goethe, da Agostino a Heidegger, da Omero a Dostoevskij.
Come non distogliere l’occhio? Come vincere l’imbarazzo? Come introdursi in una personalità
teologica di questa portata, in uno stile teologico personalissimo, ma proprio per questo difficile da
affrontare in principio?
Occorre avere un occhio particolare anche per leggere von Balthasar, un occhio che – tanto per
cominciare - sappia mantenersi puntato al centro e lasci sfumare all’intorno gli infiniti particolari, in
attesa semmai di recuperarli in seguito e di armonizzarli con quel centro. Ne è consapevole lo stesso
B., che in uno dei lavori che considereremo scrive di aver aggiunto dei chiarimenti che «nel
contenuto e nella forma sono un po’ più impegnativi ed illuminano aspetti particolare del tema
centrale. I lettori che trovano risposta alle loro domande nel testo principale non devono rompersi la
testa con le questioni dell’appendice». Ma anche così all’inizio non si è aiutati moltissimo, a meno
che – ed è questo il mio consiglio e la ragione che mi ha guidato nella scelta del tema, un tema
insospettabilmente antico e teologicamente nobilissimo – non si cominci da brevi saggi o dai
cosiddetti Scritti minori del teologo di Basilea (1905-1988). Il vantaggio è duplice: la loro mole non
è smisurata e, in secondo luogo, vale anche per questi lavori, più contenuti nelle pretese, quello che
suggerisce un famoso titolo di B., Il tutto nel frammento: anche da questi scritti si può cogliere il
tutto e il centro di questo tutto, cui sempre lo studioso rimanda.
2
Tre di questi saggi o scritti minori trattano direttamente il tema della semplicità della fede. E sembra
un paradosso per un teologo così complesso. Si tratta de La fede dei semplici del 1967 (pubblicato
dapprima con il titolo La fede dei poveri su una rivista), di Con occhi semplici. Verso una nuova
coscienza cristiana del 1969 (ma in tedesco il titolo è altra cosa: Einfaltungen. Auf Wegen
christlicher Einigung – traducibile con Riduzioni all’uno. Sulle strade dell’unificazione cristiana),
per finire con La semplicità del cristiano del 1983.
Da quest’ultimo scritto partiamo per il nostro percorso in 4 tappe:
1. L’occhio semplice
2. Semplici e dotti
3. Gli occhi della fede e l’estetica teologica
4. La semplificazione/unificazione della teologia e della vita.
1. L’occhio semplice
L’espressione è genuinamente biblica, più precisamente evangelica, ma non ce ne accorgiamo a
prima vista, perché si trova occultata dalla nostra traduzione corrente di Lc 11,34 che recita: «La
lucerna del tuo corpo è l’occhio. Se il tuo occhio è sano [anziché, come in greco: haploûs,
semplice], anche il tuo corpo è tutto nella luce; ma se è malato [anziché: poneròs, malvagio], anche
il tuo corpo è nelle tenebre».
Questa curiosa espressione di Gesù, insieme con l’altro grido di esultanza che riguarda sapienti e
piccoli in Lc 10,21, fa da sottofondo a molte osservazioni di B. sul nostro argomento. Scrive
l’Autore: «Già nell’Antico Testamento compare in parecchi passi il termine che sta per ‘semplicità’
(haplotes, haplous, haplos), nel senso di rettitudine, semplicità, sincerità (così ad esempio in 1 Cr
29,17; Sap 1,1; Pr 11,25; 1 Mac 2,60), ed in questo senso anche Gesù richiederà che l’occhio
dell’uomo sia ‘semplice’, si potrebbe dire ‘trasparente’, affinché in virtù della sua limpidità anche
tutto l’uomo sia luminoso. Ma già qui si fa visibile qualcosa di caratteristico: l’occhio, dice Gesù, “è
la lucerna del corpo” (Lc 11,34; Mt 6,22), ma è lucerna non in quanto irraggia egli stesso luce, ma
in quanto è interamente trasparente, in semplicità, per la luce. L’accento scivola pian piano da una
virtù propria dell’uomo ad una apertura e disponibilità a lasciar entrare la ‘virtù’ della luce che
proviene dal mondo e da Dio. Precisamente in questo passaggio sta quella contrapposizione messa
in luce da Gesù tra i “sapienti e furbi”, ai quali la rivelazione del Padre resta nascosta e
incomprensibile, e i “semplici” o “piccoli” (nepioi), ai quali, secondo il beneplacito di Dio, si
rivolge la rivelazione (Mc 11,25; Lc 10, 21)».
3
L’occhio dei semplici o l’occhio semplice è semplicemente aperto a quel che si rivela. Mentre
sapienti e furbi comprendono solo per categorie e per schemi, filtrano ciò che si fa loro incontro e
accantonano o lasciano fuori l’incomprensibile, i semplici non selezionano «la rivelazione di Dio in
base a comprensibile e incomprensibile», ma la lasciano irrompere nella sua interezza, assumono «il
tutto della luce». L’occhio semplice è «quello che è in grado di aprirsi totalmente alla luce e di
afferrare la totalità della figura che gli si offre».
Il tutto, la totalità della figura, perché la rivelazione che si dà non si lascia scomporre in
comprensibile e incomprensibile. E’ piuttosto “più che comprensibile”, suggerisce un sempre di più
nel cammino che la conoscenza deve compiere. Ed è così che si intendono la strana affermazione di
Paolo, contraddittoria all’apparenza: «conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza»
(Ef 3,19); o la parola detta da Gesù ai suoi, che erano semplici pescatori: «A voi è stato dato di
conoscere i misteri del Regno dei cieli». Ma allora si conosce o non si conosce? Sono misteri o non
sono misteri? Questa conoscenza che è anche non-conoscenza dipende dal mistero stesso, che ha
aspetti luminosi e aspetti nascosti, quelli che mantengono aperto il desiderio di conoscere ancora. Il
“di più” va ancora cercato, come suggerisce Agostino scrivendo: «Dio è immenso, perché una volta
trovato lo si cerchi».
L’occhio semplice è dunque l’occhio semplicemente disponibile alla rivelazione. L’uomo semplice,
di fronte al quale Gesù gioisce secondo i Vangeli, è il semplicemente disponibile, che prende vari
nomi: è il povero o il mite delle beatitudini, è il bambino che il discepolo deve diventare per entrare
nel Regno (il bambino che si affida ad altri, come l’occhio alla luce o alla figura intera), è il Figlio
che volentieri e non da servo obbedisce al Padre.
In confronto a questo elogio della semplicità cha a volte pare sconfinare nel candore, sconcerta
l’altro elogio rivolto nei Vangeli all’amministratore disonesto, lodato per la sua scaltrezza. Com’è
possibile mettere insieme semplicità e scaltrezza? Lo chiarisce Gesù stesso altrove: «Siate astuti
come serpenti e semplici come colombe» (Mt 10, 16). La semplicità non è unicamente candore, non
è affidamento di sé indiscriminato. E’ piuttosto un “saper vedere” e, dunque, anche un saper vedere
correttamente le cose terrene. Nell’appendice dedicata a «Semplicità e tecnica» il teologo fa notare
che anche Paolo mette insieme, in un unico invito, semplicità dei bambini e maturità del pensiero,
carità semplice che tutto crede e tutto spera e conoscenza che sa vagliare e riconoscere ciò che è
buono.
Se forse ora semplicità e astuzia non ci sembrano più tanto contraddittorie, dobbiamo dire almeno
qualcosa sul rapporto tra questa semplice fede e il sapere. Nulla da fare per i sapienti? Bisogna
rinunciare a cultura e teologia in nome della semplice fede?
4
Non pare proprio e meraviglierebbe sentirselo dire da uno studioso coltissimo e teologo raffinato
come B.. E’ però cosa nota che spesso, nel corso della storia del cristianesimo, si è “utilizzata”
l’affermazione di Gesù per opporre la fede dei semplici e il sapere dei dotti. Da un lato, si è tentato
un elogio dell’ignoranza contro la superbia dei dotti (B. parla altrove di «fede fanatica dei
semplici»); dall’altro versante, si è spesso ironizzato sulla semplicità dei piccoli nella fede (per B. è
«l’arrogante presunzione gnostica dei saccenti»).
Già Paolo – ricorda B. - si accorge che esiste a Corinto questo pericolo ed esorta i sapienti a farsi
stolti pur di non provocare divisioni, a “sgonfiare” la propria scienza in nome della carità: «la
scienza gonfia, la carità edifica». Come dire che quanto più si cresce nel sapere, tanto più bisogna
custodire il centro della rivelazione, aggrapparsi all’unica vera sapienza cristiana come fa Paolo. Ed
è la sapienza della croce. Tutto il sapere che si accumula non deve mai oltrepassare l’atteggiamento
di fede; la crescita del sapere deve semmai rafforzare la fede e non può contraddire la carità.
Ma torniamo al nostro occhio. Abbiamo intuito che esiste un solo occhio per cogliere la rivelazione:
è l’occhio semplice o l’occhio che si semplifica man mano, adattandosi alla luce della rivelazione.
Solo occhi semplici hanno saputo riconoscere Gesù, che - si noti - è chiaramente colui che nella
misura più alta possiede l’occhio semplice capace di scrutare anche le profondità dei cuori e vive
quella semplicità della fede che perfeziona la già indivisibile fede di Abramo. Solo occhi semplici
hanno saputo vedere in Gesù un «richiamo a Dio, così enigmaticamente singolare» anche prima
della sua morte. Solo occhi semplici, disponibili a lasciar entrare anche l’incomprensibile, quel che
pare follia, hanno potuto interpetare la croce come pienezza, come «forza [potenza] e sapienza di
Dio». Lo testimonia di nuovo Paolo in un passaggio della Lettera ai Corinti, ricordato e commentato
da B. in questo modo: « Di fronte alla Croce non c’è alcuna soluzione mediana: essa è o “pura
follia” o “forza di Dio”, la quale però “distrugge la sapienza dei saggi e annulla l’intelligenza degli
intelligenti” (1 Cor 1, 18s.) … “Mentre i Giudei chiedono segni” per poter credere al loro Dio, e “i
Greci cercano la filosofia”, per giungere per mezzo di essa più vicini al divino, “noi annunciamo
Cristo crocifisso, per i Giudei uno scandalo, per i pagani una stoltezza”. Solo per coloro ai quali Dio
apre gli occhi semplici questo Cristo è “forza e sapienza di Dio”. “Egli è stato reso da Dio
sapienza”, più ancora: “giustizia (che ci porta nel giusto atteggiamento del patto di alleanza con
Dio), santificazione e redenzione, affinché avvenga ciò che sta scritto: Chi si vanta, si vanti nel
Signore” (1 Cor 1, 20-31). Le vie giudaiche e greche verso Dio, infatti, volevano tutte tracciarsi una
strada dall’uomo in direzione di Dio, mentre ora Dio stesso si traccia una strada incontro all’uomo,
tenendo conto degli ostacoli di questo incontro, evidenziando e allo stesso tempo spazzando via la
vanità dei tentativi umani, apparentemente saggi».
5
E conclude B., anche qui giunto alla Croce come al centro della fede cristiana: «Ancora una volta la
fede in una cosa simile può venir considerata come eccessivamente semplice o in contraddizione
con ogni esperienza. Ma con questa fede semplice sta o cade per il cristiano il senso della propria
esistenza e di ogni esistenza».
Abbiamo sin qui tratteggiato i contorni della questione. Abbiamo intuito almeno che c’è una
relazione anche tra la semplicità della fede di cui parliamo e la semplicità del cuore, che spesso la
tradizione cristiana ha tradotto come “purezza di cuore” o innocenza, con un certo accento persino
moralistico, mentre, nel senso originario e strettamente legato alla qualità della fede, è più
precisamente la “non-duplicità”, l’orientamento dell’unica persona all’unico Dio.
Abbiamo anche segnalato l’emergere precoce di una certa contrapposizione tra semplici e dotti
all’interno della comunità, che si traduce in seguito nella distinzione tra cristiani semplici e perfetti
o tra semplici e gnostici, già conosciuta nella comunità di Alessandria (caso citato anche da B.) ai
tempi di Clemente e Origene, e poi molto diffusa in taluni ambienti soprattutto orientali, in specie
monastici, e protrattasi con varie versioni fino ai giorni nostri.
Completo questo primo approccio con due considerazioni (sono il secondo e terzo dei capitoli
previsti): la prima ancora su cristiani semplici e dotti, perché ci aiuta ad avvicinarci alla peculiarità
della rivelazione e della fede cristiana secondo B.; la seconda che ho intitolato «Gli occhi della fede
e l’estetica teologica». Si tratta di due precisazioni importanti che ci avvicinano al nucleo dell’intero
progetto teologico di B.. Lo sfioriamo almeno, in una misura adatta ad una relazione introduttiva
come la mia.
2. Semplici e dotti
Nel saggio del 1967 che ho citato all’inizio, La fede dei semplici, B. sembra prendere la questione
molto alla larga. Della fede dei semplici, esplicitamente, parla solo nel quinto e ultimo paragrafo,
nel quale introduce il racconto della cosiddetta “fede del carbonaio”, ricavandolo da uno scritto
cinquecentesco di Albert Pigghe (Pighius, alla latina; B. ha il gusto dell’erudizione e lo vediamo
anche da questo dettaglio). Così B. riassume e commenta il racconto: «Quel celebre carbonaio, la
cui fede un professore di teologia volle mettere alla prova per suo diletto interrogandolo sugli
articoli di fede, dapprima seppe “recitare gli articoli più importanti su Dio, di cui aveva sentito
parlare più spesso in Chiesa”. Quando il teologo però continuò a insistere con lui, “quello si
contentò di assicurare che credeva tutto quello che la Chiesa crede”, e alla domanda che cosa
credesse la Chiesa “scantonò in una specie di circolo: la Chiesa crede ciò che io credo; io credo ciò
6
che la Chiesa crede”. Questa fede del carbonaio, assai rispettabile – senza dubbio, nella sua struttura
fondamentale, insediata molto più esattamente di quella del dotto scritturista che lo stava mettendo
alla prova – certo soffre soprattutto del fatto che nelle prediche udite da lui l’evento della croce e
della resurrezione non era stato presentato in misura sufficiente. Ma forse quell’uomo era
semplicemente troppo timido per lasciare in balia di questa erosione concettuale la celata intuizione
del suo cuore [pascaliano: il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce] e si proteggeva tra
le falde del manto di sua madre, la Chiesa».
Questa è la fede dei bambini e della gente semplice che viene lodata da Gesù. Precisa B.: «Essi sono
coloro che non sono gravati né distolti dalla loro rettitudine da parte di singoli concetti dotti, sono
quelli cui riesce più facile l’ingresso alla semplicità dell’evento di Cristo. Essi hanno ‘l’occhio
semplice’, che pone tutto nella luce. Quest’occhio semplice non è solo la condizione ottimale per
cogliere con lo sguardo la semplicità dell’evento di Cristo; è più in profondità l’affinità ottimale con
l’intimo atteggiamento di Cristo, con la sua obbedienza da fanciullo verso il Padre».
Se il cristianesimo fosse solo dottrina, non ci sarebbe più spazio né per celate intuizioni del cuore,
né per i semplici tanto amati da Gesù, né infine, paradossalmente, per Gesù stesso. Ed è questo il
punto, su cui insistono i primi quattro paragrafi – apparentemente fuori tema - del saggio che sto
ricordando: il primo («L’Antico Testamento») si apre con un’affermazione apodittica: «Nessuno
vorrà contestare che l’Antico Testamento non è una dottrina, ma una serie di eventi storici»; il
secondo («Cristo») esordisce con le parole: «L’evento di Cristo nel suo centro… è ancor meno di
esso una dottrina»; il terzo («Predicazione») parla dell’annuncio apostolico del Vangelo: «Questa
lieta novella … nella sua struttura è qualcosa di totalmente diverso dalla diffusione d’una dottrina».
Il quarto è il più impegnativo («La fede e la sua evidenza»): si tratta della bellezza non
scomponibile della rivelazione e della ragionevolezza della fede; ma ci basti leggerne l’esordio: «Se
la fede cristiana non è primariamente un tenere per vere proposizioni che sono proposte nella
predicazione, ma un afferrare l’evento, dal quale chi viene alla fede ogni volta è già stato afferrato,
allora essa è – pur se in modo rudimentale – un lasciarsi adattare alla forma di questo evento:
all’ubbidienza di fede di Cristo stesso».
La fede come essere afferrati e afferrare a propria volta l’evento, il fatto, che è la rivelazione stessa
di Dio compiutasi in Gesù Cristo: siamo vicinissimi al cuore dell’intero progetto di B., al cuore
della sua estetica teologica. Ci avviciniamo ancora un passo con la nostra precisazione ulteriore.
3. Gli occhi della fede e l’estetica teologica
7
Quando si parla di occhi della fede, il pensiero, anche il pensiero di B., corre a Pierre Rousselot,
geniale autore nel 1910 di un articolo con questo titolo, tradotto dal francese dallo stesso B. e più
volte da lui citato. L’idea degli occhi non è originale, come onestamente ricordano entrambi: è
Agostino a dire: «Certamente la fede ha occhi, e sono assai potenti, assai forti» e Tommaso gli fa
eco con la sua espressione «oculata fides». Per dare almeno un’idea di Rousselot, cito soltanto un
passaggio de Gli occhi della fede: «Nell’atto di fede, come l’amore è necessario alla conoscenza,
così la conoscenza è necessaria all’amore. L’amore, l’omaggio libero reso al bene supremo, dona
occhi nuovi. L’essere, reso più visibile, incanta colui che vede. L’atto è ragionevole perché l’indizio
percepito apporta alla nuova verità la testimonianza dell’ordine naturale; l’atto è libero poiché
l’uomo può respingere, se vuole, l’amore del bene soprannaturale… Da un lato l’uomo vuole un
bene, vi si ordina e così riveste una nuova natura (che lo fa vedere). È l’ordine della volontà.
Dall’altro lato lo spirito vede un fatto, lo interpreta come indizio e ne conclude una verità (che lo fa
vivere). È l’ordine dell’intelligenza. Ma qui non ci sono assolutamente due processi realmente
separabili: tutto è integrato nell’unità vivente di uno stesso atto».
È l’atto di fede, appunto. B. assimila Rousselot, come la gran parte della teologia del ‘900, in
particolare la teologia fondamentale, non più impegnata ormai in estenuanti dimostrazioni della
credibilità del cristianesimo, di Cristo o della Chiesa; necessarie certo, ma pur sempre inadeguate di
fronte alle crescenti obiezioni e al profondo desiderio di percepire la vita, qualcosa di più della sola
dottrina appunto, possibilmente l’evento che incanta, che attrae a sé, che converte a sé mente e
cuore e fa scattare la fede.
B. assimila evidentemente Rousselot, ma gli rimprovera una insufficienza. Rousselot «intuisce la
strada giusta», ma è ancora troppo kantiano, troppo preoccupato di chiarire le condizioni di
possibilità della conoscenza nel soggetto; un chiarimento necessario, ma ancora insufficiente e
talvolta persino a rischio di ridurre la portata della rivelazione. Rousselot è troppo attento alla
“evidenza soggettiva”, mentre in primo luogo emerge per B. una “evidenza oggettiva” della
rivelazione, emerge la «forza di Dio che esprime ed afferma se stessa nella sua testimonianza
storica. Nel vangelo la capacità di credere dei discepoli è completamente sostenuta e operata dalla
persona rivelatrice di Gesù».
Rousselot parla ancora di “segni”, di “indizi”. Occorre invece parlare di «forma» e di «percezione
della forma» della rivelazione, dove il termine “forma” (Gestalt) rimanda all’idea di bellezza, di
unità intima e indissolubile di ciò che si mostra, rimanda all’esperienza estetica, a
quell’incantamento che si prova, in maniera analoga, di fronte alla natura o ad un capolavoro. Nella
passata stagione della teologia si è badato troppo poco alla capacità che la bellezza della
rivelazione, la forza intima della forma che essa assume in Cristo hanno di rapire occhi umani,
8
portando con sé le condizioni per essere accolte e comprese. Si è prestata, insomma, scarsa
attenzione al darsi effettivo della rivelazione di Dio, che culmina nell’amore crocifisso: «Dio non ci
si manifesta primariamente come maestro (verità), come redentore che porta a compimento la
promessa (bene), ma si presenta a noi in sé, per mostrare la magnificenza abbacinante [gloria] della
sua eterna vita trinitaria, in quella “gratuità” che il vero amore ha in comune con la vera bellezza».
Bellezza diventa così la prima parola della teologia per B., persuaso che Dio si riveli appunto nella
gratuità, nella profusione di sé che è propria sia della bellezza sia dell’amore. Comprendiamo
perché l’apice di una tale bellezza ed il centro della teologia di B. non possano che essere la figura
di Cristo (il più bello tra i figli dell’uomo) e l’evento della croce.
Mi piace ricordare qui l’interpretazione che di B. ha dato Benedetto XVI nel Messaggio per il
Centenario della nascita di Hans Urs von Balthasar («L’Osservatore Romano», 8 ottobre 2005):
«Nella morte e resurrezione di Gesù viene rivelato in pienezza il mistero dell’amore trinitario di
Dio. La realtà della fede trova qui la sua bellezza insuperabile. Nel dramma del mistero pasquale,
Dio vive pienamente il farsi uomo, ma nel contempo rende significativo l’agire dell’uomo e dà
contenuto all’impegno del cristiano nel mondo. In questo von Balthasar vedeva la logica della
rivelazione: Dio si fa uomo, perché l’uomo possa vivere la comunione di vita con Dio […] Una
teologia così concepita ha portato von Balthasar a una profonda lettura esistenziale. Per questo uno
dei temi centrali sui quali si intratteneva volentieri era quello di mostrare la necessità della
conversione. Il cambiamento del cuore era per lui un punto centrale; solo in questo modo, infatti, la
mente si libera dai limiti che le impediscono di accedere al mistero e gli occhi diventano capaci di
fissare lo sguardo sul volto di Cristo».
Poche frasi che suggeriscono le articolazioni di fondo dell’opera di B., i titoli della sua trilogia
(Gloria. Una estetica teologia; Teodrammatica; Teologica) ed il suo impatto con l’esistenza.
Rivelazione e fede, dunque, rischiano per B. d’essere travisate se non se ne mantiene la forma, se le
questione della bellezza, dei sensi che la possono cogliere (nella tradizione sono i cosiddetti “sensi
spirituali”), del senso complessivo della fede (la “fede oculata” dei Vangeli, di Agostino, di
Tommaso, di Rousselot) vengono di nuovo lasciate da parte. Oggi più che mai. Perché, secondo B.,
la condizione odierna è sotto questo profilo preoccupante: «In un mondo senza bellezza – anche se
gli uomini non riescono a fare a meno di questa parola e l’hanno continuamente sulle labbra,
equivocandone il senso -, in un mondo che non ne è forse privo, ma che non è più in grado di
vederla, di fare i conti con essa, anche il bene ha perduto la sua forza di attrazione, l’evidenza del
suo dover-essere-adempiuto; e l’uomo resta perplesso di fronte ad esso e si chiede perché non deve
9
piuttosto preferire il male. Anche questo costituisce infatti una possibilità, persino molto più
eccitante».
Ritrovare la bellezza, anche la bellezza della rivelazione, per poter ritrovare la persuasività della
verità e del bene. Questo è il nocciolo dell’estetica teologica balthasariana, cui siamo giunti del tutto
spontaneamente partendo dall’occhio semplice, dall’occhio che si lascia catturare dalla bellezza
della forma intera. L’estetica teologica di B., comunque la sia interpreti, è una potente provocazione
a pensare e a mutare abitudini di pensiero e di vita. Qualche esempio in ordine a questo
cambiamento lo offre lo stesso B.. Siamo all’ultimo dei nostri capitoli.
4. La semplificazione/unificazione della teologia e della vita
Se la fede è lasciarsi adattare alla forma accolta, alla forma della rivelazione, allora è chiaro perché
la fede, come l’evento da cui è generata, non possa essere che semplice, unitaria e unificante,
raccolta intorno al centro della rivelazione. Una fede così formata spinge verso la semplificazione –
tutt’altra cosa dalla banalizzazione - del sapere, anche del sapere teologico, e della vita.
B. lo mostra con argomentazioni non facili nell’ultimo dei testi che abbiamo ricordato all’inizio,
vale a dire Con occhi semplici. Verso una nuova coscienza cristiana del 1969.
Per semplificarci a nostra volta la vita, però, e per abbreviare il percorso, cito in principio un
passaggio ancora da La semplicità del cristiano del 1983, che ben si lega a quanto abbiamo detto fin
qui: «Se la teologia cristiana vuol essere una “scienza” – e che Dio voglia comunicare a chi in Lui
crede anche un sapere è fuor di dubbio -, allora essa deve possedere un metodo adeguato al suo
oggetto e determinato a partire da lui. Una prima indicazione per un simile metodo la dà l’ “en
Christo” paolino, che ha il suo parallelo nell’immagine giovannea della vite e dei tralci: l’obiettività
della riflessione e dell’affermazione teologica esige che essa si svolga non in uno ‘stare l’uno di
fronte all’altro’ prendendo distanza, ma in un ‘in-essere’ ed ‘essere a partire da’. Così anche il
termine ‘oggetto’ è caratterizzato come problematico, poiché rinvia a una distanza che falsifica
l’autentico sapere teologico. L’affermazione di Gesù: “Chi non rimane unito a me, si secca” e
“senza di me non potete far nulla” è per il pensiero e l’affermazione teologici non meno importante
che per l’esistenza e per l’operare esteriore».
Non aggiungo altro quanto all’atteggiamento richiesto al teologo, alla forma della sua fede, in
questo del tutto simile alla forma della fede di qualunque credente. Anche la sua deve essere, in
fondo, una “semplice fede”, saldamente conformata a Cristo.
10
Preferisco limitarmi a indicare le semplificazioni/unificazioni che B. ritiene auspicabili e possibili
nell’organizzazione delle discipline teologiche e dire qualcosa circa la semplificazione/unificazione
della vita.
Quanto alle prime, è venuto il tempo per B. di “ripiegare”, di “ridurre all’uno” (einfalten) quanto è
stato dispiegato in passato. Rahner direbbe: passare da una teologia ulteriormente “esplicativa” ad
una teologia “riduttiva”, che lavori per concentrazione di contenuti, per riconduzione alla radici.
Cessando (l’immagine è nuovamente di B.) d’essere albero con sempre più rami, fronde e foglie.
Una tendenza, questa, che va peraltro – scrive B. – «in direzione opposta a quella che ogni pensiero
e tutte le aspirazioni religiose dell’umanità hanno preso da sempre: dalla molteplicità all’uno, all’
‘unico-necessario’». Se davvero quel che si è prodotto era «dispiegamento dell’uno, deve
necessariamente lasciarsi ridurre all’uno» (come la bambola giapponese – così in B., mentre noi
diremmo russa – che si lascia aprire sino all’ultima bambola minuscola, indivisibile e si lascia poi
richiudere, ritornando nuovamente una).
Si può ripiegare. Senza fughe precipitose dal passato, come quelle che B. lamenta (lo scritto è del
1969 – siamo nell’immediato post-concilio), ma passando invece attraverso «un serio travaglio del
pensiero» e riguadagnando in questo modo l’unità. Quale unità?
Ci basti qui indicare gli argomenti che B. affronta, prospettando non solo diagnosi sull’unità
perduta, ma piste per la ricomposizione in avanti: vanno ricomposte l’unità tra pensiero e vita
cristiana (teologia e spiritualità), l’unità delle discipline teologiche, l’unità dei cristiani (che non
possono giustificare le divisioni appellandosi ad un pluralismo delle teologie bibliche che si
suppone incomponibile) e, da ultimo, l’unità della nostra vita. Anzi, per prima cosa, perché –
osserva B. sin dall’esordio del saggio – non è sufficiente che ci «uniamo esteriormente; il problema
è se ci viene partecipata la grazia di unificarci anche nell’intimo».
Ed è qui che emerge con forza la singolarità della Rivelazione e della fede cristiana; è qui che si
scopre che solo quel Dio che si è fatto uomo in Gesù Cristo, «solo Lui è in grado di unificare la
nostra esistenza». Ora, scrive il teologo, «l’elemento cristiano appare nella sua solitudine e
incomparabilità assoluta. Esse consistono nel fatto che solo qui, in virtù della speranza nella nostra
resurrezione in Gesù Cristo, tutto quanto v’è di incompiuto nei singoli momenti della nostra vita
consegue una pienezza celata, e nell’atto medesimo le perle sciolte delle singole nostre ore e giorni
vengono allineate in un filo robusto».
Lo si può dire altrimenti, ricordando il detto di Gesù: «Poiché dove è il tuo tesoro, là è anche il tuo
cuore». B. lo commenta così: «Se è presso te stesso, il tuo tesoro passa insieme con te e col tuo
cuore, poiché tutto quanto è temporaneo si perde; ma se tu getti il tuo cuore in Dio, non puoi tenere
presso di te assolutamente nulla, gli rimetti la sollecitudine per il tuo tesoro, la tua unità, ed Egli te
11
la custodisce nella sua eternità. Tu troverai infine la tua vita, raccolta nella sua vera unità
sotterranea, che non appare sulla terra. Questa speranza di scoprire che il cumulo di macerie,
costituito da ogni vita d’uomo, è una costruzione ben connessa e abitabile, si appoggia certo, in
senso cristiano, innanzitutto sulla grazia di Dio. Essa sa portar rimedio dappertutto all’umana
miseria, colma le incrinature e le lacune lasciate da ciò che noi non abbiamo realizzato, interpreta
gli elementi radunati come una parola dotata d’una propria forma, e ciò che noi siamo inetti con la
nostra vita umana a integrare in pienezza, completa con i beni della vita divina. Questo noi
chiamiamo grazia. Ed essa non è solo l’essere oggetto di uno sguardo munifico e misericordioso
dall’alto, ma un pulsare della vita divina attraverso le nostre vene mezze vuote».