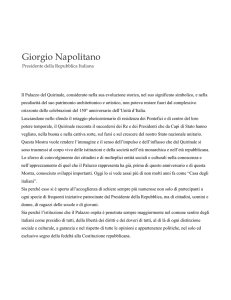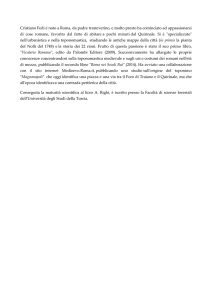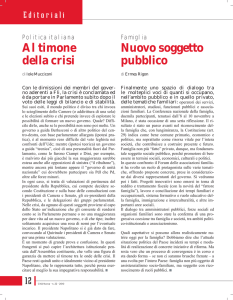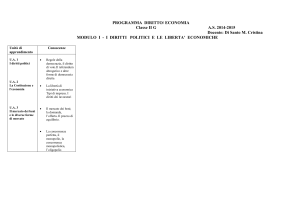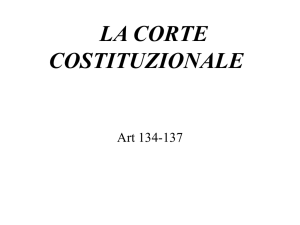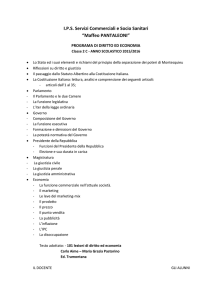Il Quirinale nella democrazia bipolare
di Michele Prospero
Premessa
Con il deconsolidamento del sistema politico-istituzionale avvenuto negli anni
’90 (per l’impatto di una nuova legge elettorale orientata ad una meccanica
bipolare, per la susseguente fictio della legittimazione diretta del capo
dell’esecutivo, per la metamorfosi dei partiti in eterogenei cartelli elettorali, per
le riforme amministrative e le nuove forme di governo locali, per la modifica del
titolo V della costituzione), è mutato il tradizionale “potere neutro” conferito al
presidente della repubblica. Le grandi trasformazioni hanno visto non un
semplice alterarsi del criterio numerico da impiegare nel conteggio delle
formazioni politiche (erosione dell’antico multipartitismo) ma l’emergere di
figure, attori, soggetti, culture, istituti nuovi che hanno conferito ai mutamenti
intercorsi nel ventennio un sia pur disordinato rilievo qualitativo o sistemico
(passaggio dal multipartitismo centripeto-consociazionale al multipartitismo
centrifugo-assorbente imposto dal congegno maggioritario prima e dal premio di
maggioranza dopo). Questa metamorfosi, che ha ridefinito i contorni sistemici
della competizione, incide anche nell’operato del capo dello Stato le cui
attribuzioni formali restano pur sempre quelle consuete, consegnate negli identici
schemi laconici della costituzione, ma sono ora interpretate con un piglio diverso
richiesto dalle condizioni politiche assai modificate. Non vincolato da norme ben
cogenti munite di conseguenze sanzionatorie, e anzi lasciato nel suo operato a
discrezionali valutazioni che oscillano tra un interventismo ramificato e una
passiva quiescenza dinanzi a cadute e straripamenti degli attori, il presidente
della repubblica può interpretare il proprio ruolo confidando sul grado di
accortezza politica e di sensibilità giuridica. Con strutture formali analoghe, ogni
capo dello Stato nell’età del maggioritario svolge funzioni organizzative e
coordina principi costituzionali rilevanti nella dinamica delle istituzioni
imponendo letture e modi d’agire molto differenti del ruolo ricoperto.
La esiguità delle fonti normative e l’ampiezza della possibilità di un autonomo
gioco condotto dal capo dello Stato inducono a rivisitare il concetto di potere
neutro. Esso è del tutto inservibile a delimitare il senso effettuale della funzione
presidenziale se rinvia ad una cogente ed esaustiva disciplina legale dell’istituto
coltivando una fuorviante idea di apoliticità di un organo di garanzia destinato a
operare nel solco della stringente clausola formale. In realtà la condotta reale del
capo dello Stato rimanda all’influenza, al ruolo di consiglio e al lavoro di sintesi
complessiva di una figura capace di inserirsi con cautela ma anche con prontezza
nella evoluzione temporale dei rapporti politici. Se la disciplina costituzionale
riferita al presidente della repubblica “rimane allo stadio di un abbozzo” 1, ciò
significa che la concreta vicenda di un capo dello Stato sconfina, ben oltre le
rassicuranti metafore del potere neutro, in compiti di pregnante significato
L. Paladin, Presidente della Repubblica, in “Enciclopedia del diritto”, 1986, p. 171. Sul potere
neutro come sintesi dinamica operata dal capo dello Stato nel ricoprire un ufficio pubblico garante
di rapporti politici cfr. A. Baldassarre, Dalle dimissioni di Leone all’elezione di Pertini,
“Democrazia e diritto”, 1979, n. 1, p. 163. Le funzioni di garanzia affidate al capo dello Stato sono
pur sempre appannaggio di un organo politico che deve favorire la funzionalità complessiva del
sistema e quindi sapere interpretare il senso del gioco politico e le aspettative riposte dagli attori
alla sua influenza rilevante. Sulla dialettica tra la forma e le funzioni degli istituti cfr. C. Mortati,
Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1991, p. 418.
1
politico. L’imprevedibilità e l’autonomia declinazione del ruolo sono elementi
fisiologici della presidenza quale organo ibrido con competenze giuridiche e
esplicite mansioni politiche. Il doppio corpo del presidente giustifica un ruolo che
è stato chiamato a fisarmonica perché vede emergere sfumature assai diverse,
risposte molto eterogenee nel portare innanzi il compito istituzionale di sintesi e
unità del meccanismo costituzionale attribuito al capo dello Stato. Nell’età
bipolare il pendolo tra interventismo, modulato secondo un esplicito disegno
politico, e ritirata nel più ristretto ambito notarile presenta oscillazioni diverse
rispetto a quelle che caratterizzavano la repubblica dei partiti (che si segnalò per
una fervida creatività istituzionale inventando mandati esplorativi, incarichi
vincolati, reincarichi, gabinetti balneari e di decantazione). La prestazione in
favore della manutenzione indispensabile a preservare condizioni di unità per
frenare le tendenze alla crisi sempre latenti nel funzionamento degli organi
costituzionali, nel corso della stagione bipolare rafforza le competenze e le
aspettative verso il capo dello Stato. Mentre il bipolarismo vedeva in molti partiti
esaltare la avvenuta legittimazione diretta del governo e rimarcare la visibilità
della sua guida dinanzi al corpo elettorale, l’inferenza per cui alla mutata
fondazione dell’esecutivo avrebbe corrisposto una tendenza a rendere il capo
dello Stato una figura più dormiente e residuale non ha trovato conferme. Anzi,
al cospetto del premier indicato sulla scheda elettorale risplende una immagine
del presidente della repubblica che è tutt’altro che sbiadita e archeologica. Il
sistema politico bipolare ha visto l’entrata in scena, più che nell’età
proporzionale, due presidenti che assumono prestigio e rivendicano competenze.
Questo duplice volto del potere è in gran parte una prerogativa italiana che non
ha molti riscontri in altri sistemi politici europei e comunque segnala un punto di
difficoltà e sofferenza dell’assetto bipolare così come è venuto configurandosi.
1. Le esternazioni
A ridosso del declino della repubblica dei partiti anche l’azione dei soggetti
costituzionali in senso lato di garanzia ha subito profondi mutamenti. Gli
indicatori tradizionali di una discrezione degli organi dello Stato, nel loro
rivolgersi all’opinione pubblica o nell’interpellare le istituzioni in vista di
fisiologiche esortazioni per adottare interventi correttivi, sono saltati già sotto la
presidenza di Cossiga. Nel solo anno mirabile 1991 egli inviò alle camere ben 10
messaggi motivati di rinvio (inclinando per una inflazione nell’uso dello
strumento che se non assunto come un veicolo d’eccezione diventa inefficace e
persino ostile al mantenimento dell’equilibrio istituzionale che è compito cruciale
del capo dello Stato). I tratti notarili e gli stili di garanzia di norma attribuiti al
Quirinale come organo discreto di coordinamento unitario del sistema
istituzionale, nella fase finale del settennato di Cossiga d’un colpo lasciarono il
posto ad un interventismo senza precedenti nella storia repubblicana. Un
abbraccio continuativo con i media per convogliare messaggi presidenziali
straripanti, che si proiettavano ben oltre gli inviti al dover essere di valenza eticonormativa o alle esortazioni necessariamente generiche, travalicò ampiamente i
contorni dei consueti poteri di esternazione e di influenza moderatrice nella
formazione delle politiche2. L’esplosione linguistica del presidente (che con le
2
Sui poteri presidenziali di esternazione cfr. A. Baldassarre, Il Capo dello Stato in G. Amato, A.
Barbera (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna, 1986. Con la presidenza Cossiga si ebbe
una impennata dei rinvii di atti legislativi. Su complessivi 57 rinvii motivati (da Einaudi fino al
2005) ben 22 sono stati decisi da Cossiga (M. Tebaldi, Il Presidente della Repubblica, Bologna,
2005, p. 263). Congelato con un presidente nel complesso silente come Einaudi (espressione di una
maggioranza centrista delimitata), il potere di esternazione cominciava ad accendersi già con
Gronchi che era l’interprete di un compito arduo di allargamento dei confini politici generali alla
sinistra socialista e non esitava ad entrare in contrasto con il governo, a formulare istanze di politica
estera nei suoi lunghi viaggi. Cresceva così sul piano fattuale un potere dalla inesistente
configurazione normativa capace di alterare equilibri politici. “L’idea del potere di esternazione
estenuanti esternazioni informali sfuggiva ai rigorosi limiti della controfirma
ministeriale e schivava così qualsiasi controllo) che ruppe ogni pretesa di inerzia
si autodefinì picconatore alterava le forme normali della retorica presidenziale
inserita entro un sistema parlamentare. Con il suo sforzo di dettare l’ordine del
giorno e di porre il grande rinnovamento costituzionale al centro dell’agenda,
Cossiga si mosse oltre l’allocazione formale delle potestà pubbliche e anticipò la
deflagrazione di un intero sistema politico improvvisamente smodato nei suoi
vertici formali e privo ormai di ogni bon ton istituzionale. Gli anni ottanta si
erano chiusi con un pacchetto di riforme che evocavano una nuova ripartizione
del potere pubblico nel senso della maggiore efficacia. Nel biennio riformatore
(1988-1990) erano state approvate la legge sulla presidenza del consiglio dei
ministri, la riforma dei regolamenti delle camere con la riduzione del voto
segreto e con la previsione della corsia preferenziale per i disegni di legge del
governo, la riforma delle autonomie locali con innesti di metafore manageriali
nell’ingranaggio istituzionale e con sperimentazioni di presidenzialismo
municipale. Non era quindi una fase di stallo o di blocco decisionale quella che si
apriva con gli anni ’90 ma il riformismo incrementale avviatosi nel sistema
politico era minato da tendenze potenti che abbattevano la realtà di partito. I
nuovi assetti internazionali, i trattati di Maastricht, il movimento referendario, le
indagini di mani pulite si abbatterono in maniera drastica su una politica debole
coinvolta da dinamiche esplosive. Il riformismo incrementale fu del tutto
impotente nel gestire una crisi che divenne presto di legittimazione, non di mera
funzionalità del sistema e che ritoccò alla radice la configurazione degli organi
costituzionali.
Della metamorfosi del riformismo istituzionale appena avviato in una
incontrollabile situazione di emergenza che marciava all’insegna di un diffuso
orientamento antipartitico (scatenata anche dal referendum sulla preferenza unica
del giugno del 1991), il presidente Cossiga fu uno dei protagonisti che accentuò
la tendenza del capo dello Stato a porsi al fuori di forme riconoscibili e accettate.
Il suo messaggio alle camere del 26 giugno del 1991 (che recava la controfirma
non del capo del governo ma del guardasigilli, a mera certificazione formale
dell’autenticità dell’atto inoltrato) non era una semplice risposta delle istituzioni
alla crisi in atto ma conteneva un elemento di accelerazione e di approfondimento
della crisi esso stesso. Sul piano storico, il capo dello Stato attestava l’usura
evidente dell’impianto normativo della costituzione e invitava a trovare il metodo
più dirompente per l’intervento correttivo radicale necessario. Cossiga si faceva
interprete del “malessere costituzionale” percepibile ed entrava nel merito
specifico delle riforme da approntare. Uno scarso apprezzamento della ritualità
degli organi costituzionali (Cossiga accantonava le procedure fissate nell’articolo
138 ed evocava altre strade di una auspicabile revisione: pieni poteri costituenti
“senza limitazioni procedurali o di merito di fronte alla costituzione vigente”), lo
indussero a una declinazione di stampo giacobina del nuovo patto costituente
come momento di una autentica “rivoluzione democratica”3 propugnata dal
Quirinale (che peraltro aveva già minato l’edificio simbolico della repubblica con
la visita alla foibe e con la riabilitazione di Sogno). La funzione di garanzia nel
processo di rendimento del sistema plurale degli istituti e quella di interprete del
quadro simbolico della rappresentazione dell’unità nazionale erano ormai
infranti. Un interventismo smodato di un fattore di equilibrio come il capo dello
Stato incrinava anche il complesso delle regole in base alle quali funzionava
l’organizzazione del potere pubblico. Più che ai poteri costituiti, il capo dello
Stato, quale veicolo di un potere costituente in cammino e non più dormiente, si
non regge sul piano concettuale, poiché le opinioni così espresse non si risolvono in alcuna
decisione e non valgono –di per sé sole- a produrre effetti giuridici tipici” (L. Paladin, Per una
storia costituzionale dell’Italia repubblicana, Bologna, 2004, p. 84).
3 Sulla discontinuità del testo di Cossiga che argomentava “come se un regime presidenziale fosse
già in vigore” cfr. Lanzalaco, Le politiche istituzionali, cit., p. 181.
collegava autonomamente con la pubblica opinione per spingere verso diversi
assetti istituzionali e determinare equilibri e rapporti di forza nuovi.
Inviando il suo messaggio prima ai media televisivi e solo dopo al destinatario
istituzionale naturale ossia al parlamento, Cossiga inaugurava una prima
scivolata nell’antipolitica che grazie all’amplificazione dei media rifiutava come
interlocutori i partiti, le sedi della rappresentanza e si affermava come connotato
genetico della crisi italiana del principio di legalità. L’antipolitica si esprimeva
con un tipo di comunicazione debordante e invasiva con la quale il capo dello
Stato entrava in sintonia con l’opinione pubblica sollecitata con scaltrezza e con
essa si intratteneva con le forme di un dialogo permanente che nei suoi simboli e
nei suoi eccessi divorava il principio della separazione dei poteri, irrideva agli
istituti della rappresentanza (imponendo come un obbligo improcrastinabile “il
dibattito parlamentare che dovrà seguire questo mio messaggio”). Attraverso lo
slogan, l’aneddoto, la battuta che risparmia la fatica dell’argomentazione, in
molte esternazioni presidenziali si lambiva la retorica dell’antipolitica che
accantonava il cittadino informato da persuadere per assumere come unico
referente lo spettatore distratto da attrarre con simboli e richiami prevalentemente
emotivi. Con le uscite talvolta stravaganti di Cossiga il Quirinale perdeva la
sorveglianza linguistica consueta e adottava un lessico aggressivo nelle sue
metafore e impregnato di una smisurata amplificatio retorica. Per incidere nei
poteri di indirizzo e nella routine di organi istituzionali egli assumeva linee di
intervento minacciose che stridevano con l’ovattato lessico presidenziale. La
virulenza inusuale del linguaggio presidenziale (qualificava come “figlio di…”
un giornalista inglese, chiamava traditori i giudici che avevano criticato la guerra
del Golfo, definiva “imbecille e cretino” il sindaco di Bari) lo proiettava oltre il
paludato lavoro di interconnessione tra istituti e soggetti della politica. Il capo
dello Stato sembrava rinunciare alla pacata tessitura delle indispensabili relazioni
tra i poteri e orientava sempre più marcatamente il potere di influenza sui
contenuti effettivi della azione concreta degli organi di governo. Più che un
supplemento di consiglio e di fiducia nella vicenda di poteri separati ma
interconnessi, il nervosismo di Cossiga indicava la presenza ai vertici dello Stato
di un potente fattore di rottura simbolica e di forzatura procedurale.
La ricerca palese e senza infingimenti di una funzione attiva nella formazione
delle politiche, e la costruzione di immagini caricaturali riferite ad alcuni suoi
avversari, inaugurarono uno stile partigiano della presidenza che di fatto
assumeva una parte attiva e spesso provocatoria nel gioco e difficilmente i toni e
le sollecitazioni parevano compatibili con le regole del parlamentarismo che non
tollerano certo un presidente con spiccate propensioni a un esplicito e dirompente
intervento nella mischia. Una discesa del capo dello Stato nell’agone politico,
sorretto nelle sue esibizioni plateali da una pervasiva copertura mediatica,
divenne il connotato originario di una caduta della riservatezza degli istituti del
controllo e di smarrimento di ogni ponderato stimolo in vista della funzionalità
equilibrata dei poteri diversi. Con Cossiga si ebbe l’appannamento dei consueti
poteri di consiglio e di stimolo verso gli organi dello Stato e prevalse
l’assunzione di una strategia deliberata di condizionamento che accompagnava il
già percepibile declino in senso populista della democrazia (attacco al parlamento
e alla corporazione dei giudici in nome della gente comune, alle cui sensibilità
più profonde tuttavia poco si addiceva il suo annuncio della grazia al capo delle
Br). Nei suoi interventi a pioggia che perseguivano un obiettivo esplicito di
codeterminazione degli atti di governo e nelle sue parole inquiete che inondavano
i circuiti del potere, Cossiga mostrava di percepire lo stato di decomposizione
delle istituzioni e di compiacersene. Per questo egli non adottava, dinanzi al
baratro della politica, un lessico della rassicurazione e della sobrietà per
contribuire allo sforzo dei pubblici poteri per tenere sotto controllo un sistema in
piena crisi. Giunti all’esaurimento di un intero ciclo politico, il Quirinale non si
limitava più ad esternazioni che denunciavano nodi strutturali irrisolti o palesi
discordanze tra la realtà e i valori costituzionali ma rispondeva alla crisi in atto
accentuandola con una continua interferenza nella pratica politica coperta con il
linguaggio della metafora, della invettiva, della rottura, della eccentricità.
Ingaggiando una contesa a tratti aspra con la sgradita realtà di partito, Cossiga
intendeva partecipare attivamente, e in maniera pervasiva, alla configurazione
delle scelte di governo e alla individuazione delle riforme istituzionali necessarie
per segnare un qualitativo passaggio di fase all’insegna della discontinuità.
Con le esternazioni di Cossiga (messaggi, atti formali, dichiarazioni straripanti
a mezzo stampa non suscettibili di controfirma e quindi al di fuori di una attività
sottoposta al controllo ispettivo delle camere) si pervenne alla frantumazione
linguistica della prima Repubblica. La retorica del Quirinale non si accontentava
più di procedere lunghi i binari collaudati della formalità ma si introduceva con
accanimento ovunque ora per suggerire, per consigliare, per orientare, e ora per
contrattare, per recriminare, per sfidare. Rispetto alla norma linguistica della
presidenza (elusa ma con altre ispirazioni anche da Pertini4) che opera come
impulso discreto tra i poteri, Cossiga introduceva oscuri momenti di eccentricità
scagliati contro le procedure per farle inceppare. Le sue invenzioni colorite
immettevano nel discorso presidenziale una inaudita pregnanza polemica e
persino una fraseologia ingiuriosa, riscontrabile in talune cadute di stile contro
singole personalità dell’opposizione. Con neologismi snocciolati a consumo dei
media e con figure retoriche assillanti, il capo dello Stato ricorreva ad un
antidiscorso che azzerava la ritualità delle istituzioni e procedeva a
comunicazioni a pioggia per sfidare le roccaforti dei poteri. Senza limiti
temporali e senza freni procedurali accolti come vincolanti, egli apriva orizzonti
di condizionamento delle scelte politiche e richiedeva il rovesciamento dei
paludati cliché della lingua delle istituzioni. In quello che si avviava a diventare il
teatrino della politica con strumenti espressivi poco controllati, Cossiga appariva
il primo attore orientato a calcare le scene in una recita in cui i media e il
presidente degli eccessi si cercavano a vicenda. Un sistema politico ormai
lacerato nella sua struttura portante esprimeva nella propria presidenza un lessico
colorito e talvolta del tutto refrattario ai nessi logici, alla coerenza espressiva, alla
sobrietà, alla formalità. Ricorrendo ad esternazioni a getto continuo che si
proiettavano oltre ogni disciplina costituzionale per il raccordo tra i poteri e
ricorrevano a un linguaggio disarticolato per molti versi, Cossiga si agitava per
accrescere la capacità di interdizione e di condizionamento efficace. Il presidente
scappava dalla norma e giocava con le tecniche di un sistema verso cui mostrava
una insofferenza evidente e mai celata5. I suoi interminabili soliloqui a reti
unificate che rompevano ogni protocollo sembravano lo specchio di una profonda
Anche la presidenza Leone non rimase immune da eccessi sul piano dell’immagine allorché “il
figlio Mauro, allora appena trentenne, veniva pian piano promosso alla carica, inesistente nel nostro
ordinamento, di vicepresidente. Una volta arrivò al Quirinale Aldo Moro e Mauro era seduto, come
sempre, al fianco del padre. Moro fece cenno che voleva restare solo con il presidente. Questi, un
po’ imbarazzato, chiese: Ma che, o’ guaglione non lo vulite” (M. Mafai, Diario italiano, RomaBari, 2006, p. 408). Sull’attivismo di Pertini (sul suo trasbordare dalla figura del presidente neutro a
quella schmittiana del presidente guardiano) e sulle “smagliature” da egli prodotte nelle prerogative
di altri organi e nelle consuetudini costituzionali (con il conferimento dell’incarico di presidente del
consiglio e con la contestuale indicazione di due vicepresidenti; con dichiarazioni pubbliche sulle
formule di governo desiderate, con l’intervento in conflitti sindacali) cfr. A. Baldassarre,
L’attivismo del Quirinale e la crisi politica italiana, “Democrazia e diritto”, 1979, n. 6, p. 881). Sul
capo dello Stato come tutore della costituzione cfr. C. Esposito, Diritto costituzionale vivente. Capo
dello Stato e altri saggi, Milano, 1992.
5 Quella di Cossiga era “una dottrina immaginaria” che attribuiva al capo dello Stato il potere di
esprimere pubbliche valutazioni su partiti, su persone, su leggi, sulla durata, sul programma e
composizione dei governi, sulla possibilità di incaricare uomini di fiducia con una formula di
governo predeterminata, sulla possibilità di sciogliere a discrezione le camere senza che i contenuti
delle esternazioni possano diventare oggetto di discussione in parlamento a causa della
irresponsabilità e insindacabilità politica del presidente (R. Guastini, La dottrina costituzionale di
Francesco Cossiga, “Politica del diritto”, 1991, n. 3, p. 475).
4
inquietudine, il sintomo di una latente patologia che ostruiva la coordinata attività
dei poteri.
L’acrobazia verbale dell’ultimo presidente della prima repubblica rivelava una
nevrosi ormai metabolizzata dai vertici del sistema che non disponeva più di
custodi accorti e leali in grado di conservare lo status quo con poteri in equilibrio
funzionale. Le riforme istituzionali erano divenute un appuntamento ambiguo e
declamatorio mentre, così scriveva Cossiga nel messaggio del 1991, “non è lecito
parlarne come di cose indispensabili, per poi lasciare tutto come prima”. La
riorganizzazione dello Stato e la rilegittimazione del sistema politico con
politiche macroistituzionali erano al centro delle indicazioni di Cossiga che si
faceva portatore di precisi e sostanziali contenuti. La prospettiva
microincrementale con aggiustamenti a spizzichi come quelli contrattati dai
partiti non gli sembrava più valida ed efficace in un tempo che evocava processi
visibili di destrutturazione e reclamava radicali atti di innovazione. La cesura
esplicita sul terreno della forma di governo comportava la necessità di favorire
attivamente una discontinuità e un salto simbolico esplicito e non reticenti6. Con
una sorta di presidenzializzazione del Quirinale, Cossiga si faceva portatore di un
disegno di politica istituzionale esplicitamente proteso alla rottura formale ben
oltre ogni velleità di manutenzione conservativa dell’ordine vigente7. Solo
l’accantonamento delle tradizionali pratiche negoziali concepite dai partiti e
l’adozione da parte del capo dello Stato di un energico piano di riassetto
istituzionale d’impronta commissariale avrebbe potuto favorire la discontinuità
indispensabile. Le esternazioni sfornate a getto continuo da Cossiga lo rendevano
il cantore di una politica che non intravedeva più spiragli di salvezza nell’ordine
dei poteri costituti e lavorava per accentuare la velocità dei salti radicali e delle
rotture di continuità nella linea storica delle istituzioni parlamentari. Con le sue
dissimulazioni, con il suo linguaggio inquieto e indispettito, con i suoi insulti via
etere (Zombie con i baffi, gatto Felix, piccolo Vysinskij, sbandato, piccolo
arrampicatore sociale, boss di provincia), con le sue stravaganze, Cossiga
tramutava l’alta carica istituzionale contemplata per disegnare una logica unitaria
a poteri plurali in un momento di distruzione creatrice (“io mi batto per riformare
il sistema e smantellare il regime”)8. Non mancavano nel suo codice linguistico
scenari pittoreschi, immagini grottesche, deformazioni popolaresche e persino
scadimenti triviali. Quando si rivolgeva a chi lo criticava per i suoi eccessi non
disdegnava metafore arcane, dietrologie insondabili, messaggi proteiformi rivolti
ad apparati dello Stato di cui si premurava di dichiararsi un estremo difensore.
Per togliersi i sassolini dalle scarpe egli ricorreva a un linguaggio colorito, non
privo di lampi visionari e di percezioni dell’usura dei meccanismi di comando.
Nelle descrizioni degli scenari politici e istituzionali indispensabili per un salto di
qualità nella storia delle istituzioni, Cossiga ricorreva ad un paragone con il
presidente Coty che in Francia aprì le porte al commissario incaricato di
sospendere la continuità della Quarta Repubblica. L’impianto discorsivo del
presidente si caricava spesso di richiami ludici, di battute ricorrenti, di
simbologie fulminanti quasi a dire che la rottura della norma ha un tratto giocoso.
6
Per questo intreccio dinamico di molteplici profili, più che di forma di governo, intesa come
organizzazione giuridica statica, alcuni giuristi prediligono l’espressione “strutture di governo” che
richiama l’attenzione verso una pluralità di organi e di attori (C. Lavagna, Istituzioni di diritto
pubblico, Torino, 1985, p. 527). Per una rassegna della letteratura, che oscilla tra individuazione dei
caratteri giuridici e concetti spuri che rinviano alla ricognizione del sistema politico e di altri fattori
extragiuridici, cfr. G. D’Anna, Forme di governo e modelli istituzionali, Roma, 2008.
7 Il tratto della rottura differenziava l’interventismo di Cossiga da quello di Gronchi che calibrava il
suo disegno di innovazione su una politica istituzionale di attuazione della costituzione e dei suoi
istituti garantistici dopo la chiusura del ciclo politico centrista (Cfr. L. Lanzalaco, Le politiche
istituzionali, Bologna, 2005, p. 106).
8 Tragiche si rivelarono le parole di Cossiga sul “giudice ragazzino”. Sul cosiddetto potere di
esternazione cfr. M. Dogliani, Il “potere di esternazione” del Presidente della Repubblica, in M.
Luciani e M. Volpi (a cura di, Il Presidente della Repubblica, Bologna, 1997).
Anche i suoi atti in apparenza più formali dispiegavano eccentricità nella
gestione delle crisi di governo (rinvii alle camere per scongiurare elezioni,
incarichi a esponenti non di primo piano come Goria, reincarichi, indicazione di
precisi punti programmatici da inserire nell’agenda del futuro esecutivo,
suggerimento di nomi di papabili ministri ritenuti più in consonanza con il
Quirinale) e palesavano il trionfo di una logica interventista esasperata pronta a
ingerenze nel conflitto politico quotidiano. Tutto ciò tramutava il capo dello Stato
in palese riferimento di una manovra politica parziale in contrasto con le
soluzioni prospettate dai partiti per la composizione dei dicasteri e per tracciare
gli orientamenti di un indirizzo politico condiviso9.
Se a differenza della comunicazione istituzionale che per destinatari privilegiati
ha organi dello Stato e procedure formali, “i discorsi politici costruiscono identità
e preferenze”10, le prese di posizione di Cossiga ammainavano la regola e
scivolavano con tutta evidenza sul versante delle opzioni politiche partigiane. Le
istituzioni perdevano la loro consueta fisionomia e, almeno sul piano del
linguaggio presidenziale, diventavano irriconoscibili come ambiti super partes
che incarnavano una logica del generale. Al tempo dell’ordine scandito in
cerimoniali lenti e in arcaiche consuetudini, Cossiga contrapponeva a più riprese
un linguaggio del caos e una condotta ispirata alla completa informalità. Nel
1991 minacciò di inviare i carabinieri a Palazzo dei Marescialli per impedire una
riunione del Csm. La deviazione dalla forma sviluppata nei luoghi ovattati del
formalismo e della procedura rigorosa diventava una maschera per lavorare ai
fianchi una politica in radicale ristrutturazione e spingerla lunga un crinale
desiderato. Spesso la rottura della forma avveniva aggrappandosi a un
formalismo estremo. Proprio quando lasciava sguarnita la costituzione e lo spirito
della leale collaborazione tra i poteri, Cossiga pretendeva di conferire
direttamente al Quirinale, con una invasione esplicita dei ruoli spettanti alla Corte
costituzionale e al parlamento, il compito di predisporre una integrale custodia
preventiva della costituzionalità della norma. Rifiutò perciò di promulgare nel
gennaio del 1992 la legge in materia di obiezione di coscienza sviluppando rilievi
di sostanza e inviando al riguardo un messaggio alle camere che però erano
ormai state sciolte.
Con il suo sperimentalismo aggressivo che strigliava i poteri e non li
coordinava funzionalmente, il presidente appariva il tormentato inquilino di una
istituzione preposta all’unità sotto cui si stava sgretolando il vecchio sistema dei
partiti e le antiche basi di sostegno al regime costituzionale. Dal Quirinale non
veniva alcuna indicazione costruttiva in vista di una più morbida e cooperativa
strategia istituzionale per accompagnare il percorso tortuoso di un sistema che
vedeva la crisi dei soggetti politici e l’asfissia delle risorse procedurali richieste
per smussare le troppe incognite legate alla decadenza della repubblica dei partiti.
La mancanza di un sereno custode delle regole gestite come un deposito
condiviso di poteri plurali, in quegli anni inasprì la crisi del sistema politico
portandolo sull’orlo della catastrofe istituzionale. Le stravaganti neoformazioni
verbali del capo dello Stato escogitate per colpire persone, soggetti politici, ruoli
9
M. Tebaldi, Il Presidente della Repubblica, cit., p. 199; C. De Fiores, Il presidente della
discordia, in “Democrazia e diritto”, 1991, n. 4. Lo scontro istituzionale tra il Quirinale e
Montecitorio per imporre lo scioglimento anticipato delle camere fu vinto dal parlamento che così
isolò il presidente esternatore e il suo partito del piccone. Con la formazione indesiderata del
settimo governo Andreotti (da cui si sfilava il Pri in nome di una opposizione di centro che dialoga
con gli onesti contro il regime in dissoluzione) non solo il parlamento deliberava la sua continuità
d’azione rispetto ai propositi presidenziali ma l’espulsione dal programma di governo di ogni
riforma costituzionale segnò un ulteriore smacco per Cossiga (sostenuto con forza solo dal Msi).
10 J. G. March e J. P. Olsen, Governare la democrazia, Bologna, 1997, p. 181. Una difesa di
Cossiga dall’accusa di aver prodotto un “marasma istituzionale” e reso le istituzioni “un vuoto
simulacro” si trova in M. Patrono, La repubblica di Icaro, Roma, 1995, p. 254. Sulla pretesa di
Cossiga di guidare uno sbrego come un commissario garante di una transizione insiste E. Bettinelli,
Tre approcci al riformismo costituzionale, “Politica del diritto”, 1992, n. 2, p. 214.
documentavano una volontà esplicita del presidente inquieto di sottrarsi alle
coercizioni dell’abito istituzionale vigente per pronunciare parole dissacranti
attorno allo stato reale delle istituzioni e alla natura degenere dei partiti da
sostituire. Cossiga rinunciava ad ogni credibile prospettiva ricostruttiva e al posto
del sereno e cauto raccordo tra le istituzioni principali preferiva rompere la
funzionalità dei meccanismi di decisione. Invece del contributo vigile per il
rilancio del patrimonio e dei poteri della costituzione, la sua principale
preoccupazione divenne quella di segnare momenti di dissacrazione per spingere
le istituzioni verso approdi sconosciuti. Per molti versi, rivolgendosi direttamente
ad una disarmata opinione pubblica, il presidente anticipava uno stile che molti
intrecci presentava con il populismo elettronico oggi trionfante. Provenienti
proprio dal Quirinale e dal suo linguaggio a tratti surrealista, le intemperanze
verbali annunciavano l’ingresso in una età sconfinata, in una fase assai confusa di
poteri incontrollati e debordanti, in un assetto smodato delle istituzioni prive di
reti e procedure per tutti vincolanti secondo gli imperativi della comune
responsabilità. Cossiga, che preferiva entrare in rapporto con il pubblico con gli
strumenti della rappresentazione e del gioco linguistico, era a tutti gli effetti un
politico sintomatico, insieme tragico e comico nella sua retorica, agitato da una
febbre incontenibile che lo proiettava oltre la cornice istituzionale vigente di cui
garantire la funzionalità. Egli dissodava il terreno su cui presto si stanzierà una
politica senza simboli di riconoscimento durevoli e priva di solidi veicoli di senso
nel governo delle istituzioni. Il virus del populismo contagiava i poteri costituiti
inaugurando una stagione di aperto deconsolidamento democratico in cui il capo
dello Stato, contando sul fascino delle parole in libertà contro i conservatorismi,
si rapportava direttamente ai cittadini per scavalcare le arcaiche mediazioni
istituzionali e sociali11.
Il presidente abbandonava i riti più resistenti delle istituzioni rappresentative e
scivolava volentieri in un vocabolario simbolista, cioè in un fare ricorso a parole
e immagini allusive per meglio entrare in sintonia con una opinione pubblica
contenta di decodificare un messaggio così dissacrante proveniente proprio dalla
istituzione più elevata e misurata. Cossiga è stato il primo presidente a cambiare
il destinatario del messaggio istituzionale e ad avvertire i tempi e le provocazioni
sprezzanti sollecitate dagli imperativi della videopolitica12. Egli non confidava
più nel cittadino informato e abituato a coltivare un senso delle istituzioni e per
questo le sue comunicazioni non ricorrevano al linguaggio della persuasione e
della ragionevolezza. La sua comunicazione era pervasa di una vertigine
leaderistica destinata a piegare le resistenze di un ordinamento alla deriva e
privilegiava un segmento parziale dell’opinione pubblica, quello che coincideva
con una zona marginale e provvista di una enciclopedia estremamente contratta,
ripiena di simbologie avverse alle forme della politica. Prima ancora del
definitivo e irreparabile trionfo della videopolitica, era proprio nel Quirinale che
si era originariamente incuneata la preoccupazione del politico di essere visto, la
mania di una quotidiana misurazione del gradimento tra “la gente comune” delle
sue trovate eccentriche contro il sistema. La stessa decisione di Cossiga di
rassegnare le dimissioni dalla carica non fu annunciata per vie istituzionali agli
organi costituzionali chiamati a prenderne atto ma, con un profilo di evidente
11
Una traccia di critica del parlamentarismo si rinveniva anche nel messaggio alle camere del
presidente Segni (17 settembre 1963) che sebbene accostato alle correnti che si agitavano attorno a
Pacciardi tuttavia non coincideva del tutto con i propositi dei movimenti presidenzialisti per una
nuova repubblica. Parco nelle esternazioni e meno interventista del predecessore, Segni intendeva
codeterminare nel merito talune scelte dell’esecutivo e fatale, nel sollevare il vespaio dei sospetti
golpisti nella sua condotta, fu la convocazione al Quirinale, per le consuete consultazione, anche
del generale De Lorenzo.
12 Sulla politica spettacolo di Cossiga, e sulla sua “straordinaria e bizzarra vocazione teatrale” che
lo indusse a cucire sulla giacca le mostrine dei carabinieri per mostrare la vicinanza all’arma, a
indossare una T-shirt adolescenziale o a raccontare i sogni, a bere whisky nel corso di una
conferenza stampa cfr. F. Ceccarelli, Il teatrone della politica, Milano, 2003.
scorrettezza formale rispetto agli adempimenti procedurali richiesti, fu
annunciata attraverso un discorso a reti unificate trasmesso il 25 aprile 199213. La
solitudine recriminatoria e aggressiva del capo dello Stato, che sbeffeggiava il
sistema e gli attori e si dimetteva in pubblico in maniera del tutto irritale, senza il
passaggio formale di consegne al presidente del senato che ne è il supplente,
entrava in sintonia con una porzione di società che inveiva contro il regime. In
piena euforia per l’89, per il crollo dei muri, per i nuovi inizi, per il
ricominciamento assoluto, Cossiga interpretava il ruolo del presidente inquieto
che, in nome della “verità, della tradizione e di Dio”, colpiva tutti i poteri
costituiti con simboli trancianti, con invettive talvolta contorte e accuse
recriminatorie. In taluni momenti dal Quirinale sembrava provenire il grido
dell’anima dinanzi al dissesto di un sistema che andava trasfigurato per essere
salvato. La discesa nei bassifondi più oscuri della politica assumeva i colori
accesi di una istanza di purificazione rispetto alle degenerazioni partitocratiche.
Le esternazioni, che per ore Cossiga compieva dagli schermi, assumevano la
valenza di un ossigeno al contempo tragico ed esilarante che infliggeva scossoni
gravi alla tenuta di un ordinamento infiacchito. Il male interiore del presidente
era anche il male di vivere di un sistema fragile che sprofondava nelle viscere del
suo passato mentre intorno si celebrava una grande festa per inaugurare, sulla
scia di combattivi movimenti referendari, i nuovi cominciamenti della integrale
democrazia dei cittadini. Con la palese provocazione del gesto e con il ricorso
all’oltraggio, con la conversazione prolissa, con i suoi aneddoti non privi di
arguzia, con la brusca interruzione del corso logico dei pensieri, con il supporto
di talune volte grevi motti di spirito, con la predilezione per l’invenzione di
nomignoli graffianti, Cossiga svelava che ormai il sistema si sbriciolava e
cominciava a franare a cominciare proprio dai suoi vertici istituzionali14. Quando
sono i piani alti dell’edificio a mollare le convenzioni più delicate e simboliche
indispensabili per un corretto e organico funzionamento dei differenti poteri,
prima o poi chi è fuori del palazzo proseguirà nell’opera di rottura di ogni
paradigma condiviso facendo precipitare il sistema politico nel vortice
dell’informalità più completa.
2. Tra stallo e caduta
La profonda crisi che negli anni ’90 investì il sistema dei partiti produsse alcune
ipotesi ricostruttive che si contesero il primato nell’agire politico. Una soluzione,
promossa da Cossiga, prevedeva un sommovimento artificialmente indotto dal
custode della armonia dei poteri contemplati dalla costituzione per favorire un
riassetto complessivo della repubblica su basi presidenzialiste. Questa alternativa
radicale, sollecitata da organi non sleali al punto da incorrere in censure
conseguenti ma certo non rassegnati alla custodia statica della forma, fu arginata
ma contribuì ugualmente a smuovere energie in parte assorbite dal Msi che a più
13
Le dimissioni del capo dello Stato non sono ingabbiate entro clausole formalizzate e non
richiedono una accettazione parlamentare in quanto si tratta di un atto del tutto unilaterale e
incondizionato a disposizione piena del presidente. Leone rassegnò le dimissioni comunicandole
soltanto al consiglio dei ministri e non agli altri organi costituzionali e lasciò il Quirinale trafelato
(Baldassarre, Dalle dimissioni di Leone all’elezione di Pertini, cit., p. 165).
14 Cossiga non ricorreva solo ad atti formali (messaggi) di cui, con la controfirma ministeriale, non
lui ma il governo portava la responsabilità politica dinanzi al parlamento ma a comportamenti
eccentrici o informali che prevedevano commenti, opinioni dal sicuro impatto politico ma di cui
nessuno rispondeva dinanzi alle camere. Dinanzi al capo dello Stato cessano le condizioni della
responsabilità politica (“in senso forte e tecnico, un organo si dice politicamente responsabile di
fronte a un altro allorché il secondo ha il potere di deporre o revocare il primo”) ma ciò non
significa che, al pari dei messaggi, anche le esternazioni informali non siano possibili oggetti di
discussione parlamentare (Guastini, op. cit., p. 479).
riprese sostenne le esternazioni del capo dello Stato e in parte entrate a
sorreggere una dottrina dello sbrego costituzionale molto rilevante negli
accadimenti politici. Attorno al messaggio alle Camere di Cossiga si definì una
embrionale coalizione alternativa alla sinistra Dc ed ex Pci che comprendeva
settori del Psi, del Pli, la Lega e il Msi. Una seconda possibilità, “interna”
stavolta, evocava la possibilità di una evoluzione della crisi tenuta sotto controllo
da soluzioni dapprima ibride (politico-tecnica, con il governo Amato osteggiato
da molte forze parlamentari) e poi più decisamente tecnica (con il governo
Ciampi costituito senza consultazioni formali dei partiti e sulla cui formazione ci
furono le astensioni della Lega e del Pds, dopo la fuoriuscita della delegazione
degli esperti indicati dal Pds). Questa soluzione non produsse effetti durevoli
perché la strada della ricostruzione di governi di coalizione o anche di esecutivi
di tregua fu giudicata impraticabile. Il pregiudizio giustizialista contro il
parlamento degli inquisiti non si espresse solo in sostegni incondizionati alle
inchieste della magistratura (propositi del genere accomunarono il Pds, il Msi, la
Lega) ma soprattutto nella ostilità contro i partiti macchiati dalle indagini (e
quindi da escludere da ogni rapporto di collaborazione) e contro le residuali
funzioni del parlamento (e quindi recisa esclusione di ogni ipotesi di riforma
incrementale sul testo redatto dalla bicamerale “delegittimata”). Una terza
alternativa, esterna alle sedi della rappresentanza nelle sue manifestazioni, fu
quella promossa dal movimento referendario. Neanche le velleità di conduzione
della transizione sotto il controllo dei movimenti referendari si affermarono. La
forza referendaria ebbe però un effetto lacerante per le flebili forze politiche
perché impose innovazioni esterne bloccando ogni riforma elettorale-istituzionale
condotta per le normali vie parlamentari. Il movimento referendario, inibendo
meccanismi interni di revisione, tramutò la crisi del sistema da crisi di legalità,
affrontabile con le risorse ordinamentale normali, in una crisi di legittimità
destinata a risolversi sul piano scivoloso dell’effettualità dei nuovi rapporti di
forza. Da ciò scaturì la quarta alternativa che assegnò un ruolo inedito a un
composito arco di forze esterne (alla antica legalità costituzionale) che
sollecitavano un salto di legittimità (simbolico-culturale-costituzionale) nel
quadro di una riconquista di potere da parte di forze tradizionali (anche se con
nuovi simboli) del vecchio assetto.
Negli anni ’90 i legalisti non trovarono le vie della legittimazione per guidare
un passaggio di fase perché la crisi dei partiti venne confusa con la
delegittimazione delle istituzioni a operare delle incisive riforme elettorali ed
istituzionali. I legittimisti non riuscirono ad esprimere una diversa legalità perché
la loro coalizione “anti” (partitocrazia) non mostrava sufficiente coesione e
determinazione. Ne scaturì una transizione effettuale (nuovi soggetti presero il
posto degli antichi attori) ma incompiuta sul piano formale (normalizzazione di
una seconda repubblica) e sul versante materiale (partiti rimasti fluidi e
vulnerabili). La dottrina Cossiga, se non ha avuto la forza per imporsi grazie alla
forza d’urto di uno sbrego formale (la seconda commissione bicamerale per le
riforme istituzionali assorbiva però l’indicazione di Cossiga di andare oltre il
dettato dell’articolo 138 e di introdurre delle procedure speciali di revisioni da
sottoporre al referendum confermativo), ha però determinato processi politici
rilevanti e ha svelato un nodo scoperto dell’ordinamento. I poteri del presidente
messi “in forma” dalla costituzione sono suscettibili di diverse interpretazioni e
risentono di meccanismi legati alla contingenza della prassi politica. Per ragioni
assai diverse la X e l’XI legislatura, quella del deconsolidamento e quella della
transizione, si svolsero entrambe all’insegna del ruolo anomalo del Quirinale e
della sua sovraesposizione nel gioco politico-parlamentare. Se Cossiga operò in
vista di fratture artificiali da introdurre nell’ordinamento per provocare un vuoto
abissale nella costituzione materiale, Scalfaro agì dentro un completo vuoto
normativo e di disordinata ritirata degli attori organizzati per ridefinire un
rapporto funzionale tra costituzione formale (inalterata) e costituzione materiale
(deformata). Con una prolungata supplenza politico-parlamentare (per gestire la
crisi delle formule di governo di coalizione con la sperimentazione di esecutivi a
forte impronta presidenziale-istituzionale), Scalfaro affidò al Quirinale un
compito di custode attivo degli equilibri del sistema parlamentare che non
esauriva la sua funzione nel controllo ex post ma la esercitava nell’evolvere dei
processi politici e istituzionali con una regia visibile nelle istituzioni sguarnite e
nel paese (relazione con l’opinione pubblica).
Intenzionato a svolgere una funzione di “traghettatore” verso un nuovo assetto
istituzionale, Scalfaro influì nelle scelte politiche essenziali maturate nella fase di
transizione. Nella tensione tra parlamento ingestibile e movimento referendario
incalzante, il Quirinale si preoccupò di mantenere un equilibrio tra le competenze
formali delle camere (sfibrate dalle inchieste di Milano e continuamente sull’orlo
della rinuncia e della paralisi) e le istanze esterne promosse da un forte
trasversalismo referendario. Dopo la celebrazione del referendum elettorale (82
per cento di sì al quesito), per Scalfaro occorreva respingere una propensione
nefasta ad accorciare il tempo della legislatura (come richiesto da chi temeva le
conseguenze del congegno maggioritario e intendeva andare al voto con le regole
antiche). Si fece per questo garante della prosecuzione della legislatura con un
mandato politico esplicito e a tempo determinato: assicurare il percorso residuo
necessario per approvare le nuove normative elettorali conseguenti al
pronunciamento referendario che “la stragrande maggioranza degli italiani ha,
con il voto del 18 aprile, dimostrato di preferire”. Con il passaggio dal governo
Amato (con un recupero di etichetta, si fece persino ricorso, in un’aula ormai
sprovvista di gruppi organizzati, alla prima crisi di governo di carattere non
extraparlamentare) al nuovo esecutivo retto da Ciampi, il Quirinale intendeva
rivendicare al sistema il tempo fisiologico necessario per implementare
l’adozione delle nuove clausole elettorali. Scalfaro parlò del governo Ciampi
come di un esecutivo “che si è voluto il più possibile non condizionato da logiche
di parte”, sebbene anch’esso formalmente sostenuto dalla fiducia parlamentare.
Fatte salve le formali “procedure per l’investitura parlamentare del governo”, il
capo dello Stato affermava con determinazione che il tempo della durata
dell’esecutivo era di fatto sottratto alle scelte del parlamento perché, oltre la
logica di parte o al di là di reazioni emotive devianti, esisteva un superiore
interesse generale che spettava al Quirinale difendere e interpretare al meglio.
Alle camere occupate ancora da vecchie sigle non più rappresentative (come
appariva dalle elezioni amministrative del giugno del 1993 svoltesi con le nuove
norme) veniva affidato un compito ingrato: gestire le condizioni per il commiato
dei partiti e assecondare una forte spinta dell’opinione pubblica a un repulisti
generale.
Nel maggio del 1993 Ciampi si presentò alle camere come “semplice cittadino,
senza mandato elettorale” che, nella “eccezionalità” del momento, assumeva un
suo specifico programma di governo: “dare esecuzione agli indirizzi che sono
stati espressi con i referendum del 18 aprile” e favorire così “la transizione in
corso” verso nuovi equilibri istituzionali. Il richiamo al “rispetto profondo per le
istituzioni rappresentative” non poteva che essere di mera circostanza perché, in
realtà, né il governo rinviava a un organico rapporto fiduciario con le aule né
l’esecutivo traeva dalle camere un esplicito indirizzo politico di maggioranza.
Dal mandato elettorale ricevuto dal parlamento con il voto e ritenuto obsoleto per
la dissoluzione dei partiti, Ciampi passava esplicitamente ad un’altra fonte di
legittimazione: il referendum come soggetto della transizione provvisto di una
effettività che sconsigliava allo stesso governo di azzardare un qualsiasi e
autonomo progetto di riforma elettorale. Saltando il parlamento e i partiti, il
governo tecnico si affidava al referendum quale sostegno effettivo alla sua
iniziativa. La contraddizione del governo Ciampi era evidente: da una parte il
premier annunciava che la nuova normativa elettorale costituiva la “finalità
preminente e prioritaria” dell’esecutivo e dall’altra precisava “la viva speranza”
di non mettere mano a una riforma già appaltata nella sostanza al referendum.
Come “anziano servitore della res publica” Ciampi dichiarava di guidare un
“governo della transizione” che non disponeva più di un esplicito collegamento
con una maggioranza precostituita (i vertici dei partiti della coalizione furono
sostituiti da un più solido legame con il capo dello Stato).
I partiti estranei alle antiche coalizioni di governo, sulla base delle nuove
dinamiche elettorali emerse nei comuni, incalzavano nella loro richiesta di
accorciare ai minimi termini la durata del governo per andare al voto e registrare
così i nuovi rapporti di forza maturati. A una legislatura sotto ricatto di
imminente esaurimento (Ciampi poggiava sull’astensione del Pds che a piè
sospinto minacciava però di revocarla15), il Quirinale si proponeva come garante
di una ragionevole durata (per ridisegnare i collegi elettorali e applicare le nuove
normative da uniformare per camera e senato). Emerse un conflitto aspro tra il
decisionismo del capo dello Stato (per costringere le camere a durare, e non come
nei casi di scuola per imporre una dissoluzione anticipata della legislatura) e le
intenzioni del parlamento (diviso tra chi voleva anticipare il voto e chi aspirava a
prolungare la vita all’assemblea). Il Quirinale si appellava, quale fonte delle sue
volontà di non ricorrere all’incognita della chiusura anticipata della legislatura,
non più al parlamento (che peraltro procedeva sulle materie più delicate con il
meccanismo del voto palese) e alle sue determinazioni maggioritarie ma ad una
forza vincolante esterna: l’opinione pubblica. Il corpo elettorale che si era
espresso con il referendum, con il suo sì plebiscitario obbligava gli organi dello
Stato a imporre il puntuale mandato del popolo referendario sulla stessa volontà
delle camere. Oltre i protagonisti parlamentari, indeboliti e privi di una
determinazione univoca, esisteva un organo ben più incisivo e influente che il
Quirinale intendeva interpretare: la volontà del popolo sovrano manifestatasi
tramite i referendum. Si costruì così un ponte tra il capo dello Stato e il popolo
(oltre la rappresentanza) che fungeva da schermo protettivo efficace e imponeva
alle camere un mandato vincolante (la riforma elettorale) e stabiliva anche i
tempi del lavoro delle assemblee. La funzione del parlamento venne condizionata
al mandato imperativo riconducibile ai desideri del corpo elettorale decodificati
dal capo dello Stato.
Il parlamento sotto tutela (della cosiddetta “trinità istituzionale”) veniva
sovente invitato a rappresentare gli umori reali del paese e a soddisfare le
aspettative affiorate con il pronunciamento referendario e le emergenze di
governo (risanamento, manovra di bilancio). Con una sorta di suicidio assistito,
le camere furono condotte dall’esterno a un ragionevole approdo (durata
condizionata al varo di nuove procedure elettorali) capace di schivare le insidie
della rozza dottrina del tacchino (che non poteva decidere le nuove regole perché
si sarebbe dissolto) e le fughe dalla responsabilità dal dovere istituzionale di
approvare le nuove regole. Le forzature a fin di bene progettate dalla trinità
istituzionale costituivano comunque una anomalia sia pure giustificata dal vuoto
politico esistente che non tollerava assenze. Le responsabilità di percorsi irrituali
e di supplenze ricadevano sulle forze politiche non travolte dagli scandali e però
sprovviste di una linea coerente per governare la gestione dei passaggi della
transizione. Loro avrebbero dovuto garantire un percorso coerente di guida
politica all’innovazione e invece furono condizionate da fughe insistite nelle
istanze di delegittimazione degli organi istituzionali. Invece che da ceppi di
partito insicuri, la partita fu gestita dai tre presidenti (della repubblica e della
camera e del senato) impegnati in una frenetica azione di pressione, di appelli e
Nelle sedute convulse dell’XI legislatura il Pds garantì il 60 per cento di presenza dei suoi
deputati nelle convocazioni. Spesso però fece mancare il numero legale in segno di dissenso. Nel
corso del 1993, ricorda l’allora presidente della camera, “ho dovuto reagire pubblicamente alla
decisione del Pds di far mancare, per dissensi di qualsiasi natura, il numero legale; comunque non
si può contare sul Pds per il prolungamento, in condizioni impervie, della travagliatissima vita
dell’XI legislatura” (G. Napolitano, Dove va la repubblica, Milano, 1994, p. 85).
15
convincimento per garantire alcuni mesi di durata alla legislatura che avrebbe
dovuto operare in condizioni di piena legittimità malgrado la perdita di
rappresentatività politica emersa nelle tornate amministrative che avevano
coinvolto 9 milioni di cittadini. La presuntiva legittimità (del popolo referendario
e comunale) veniva scagliata contro la gracile legalità (del parlamento degli
inquisiti) e la capacità rappresentativa di un sistema di partito non più specchio
delle tendenze reali del paese. Il crollo repentino della coalizione di governo
comunque non comportava la nascita di formazioni esterne al quadro politico e
quindi formalmente il voto comunale era pur sempre uno spostamento di
consenso tra partiti ospitati in parlamento e non il segno di un movimento
alternativo portatore di una diversa legittimità. Lo scostamento netto tra i dati
delle consultazioni politiche del 1992 e le espressioni di voto maturate tra il
giugno e il novembre del 1993 coinvolgeva pur sempre formazioni già
rappresentate e non imponeva un formale obbligo di procedere tempestivamente
alla dissoluzione della legislatura.
Nel respingere le invettive contro il parlamento delegittimato, Scalfaro
accettava comunque il postulato che le aule avessero una legittimazione residuale
e non tale da coprire l’intero arco della legislatura. Il presidente propose allora la
sua funzione di supporto a un governo diverso che, anche se formalmente
investito dalle camere, non era in un parlamento minato che traeva la sua fonte
ultima di legittimazione e lo stesso suo indirizzo programmatico. Si definì così la
categoria ambigua di un indirizzo politico vincolante al di là dei partiti e
depositato nella volontà popolare espressa nel referendum. Accanto a questo
aggancio tra la domanda popolare, trasmessa con la prova referendaria per
l’adozione di una diversa legge elettorale, e il ruolo di garanzia del capo dello
Stato, che attivava inedite funzioni di consiglio, indirizzo, proposta nel sistema
operava contemporaneamente un’altra e potenzialmente antitetica soluzione,
quella che sin dal suo insediamento lo stesso presidente aveva auspicato: una
commissione bicamerale per le riforme. Al parlamento delegittimato si rispose
con un parlamento a legittimità condizionata (legata alla riscrittura “sotto
dettatura referendaria” della nuova legge elettorale) e con una commissione
bicamerale costretta a operare in condizioni difficili e a sostanziale sovranità
limitata. Il potere costituente del referendum conviveva con il potere costituito
della commissione che, nelle sue attribuzioni, finì per essere collocata ai margini
del sistema e in una posizione di subordinazione rispetto all’opinione pubblica
interpretata dal capo dello Stato, almeno in questo in sintonia con i referendari, e
deciso a imporre la agenda del movimento all’assemblea costringendola a
garantire margini di residua funzionalità delle istituzioni. Gli elettori (quelli del
referendum, non quelli delle elezioni politiche) divennero la fonte della
legittimazione degli organi istituzionali e di un preciso indirizzo politico da
perseguire a tappe forzate combattendo le incertezze, le disillusioni, le tentazioni
di sabotaggio (per la mancanza continua del numero legale nell’autunno del
1993, dovuta alla diserzione in massa dei partiti colpiti dai magistrati e, per
ragioni opposte, dalla fuga del Msi, della Lega, dalle incertezze del Pds). Sul
piano numerico determinante, nella azione politica di salvataggio della
funzionalità delle istituzioni e di sostegno ai governi della transizione, si rivelò il
senso dello Stato di uno dei partiti maggiormente travolto dagli scandali come la
Dc16.
Senza una maggioranza politica prevalente e disposta con la dovuta coerenza a
proseguire il cammino della legislatura, toccava alla supplenza irrituale del capo
dello Stato impedire esiti del tutto catastrofici traghettando il parlamento, solo
16
La Dc perdeva il suo ruolo storico di asse centrale della politica nazionale ma non venne mai
meno una sua profonda lealtà costituzionale. Essa non riuscì a far coincidere un elevato senso delle
istituzioni con una nuova strategia politica capace di costruire alleanze e quindi in grado di risultare
competitiva con l’adozione di una diversa meccanica elettorale. La sua sconfitta fu determinata
anche dal risoluto, quanto miope, diniego del Pds di concedere una vita più lunga all’XI legislatura.
formalmente rimasto in funzione, verso un diverso assetto. Aver assicurato
funzionalità alle camere è stato un contributo più rilevante che la “trinità
istituzionale” ha portato per arginare la crisi strisciante della democrazia. Ma il
suo apporto non ha inciso nell’andamento della transizione poiché mancarono
soggetti politici in grado di guidare i processi e tenerli sotto controllo per
scongiurare l’assalto di forze esterne sleali che sempre maturano nelle fasi
critiche. Alla fine, lo stesso operato del presidente Scalfaro risultò minato nel
profondo da due istanze contraddittorie: quella della legalità, escogitata per
garantire un organico lavoro di riassetto istituzionale (auspicato con la
promozione di una commissione bicamerale) e quella della legittimità, agitata per
contenere il campo d’azione del parlamento (e farsi interprete del mandato
popolare emerso con il referendum e imporlo come un vincolante mandato
politico al parlamento e alla bicamerale). Tenere aperte due strade tra loro
alternative, quella incrementale interna, e quella della legittimità esterna
contribuì a indebolire le risorse del parlamento obbligato a lavorare in sintonia
con l’agenda referendaria (come quando nel marzo del 1993 varò la normativa
elettorale maggioritaria per comuni e province oggetto anche di una iniziativa
referendaria che tuttavia non contemplava l’elezione diretta del sindaco e del
presidente della provincia) assunta di fatto come prevalente (da qui la rinuncia
della stessa bicamerale ad avanzare ipotesi di riforma elettorale appaltate al
referendum17). Il parlamento, che ormai non funzionava più secondo una
demarcazione nitida tra maggioranza e opposizione, non seguiva con regolarità
una disciplina di voto da parte dei gruppi, fu ritenuto legittimo nel lavoro di
riforma sotto dettatura dell’istanza referendaria ma non fu considerato abilitato a
spingersi oltre nei suoi propositi riformatori. Lo stesso capo dello Stato che,
dinanzi al parlamento riunito in seduta comune (28 maggio 1992), aveva
auspicato la convocazione di una commissione bicamerale “con il compito di una
globale e organica revisione della carta costituzionale”, finì per privilegiare, data
la friabilità degli equilibri partitici non più in grado di sostenere in maniera
efficace i governi, un altro circuito decisionale rispetto a quello
infraparlamentare, il circuito Quirinale-opinione pubblica18.
Con la presidenza Scalfaro l’esposizione del capo dello Stato, già evidente con
Cossiga, è proseguita, ma ben diverso è il contesto politico contingente e
soprattutto la finalità istituzionale della presenza del Quirinale nell’arena
istituzionale19. Già nel luglio 1991, appena eletto presidente della camera, egli
sferrò un duro attacco alla comunicazione istituzionale di Cossiga. “Mi pare assai
ardito che il propugnatore di riforme costituzionali sia il capo dello Stato. Egli ha
giurato fedeltà a questa costituzione e ne deve essere per debito costituzionale
supremo garante”. Nel corso del suo viaggio presidenziale in Messico, Scalfaro
dichiarò la sua completa avversione al presidenzialismo (anche se in una
occasione egli si pronunciò per una elezione diretta del capo dello Stato con la
conservazione dei suoi attuali poteri). Il senso delle comunicazioni istituzionali di
Scalfaro era soprattutto quello di proteggere con l’autorevolezza del presidente
17
Ciò accadde sebbene nella legge istitutiva votata nel luglio del 1992 si convenisse che la
commissione avrebbe lavorato anche sui “sistemi elettorali per gli organi costituzionali”. A
determinare l’affossamento del lavoro parlamentare per le riforme di fatto fu la sentenza della corte
costituzionale che nel gennaio del 1993 rese ammissibile il referendum sulla legge elettorale. Fu
allora che Segni annunciò il suo rifiuto di partecipare ai lavori della commissione bicamerale per la
riforma elettorale perché non spettava più alle camere decidere e neppure intervenire su una
normativa di risulta direttamente applicabile come nuova tecnica elettorale (senza alcun bisogno di
un atto parlamentare per dirimere questioni complesse). In nome del “popolo legiferante” si finì per
“mitizzare la valenza dei referendum” (Napolitano, Dove va la repubblica, cit., p. 107).
18 Napolitano (Dove va la repubblica, cit., p. 96) ha parlato di una “persuasione morale” esercitata,
accanto al Quirinale, dai presidenti di camera e senato, per spingere i parlamentari a portare a
termine le necessarie riforme elettorali ed istituzionali prima di spegnere la XI legislatura. Sulla
rilevanza del rapporto con la pubblica opinione cfr. G. Pasquino, The government, the opposition
and the President of Republic, in “Journal of Modern Italian Studies”, 2006.
19 A. Baldassarre e C. Mezzanotte, Gli uomini del Quirinale, Roma-Brai, 1985.
un parlamento improvvisamente decaduto sul piano della legittimità e del
prestigio dopo le mosse giudiziarie che recapitarono 619 richieste di
autorizzazione a procedere. In una condizione di aperta emergenza toccava
proprio al più parlamentarista dei presidenti giocare un inedito ruolo politico
sorretto nella sua azione anche dai presidenti di camera e senato. La
composizione del governo Amato, il vincolo di programma dell’esecutivo, la
durata del dicastero erano stabilite dal Quirinale che così operava da supplente
nel vuoto dei partiti. Il ricorso a governi tecnici o del presidente consentì di
limitare i danni della caduta del sistema di partito e l’abilità della trinità
istituzionale fu senza dubbio quella di far proseguire il lavoro di un parlamento
“delegittimato” che garantì con regolarità il numero legale nelle sedute decisive,
e varò importanti leggi (elezione diretta dei sindaci, sistema maggioritario nei
comuni come sollecitato dai referendum, soppressione dell’immunità
parlamentare). Il governo tecnico-istituzionale affidato a Ciampi, senza neppure
il rituale ricorso alle consultazioni dei gruppi parlamentari, completò il suo
lavoro emergenziale e nel gennaio del 1994 rassegnò le dimissioni. Il radicale
Pannella, per un preciso intento procedurale di determinare un rinvio del
calendario presidenziale per lo scioglimento del parlamento, presentò una
mozione di sfiducia in modo da ottenere un dibattito in aula. Il capo dello Stato
respinse le dimissioni di Ciampi, ma con un atto per certi versi irrituale (il
governo nella pienezza dei poteri controfirmò il decreto di scioglimento), sciolse
il parlamento adducendo per iscritto le varie ragioni a supporto della decisione.
La lettera del presidente esplicitava che “il fatto di maggior rilievo è il risultato
del referendum per la sostanziale e profonda modifica del sistema elettorale
politico”. La volontà del popolo era richiamata come fonte ineludibile di una
volontà di andare al voto per verificare il consenso con nuove regole. Si stabiliva
un automatismo tra la richiesta di nuova normativa elettorale e l’immediata
applicazione delle norme in nuove consultazioni. Scalfaro, con una
comunicazione istituzionale imperniata anzitutto sulla figura dell’ethos, ossia del
carattere, del prestigio collegato all’alta dignità della carica, richiamava alcune
circostanze nuove che richiedevano il voto anticipato: l’adozione “sotto
dettatura” referendaria di una legge maggioritaria (il referendum “non manifesta
soltanto la volontà di ottenere dal parlamento una legge elettorale nuova e
radicalmente diversa dalla precedente, ma logicamente richiede anche che tale
nuova legge venga in concreto applicata”), l’emersione nelle consultazioni locali
del 1993 di un diverso quadro politico (il voto “ha evidenziato un divario molto
sensibile tra le forze rappresentate oggi in parlamento e la reiterata volontà
popolare”), il difficile lavoro quotidiano delle camere non più rappresentative del
paese (il voto amministrativo ha inciso “sullo stesso funzionamento delle camere,
la cui attività si è manifestata sempre più difficile e faticosa, e la cui forza
rappresentativa ne è risultata compromessa”). La crisi di rappresentanza e di
funzionalità del meccanismo parlamentare sollecitavano il voto anticipato per
rilegittimare la classe politica e ripristinare la piena funzionalità delle istituzioni.
Accanto a queste considerazioni sugli aspetti funzionali che alteravano la ratio
del sistema parlamentare, il presidente rimarcava il ruolo delle “necessarie e
valide” indagini giudiziarie che avevano colpito le patologie del sistema politico
ed economico-finanziario. La decisione di Scalfaro non era all’insegna di una
volontà di lotta del capo dello Stato contro un parlamento debole, ma conteneva
in fondo una propensione all’atto di scioglimento consensuale, in favore del
quale peraltro si erano dichiarate anche le opposizioni. In questa convulsa fase
politica le esternazioni del presidente furono numerose e senza dubbio si
rivelarono necessarie per fornire sponde a un sistema senza più centro politico
riconoscibile.
3. La presidenza di lotta
Non è forse del tutto irrilevante, nella valutazione del ruolo svolto dal Quirinale
nella cosiddetta seconda Repubblica, partire dal fatto che i tre presidenti della
repubblica della lunga fase seguente alla transizione del 1992-94 siano stati
espressi finora dalle forze del centrosinistra. La costante che li accomuna è in
fondo una cultura istituzionale di stampo parlamentare indotta ad adattarsi a un
contesto competitivo differente, e ciò li ha posto spesso in contrasto aperto con le
declinazioni in senso plebiscitario delle funzioni spettanti al presidente del
consiglio entro una democrazia a impianto bipolare malinteso. Con stili e modi di
reagire diversi, i tre capi dello Stato hanno dovuto gestire momenti di aspra
tensione istituzionale innescata dalle volontà di potenza della coalizione
governativa su materie delicate incentrate soprattutto sul conflitto politicamagistratura. Una invariante dell’ultimo quindicennio della storia politica italiana
è sicuramente stata quella dell’immancabile duello tra Quirinale e Palazzo Chigi
ingaggiato quasi inevitabilmente quando al governo sedeva Berlusconi e dettava
l’agenda per affrontare imprevisti di natura giudiziaria. Rituali nelle fasi di
leadership del centrosinistra (anche se non privi di richiami e severe censure
operate soprattutto da Napolitano contro l’alluvionale penetrazione della
decretazione e delle mozioni di fiducia), i rapporti tra le due istituzioni
diventavano burrascosi nelle fasi che Berlusconi, con evocazioni francesi
alquanto fuorvianti dal punto di vista formale, ha chiamato di “coabitazione” tra
due presidenti dalla diversa legittimazione e coloritura politica. Tra le evocazioni
di un plusvalore politico connesso ad una investitura diretta (mai realmente
avvenuta) e i richiami alle funzioni di controllo spettanti ai custodi della
funzionalità degli organi previsti dalla costituzione è sorta una tensione tra poteri
sconosciuta nei regimi parlamentari. Nella condizione di costituzione decentrata
e contesa sorta dopo il collasso dei partiti, si fronteggiano due pretese di
legittimità talvolta prive di mediazioni. Quella del premier il cui nome è scritto
sulla scheda e rivendica pienezza di potere, da un lato. Quella del capo dello
Stato, depositario di delicati poteri neutri di equilibrio, correzione e controllo,
dall’altro. Finora, la forma è riuscita a schivare i colpi della sostanza di una
pretesa costituzione materiale mantenendo nell’operato del Quirinale un prezioso
riferimento attivo in grado di prospettare un contenimento delle pretese del
premier legibus solutus. Non è però stato indolore l’amputazione
dell’occasionalismo politico del capo del governo. Il conflitto tra poteri era già in
auge ai tempi di Cossiga, ma in quella congiuntura era il Quirinale a affermare le
ragioni di una sostanza e a contrapporle con una forza inaudita al parlamento
visto come forma ormai svuotata di senso.
Se a ridosso del referendum elettorale Scalfaro aveva riconosciuto la portata
quantomeno materialmente costituzionale della nuova legge elettorale (la cui
approvazione era per lui motivo di scioglimento anticipato delle camere), con il
trionfo della coalizione elettorale di centrodestra egli propese verso una
interpretazione più restrittiva dell’implicazione sistemiche della normativa
elettorale e abbracciò anzi la bandiera della continuità degli organi costituzionali
non contaminati nel loro operato e nelle loro procedure dalla legislazione
maggioritaria. Con l’affermazione della coalizione guidata da Berlusconi, gli
sforzi della trinità istituzionale per scongiurare la tensione entro l’ordinamento
costituzionale si rivelarono se non proprio un lavoro vano (perché fu comunque
salvaguardata la delicata linea della continuità costituzionale) un tentativo
insufficiente a risolvere le contraddizioni imputabili agli attori politici riottosi
nell’aderire a un patriottismo costituzionale. Il timore dei partiti che li indusse a
non fornire una soluzione politica a tangentopoli (con una loro sistemica
assunzione di responsabilità sull’illecito finanziamento) e la ritrosia ad affidare al
parlamento il compito di redigere una legge elettorale organica furono motivati
dalla preoccupazione di non opporsi all’onda di un movimento inarrestabile
d’opinione che premeva sull’accoppiata repulisti-nuova tecnica elettorale. Il fatto
è che, appena qualche mese dopo il referendum, le prime consultazioni con la
formula maggioritaria svelarono l’assoluta insignificanza della frattura si o no al
quesito referendario per la determinazione delle fortune elettorali dei partiti.
Neanche la questione morale e quindi l’appoggio all’azione giudiziaria si rivelò
alla lunga decisiva: Berlusconi riuscì a conferire una continuità alla vecchia
coalizione di potere e di interesse crollata nei suoi simboli di partito ufficiali e a
inglobare a difesa dell’antico ordine proprio le forze più ciarliere contro il regime
dei “ladri”. La coalizione di centrodestra risultata vittoriosa coagulava tendenze
antinomiche e palesava, una volta insediatasi al governo, un deficit strutturale di
cultura istituzionale. Furono sfidate alla radice le aspettative riposte in una
democrazia immediata che, grazie alle tecniche elettorali maggioritarie, oltre a
favorire l’alternanza e la stabilità dei governi, avrebbe sortito il miracoloso
effetto di impiantare esecutivi più responsabili, di collegare la politica alla
società, di rimotivare il ruolo del parlamento e la funzione costruttiva e di
controllo dell’opposizione, di imporre “l’attenuazione dei conflitti e il
compromesso razionale” tra i soggetti istituzionali20. Di governo responsabile e
recettivo, come naturale conseguenza della democrazia a investitura dei governi
in virtù della competizione elettorale in collegi maggioritari, neanche l’ombra. Il
conflitto tra le forze nuove uscite trionfanti nel voto e la cornice istituzionale
eredita esplose presto in maniera incontenibile. Scalfaro non rinunciò a
ingaggiare una contesa di carattere sistemico e a portarla a termine con una
risoluta determinazione politica che non mancò di sollevare proteste. I toni della
disputa non erano dissimulati (anche nei confronti della minaccia di secessione
Scalfaro non risparmiò nel 1996 un messaggio allarmato)21.
Il conflitto tra capo del governo e capo dello Stato fu aperto, non reticente. Sul
piano della comunicazione, in Scalfaro compariva una certa predilezione per la
amplificatio retorica, per l’impiego di figure e immagini non sempre sorvegliate
criticamente ma utili per indicare bersagli e annunciare incombenti pericoli.
Evidente era anche il ricorso al movere, al richiamo alla responsabilità
istituzionale sorretto da un forte pathos quali strumenti indispensabili da
impiegare in una battaglia aperta protesa a difendere le prerogative del capo dello
Stato in merito alla dissoluzione delle camere e alla investitura del governo.
Nella comunicazione del presidente il tono enfatico e la carica suggestiva delle
immagini richiamate per condurre una battaglia senza esclusione di colpi non
occultava la disposizione all’argomentazione pacata per mostrare all’opinione
pubblica la rilevanza della posta in gioco. Dopo le prime consultazioni
maggioritarie, il sistema politico agli occhi di Scalfaro sembrò precipitare nel
vortice di una emergenza istituzionale provocata dalla conquista del governo da
parte del partito azienda di Berlusconi. Ancora una volta, per i mutamenti radicali
avvenuti nel sistema politico, il presidente della Repubblica doveva
paradossalmente ricorrere a una presenza diretta, contrastante con la funzionalità
del regime parlamentare, per sostenere proprio le ragioni del parlamentarismo.
Nel corso del suo settennato, Scalfaro dovette gestire 6 crisi di governo e spesso
A. Barbera, Rappresentanza e istituti di democrazia diretta nell’eredità della rivoluzione
francese, in “Politica del diritto”, 1989, n. 4, p. 557.
21 Alla richiesta di Berlusconi di sciogliere in anticipo le camere per sconfiggere alle urne la
defezione della Lega uscita presto dalla maggioranza, Scalfaro rispose che nel parlamento erano
comunque presenti le condizioni per un proseguimento della legislatura. “Mai, nella storia politica
e istituzionale della prima repubblica l’intervento del capo dello Stato era stato più incisivo e
determinante” (G. Mammarella, L’Italia contemporanea, Bologna, 2008, p. 542). Anche
tecnicamente, il presidente non avrebbe potuto aderire alla richiesta di Fi cioè del terzo partito in
parlamento. Diverso è la portata politica della contesa. Favorendo il costituirsi del governo Dini,
nelle forme di un governo tecnico, i cui componenti sembrava che in talune occasioni sfuggissero al
potere del presidente del consiglio di proporre il nome dei ministri, in realtà il Quirinale copriva
“una significativa funzione politica di copertura per il processo di formazione e di consolidamento
dell’alleanza di centro-sinistra” (ivi). Il quadro politico era di complessa decifrabilità: la Lega (con
il dissenso interno dei deputati vicini a Maroni) rompeva l’alleanza con FI, il PPI si sgretolava
ulteriormente con una metà raccolta da Buttiglione e orientata verso l’intesa con il centro destra e
un’altra metà disponibile al dialogo con la sinistra.
20
operando in condizioni di precarietà degli assetti politici che reclamavano per il
capo dello Stato una inventiva istituzionale da far fruttare nella capacità di
indirizzo e di garanzia. Dinanzi al primo governo Berlusconi, Scalfaro operava di
fatto come un sicuro fattore di condizionamento e anche di inibizione rispetto alle
disinvolte pratiche istituzionali imputate alla nuova legge elettorale
maggioritaria. Secondo alcuni interpreti, il premierato di fatto, introdotto con la
legge maggioritaria, andava trasformato in un esplicito regime del primo
ministro22. Il governo, che trionfava nelle urne e godeva ormai di una investitura
diversa da quella parlamentare, doveva rispondere solo al corpo elettorale e
disdegnare le transazioni dei partiti. Contro questa declinazione della democrazia
maggioritaria, come specifica forma di governo imperniata su un diverso criterio
di legittimazione, si batté con vigore Scalfaro in una ardua battaglia istituzionale
contro il governo in carica. Il Quirinale rivendicò le prerogative del capo dello
Stato e la sua possibilità di incidere nel processo politico sia nel momento di
avvio (il conferimento dell’incarico di formare il governo) sia nella fase di
chiusura della legislatura (valutare le condizioni per lo scioglimento). Un
presidente come puro e inerte potere neutro si rivelava una figura del tutto
improbabile soprattutto in condizioni politiche di elevata frantumazione e di
sfilacciamento continuo delle maggioranze. E’ indubbio che in fasi di
sgretolamento dei partiti, anche la riproposizione della funzione del presidente in
linea con l’impianto classico del parlamentarismo, comportava una esplicita
torsione attivista del ruolo del Quirinale. L’alternanza nel 1994 consegnò le
chiavi del governo a forze che Scalfaro riteneva in gran parte estranee ai valori e
ai processi storici di costruzione della repubblica.
Al parlamento degli inquisiti subentrò il governo degli alienati, composto anche
da soggetti estranei storicamente e ideologicamente ai valori costituzionali.
L’alternanza cadde dunque in un sistema che non aveva più nella costituzione un
riferimento valoriale da tutti condiviso. Scalfaro percepì questo vuoto valoriale,
la mancanza cioè di un comune sentire attorno ai principi. Nel conferire a
Berlusconi l’incarico di formare il governo, Scalfaro presentò una irrituale ed
inedita lettera con la quale il garante della funzionalità degli organi della
costituzione fissava dei limiti all’azione di un esecutivo ritenuto privo dei
normali requisiti di legittimità. Dinanzi a un governo anomalo investito da aspre
polemiche sulla stessa eleggibilità di Berlusconi per via della titolarità delle
concessioni televisive, il Quirinale pur conferendo l’incarico intendeva svolgere
una esplicita funzione di controllo con il richiamo ad una politica estera
saldamente ancorata all’Europa, con il monito al ministro degli interni perché
assicurasse legalità e unità della nazione, con il riferimento alla solidarietà
sociale quale collante delle politiche pubbliche, con l’invito a non inserire
nell’esecutivo esponenti della destra coinvolti nell’esperienza di Salò. Per la
prima volta il capo dello Stato si ergeva a tutela suprema di un ordinamento
costituzionale ritenuto minacciato da una coalizione di governo aliena rispetto ai
principi della carta del ’48. Nel corso dei sette mesi di durata del primo governo
Berlusconi il conflitto tra Quirinale e Palazzo Chigi abbracciò molteplici campi e
per far valere le ragioni del controllo attivo Scalfaro divenne il presidente più
esternatore della repubblica23. A fronteggiarsi erano un presidente
parlamentarista e un capo di governo che rivendicava la sua superiorità derivante
dalla investitura immediata degli elettori. Il populismo sul terreno istituzionale
assumeva come fondamento culturale proprio la contrapposizione drastica tra gli
istituti tecnici e di garanzia che nessuno ha eletto e il capo unto da milioni di
schede elettorali. Per il capo populista, le schede elettorali hanno impregnato
22
S. Cassese, Maggioranza e minoranza, Milano, 1996.
Tebaldi (op. cit., p. 276 e p. 298) riscontra un andamento ondivago nella tendenza ad esternare
che inizia con Pertini per poi raddoppiare in termini quantitativi con Cossiga (311 esternazioni), e
addirittura triplicare con Scalfaro (405 esternazioni). Cossiga ha il record della intensità delle
esternazioni (200 esternazioni in soli dieci mesi).
23
qualcosa di sacro, quando gli donano la vittoria, nascondono invece i segni
dell’alterazione e dell’imbroglio quando gli consegnano la sconfitta. Un senso di
frustrazione, di recriminazione permanente accompagna il leader populista. Ha
sempre bisogno di un capro espiatorio, di un senso del complotto ordito da
potenze oscure (corte di cassazione, corte costituzionale, giudici ordinari,
pubblici ministeri). Dietro la neutralità delle funzioni istituzionali, per il leader
populista si nasconde il nemico oscuro che complotta nel regno delle tenebre.
Rispetto a questo universo simbolico insidioso, la comunicazione di Scalfaro
assunse anch’essa i toni forti e polemici per affermare le ragioni salde della
continuità istituzionale violata. Sul piano del potere di controllo, egli impose al
governo lo stralcio della materia previdenziale dalla legge finanziaria così
forzando e amplificando in estrema misura il ruolo di sorveglianza del capo dello
Stato che entrava nel merito dei provvedimenti e non si limitava, nei confini di
una interpretazione non estensiva dell’istituto dell’autorizzazione, a riscontrarne
l’esistenza di evidenti profili di incostituzionalità24.
Il Quirinale respinse con forza il criterio per cui il leader, espresso dagli elettori
con un voto, non può sopportare che il parlamento cancelli l'unzione originaria.
Con puntiglio il capo dello Stato rigettò la credenza che in presenza di un
mandato ricevuto tramite il contatto immediato con il popolo, nessuna istituzione
può permettersi di calpestare l'azione del premier. Scalfaro negò qualsiasi valore
all’idea che ogni organo di mediazione o di garanzia dovesse indietreggiare
dinanzi alla pienezza della sovranità del popolo trasferita d’incanto al leader con
il nome indicato sulla scheda. Il Quirinale smontò con accanimento la finzione
giuridica in virtù della quale il capo ottiene il suo potere soltanto dal popolo e
quindi ogni condizionamento è inammissibile, provenga esso dal parlamento,
dalla magistratura, dal capo dello Stato. Scalfaro rigettò la formula per cui
soltanto il popolo può cancellare una leadership piena rispetto alla quale non è
possibile alcuna parvenza di controllo sistematico. Il garantismo costituzionale
era interpretato dal populismo come un fardello che usurpava la legittima volontà
del popolo depositata nella decisione del capo eletto. Il leader populista si
riteneva l'unico legittimo interprete di ciò che il popolo desiderava nel profondo.
Scalfaro si batté con risolutezza contro questo confuso regime del primo ministro
la cui persona, e non il parlamento, pretendeva di assorbire la certezza che il voto
popolare non sarebbe mai stato tradito. Il premier indicato per Scalfaro non
assorbiva affatto il corpo elettorale, e non era in alcun modo protetto come un
presidente irresponsabile. Il semplice fatto che il suo nome fosse noto agli elettori
prima del voto, non cancellava la necessità della fiducia esplicita del parlamento.
Sulla base del mito della elezione diretta del governo (non contemplata in alcuna
norma costituzionale), Berlusconi ritenne una sorta di golpe strisciante la scelta
del presidente Scalfaro di tener conto degli orientamenti del parlamento e non di
quelli del premier dimissionario dopo la dissoluzione della coalizione di destra e
visse come un affronto la deliberazione di consentire la prosecuzione della
legislatura con un governo diverso (varato nel gennaio 1995 con venti dicasteri
tutti a copertura tecnica e non parlamentare) presieduto da Dini, con obiettivi
circoscritti, secondo le indicazioni del Quirinale, che tornava a ricoprire una
funzione di supplenza politica25.
24
Cfr. S. Bonfiglio, Controfirma ministeriale e responsabilità politica nei regimi parlamentari,
Milano, 1997, p. 165.
25 Una grana costituzionale di grande rilevanza il presidente la dovette dirimere, quale organo
garante della normale funzionalità del sistema, in occasione della controversa sfiducia individuale
presentata contro il ministro Mancuso che, dopo la censura dell’aula, rifiutava di rassegnare le
dimissioni e sollevò il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Nel 1996 la Consulta
riconobbe che il carattere collegiale del governo e il vincolo di programma non escludevano la
legittimità costituzionale della sfiducia contro un singolo ministro e ribadì il potere del capo dello
Stato di revocarlo in caso di mancate dimissioni. Per la consulta anzi proprio l’istanza
dell’unitarietà dell’indirizzo politico comportava la possibilità di sfiduciare un singolo titolare di un
dicastero entrato in collisione esplicita con le deliberazioni di maggioranza.
In una sorta di ritorno agli albori dell’orleanismo, il governo poggiava su una
fiducia doppia: formalmente parlamentare e sostanzialmente presidenziale. Più
che la caduta in un semipresidenzialismo di fatto (permaneva l’istituto della
controfirma ministeriale) con governi tecnici rispondenti per intero al Colle, si
riscontrava un indubbio ruolo politico attivo del capo dello Stato per fronteggiare
un palese vuoto di potere e una tendenziale fibrillazione degli organi
costituzionali. Anche senza attivare un governo del presidente (già Cossiga aveva
concordato con Andreotti alcune personalità gradite cui affidare un dicastero), e
guardandosi da ogni velleità di ricorrere ad una compagine governativa allestita
in larvata contrapposizione verso il parlamento, proprio nell’esplicazione di una
funzione moderatrice e di garanzia il capo dello Stato svolgeva un ruolo attivo
nella formazione del governo possibile. Il laconico inquadramento delle
attribuzioni del Presidente, l’esistenza cioè di una figura istituzionale coperta da
una scarsa normativa di riferimento, consentirono al Quirinale un efficace
intervento per innescare un propulsore imprevisto in un sistema altrimenti
farraginoso e di operare con un formato provvisorio in attesa della graduale
maturazione di altri equilibri dopo il voto ormai imminente. Secondo una
polemica ancora rovente, il ribaltone cancellava l’effetto del voto popolare e
impiantava un governo degli abusivi che impediva di tornare subito alle urne per
ripristinare la pienezza di un potere legittimo. La confusione che nella contesa
teneva banco era quella tra il piano politico (sarebbe auspicabile per la
funzionalità del sistema un governo rispondente alle indicazioni degli elettori) e
l'ambito istituzionale (non esiste per il parlamento alcun divieto a fare e disfare
governi graditi dalla maggioranza in aula). Scalfaro ribadì con puntualità che nei
sistemi parlamentari è solo la fiducia delle camere a impiantare i governi e
pertanto sono possibili tutti i governi che ottengono il voto favorevole dei
deputati. Non c'è per questo nessun obbligo di scioglimento delle camere, quando
il governo cade per le sue debolezze congenite e nel parlamento sono possibili
altre maggioranze anche se non omogenee o precostituite. Nel caso di
Berlusconi, egli era fra l’altro alla testa di un partito che, in termini di seggi, era
solo il terzo in parlamento e in ragione di ciò mai avrebbe potuto pretendere
l’anticipata chiusura della legislatura. La specificità del regime parlamentare del
resto è sempre stata quella di essere duttile, di poter sfornare soluzioni dinamiche
senza ingessare con norme vincolanti il sistema fino a bloccarlo nelle fasi più
critiche26. Il capo dello Stato avrebbe violato la costituzione proprio se avesse
accolto la richiesta di scioglimento minoritario delle camere avanzata da
Berlusconi in lotta contro la volontà della maggioranza parlamentare.
Nei regimi parlamentari non è possibile, sulla scorta dell’ordinamento vigente,
uno scioglimento di lotta, che vede il presidente dissolvere le camere contro la
volontà della maggioranza disponibile a sostenere altri esecutivi. Scalfaro
rivendicò il carattere presidenziale del potere di scioglimento non tanto come una
prerogativa personale (era comunque accertata la volontà della maggioranza
parlamentare di varare un nuovo governo) quanto come un dispositivo di lotta
contro una esplicita e non ricevibile richiesta del capo del governo dimissionario.
Era nel complesso compatibile il ruolo esercitato da Scalfaro con quanto previsto
dalla costituzione che prevede soltanto lo scioglimento di maggioranza27.
Soprattutto con il tentativo di varare il governo Maccanico prima di andare al
voto, il Quirinale cercò di giocare una carta (fallita per i discordi orientamenti del
26
Su questo carattere del parlamentarismo, come arena deliberativa che favorisce integrazione e
legittimazione, cfr. J. J. Linz e A. Valenzuela (a cura di), Il fallimento del presidenzialismo,
Bologna, 2005. Sulle diverse modalità di intervento attivo dei presidenti, talvolta approdate ai limiti
di una diarchia, cfr. A. Baldassarre, C. Mezzanotte, Gli uomini del Quirinale, Bari-Roma, 1985.
27 Il presidente Scalfaro influì molto nella risoluzione di tre delle sei crisi di governo registratesi nel
corso del suo mandato intervenendo in modo attivo sulle linee programmatiche, sulla composizione
degli esecutivi (S. Grimaldi, Presidenti, in M. Almagisti e D. Piana, a cura di, Le parole chiave
della politica italiana, Roma, 2011).
parlamento in merito ad una soluzione ispirata al semipresidenzialismo) per
allestire un governo tecnico la cui forza di legittimazione proveniva dal capo
dello Stato più che dalla fiducia dei partiti28. Nel complesso Scalfaro ha oscillato
tra compiti di supplenza in fasi di sfaldamento della cornice politica, di esplicita
conflittualità con esecutivi percepiti come potenzialmente sleali, di supporto a
mansioni di distaccato tutoraggio verso governi amici maturati in condizioni di
relativa stabilizzazione degli equilibri bipolari.
Con le consultazioni del 1996 (che si svolsero in un clima di par condicio nella
presenza delle forze politiche nel sistema radiotelevisivo fortemente sollecitato
da Scalfaro) si verificò una alternanza di governo e con il successo di una
maggioranza di centrosinistra anche il ruolo del capo dello Stato rifluì negli spazi
più consoni ad un organo di garanzia della prevedibile funzionalità degli istituti.
Nella stagione del bipolarismo la consuetudine ha condotto ad una relazione
esplicita del governo con la dimensione elettorale ha confinato in una mansione
di mera ratifica l’operato del Quirinale. Tuttavia, anche negli anni dell’Ulivo e
del cosiddetto governo eletto dai cittadini, non sono mancate crisi di governo con
il ripristino di una qualche attività presidenziale. Trattandosi però di crisi senza
cambi di coalizione, esse non hanno resuscitato il potere presidenziale di tessitore
abile che predilige intervenire come discreto regista della politica capace di
favorire l’evoluzione di condizioni sistemiche ancora indefinite. Poiché le crisi
erano interne alla coalizione, e non evocavano una rottura degli equilibri sorti
negli appuntamenti elettorali, la funzione del capo dello Stato (anche quando
conferì un disperato reincarico al Prodi dimissionario dopo il voto di sfiducia)
rimaneva ben circoscritta nel suo alveo e in gran parte sembrava limitata alla
paziente cucitura per la conservazione della coesione della maggioranza. Nei
regimi parlamentari, in taluni frangenti particolarmente agitati di fluidità politica,
si rivela prezioso l’apporto di una figura rappresentativa e lontana dai giochi
politici alla quale affidare, in passaggi caotici con gli equilibri politici ancora in
gestazione, dei delicati compiti di decantazione e di garanzia nel funzionamento
degli apparati di governo. Anche se si accentuava l’investitura elettorale della
carica monocratica, non si eliminavano d’un tratto le condizioni della vita
parlamentare con le sue imboscate, le sue repentine cadute di leadership, le sue
difficoltà di tenuta delle coalizioni eterogenee. La semplificazione delle
improponibili liturgie tipiche dell’età d’oro del parlamentarismo (consultazioni al
Quirinale, incarichi esplorativi) non comportava la completa scomparsa del ruolo
innovativo del capo dello Stato da esplicare in talune situazioni di blocco del
sistema politico o di incertezza sulla tenuta degli equilibri esistenti. Non si
trattava certo di insidiare il mandato popolare con la copertura di esplicite
funzioni politiche da parte del capo dello Stato. Ma la presenza di un rapporto di
investitura tra elettori e governo non significava affatto che la legislatura non
potesse precipitare in condizioni delicate per l’usura della maggioranza, per
l’emersione di condizioni politiche inedite. In tali casi, il potere presidenziale,
dormiente al cospetto dell’apparente mandato polare riversato sul premier, si
risveglia nelle forme interventiste inaugurate già con Gronchi (che usò il potere
di incarico per inserirsi nei giochi tipici aperti dopo la crisi di un governo e per la
indicazione di un altro esecutivo da lui gradito, come quello di Zoli, per la
formazione del quale si espose in pubblico fino alla richiesta di un voto
favorevole da parte delle camere).
Le emergenze che esplodono nei sistemi politici vanno affrontate con risorse
interne all’ordinamento (il capo dello Stato è fra queste) e non con continue
consultazioni elettorali che potrebbero rendere vulnerabile le capacità di risposta
delle istituzioni. Esistono pertanto intereventi interni di tipo adattivo-funzionale e
28
Questa fase è stata da taluni descritta come inaugurazione di un momento di
semipresidenzialismo di fatto (cfr. G. Rebuffa, Verso il presidenzialismo, in M. Fedele e R.
Leonardi (a cura di), La politica senza i partiti, Roma, 1996.
interventi esterni che inaugurano un autonomo circuito aperto al coinvolgimento
del pubblico. Negli anni della sua presidenza, oltre a interventi adattivi,
funzionali al rilancio delle prestazioni della macchina istituzionale, Scalfaro
diede luogo anche a interventi esterni con una tentazione di lanciare alcuni
segnali destinati all’opinione pubblica. Una certa propensione a proporsi come
interprete dell’opinione pubblica è stata espressamente rivendicata da Scalfaro
nella lettera con la quale ha motivato la mancata firma a un provvedimento sul
finanziamento ai partiti. Tuttavia gli anni di Scalfaro videro, nelle politiche
istituzionali della presidenza, la netta prevalenza delle preoccupazioni interne
maturate sulle necessità di approntare un supporto alla funzionalità delle
istituzioni rispetto alla ossessiva ricerca della accettazione della pubblica
opinione di un autonomo progetto politico del capo dello Stato.
4. La moral suasion e il Quirinale
Nelle elezioni del 2001 si è registrata la seconda affermazione di Berlusconi. Il
suo governo proseguiva nella prolungata offensiva contro gli istituti di garanzia
responsabili di atti non graditi e nella caparbia emissione di leggi ad personam. A
fronteggiarlo stavolta non era più un presidente di lotta come Scalfaro, che non
disegnava per la suprema autorità dello Stato, votata quasi per definizione alle
asettiche figure dell’unità, il recupero polemico della parzialità combattiva in
difesa delle istituzioni. Al Quirinale era stato eletto Ciampi che, votato in modo
bipartisan sin dal primo scrutinio, assumeva l’impegno programmatico di
rappresentare l’unità dell’ampio schieramento che aveva concorso alla sua
elezione. Salito a ruoli politici di governo quando la crisi italiana invocava
competenza e copertura tecnica in luogo della politica decaduta, Ciampi
appariva, per esperienza e profilo personale, alquanto spiazzato dinanzi alla
curvatura demagogica e plebiscitaria assunta dalla politica. La crisi italiana non
ha condotto alla soluzione tecnocratica bensì alla deriva leaderistica e populista
per arginare la quale, questo anche è il senso del messaggio presidenziale del
2002 sui temi del pluralismo e della imparzialità dei media, occorreva impostare
un preciso profilo giuridico dell’informazione. Nelle sue comunicazioni Ciampi
non adottava, a differenza di suoi predecessori, uno stile rivolto alla costruzione
di un consenso di tipo plebiscitario attraverso il supporto dei media alle
esternazioni infinite. Il suo richiamo alla comunità, alla patria, alla bandiera
erano nel complesso corredati da un retorica mite che rivolgeva il prestigio verso
le istituzioni più che alla persona. Il suo nazionalismo controllato e i simboli
stessi della bandiera non assumevano i tratti propri delle soluzioni mitiche e
plebiscitarie destinate ad accompagnare culti irrazionali per il carisma.
Preoccupato dal tragitto italiano, che procedeva verso il federalismo per
smembramento e per caotica disarticolazione del vecchio ordinamento, attraverso
un modello confuso che presentava la commistione di elementi territoriali e di
componenti culturali, Ciampi richiamava la forza unificante del simbolo
nazionale per lui mai appassito.
La riforma costituzionale del 2005 imposta dalla sola maggioranza mostrava la
difficoltà di convivere in un bipolarismo in cui la maggioranza politica
occasionale tendeva a convertirsi in maggioranza costituzionale in grado di
imporre svolte radicali all’ordinamento. Gli elementi disfunzionali presenti sin
dal 1994, quando comparve un sistema profondamente diviso sulle regole
fondamentali, non erano stati arrestati e per questo toccava al presidente calibrare
un ruolo peculiare difficilmente predeterminato da un tracciato procedurale già
dato. Convivere senza condividere valori è diventata la consuetudine del sistema
politico bipolare scaturito dalla crisi degli anni ’90 incapace di prospettare un
senso del limite nel terreno istituzionale. Da questa fragilità di un bipolarismo
aggressivo e poco incline a riconoscere un qualche ambito cooperativo
derivavano le funzioni accresciute del presidente della repubblica che doveva a
più riprese ampliare il ventaglio della discrezionalità degli interventi. Il problema
del capo dello Stato entro la cornice sfibrata del bipolarismo non era se
intervenire ma in che misura circoscrivere un intervento non rinviabile. Alla
consuetudine di convivere senza condividere, ad essa si ricollegava anche la
velleità di imporre riforme della costituzione a colpi di maggioranza, non poteva
che innalzarsi il ruolo simbolico e l’aspettativa risolutrice in una presa di
posizione del capo dello Stato. Con l’occasionalismo costituzionale, i partiti
strapazzavano di continuo le metaregole come terreno condiviso e imponevano
rotture formali tramite il principio di maggioranza. Al Quirinale non restava più
il tradizionale riserbo e la riduzione del ventaglio di intervento ma si imponeva la
sovraesposizione assumendo stili di intervento elastici ma continuativi. La
costituzione contesa diventava così la ragione dell’ingresso sempre più marcato
del capo dello Stato come parte del gioco politico. Le maggioranze si gonfiavano
con propositi di costituzionalizzazione degli appetiti partigiani e il sistema si
incamminava verso una completa decostituzionalizzazione per impedire la quale
il capo dello Stato doveva affrontare il peso del confronto politico. Con il
governo Berlusconi si sviluppava un tentativo esplicito di ridimensionare il ruolo
del capo dello Stato come insopportabile figura di garanzia. Ma a questa
tendenza si opponeva un’altra si segno contrario che implorava un rafforzamento
del coinvolgimento correttivo e sanzionatore del presidente.
Il compito di supremo guardiano dei valori costituzionali dell’unità veniva da
Ciampi interpretato con una scrupolosa attenzione alla procedura. Alla
assunzione immediata di un volontà di arresto di un processo politico
irragionevole, egli preferiva una risposta più duttile che esaltasse la vocazione
alla estraneità del presidente al rumore del conflitto politico ma non alla
sottomissione supina. Gli strumenti comunicativi che egli adottava non
privilegiavano per questo la denuncia delle difficoltà istituzionali, non
prendevano cioè di petto gli atti censurabili della maggioranza ma suggerivano in
ogni momento concordia, responsabilità comune. Il quadro politico che aveva
assegnato alla destra una maggioranza ampia e piuttosto compatta non consentiva
al Quirinale delle soverchie possibilità di inserimento nella decisione sulla
politica, con la velleità di suggerire altri indirizzi programmatici o impedire
scelte discutibili. La consistenza numerica della maggioranza decurtava lo spettro
dei poteri presidenziali e Ciampi doveva rientrare in una ottica più dimessa ma
non inoperosa e passiva. Gli attacchi di piazza contro l’insipida debolezza
dinanzi alle “leggi vergogna” rimpiangevano il garantismo costituzionale attivo
esercitato da Scalfaro, che però con le sue mirate esternazioni aveva dietro di sé
un potere ben superiore di interdizione e manovra per via delle incertezze
numeriche delle maggioranze. Lo scarto tra il lessico di Ciampi proteso all’unità,
alla comune responsabilità e la pratica di governo proiettata verso soluzioni
particolaristiche era fin troppo evidente. In nessun sistema l’alternanza produce
effetti positivi se persiste a lungo una situazione di mancanza di valori
costituzionali condivisi dagli attori più rappresentativi. Quando le condizioni
basilari del sentire comune sfumano, anche la connotazione bipartisan che il
capo dello Stato intende conferire al proprio mandato rischia di rivelarsi
ingannevole. L’alternanza senza patriottismo costituzionale in effetti presentava
insidie e minacce per un sistema politico fragile e destrutturato e quindi nella
sostanza poco adatto a comprendere le ragioni delle programmatiche ambizioni
del Quirinale di essere super partes. Rinunciando a atti di discrezionalità e a
momenti di intervento dal significato politico, Ciampi prospettava un ruolo
degno di un sistema stabilizzato e maturo e poco in sintonia con le croniche
debolezze della politica italiana minacciata da dispute senza tregua. L’alternanza
e la democrazia di investitura producevano costi elevati anche per gli istituti di
garanzia perché il sistema politico non esprimeva un sentimento comune attorno
alla custodia delle regole.
La richiesta pressante che giungeva a Ciampi dalla piazza, in condizioni
politiche che vedevano una maggioranza molto solida sul piano numerico e sorda
ad ogni senso del limite, era quella di farsi interprete di un nuovo ruolo del
Quirinale, quello di fungere da elemento di garanzia degli spazi appannati
dell’opposizione in un momento di costituzione sguarnita per l’inesorabile logica
maggioritaria. Non che Ciampi rinunciasse ad esternare e a intavolare un
rapporto con i media, ma i suoi interventi svicolavano rispetto ai nodi della
battaglia politica e istituzionale perché al presidente spettava pur sempre di
svolgere una parte se non attiva quanto meno non ostile pregiudizialmente al
governo nella determinazione dell’indirizzo politico. La inedita situazione
reclamava per molte voci dei movimenti collettivi un capo dello Stato che, forte
dei suoi poteri formali e delle sue risorse informali, scendesse su un piano di più
intransigente difesa delle prerogative costituzionali. Ciampi non ha indossato
questa maschera di lotta, che per certi versi gli apparve anche irrealistica dinanzi
a una maggioranza numerica che non lasciava spazio ad agevoli recuperi di
funzioni arbitrali o addirittura di supplenza. Il Quirinale preferì assumere una più
dimessa prospettiva di mediatore discreto verso gli sconfinamenti della
maggioranza ma non per questo il suo contegno era avvertito come meno
rigoroso nel sorvegliare la corretta distribuzione tra i vari organi delle diverse
funzioni normative. Soprattutto in alcuni delicati frangenti, Ciampi non ha esitato
ad assumere atteggiamenti non negoziabili avvalendosi con rigore dei poteri
concessi dalla costituzione (rinvio, messaggio). Gli effetti di tali provvedimenti
sul piano della legislazione si sono rivelati piuttosto esigui poiché il richiamo del
presidente a solenni principi costituzionali condivisi non ha trovato sempre
orecchie sensibili nella maggioranza di governo decisa ad andare avanti spedita
accordando nel migliore dei casi solo marginali aggiustamenti linguistici ai testi
(sull’ordinamento giudiziario e sul pluralismo del sistema radiotelevisivo). In un
contesto di grave dimagrimento della cultura costituzionale nella determinazione
responsabile dell’indirizzo politico secondo lo spirito della separazione dei
poteri, il bene dell’alternanza si accompagnava con l’incertezza sul destino delle
regole fondamentali colpite da calcoli di mera convenienza e da atteggiamenti
sordi rispetto alle esigenze di reciproca indipendenza degli organi costituzionali.
Dinanzi ad una maggioranza che deponeva la differenza tra legge costituzionale e
legge ordinaria, la dottrina della moral suasion (abbozzata già da Cossiga ma
perfezionata da Ciampi come relazione informale e riservata che si esplica con
poteri di consiglio elargiti in corso d’opera per evitare in anticipo palesi
distorsioni normative29) se non urtava contro le esigenze di garantire la
speditezza dell’indirizzo politico, cui neanche il Quirinale poteva a rigori
ritenersi insensibile, non appariva particolarmente vigoroso per conservare
l’essenza del costituzionalismo. Nel corso del bipolarismo senza regole valoriali
condivise, il sistema politico ha presentato carenze strutturali che hanno ostruito
l’organizzazione delle forme del governo secondo parametri di reciproco
intreccio ed è apparso sovente senza degli efficaci argini legali, con deboli
funzioni di controllo e di garanzia cui si proiettavano attese crescenti e
miracolistiche.
Vulnerabile su più fronti, il governo ha dovuto spesso ricorrere ad una sorta di
coabitazione non competitiva con il Quirinale che ha esercitato una supervisione
sui punti più critici dei disegni di legge anticipando in corso d’opera le possibili
obiezioni formali e ottenendo gli aggiustamenti minimi per impedire un contrasto
esplicito. In taluni passaggi, la partecipazione indiretta del capo dello Stato come
soggetto costituzionale alla definizione di cruciali aspetti dell’indirizzo politico29
Sui rischi del presidente come influente colegislatore che con un controllo ex ante interviene per
ragioni di legittimità o di merito nel percorso decisionale, ricorre all’irrituale promulgazione con
riserva e attenua la estraneità dall’indirizzo legislativo pur di stemperare conflitti tra esecutivo e
giudiziario o aspri scontri in aula cfr. G. Pasquino, La presidenza Ciampi, in J. Blondel e P. Segatti
(a cura di), Politica in Italia, Bologna, 2003, pagg. 115 sgg.
legislativo diventava esplicitamente un coinvolgimento diretto all’assunzione di
norme controverse. Dal controllo ex post del disegno di legge, il capo dello Stato
passava così ad un rischioso al controllo ex ante (con le correzioni preliminari
apportate alla legge Cirami, ad esempio) ossia alla sostanziale condivisione
dell’iter legislativo limato dalle più appariscenti asperità e quindi reso immune da
censure più rilevanti. In tal modo però il capo dello Stato si immetteva di peso in
un terreno scivoloso nel quale tendeva a sfumare la distinzione tra l’operato
nell’ambito dell’indirizzo politico, che compete anche al presidente quale
collante dell’unità nella distinzione degli organi costituzionali, e l’intervento nel
settore specifico dell’iniziativa legislativa che è invece pertinenza esclusiva del
circuito parlamento-governo30. Dinanzi alle proteste suscitate da leggi
controverse, Ciampi dichiarava che il presidente era silente ma non assente. Non
solo evitava esplicite tensioni con un governo che rivendicava una legittimazione
qualitativamente superiore a quella di qualsiasi altro potere ma compiva anche
atti inediti come quello che lo vide presentarsi in una conferenza stampa con il
capo del governo. A una disinvolta pratica di governo che si mostrava sordo
verso le regolazioni formali per imporre norme controverse, Ciampi non
rispondeva con l’energia di Scalfaro ma con la dottrina flessibile della
indicazione morale discreta e con i suggerimenti preventivi tesi ad ammorbidire
talune soluzioni legislative depurandole dalle eccessive mire particolaristiche che
le avrebbero rese irricevibili31. L’attività del capo dello Stato e il suo più ampio o
più marginale coinvolgimento nella titolarità del potere di indirizzo politico più
che alla forma erano situate in una zona ibrida in cui forma e politica si
intrecciavano e si mostravano connesse alle caratteristiche del sistema di partito,
all’impatto della legge elettorale, al connotato del pluralismo sociale esistente,
alla ampiezza del ventaglio dei compiti degli organi di garanzia. Le predilezioni
lessicali di Ciampi per la responsabilità, la coesione, la convergenza e l’unità agli
occhi dei suoi critici urtavano contro il reale esercizio del potere che tendeva a
saltare controlli e condizionamenti formali per spingersi verso i lidi dell’abuso. Il
suo linguaggio privo di grandi ornamenti non riteneva utile assumere le vesti
polemiche recuperate da Scalfaro con parole talvolta calde e coinvolgenti che
non cercavano affatto di simulare o dissimulare i contrasti. La misura, il contegno
dell’ethos presidenziale suggerivano a Ciampi moderazione nei toni, cautela nei
rilievi, ponderazione nelle scelte. La discrezionalità del potere di intervento del
capo dello Stato indicava un ruolo elastico che nelle sue diverse manifestazioni
dipendeva da variabili esterne, legate ai rapporti politici che ampliavano o
restringevano le opportunità di inserimento del capo dello Stato nella gestione
reale delle politiche, dei meccanismi di genesi e crisi dei governi. Poiché ogni
terreno valoriale comune mancava tra gli attori, i richiami presidenziali alla
responsabilità sfumavano nel vuoto e non trovavano alcuna reale efficacia
nell’incidere nella scelta normativa. L’esercizio super partes del cruciale ruolo
di custode dei meccanismi di produzione delle regole faceva riemergere con la
presidenza Ciampi la dottrina della moral suasion declinata come uno strumento
sofisticato che attutiva i toni della polemica per accrescere la fiducia nelle
istituzioni e come unica prerogativa del Quirinale per ammorbidire l’asprezza di
atti unilaterali o sleali della maggioranza di governo cui nondimeno spettava la
funzione di indirizzo politico32. Mancava nel costituzionalismo italiano un
30
Sulla distinzione tra indirizzo politico e funzione legislativa cfr. T. Martines, Diritto
costituzionale, Milano, 1997, p. 200.
31 Si è in tal senso parlato di una “presidenza della normalizzazione maggioritaria” (Tebaldi, op.
cit., p. 283).
32 Sul tema insiste G. Sartori, Mala tempora, Roma-Bari, 2004. Ciampi non ha esitato a ricorrere ad
un aspro scontro istituzionale (sulla titolarità del potere di scioglimento su cui laconico e duttile è la
copertura costituzionale) quando, in prossimità della scadenza del mandato, si creava un ingorgo
istituzionale per cui si sarebbe dovuto andare al voto ad agosto. Alla richiesta di uno scioglimento
anticipato, il governo rispose che al parlamento toccava proseguire i lavori per approvare la legge
apprezzamento positivo del conflitto istituzionale come dato fisiologico richiesto
in taluni frangenti altamente simbolici proprio per la conservazione della
separazione dei poteri dinanzi alla elusione delle regole da parte delle
maggioranze che, in nome del rapporto di fiducia originario che le legava al
popolo e le autorizzava quindi a incarnare l’unicità della funzione dell’indirizzo
politico, escludevano la rilevanza dell’apporto di altri organi ritenuti a legittimità
senz’altro inferiore in quanto non elettivi. Esistono poteri cosiddetti neutri
(nomina, rinvio, messaggio) che vanno esercitati (magari non nel senso di
Cossiga, che in due anni tra il 1990 e il 1992, operò come una sorta di
contropotere permanente che rinviò 15 leggi)33 contro gli abusi della
maggioranza altrimenti la funzione di sorveglianza dell’equilibrato intreccio dei
poteri plurali contemplati nella costituzione si addormenta e scricchiola il
delicato equilibrio dei poteri che il capo dello Stato deve garantire proprio perché
non inserito nel circuito della rappresentanza elettiva. Conservare una reciproca
condizione di indipendenza tra i vari organi dello Stato, sia pure in presenza di
una disparità sul piano della loro fonte di sovranità e dell’istituzione del rapporto
fiduciario, è il problema cruciale del parlamentarismo alla cui soluzione il
presidente è chiamato a collaborare.
Ciampi ha attivato il suo potere di messaggio e di rinvio in occasioni
simboliche che non potevano lasciare indifferente un custode delle regole civili.
In occasione di norme di riforma che accentuavano il conflitto con il potere
giudiziario, Ciampi si avvalse del potere di rinvio alle camere. Il 16 dicembre del
2004 il presidente riscontrò molteplici profili di incostituzionalità alla legge da
promulgare. Il primo aspetto controverso concerneva l’attribuzione al
guardasigilli del potere di rendere delle comunicazioni alle camere in merito alla
linee annuali di politica giudiziaria. Secco fu il richiamo di Ciampi al riguardo:
“la norma approvata dalle camere configura un potere di indirizzo in capo al
ministro della giustizia che non trova cittadinanza nel titolo IV della costituzione,
in base al quale l’esercizio autonomo e indipendente della funzione giudiziaria è
pienamente tutelato”. Il secondo profilo di incostituzionalità, e di stridente
violazione dell’autonomia e indipendenza della magistratura, traspariva nella
istituzione dell’ufficio per il monitoraggio dell’attività dei magistrati presso ogni
direzione regionale o interregionale. Il terzo rilievo di incostituzionalità colpiva
la sottrazione alla Consulta del conflitto di attribuzione tra i poteri che veniva
dislocato altrove con il previsto conferimento alla giustizia amministrativa.
Quarto tassello era secondo Ciampi l’incostituzionale affidamento a commissioni
esterne al Csm di compiti relativi alle assunzioni e ai trasferimenti dei membri
dell’ordinamento giudiziario34. Anche sul terreno delicato della libertà di stampa
e sull’assetto del sistema radiotelevisivo il Quirinale ha lanciato significativi
avvertimenti al governo e ha invocato soluzioni legislative più coerenti con il
pluralismo. Il compito del capo dello Stato diveniva arduo. In sistemi molto
polarizzati e con profonde fratture culturali “la perdita di un linguaggio comune e
di concetti condivisi equivale a una perdita del senso di comunità politica, di
risorse retoriche e dialogiche”35. Proprio questo era il clima che spesso scandiva i
passaggi del bipolarismo italiano abitato da soggetti fragili e con una scarsa
condivisione di valori costituzionali comuni. La moral suasion, recuperata in tali
circostanze conflittuali, non poteva che girare nel vuoto perché si appellava a un
cosiddetta Pecorella che il Capo dello Stato aveva invece rinviato alle camere. Cfr. C. De Fiores,
Brevi considerazioni sul potere di scioglimento, in “Costituzionalismo.it, 2006, n. 1.
33 Tra il 1994 e il 2010 si sono verificati 15 casi di impiego del potere presidenziale di rinvio:
Ciampi ha rinviato 8 leggi, Scalfaro 5, Napolitano una soltanto. Prevalenti risultano essere
considerazioni relative alla copertura finanziaria anche se non è agevole un modello interpretativo
di merito o di procedura (Grimaldi, Presidenti, cit., p. 180).
34 Sulla incostituzionalità di sistema della riforma della giustizia cfr. M. Dogliani e I. Massa Pinto,
La crisi costituzionale italiana nell’attuale fase della lotta per la Costituzione,
“Costituzionalismo.it”, Napoli, 2011, p. 904.
35 March e Olsen, op. cit., p. 216.
senso di responsabilità e a un sentimento del limite che solo una condivisione
profonda di norme costituzionali e di procedure avrebbe potuto favorire. La
moral suasion supponeva un dialogo, una propensione alla condivisione come
meta regola da porre alla base dei processi di deliberazione, non lo creava ove
questo atteggiamento negoziale latitasse del tutto. Il rischio di questa pratica è
stato sovente quello di sviluppare una preventiva riconduzione dei poteri di
controllo del presidente al semplice esercizio di una opinione dissenziente di per
sé disarmata. La figura del presidente etico, che consigliava una maggioranza
riottosa ad introiettare regole e valori fondamentali, ed elargiva apprezzamenti
preventivi sui testi più controversi, indeboliva in taluni passaggi i poteri di
garanzia del corretto ed equilibrato intreccio dei poteri e di indirizzo politico
appannaggio del Quirinale. La politica in tempi bipolari non era affatto una
omogenea comunità interpretativa che vedeva gli attori più influenti ragionare
con lungimiranza sulle decisioni collettive nel completo disinteresse e nella
condivisione dei significati rilevanti dell’agire. Per questo era assai difficile per il
capo dello Stato far funzionare nel corso delle loro esternazioni la distinzione tra
discorso politico, inteso come dibattito attorno a ciò che è controverso e divide le
parti nello scontro, e comunicazione istituzionale, assunta come meccanismo di
oliazione della macchina istituzionale. Anche sotto la presidenza Ciampi era
saltata questa demarcazione. Nelle esternazioni del presidente prevaleva un
registro linguistico statico, molto sentito era il luogo istituzionale come centro
nevralgico di prestigio, affidabilità. Il simbolo unificante della nazione, la
solennità delle radici storiche della patria, suggerivano un linguaggio delle
istituzioni sobrio, sorvegliato e non privo di impennate retoriche e di trovate
auliche. Il discorso del capo dello Stato seguiva tecniche e percorsi collaudati e
rivelava valori espressivi imbevuti di tradizionalismi, di solenne aulicità nel
tentativo di abbozzare in pubblico una rivisitazione della identità civile che
accanto alla forte accentuazione dei miti fondativi e della memoria
(reintroduzione della festa della repubblica, istituzione della festa del tricolore)
contemplava anche la comprensione per i caduti dalla parte sbagliata (con la
visita a El-Alamein del 2002). Patria, inno, tricolore, Vittoriano erano i valori
simbolici privilegiati per sedimentare un patriottismo assente. Anche le parole
più cariche di pathos in Ciampi contenevano un invito al dialogo come cemento
di un bipolarismo meno centrifugo e in esse l’inclinazione informativa non
risultava mai del tutto soverchiata dalla costruzione retorica ed emozionale.
Comparivano nei suoi discorsi ufficiali espressioni e toni moraleggianti
recuperati per conferire pregnanza al ruolo di supplente etico-politico ricoperto
dal Quirinale. Con la presidenza anche Ciampi acquisiva un amore per la parola:
“vedete, per decenni ho parlato poco, credevo che questa fosse la mia natura.
Evidentemente sbagliavo, forse non mi conoscevo bene”. Sovente per richiamare
le parti ad un confronto più consono alle forme di una democrazia matura egli
cadeva in un discorso non privo di artificiosità e di qualche pesantezza
espressiva. Tuttavia lo stile argomentativo di Ciampi seguiva il primato della
risorsa logica, e la sua oratoria era sorretta da una inclinazione alla
determinatezza quale ingrediente di una democrazia bipolare meno gridata e più
capace di buona argomentazione.
Le scelte auliche predilette in contesti espressivi in cui comparivano toni
enfatici contenevano certo pathos ma in una proporzione contenuta, non
alternativa cioè all’oggettività delle cose e alla solidità dei fondamenti analitici
delle decisioni. Il codice linguistico di Ciampi, imperniato di evocazioni all’unità
come supremo valore costituzionale, s’imbatteva in sperimentalismi istituzionali
di un gambero federalista che procedeva all’indietro, per smembramento, e a
dispetto della patria invocata confidava sull’invenzione di tradizioni spesso
inesistenti. Alla patria richiamata dal Quirinale come fondamento del sistema
bipolare rispondeva un governo che disegnava una forma di Stato che esaltava la
differenziazione territoriale e rispolverava le identità del tutto sprovviste di reale
ancoraggio storico delle piccole patrie regionali. Ai solenni richiami presidenziali
alla coesione e alla integrazione seguivano i disegni di un federalismo posticcio
che intendeva solo ratificare l’esistenza di territori più veloci. Nella
comunicazione istituzionale di Ciampi risuonavano le parole canoniche del
risorgimento e le figure della patria sia pure in un quadro argomentativo che
prediligeva percorsi sorvegliati di persuasione tramite il pacato ragionamento. Gli
appelli del presidente alla patria, alla coesione e le sue stesse pratiche contrattuali
attivate con una maggioranza aggressiva si scontravano irreparabilmente con
tempi in cui tra le culture politiche non si notava alcun riconoscimento dello
spazio istituzionale comune. Ciampi adottava uno stile che postulava, al dispetto
dei rudi fatti, la comunità di comunicazione tra i partiti e le istituzioni, la
condivisione dei linguaggi tra gli attori. Le sue scelti lessicali contrapponevano
ragione e interessi particolari, doveri e tornaconti e dosavano elementi aulici e
codici tecnici ed economici. L’autorità di chi parla, l’ethos di un presidente eletto
con un voto quasi unanime, era invocata a sorreggere il discorso e a rendere più
incisivi i rilievi adombrati per rimotivare un rispetto dei luoghi istituzionali. Il
codice linguistico imperniato sui valori dell’unità e della coesione si infrangeva
talvolta urtando contro una rude pratica dell'occasionalismo politico, che
declassava di rango la costituzione riducendola a legge ordinaria e quindi a
momento di conflitto. In assenza di una normatività riconosciuta alla
costituzione, che comportava anche conseguenze di valore sul piano simbolico e
politico, veniva a mancare ogni sfera sottratta al conflitto e la moral suasion
poteva apparire come un autentica fabbrica del dover essere propedeutica al
disarmo preventivo. Fino a quando la costituzione stessa era ridotta a cosa di
maggioranza, non era disponibile un bipolarismo responsabile, che suppone
sempre una contesa politica aperta nella condivisione di regole fondamentali di
sistema.
Il disegno di revisione costituzionale tratteggiato dalla maggioranza, quando
suggeriva l’abolizione del potere presidenziale di autorizzazione dei disegni di
legge del governo, prospettava una ulteriore perdita della capacità del sistema
istituzionale di controllare l’esercizio delle funzioni di governo. Tutto ciò che
lambiva il terreno dell’indirizzo politico di maggioranza veniva prosciugato
definendo il capo dello Stato come una figura molto sbiadita di custode delle
regole che ammainava ogni velleità di garanzia e controllo preventivo efficace.
Un sistema a garantismo ridotto postulava che il mandato degli elettori
scongiurasse di per sé ogni preoccupazione di vigilanza sul regolare
funzionamento delle istituzioni plurali. La dottrina della moral suasion era un
invito da parte del capo dello Stato, in virtù dell’ethos collegato alla sua alta
carica, alla classe politica affinché mostrasse di essere responsabile. Questa
invocazione, che spesso assumeva toni solenni, alla responsabilità nell’azione di
governo e alla prudenza e all’equilibrio nei principi della legislazione dovrebbe
essere connaturata alla funzione rappresentativa. In realtà il comportamento
irrituale di una maggioranza minata dal conflitto di interessi aprì un buco nero
nel funzionamento del sistema politico. Gli inviti reiterati di Ciampi alla
responsabilità, il suo stesso richiamo all’interesse generale come stella polare
restavano sovente del tutto inascoltati da parte una maggioranza ampia che non
temeva alcuna defezione. Il tribunale della moral suasion cui il presidente si
appellava poteva essere completato solo con una censura da parte dell’opinione
pubblica che però restava una misura coercitiva assai labile per determinare
l’arresto di comportamenti percepiti come sleali. Il rischio di esporsi alla
disapprovazione della coscienza civica sensibile alle esortazioni del presidente
era corso ben volentieri in nome di vantaggi immediati incamerabili sul piano
economico e simbolico. Il render conto delle proprie azioni dinanzi alla
cittadinanza informata era una eventualità che di per sé non tratteneva affatto una
classe politica che non temeva gli effetti di significative e ricorrenti defezioni nei
propri ranghi. La dottrina della moral suasion supponeva l’idea repubblicana di
una democrazia riflessiva che postulava la responsabilità nell’agire e rifletteva
sulle esperienze e sulla natura delle leggi alla luce del bene pubblico. Il sistema
di giustificazione cui Ciampi si appellava per sostenere i suoi inviti alla sobrietà e
all’equilibrio era soprattutto quello di un patriottismo rivisitato che con
l’istituzionalizzazione della trasparenza e della riflessività avrebbe dovuto
cementare un sistema politico fragile e un’opinione pubblica altrimenti dispersa.
Dinanzi a leggi ad personam che convertivano la politica da governo della
discussione a interesse particolare, il capo dello Stato si rifugiava nel richiamo al
dialogo, alla transazione tra le parti secondo un linguaggio comune ispirato alla
patria, alla bandiera. Il repubblicanesimo civile di Ciampi non assumeva il
linguaggio dell’intransigenza costituzionale, ma adottava il lessico dello scambio
reciproco, della limitazione delle angolature dettata dalla responsabilità orientata
a un più lungo periodo.
Se l’efficacia di un mandato presidenziale si ricava dalla prestazione di un
senso di unità che, in quanto tale, diviene riconoscibile nel comportamento degli
attori principali, allora il settennato di Ciampi ha realizzato in pieno la aspettativa
di coesione demandata a una figura super partes operante con discrezione dietro
le quinte. Non a caso, alla scadenza del suo mandato, entrambi gli schieramenti
chiesero al capo dello Stato uscente la disponibilità ad essere rieletto. Ciampi in
un comunicato rigettò l’invito dichiarandosi comunque grato dell’ampio
consenso riscosso dalla sua persona, chiaro indicatore di una riuscita del delicato
compito di “garante dell’unità nazionale e custode dell’ordine costituzionale”. A
dispetto di un consenso politico generalizzato, dal punto di vista giuridicoistituzionale, la figura di Ciampi non è stata tuttavia esente da considerazioni
critiche di chi rimprovera al Quirinale una sostanziale inerzia dinanzi agli
scivolamenti arbitrari della politica36. I rilievi critici più severi enfatizzano una
scarsa incisività nel porre argini ad una dialettica parlamento-governo che
procedeva con preoccupanti segni di decadenza sistemica (una involuzione
profonda dell’ordinamento si ebbe con la proliferazione del maxiemendamento
con un solo articolo e 612 commi37), una debole e comunque poco efficace opera
di difesa della costituzione dagli assalti delle leggi ad personam con la dottrina
fragile della moral suasion declinata spesso come un coinvolgimento del
presidente nella confezione di leggi controverse cui poi si era costretti a fornire
una promulgazione quasi meccanica perché il potere di rinvio era ormai stato
sterilizzato dalla copertura presidenziale all’iter convulso della norma.
Il rischio insito nella pratica della leale collaborazione, che si svolge al di fuori
di una stretta regolamentazione formale e evoca il piano sfuggente del personale
coinvolgimento del Quirinale in relazioni di persuasione e consiglio, è quello di
un offuscamento delle competenze autonome dei rami dell’esecutivo e della
presidenza. Nei casi di maggiore forzatura riscontrabili in atti e decreti su materie
delicate, la strategia di coinvolgimento, sia pure solo preventiva e a fini di
consiglio, conduce la figura del capo dello Stato in una situazione di imbarazzo
allorché intervenga ex post un pronunciamento di censura della corte
costituzionale. Anche se la dottrina discute la definizione del capo dello Stato
come custode della costituzione (i suoi atti essendo peraltro sottoposti al
controllo di costituzionalità e all’approvazione da parte del governo tramite
36
Cfr. A. Gentilini, Costituzione materiale in movimento? Riflessioni sulla presidenza Ciampi,
Paper, 2006.
37 Invero in un messaggio alle camere per il rinvio della legge sull’ordinamento giudiziario (10
dicembre 2004), Ciampi denunciava con forza la degenerazione legislativa (“un modo di legiferare
invalso da tempo che non appare coerente con la ratio delle norme costituzionali che disciplinano il
procedimento legislativo”) rammaricandosi anche del fatto che “l’analisi del testo sia resa difficile
dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei
quali consta di 49 commi ed occupa 38 delle 40 pagine”. L’effettiva incidenza del potere correttivo
del Quirinale si scontrava la sensibilità anche culturale delle forze politiche. Se questa manca, le
armi del presidente sono scariche.
l’istituto della controfirma)38, spetta comunque al presidente un compito di difesa
della carta e questo ruolo sfuma allorché le esigenze di una maggioranza
imbrigliano il Quirinale nella scomoda mansione del co-legislatore. La leggenda
di una tradizione dominata dalla figura del presidente notaio non trova conferme
neppure nel settennato di Einaudi che vide consuetudini di rapporti, pressioni,
rilievi informali. Pur nella assenza di un “collegamento diretto tra il Quirinale e
la pubblica opinione” e nel solco di un atteggiamento “collaborativo e riservato”
con il governo, il presidente non esitava a esercitare il potere di rinvio entrando
nel merito dei provvedimenti39. Se il capo dello Stato riesce nella sua opera di
convinzione priva di sanzioni avrà migliorato un disegno di legge o un decreto
ma imponendo una collocazione del Colle nel campo dell’iniziativa politica che
dovrebbe rimanergli preclusa. Se invece malgrado il suo consiglio e controllo
preventivo il testo conserva tracce di incostituzionalità evidenziate dalla Consulta
anche il capo dello Stato è lambito da un pronunciamento negativo che
contraddice la sua piena irresponsabilità. Il consolidamento della moral suasion
come potere di influenza del Quirinale dettato più che dal criterio della legittimità
dal riferimento alla opportunità confonde gli atti specificamente presidenziali con
le competenze degli atti di governo. La irresponsabilità politico-giuridica
conferita all’organo si mescola con il coinvolgimento in una responsabilità
politica negli atti sostanziali dell’esecutivo (mentre la consuetudine sinora
rispettata di non rieleggere un capo dello Stato attenua anche il labile principio
della responsabilità politica e del controllo del Quirinale da parte del corpo che lo
elegge con quorum speciali).
La presidenza Ciampi ha dovuto convivere con una intensa attività legislativa
su materie scottanti (legge sulle rogatorie internazionali del 2001, legge sul
legittimo sospetto per arginare il principio del giudice naturale precostituito
varata nel 2002, lodo Schifani sullo scudo penale per le alte cariche dello Stato,
riforma del falso in bilancio del 2002, norme del 2005, sull’accorciamento dei
tempi per la prescrizione). Le norme varate sollevarono proteste nell’opinione
pubblica e una pressante richiesta al capo dello Stato di non firmare, quasi a fare
del Quirinale un contropotere costantemente attivato nell’arena politica. Pur
sollecitando un rinvio del lodo Schifani, il presidente Ciampi promulgò la legge
ordinaria (non costituzionale) perché, dichiarò, non vi rinvenne le tracce di una
“manifesta non costituzionalità” che invece vennero rimarcate nella sentenza
della corte costituzionale del 2004 che ritenne illegittimo ricorrere a norme
ordinarie per risolvere materie di evidente natura costituzionale. Più che sulle
materie scottanti relative all’immunità delle alte cariche (la stessa corte
costituzionale, nel dichiarare illegittima la legge rimarcò un “interesse
apprezzabile” al sereno svolgimento delle funzioni istituzionali40) e alle norme ad
personam introdotte per sospendere processi a carico del presidente del consiglio,
la firma di Ciampi (che comunque non è apparso affatto quiescente e non ha
esitato a rinviare la legge Gasparri del 2003 sul sistema radiotelevisivo, la
riforma Castelli dell’ordinamento giudiziario del 2004, la legge del 2006 sulla
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) è stata particolarmente lesiva
38
Sulla impossibilità di considerare il capo dello Stato come garante giuridico (che sostituisce o
anticipa la corte costituzionale) o garante politico della costituzione e di assumerlo invece come
garante del corretto funzionamento dei meccanismi istituzionali cfr. M. Luciani, Il Presidente della
Repubblica: oltre la funzione di garanzia della costituzione, in M. Luciani e M. Volpi (a cura di), Il
Presidente della Repubblica, Bologna, 1997. Opposta è la interpretazione di S. Galeotti, Il
Presidente della Repubblica garante della Costituzione, Milano, 1992.
39 L. Paladin, Per una storia costituzionale dell’Italia repubblicana, Bologna, 2004, p. 85. Senza
“mai dare luogo a veri e propri veti” Einaudi non rinunciò a stabilire una “fitta serie di rilievi e di
consigli” (ivi). Molto poco visibili furono le attenzioni del Quirinale verso le evidenti
degenerazioni in senso autoritario del governo e della magistratura nei confronti delle opposizioni
politiche e sindacali.
40 Sui nodi insoluti del pronunciamento della corte costituzionale cfr. T. F. Giupponi, Immuni per
legge, “Il Mulino”, 2008, n. 6, p. 1016.
degli equilibri costituzionali nel caso della promulgazione della legge elettorale
varata dalla maggioranza sul finire della legislatura (21 dicembre 2005). Già la
strumentalità di una legge elettorale studiata a sostegno di scopi particolaristici e
denominata Porcellum avrebbe dovuto sollevare cautela nella sua promulgazione
che, dal punto di vista del Quirinale, non può mai essere un semplice atto dovuto
e un dispositivo automatico. Se all’uso partigiano della legge elettorale cui è
difficile porre rimedi, si aggiungono i connotati di dubbia costituzionalità (il
premio di maggioranza conferito senza prevedere alcun limite minimo per
aggiudicarselo) e di esplicita distorsione in essa presenti (deputati nominati in
ordine alla loro collocazione in lunghe liste bloccate senza alcuna possibilità per
l’elettore di stabilire un vincolo fiduciario di qualche rilevanza), più evidente
diventa il peso della promulgazione della legge. In presenza di una legge così
distorsiva riscontrabile solo in paesi semi-democratici (la Romania degli anni ’30
e Russia e Corea del Sud tra il 1985 e il 1992)41 il capo dello Stato non ha
esercitato alcun filtro efficace o un potere di rinvio che l’avrebbe invalidata per la
scadenza naturale della legislatura. In questo caso, la moral suasion (la
discussione preventiva dei decreti fa dipendere il governo debole dall’appoggio
del capo dello Stato che suggerì in corso d’opera degli accorgimenti relativi al
conferimento del premio su base regionale per l’elezione del Senato) mostrò lo
scacco della consuetudine di affidare proprio al capo dello Stato una prima e sia
pur sommaria valutazione circa l’esistenza di palesi indizi di incostituzionalità
(mai così evidenti come nella normativa elettorale del 2006).
5. Una presidenza sobria
Con la riforma totale della seconda parte della costituzione presa in appalto
dalle forze del governo, si è posto per la prima volta in maniera esplicita il
problema del passaggio qualitativo ad una diversa repubblica. Solo una finzione
avrebbe potuto ritenere ancora la stessa costituzione quella piuttosto malconcia
che sarebbe rimasta in piedi dopo l’eventuale conferma referendaria al quasi
totale intervento del governo sul corpo della carta del ‘48. La vittoria al
referendum costituzionale avrebbe avuto il significato di una ratifica popolare a
una discontinuità di valenza costituzionale. Il referendum del giugno 2006 ha
bloccato una riforma totale che avrebbe spezzato la logica unitaria dell’impianto
costituzionale. La sconfitta del costituzionalismo di maggioranza e l’elezione al
Quirinale di Napolitano (che in tutti i suoi oltre 100 discorsi ufficiali ha sempre
citato il valore della costituzione) annunciano una possibile ripresa della cultura
della normatività della costituzione. Dopo il voto dell’aprile 2006 sono state
scomodate metafore belliche che parlano di un paese spaccato, di un uso
sistematico dei brogli, di un voto delegittimato, di cariche dello Stato abusive,
insomma di regime da abbattere con una spallata e con la disobbedienza fiscale.
La fragilità del sistema politico emerge proprio da questa propensione alla
drammatizzazione dello scontro che rivela un bipolarismo poco maturo. In molti
paesi capita di vincere per pochi voti e persino di conquistare la presidenza in
maniera discutibile. In taluni frangenti, può verificarsi anche che la maggioranza
dei seggi sia appannaggio di chi ha riscosso meno voti. Ma il grado di
strutturazione delle culture politiche evita accese dispute attorno alla legittimità
del voto. In Italia manca ogni asse strategico condiviso e la competizione è
irregolare, sfrenata e priva di regole minime nel rapporto tra parlamento e
governo ed altri organi costituzionali. Eletto, unico tra i presidenti della
cosiddetta seconda repubblica con il solo voto della maggioranza di governo,
R. D’Alimonte e A. Chiaramonte, Proporzionale ma non solo, “Il Mulino”, 2006, n. 1, p. 34.
Rilievi critici sulla legge, circa il profilo della palese incostituzionalità, già in G. Zagrebelsky, Una
riforma del voto irrazionale e incostituzionale, “La Repubblica” del 25 ottobre 2010.
41
Napolitano conquista con il suo operato un grado di apprezzamento e di consenso
assai largo. Nel suo sforzo di preservare le regole costituzionali dinanzi al
precipitare di un gioco politico dai toni incandescenti egli ha saputo armonizzare
impulso politico e contenimento formale. La metaregola che vuole la qualità del
contributo del Capo dello Stato connessa alle modalità di definizione
dell’ampiezza della coalizione presidenziale non sembra in questo caso
funzionare42. Anche Einaudi, emanazione della maggioranza centrista, seppe
interpretare con rigore il mandato. Nel suo discorso d’insediamento al Quirinale,
Napolitano introduce, con la sua téchne retorica di scuola realista, notevoli
innovazioni nella forma e nei contenuti nella comunicazione istituzionale propria
dei tempi della democrazia maggioritaria. Con un linguaggio sobrio e con un
impeccabile controllo delle formule e delle opzioni lessicali, il presidente
tratteggia una coerente agenda politico-culturale predisposta per porre degli
argini ad una competizione che spesso deraglia investendo i pilastri del sistema
politico.
Napolitano, anche quando parla a braccio, presta una scrupolosa attenzione alla
inventio e conferisce un ordine rigoroso alle argomentazioni sorrette da un
approccio discorsivo logico e realista che più si adegua al carattere di un capo
dello Stato che desume il proprio plusvalore politico non in virtù di un ricercato
contatto immediato con l’opinione pubblica ma in ragione del prestigio di chi sa
comportarsi come un sapiente un custode delle regole e come un interprete
imparziale dell’interesse generale. Il probare nei suoi discorsi appare sempre
incalzante e denso di figure razionali che nulla concedono alla fissazione dei
tempi della videopolitica per la delectatio del pubblico con facili figure e
esibizioni giocose. Nulla è più distante dal modo di Napolitano di interpretare la
funzione della immagine di un capo dello Stato che si rianima con il contatto
diretto con l’opinione pubblica. Il plusvalore politico di Napolitano non risiede in
una ricerca di visibilità e di libertà di manovra ma in una capacità di servire le
istituzioni come oggettivazione di un bene pubblico condiviso. Malgrado
l’apprezzamento generale che i sondaggi registrano per il capo dello Stato tocchi
vertici assai elevati, non è nella sintonia meccanica con l’opinione pubblica che il
capo dello Stato intende costruire il sostegno per il proprio operato. Non c’è mai
in Napolitano l’accondiscendenza verso gli umori passeggeri o le soluzioni
affrettate, il sollecitare furbesco di facili motivi di consenso estemporaneo,
l’inclinazione a seduzioni demagogiche o inferenze che restano del apparenti. Tre
sembrano essere i temi che più interessano il presidente: il parlamento, il lavoro,
la laicità.
Sul lavoro il capo dello Stato esercita un presidio valoriale della costituzione
sociale-materiale della repubblica. Con il messaggio motivato del 31 marzo 2010,
con cui rinvia alla camera l’allegato alla manovra di finanza pubblica 2009-2013,
Napolitano sviluppa considerazioni forti sulla dignità del lavoro ragionando
senza alcuna sponda con una opinione pubblica piuttosto distratta43. Rigettando le
disposizioni sul compromesso arbitrale in materia di lavoro (con la possibilità di
derogare dal giudice del lavoro per affidarsi alla decisione secondo equità) il
presidente rileva la “indubbia delicatezza sul piano sociale” della questione dei
diritti del lavoratore e la minaccia portata verso “diritti indisponibili”. La
presenza di alternative al ricorso giurisdizionale, e le tendenza alla
delegificazione, sollevano perplessità perché con simili soluzioni sfuma del tutto
la preoccupazione di tutelare il contraenti più debole. Per il capo dello Stato,
nella stipulazione del contratto di lavoro “la fase della costituzione del rapporto è
Sul nesso tra tipo di elezione e legittimazione dell’inquilino del Quirinale cfr. C. Fusaro, Il
Presidente della Repubblica, Bologna, 2003.
43 Un commento (N. Maccabini, Il Presidente della Repubblica rinvia alle camere il ddl collegato
alla manovra di finanza pubblica, in “Rivista dell’associazione italiana dei costituzionalisti”, luglio
2010) rileva giustamente che l’intervento del presidente avvenne “senza particolari prese di
posizione e denunce della stampa quotidiana”.
42
il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre
la prestazione di lavoro”. L’introduzione della decisione arbitrale, che procede
sulla base dell’equità, di fatto comporta un indirizzo di esplicita delegificazione
che “incide sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro rendendolo
estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale”. Con grande
acutezza il messaggio rivela un surrettizio modo di legiferare per cui, alterando
taluni istituti processuali, si alterano nel profondo degli istituti di diritto
sostanziale non attaccati in maniera palese. Un monito ricorrente nelle parole del
capo dello Stato è quello che riguarda il lavoro. Dopo anni di
decostituzionalizzazione del lavoro, dal Quirinale proviene un assillante invito a
mettere di nuovo il lavoro al centro dell’agenda politica. Costituzione e lavoro in
Napolitano tornano a coincidere. Si può dire che l’agenda del presidente è quella
della costituzione-progetto che per anni è entrata in desuetudine.
Anche gli interventi di Napolitano in tema di laicità appartengono alla
salvaguardia di valori sostanziali della costituzione. In occasione del caso Welby
egli lancia un significativo appello al parlamento perché discuta i temi eticamente
sensibili con il rigore necessario all’impresa. Il presidente del senato risponde che
la parola eutanasia non appartiene al suo vocabolario. Anche concedendo la
grazia a un genitore che aveva ucciso un figlio gravemente disabile, Napolitano
di fatto solleva la necessità di un intervento legislativo. Il sistema politico non
sembra però che abbia colto il senso delle mosse presidenziali. Sulla vicenda
Englaro si saldano questioni (indirette) di laicità e problematiche (dirette) di
certezza del diritto. Muovendosi su un terreno controverso come quello della
emanazione come atto tipico presidenziale, e con pochi punti di appoggio nella
consuetudine, Napolitano rifiuta l’emanazione di un decreto legge concepito non
per dettare una urgente disciplina generale di una materia scoperta dal punto di
vista normativo ma per intervenire su un singolo caso con una procedura
inappropriata. Con il diniego alla emanazione di un decreto che non è
irrevocabile nei suoi effetti come la promulgazione di un testo, il presidente
contesta la procedura e non entra nel merito della questione (l’emanazione non
comporta una sostanziale condivisione e un assenso di merito con la
partecipazione del presidente all’atto, quasi si tratti di un atto complesso) perché
non evidenzia la frizione con diritti costituzionali protetti e non chiude dinanzi
all’autorizzazione della presentazione di un disegno di legge dal contenuto
identico44.
Il presidente del consiglio gioca una grande crisi istituzionale attorno al caso
Englaro cercando di capitalizzare una spinta emozionale (e una completa sintonia
con una porzione del clero) e rivoltarla contro il Quirinale accusato di sordità
etica dinanzi a una sventurata creatura inerme. Berlusconi affonda la polemica
contro il capo dello Stato e interpreta tutta la vicenda come “omissione di
soccorso nei confronti di una persona in pericolo di vita” e cerca di cavalcare una
reazione emotiva a fini di una rottura istituzionale. Con parole di fuoco trasmette
imperativi e minacce, e accusa Napolitano di aver recapitato al consiglio dei
ministri una missiva che, nel nome del puro formalismo giuridico, “conteneva
anche una implicazione grave di una eutanasia”. Al presidente della repubblica si
rivolge con metafore morali, con formule polemico-allusive che implicano
accuse furenti: se non firma il decreto del governo “si carica di questa
responsabilità nei confronti di una vita”. Per salvare una vita dalla volontà di
omicidio dei giudici, dall’inopinata apertura all’eutanasia da parte del capo dello
Stato, dall’egoismo crudele del padre, Berlusconi dichiara di aver varato il
decreto con una ispirazione santa. Con forme di coordinazione disgiuntiva o
alternativa (vita contro morte) e con figure retoriche corpulente minaccia persino
44
Sulla differenza tra promulgazione (della legge) ed emanazione (del decreto) e sulla
inconsistenza della riconduzione di entrambe in una funzione analoga di controllo cfr. M. Luciani,
L’emanazione presidenziale dei decreti-legge, Astrid, 2009.
un cambiamento repentino di costituzione che consentirebbe finalmente di
governare a lungo con un semplice decreto sottratto al filtro del capo dello Stato.
Se neanche un decreto salvavita gli è stato consentito di varare in tempo utile, ciò
significa solo che “non comando nulla” posso soltanto redigere l’ordine del
giorno del governo. Berlusconi si presenta come l’immacolato padre amoroso
che combatte l’irrazionalità dello Stato di diritto in una guerra nella quale “da
una parte c’è la cultura della morte, dello Stato che si impone sulla vita e
dall’altra c’è la cultura della libertà e della vita”. In nome della sacralità della vita
rivendica la possibilità di legiferare tramite decreti, di decidere senza controlli
(“speravo che il Colle capisse”), di istituzionalizzare un potere carismatico
informale (“si può arrivare ad una scrittura più chiara della costituzione senza la
possibilità di ricorrere ai decreti legge, tornerei dal popolo a chiedere di cambiare
la costituzione, il governo”). A Berlusconi che rivendica indipendenza e
autonomia di decisione e adombra la soluzione carismatica-presidenzialista,
Napolitano risponde con le risorse della forma e della ostinata fedeltà alle regole.
Per fondare il potere presidenziale non formalmente menzionato nella carta di
negare l’emanazione di decreti leggi rintraccia precedenti, il capo dello Stato
mostra rigore, conoscenza del protocollo. La disputa si chiude con la consueta
smentita di Berlusconi che assicura di non aver mai contrastato con le sue parole
il capo dello Stato (aveva invece sostenuto che “o firma o convoco le camere ad
horas e in tre giorni si fa la legge”).
Il comportamento di Napolitano, in occasione di un decreto che ha scatenato
una accesa disputa istituzionale, è stato inappuntabile nel configurare la giusta
collocazione della decretazione d’urgenza nell’ordinamento45. Il fondamento
solido della sua decisione risiede nel recupero delle ragioni della certezza del
diritto e delle esigenze della separazione dei poteri che erano state invece
calpestate da un decreto che interferiva con il giudicato, annullando gli effetti di
una regolare sentenza di una corte d’Appello e di atti della cassazione. La
separazione dei poteri e le prerogative costituzionali della giurisdizione sono
state calpestate con il decreto. Tocca quindi al capo dello Stato, quale garante
dell’ordinato fluire dei poteri plurali, reagire ad un atto che avrebbe avuto un
effetto immediato e irreversibile, senza alcun coinvolgimento del parlamento.
Nella gestione di un caso eccezionale come il decreto che racchiude una specifica
logica giuridica, il capo dello Stato non avrebbe potuto fare affidamento sulla
attivazione di un meccanismo dialogico per influenzare l’iter decisionale perché
l’essenza del decreto è proprio quella di produrre effetti immediati senza controlli
oltre a quello del sindacato riservato al capo dello Stato che lo esercita al
momento della emanazione. Napolitano mostra una cura nel calibrare gli
interventi. Non esita a porre un veto a un decreto per lui manifestamente privo
dei necessari requisiti e ad accettare un esplicito conflitto dinanzi a decreti che
nascondono incertezza e che presentano vizi di procedura, di incompetenza e
sfuggono ai requisiti di legittimità. Non rinuncia anche a partecipare con
discrezione, operando con la moral suasion e con alcune sollecitazioni informali,
quando valuta opportuno correggere, suggerire nell’ottica della fisiologica leale
collaborazione dei poteri. Egli opera nella consapevolezza che la sostanziale
estraneità del capo dello Stato alla funzione di indirizzo legislativo intesa in un
senso stretto non lo esenta da un ruolo di indirizzo politico più ampio che si può
esprimere con interventi per assicurare la piena funzione politica e
amministrativa eliminando ogni patologia che si annida nel sistema. La funzione
politica del presidente può prevedere, a seconda dei casi, l’apertura di
meccanismi dialogici con l’esecutivo per correggere, limare misure come anche
l’esercizio delle competenze discrezionali del capo dello Stato che resiste ad una
autonoma volontà del governo esercitando i poteri di veto o risponde al testo del
parlamento con il rinvio della promulgazione.
45
Cfr. U. Allegretti, Un rifiuto presidenziale ben fondato, “Astrid”, 2009.
L’uso improprio della decretazione d’urgenza e la tecnica distorsiva del
maxiemendamento, cui si accompagna spesso la richiesta del voto di fiducia, non
solo incidono sulla qualità della norma ma si riverberano anche sulle competenze
del capo dello Stato e del parlamento con la drastica contrazione dei tempi della
discussione in aula per un esame congruo. Con reiterate note e lettere ai
presidenti delle camere e al presidente del consiglio, Napolitano segue con assillo
la degenerazione della forma della legge e la compressione delle prerogative
classiche del parlamento. La sua istanza di una necessaria conciliazione delle
“esigenze di governo e di tutela delle prerogative del parlamento” non obbedisce
a scrupoli puramente procedurali o a rimbrotti ormai rituali. Il forte e insistito
richiamo alla rappresentanza e alla necessità di un rinvigorimento delle
assemblee contiene un esplicito auspicio di introdurre dei calibrati adeguamenti
istituzionali che controllino una eccessiva deriva mediatica, demagogica e
leaderistica della politica. La sofferenza del parlamento, l’uso irrituale del voto di
fiducia, il ricorso continuo a forzature procedurali, l’emergenza della condizione
riscontrabile nel senato per via della rilevanza politica decisiva dei senatori a
vita, il richiamo alla necessità di riforme condivise nel terreno scottante della
giustizia, sono al centro dei richiami del capo dello Stato. Le sue parole
sollecitano a non confondere il piano della polemica politica e quello della
correttezza istituzionale, la necessità della decisione e il rispetto di compiti
costituzionali essenziali del parlamento. Le ragioni della stabilità dell’esecutivo e
dell’autonomia del governo non comportano il sacrificio di competenze degli
organi costituzionali nel quadro di un equilibrio dei poteri e di scelte
approfondite anche dal punto di vista analitico. Nell’universo della narrazione
superficiale, il capo dello Stato rivendica le esigenze della puntualità e del
supporto competenziale della decisione. Grandi preoccupazioni in merito alla
decadenza qualitativa della forma della legge traspaiono nel messaggio del 31
marzo 2010. Napolitano affonda con decisione una invalsa consuetudine per cui i
disegni di legge ospitano una eterogeneità insostenibile di materie scavalcando le
competenze delle specifiche commissioni parlamentari, le prerogative del capo
dello Stato.
Ospitando materie le più disparate (il collegato alla finanziaria raccoglieva
disposizioni sulla salute, sul lavoro, sugli enti) si incide negativamente, avverte il
capo dello Stato, “sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla
organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto”. Nei rilievi
sulla legge di conversione del decreto incentivi (2 luglio 2010) Napolitano
denuncia una tendenza deleteria che vede una metamorfosi del decreto iniziale
presentato al capo dello Stato che diventa inopinatamente un maxiemendamento
(con circa 60 articoli e numerosi titoli e 1364 commi) assorbendo per strada una
molteplicità di materie che lo sfigurano e mettono in imbarazzo il presidente che
dovrebbe promulgare un atto sostanzialmente diverso da quello inizialmente
avallato. Nella sua censura verso queste pratiche di legislazione che assemblano
materie troppo eterogenee per essere compatibile con le esigenze della certezza
del diritto, Napolitano denuncia il consolidarsi di “una tecnica legislativa con
incidenza negativa sulla qualità della legislazione”. La funzione di sorvegliante
delle regole e della certezza del diritto è compromessa con la promulgazione di
un testo di legge sostanzialmente eterogeneo rispetto al momento iniziale della
emanazione del decreto legge. Per questo Napolitano insiste spesso con la
rivendicazione del ruolo della rappresentanza aggirata nel profondo con la
“tendenza a caricare di contenuti impropri i disegni di legge di conversione dei
decreti legge”.
I discorsi di Napolitano muovono da un giudizio preoccupato sulle incognite di
un processo politico avviato negli anni ’90 e non ancora pervenuto ad approdi
istituzionali soddisfacenti ma anzi tallonato da palesi esiti involutivi. Negli anni
’90, nel quadro di una cultura politica superficiale, si è appannato nelle culture
istituzionali il ruolo del parlamento visto come luogo solo residuale della vicenda
politica occupata dalla personalizzazione del potere e dai media. L’aula
parlamentare, spesso ridotta a esercizi di appoggio conformistico a un leader che
si fa schermo con le pretesa investitura elettorale diretta, non appare più come
anello fondamentale del funzionamento del sistema di governo. Sia dal punto di
vista normativo, sia sotto l’aspetto strutturale, il parlamento declina vistosamente
nella configurazione dei pubblici poteri. Nella cultura istituzionale di Napolitano
traspare invece l’ambizione di contribuire a una difesa non statica della
repubblica parlamentare basata sul confronto rigoroso delle alternative
programmatiche. E’ evidente nelle sue esternazioni la consapevolezza che entro
una compagine di coalizione, nessun dato normativo sarebbe di per sé sufficiente
a rendere più incisivo il meccanismo di comando del capo del governo.
L’elemento di debolezza dei governi è nascosto infatti nei precari equilibri
politici della coalizione che ogni inquilino di Palazzo Chigi si guarda bene
dall’infrangere, se vuole restare in sella per lungo tempo. Il capo del governo è
necessariamente l’espressione e il garante al tempo stesso di un equilibrio
delicato e incerto. Il capo dello Stato percepisce che su questo dato di sistema è
arduo intervenire e sterile sono destinate a rivelarsi le sollecitazioni a grandi
riforme all’insegna del leaderismo assoluto (ruotante indifferentemente sul
premier forte o sul semipresidenzialismo alla francese) e del dimagrimento
funzionale delle assemblee. La percezione delle illusioni istituzionali del
ventennio che rischiano di trasformare una pretesa forma di governo
neoparlamentare (con investitura diretta del premier indicato sulla scheda) in un
sistema di fatto aparlamentare e disfunzionale non comportano tuttavia la
chiusura del Quirinale dinanzi agli opportuni correttivi incrementali
indispensabili per razionalizzare il sistema istituzionale. Napolitano non mostra
di credere che la leadership piena e la rapidità della decisione implichino una
democrazia di investitura che elegge il governo e affida a una singola persona
compiti che sfuggono al parlamento, emarginato anche formalmente dopo il
logoramento di fatto degli istituti della rappresentanza.
Il ruolo della rappresentanza rimarcato a più riprese dal capo dello Stato argina
le mitologie del leader assoluto con alle spalle un preteso mandato pieno per
governare che nessun organo di mediazione (partito e camere) può intralciare. Le
parole del Quirinale sembrano non credere che il paradigma cesaristico così
diffuso sia un valido veicolo di accesso ad un sistema più agile e a istituzioni più
moderne. La democrazia di investitura suppone un preteso contratto diretto
intervenuto tra il capo e gli elettori. Poiché il capo ha vinto, siglando un contratto
diretto con gli elettori, il parlamento e i partiti non possono disturbare il quadro
idilliaco costruito attraverso questo rapporto a due tra leader e popolo. Questo
paradigma non trova ascolto nel Quirinale, che pure coglie la novità del quadro
politico che assegna al parlamento un ruolo molto diverso da quello ricoperto in
passato. Il mutato rilievo del parlamento nulla geografia dei poteri ha a che fare
con il postulato di un'investitura originaria data direttamente dai cittadini, al
cospetto della quale più nulla di significativo è possibile fare attraverso la
funzione solo residuale e scenica rimasta al parlamento. Napolitano è
consapevole che al Quirinale oggi si richiede una attitudine più garantistica nel
gioco tra maggioranza e opposizione46. Il governo che sopravvive ricorrendo a
colpi di voti di fiducia segnala una condizione di grave malessere istituzionale
che il capo dello Stato a più ripresa denuncia quale che sia la maggioranza
contingente. L’esiguità della maggioranza di governo del centrosinistra al senato
46
Una insidiosa tendenza a sottrarsi ai poteri di controllo del presidente della repubblica (e anche
alla valutazione preventiva della Corte dei conti) si riscontra nella proliferazione dell’uso abnorme
delle ordinanze di protezione civile al posto del decreto legge. Un diritto amministrativo parallelo
con strumenti extra ordinem che spezza l’idea unitaria di ordinamento cfr. M. A. Cabiddu,
Necessità ed emergenza ai confini dell’ordinamento, “Amministrare”,2010, n. 2; E. Albanesi e R.
Zaccaria, Le fonti dell’emergenza: dal decreto legge alle ordinanze di protezione civile,
“Amministrare”, 2010, n. 2.
costringe a forzature evidenti del quadro parlamentare. Si perviene ad una sorta
di bicameralismo differenziato per vie traverse e inaccettabili. Le aule sono
tramutate in luoghi passivi di approvazione. La disciplina corazzata sostituisce
ogni ingenua raffigurazione del parlamento come governo della discussione. Le
esternazioni del presidente invocano coesione nel governo minato da una
litigiosità intestina per restituire dignità alle istituzioni.
Quando la maggioranza mostra segni di instabilità e conflitti interni anche un
presidente con una spiccata correttezza istituzionale è indotto a prendere qualche
iniziativa e il suo nome viene associato a insistite richieste di una correzione
della legge elettorale da attuare magari attraverso governi di decantazione.
Poiché i segnali di crisi non si esauriscono a spostamenti marginali entro la
coalizione ma, data l’esiguità della maggioranza soprattutto al senato, rendono
ipotizzabili soluzioni di ricambio oltre il recinto dell’Unione, il ruolo del capo
dello Stato è sulla carta accresciuto nel pilotare la formazione dei possibili
governi. Napolitano richiama la maggioranza ai suoi doveri di coesione e il
monito è giustificato dall’interesse nazionale ad avere un governo e un
parlamento che funzionino nel modo più efficace. Reclamando coesione, ma
anche rispetto delle prerogative degli organi istituzionali (rinvia alle camere il
governo Prodi dopo gli infortuni al senato), il capo dello Stato postula che la
coerenza dell’indirizzo politico e la saldezza della maggioranza siano una
fondamentale esigenza del sistema politico. Il presidente in tal senso compie un
atto di fluidità istituzionale che nulla ha a che fare con il perseguimento di
autonomi giochi politici.
Spesso, soprattutto quando coabita con una maggioranza di centro destra, il
capo dello Stato viene coinvolto, alla luce di una stravolta interpretazione del
potere presidenziale in sede di emanazione degli atti con forza di legge o di
decreto legge, in forme del tutto improprie per sollecitarlo a entrare in conflitti
che sono di esclusiva natura politica. La sua chiamata in causa quale viva vox
Constitutionis obbedisce solo ad una logica asfittica di resa dei conti finale e di
confusione istituzionale circa i margini cui il potere di rinvio si insinua. Molte
sono le puntualizzazioni che in questi casi il capo dello Stato è costretto a
scrivere con una prosa precisa e rigorosa. Il presidente come “magistrato della
persuasione” (che su materie controverse come intercettazioni, sicurezza,
sospensione dei processi corregge in corso d’opera le leggi attraverso esplicite
contrattazioni con il governo) espande il proprio ruolo di rassicurazione in una
elastica interpretazione della funzione della leale collaborazione tra gli organi
istituzionali. Il Quirinale è diventato un esplicito organo correttivo rispetto alle
degenerazioni del sistema politico e anche ai vuoti di potere che caratterizzano la
fase calante del berlusconismo. Napolitano però rimarca sempre il confine
invalicabile della sua funzione: “non esiste che il capo dello Stato emana una
legge se e quando gli pare e piace. Non sono corresponsabile di atti legislativi
che sono di competenza esclusiva del governo”47. Il Quirinale non può
riconvertirsi in un supplemento di opposizione che interviene a getto continuo
nella vita istituzionale tramutandosi così da accorto regista chiamato a
depotenziare le situazioni potenziali di crisi in un fattore esso stesso scatenante
tensioni incontrollabili48. Tocca al capo dello Stato, delicato attore che si opera al
47
Dinnanzi alla legge Alfano n. 124 del 2008, Napolitano emette un comunicato stampa (altre note
e commenti seguiranno dopo l’approvazione della legge e in vista della promulgazione) che si
rivolge all’opinione pubblica per chiarire, giustificare e spiega di autorizzare la presentazione del
disegno di legge governativo alle camere avendo come punto di riferimento la sentenza della
Consulta del 2004. Al capo dello Stato “compete un primo esame” e il disegno di legge governativo
“è risultato corrispondente ai rilievi formulati in quella sentenza”.
48 Cioè, per scongiurare la metamorfosi in organo di paralisi e di tensione, il capo dello Stato “non
deve o non dovrebbe contrapporsi apertamente né al governo né ad altri poteri dello Stato né a
determinati raggruppamenti politici” (Paladin, Il Presidente della Repubblica, cit., p. 223). Per
questa attitudine (squisitamente politica) all’equilibrio, il presidente opera costantemente dentro la
costituzione, e si insinua con delicatezza dentro i poteri costituiti, ma collocandosi anche in un
riparo da sanzioni istituzionali, schivare le insidie di una paralizzante oscillazione
tra quiescenza e iperattivismo cercando di conciliare la ragione dell’unità
(fondativa della elevata carica ricoperta) e i compiti di una garanzia attiva della
costituzione e dell’equilibrio delle istituzioni fondamentali.
6. Tra supplenza e conflitto
Eletto secondo una logica maggioritaria, Napolitano mostra il suo essere “di
parte” nei valori che richiama nelle sue esternazioni (in primo luogo la grande
insistenza sulle tematiche del lavoro e della lotta alle morti bianche con il rinvio
alle camere della legge del 2010 sull’arbitrato in materia di diritto di lavoro; nella
forte impronta europeista che emerse nel 2007 per i festeggiamenti al Quirinale
dell’anniversario dei Trattati di Roma) ma non nella conduzione della vita
istituzionale, che appare impeccabile e priva di ogni atto eterodosso a sostegno di
un piano. I suoi reiterati inviti alla coerenza e alla coesione dell’esecutivo nulla
hanno a che fare con una riedizione dello stile presidenziale di Saragat che si
atteggiò a tutore di una specifica maggioranza di governo e persino a paladino di
una peculiare formula dell’esecutivo. La politica, quella di un capo dello Stato
ancor più, è legata alle parole. Le utilizza per minimizzare, per simulare, per
occultare. Quelle che in Finlandia ha usato il presidente della Repubblica sono
parole di una geometrica trasparenza, il loro impatto non si arresta alla pura
congiuntura. In questi anni di presidenza, Napolitano ha inteso, prima di ogni
altra cosa, interpretare il suo mandato all’insegna di un patriottismo
costituzionale condiviso. Ha per questo scelto di indossare un elevato profilo
metapolitico. Egli cioè concede la piena e legittima libertà di manovra alle
maggioranze occasionali, per le specifiche questioni di governo e di indirizzo, e
però pretende che i confini dell’ordinamento repubblicano non siano minacciati
dalle incursioni corsare dei revisionismi storiografici. Non rientrano, nel sempre
controllato repertorio linguistico di Napolitano, metafore scadenti, fughe
retoriche facili e corto circuiti argomentativi. Quando, da un registro lessicale
così sobrio e sorvegliato, escono misurate ma lineari parole di denuncia significa
perciò che i comportamenti, i processi che le hanno scatenate sono di una gravità
istituzionale inaudita. Questo implica un senso vivido della cruciale distinzione
tra il principio di maggioranza, rispetto alla discrezionalità del quale il Quirinale
non intende in alcun modo interferire oltre le sue fisiologiche competenze di
controllo iniziale della legalità, e la questione del fondamento storico-valoriale
della repubblica, sulla quale il Colle non è invece disposto a scambi, cedimenti.
In occasione dell’annullamento da parte della Consulta della legge Alfano il
presidente del consiglio Berlusconi reagisce in modo scomposto. Con un estremo
di bizzarria, il discorso del titolare del potere esecutivo diventa un altezzoso
discorso acratico rivolto contro il potere e le sue forme. Critica in diretta Tv il
capo dello Stato perché è stato fedele alla lettera e allo spirito della costituzione e
non ha invece usato “la sua nota influenza sui giudici costituzionali per cambiare
l’orientamento di almeno due di loro” così da far passare il lodo sull’immunità
del premier. Parlando a Bonn con parole gravi contro i giudici, i presidenti della
repubblica, i membri della corte costituzionale. Se uno statista sempre misurato
nel linguaggio e assai cauto nelle sue esternazioni, come il presidente Napolitano,
parla senza remore di un “violento attacco contro fondamentali istituzioni di
garanzia volute dalla costituzione”, ciò vuol dire che le frasi di Berlusconi aprono
un aspro conflitto tra i poteri. Mai nella storia d’Italia un capo dello Stato aveva
censurato come “violento” un discorso del capo del governo. C’è un altro
richiamo, non meno dirompente del primo, che è essenziale cogliere nella nota
del Quirinale. Le espressioni di Berlusconi sono apparse ancora più gravi per il
solco sfuggente e non definito in maniera perentoria e comunque sempre “ai limiti del diritto
costituzionale”.
Colle proprio perché pronunciate “in una importante sede politica
internazionale”. E questa notazione rimanda ad una scarsa sobrietà istituzionale
che ostacola ogni efficace leale collaborazione.
La vicenda connessa ai rilievi non ufficiali del capo dello Stato al decreto legge
su stabilizzazione finanziaria e competitività (26 maggio 2010) rivela come densa
di incognite sia la strada della leale collaborazione (con limature, suggerimenti,
perplessità, richieste di stralci) quando si è in presenza di un partner di governo
che non mostra una dimestichezza con le consuetudini costituzionali. Il
presidente del consiglio parla pubblicamente, e quindi in palese sfregio con la
riservatezza che accompagna le frequentazioni tra gli organi istituzionali, di un
testo da lui non firmato e sottoposto alla valutazione del capo dello Stato
pervenuta la quale anche il capo del governo avrebbe finalmente apposto la
propria firma. Il percorso informale, ma del tutto fisiologico, di un contatto tra
l’ufficio giuridico del Quirinale e i tecnici dei dicasteri economici si carica di
mistero allorché il presidente del consiglio dichiara di attendere le indicazioni di
merito del capo dello Stato adombrando così una operazione irrituale di colegislazione che avrebbe scaricato sul Colle la responsabilità di misure dolorose e
di conseguenza ristretto anche la legittima possibilità di contestazione della
manovra da parte delle opposizioni. La sfasatura dichiarata da Berlusconi tra testi
solo provvisori non ancora da lui firmati e misure anticrisi definitive varate solo
dopo la supervisione del Colle prova l’irritazione e l’imbarazzo del presidente.
Napolitano ribadisce l’impossibilità di tramutare i contatti tecnici, le
sollecitazioni informali e anche i rilievi circa la “sostenibilità giuridica e
istituzionale della manovra” con la indebita assunzione di una responsabilità
politica dei decreti che ricade solo sul governo, che se ne avvale quale titolare di
una volontà normativa che ha immediati effetti di fatto anche se solo protempore49. Napolitano critica esplicitamente il funzionamento effettivo del
bipolarismo, non l’astratta configurazione della democrazia dell’alternanza. Il
correttivo che egli auspica ruota attorno ad una corretta interpretazione dei ruoli
distinti spettanti al governo e all’opposizione. Il richiamo al galateo, al lessico e
alle procedure di un bipolarismo funzionante (che non veda tra le parti “solo
conflitto, soltanto scontro fine a sé stesso”) e però mancante è costante. Entro una
cornice infranta in cui poco spazio è concesso alla “discussione seria e aperta”
tocca proprio al capo dello Stato tamponare le degenerazioni del governo (con
l’invito a evitare forzature come quelle, in piena emergenza economica, di
privilegiare la discussione sulle intercettazioni che andrebbe invece rinviata a
“tempi opportuni”) e le debolezze dell’opposizione.
Un momento di particolare tensione istituzionale (tra le ragioni della volontà
del più forte e le procedure della funzione specifica di garanzia spettante al capo
dello Stato in merito all’autorizzazione di decreti e di disegni di legge
governativi) sorge in occasione delle regionali del 2010, quando le liste della
destra non riescono a presentare in tempo i contrassegni e le firme necessarie.
Con il ritrovato del tutto inedito del decreto interpretativo, la sostanza del potere
che non cede neanche dinanzi ai propri errori procedurali sfida la debole forma
del controllo di legalità. Il governo, con il suo unilaterale atto d’imperio, non
aspetta i tempi fisiologici del pronunciamento degli organi della giustizia
elettorale ed amministrativa, in attesa di una qualche sorpresa ermeneutica
capace di contemperare rappresentanza e formalità. In nome della sacralità della
sostanza (la difesa ad oltranza delle sue roccaforti elettorali), l’esecutivo, con la
irrituale maschera di un decreto interpretativo che in realtà sana le acclarate
irregolarità commesse, mette le istituzioni dinanzi al fatto compiuto senza
neppure consultare le opposizioni in vista di una ardua soluzione
49
Per una ricostruzione della vicenda cfr. N. Maccabini, Rilievi non ufficiali al decreto legge su
stabilizzazione finanziaria e competitività economica, in “Rivista dell’Associazione italiana dei
costituzionalisti”, luglio 2010.
“consociazionale” a tutela della reale competitività del voto. Con un testo “solo”
interpretativo, il governo aggira il chiaro divieto di intervenire con un decreto
nella cruciale materia elettorale. Il governo con il decreto salva liste e con la
mera finzione lessicale del decreto solo “interpretativo” muta le condizioni del
gioco e altera la parità dei diritti di chi partecipa alla gara elettorale. La politica,
come scontro effettuale di forze, può anche valicare il confine tra lecito e illecito
ma se la fisiologica opera di sorveglianza prestata dai poteri costituiti rileva
violazioni delle norme nessuno può schivare la sanzione prevista
dall’ordinamento. Come conciliare l’esigenza secondo cui nessun potere
pubblico o privato può oltrepassare la norma valida (funzione presidenziale di
controllo e freno sugli atti di governo) e il contestuale interesse pubblico di
celebrare elezioni davvero competitive aperte cioè anche alle forze azzoppate da
cavilli e arcaismi che tuttavia vincolano le autorità giudiziarie: questo l’arduo
dilemma che si pone al capo dello Stato. Ogni soluzione ha del paradossale:
avallare le scelte di un potere senza legalità oppure accettare la figura di un
governatore trionfante ma senza rappresentanza. Lecitamente il capo dello Stato
interpreta la funzione di controllo in modo attivo e non puramente formale
valutando che restano attivati gli organi della giustizia amministrativa e che
comunque il voto popolare può sanare i possibili vizi di forma nella
presentazione delle liste. In tale ottica, il capo dello Stato opera non in un mero
quadro notarile ma nel ruolo di garanzia del funzionamento di un sistema che ha
alla sua base il principio della sovranità popolare. Come garante di una
funzionalità sistemica, il Quirinale non può che aderire ad una visione dinamica
dell’opera di controllo.
Soprattutto dopo il mancato successo della mozione di sfiducia del 14 dicembre
del 2010 (per la discussione della quale il capo dello Stato aveva sollecitato il
rinvio di un mese per consentire l’approvazione della finanziaria), Berlusconi
trae la propria legittimazione da una risicata maggioranza parlamentare e in
occasioni nevralgiche l’assenza del potere viene coperta con un compito delicato
di tenuta del quadro costituzionale e della coesione nazionale svolto dal capo
dello Stato. Non che si profili un qualche impianto dualista con le ambigue
sembianze di un governo a doppia legittimazione, ma il contributo del Quirinale
si rivela decisivo per gestire un vuoto politico sempre più percepibile e aggravato
dalla esplosione di una pesante emergenza economica. Anche se il capo dello
Stato in atti formali e informali rammenta sempre la debole capacità di decisione
del Quirinale, Napolitano è indotto proprio dal vuoto politico a svolgere delicate
funzioni necessarie per lo stesso funzionamento del governo parlamentare e ad
amplificare il proprio rapporto di sintonia con l’opinione pubblica smarrita
dall’incalzare della crisi. Il potere di influenza su avvicendamenti ministeriali, su
certe clausole della finanziaria, sul calendario dei lavori parlamentari, sulla
consultazione delle parti sociali, sulla censura di un ministro senza portafoglio
appena nominato che dichiara di avvalersi dello scudo del legittimo impedimento
per non presentarsi al processo, sul riconoscimento del ruolo dell’opposizione
ampliano la sfera d’influenza del capo dello Stato. Il Quirinale svolge un operato
di integrazione della struttura di governo indebolita dalla caduta di autorevolezza
del premier e manifesta un potere di influenza negli orientamenti delle
maggioranze parlamentari ampliato dalla debolezza delle organizzazioni
politiche e dalla clamorosa mancanza di una responsabilità e di una coerenza
della politica del governo.
Consapevole di operare nel cuore di una vera crisi di sistema, il Quirinale
spinge verso l’adozione di un ruolo attivo del presidente in un’ottica di lettura
dinamica della leale collaborazione istituzionale. Il governo è così ricondotto
entro una sorta di quadro dualistico nel quale il contatto con il capo dello Stato è
non meno cruciale del mantenimento di una risicata fiducia parlamentare. Una
riedizione dei governi del gabinetto con il Quirinale che opera come un accorto
regista capace di correggere le dissonanze del governo rispetto agli attacchi della
speculazione internazionale e di sollecitare una condotta diversa da parte
dell’opposizione si avverte nelle fase più convulse della emergenza economicofinanziaria. Il capo dello Stato rimarca le debolezze e le insufficienze della
manovra del 2011 e sollecita una “coesione nazionale” dinanzi a una crisi
economica che, malgrado le turbolenza finanziarie e le speculazioni dei mercati
internazionali, il governo nega esserci in un paese che è “solido”. L’11 luglio del
2011 Napolitano dichiara di aver “preso nota con viva soddisfazione degli
annunci venuti dall’opposizione nel senso di un impegno a concorrere a una
rapidissima approvazione della necessaria manovra economica”. Non risparmia
sollecitazioni critiche al governo e al presidente del consiglio che ha definito
“criminale e anti italiana” l’opposizione: “ci si attende che a ciò corrisponda la
immediata disponibilità di governo e maggioranza a condurre le consultazioni
indispensabili e a ricercare le convergenze opportune”.
In quello che è stato definito il più politico dei suoi interventi, quello
pronunciato al meeting di Rimini nel 2011, Napolitano dinanzi a “un angoscioso
presente” come quello della crisi economica globale mostra come compito del
presidente non sia solo quello statico del controllo ma anche quello più dinamico
dell’impulso, della moderazione. Il dovere di contribuire alla funzionalità
complessiva del sistema istituzionale non può essere esplicato in un quadro
statico del compito di controllo ma sollecita un più attivo intervento nel quadro
della sollecitazione imparziale rivolta a una pluralità di poteri e soggetti politici e
sociali. Trova qui conferma l’istanza di Esposito di accogliere la posizione del
capo dello Stato nell’ambito del potere esecutivo perché pur spettando l’atto
politico al governo il capo dello Stato coopera attraverso la collaborazione con il
governo50. Tale prospettiva induce Esposito ad infrangere la clausola della
imparzialità dell’organo chiamato a svolgere una funzione super partes. Le
funzioni del presidente si estendono proprio in nome della imparzialità mentre
una più esplicita collocazione nell’ambito dell’esecutivo e dell’indirizzo politico
restringerebbe le competenze del Quirinale fino a renderle residuali. Il ruolo
politico attivo del capo dello Stato anche se non si esplica in atti normativi
autonomi emerge nelle condizioni critiche quando a una figura super partes sono
affidate mansioni inedite sia pure nei limiti per cui in assenza di controfirma
ministeriale gli atti presidenziale risultano inesistenti. Proprio nel riconoscimento
della neutralità del capo dello Stato si giustificano gli ambiti d’azione ricoperti
nelle fasi critiche quando è ostruito il normale tragitto dell’indirizzo politico. Al
governo Napolitano rimprovera di aver, dinanzi alla crisi, scartato “il linguaggio
della verità” scambiato per pessimismo antieconomico mentre “dare fiducia non
significa alimentare illusioni”. Il governo ha fatto ricorso a “semplificazioni
propagandistiche e comparazioni consolatorie su scala europea”. L’opposizione
riconduce “ogni criticità della condizione attuale del paese a omissioni e colpe
del governo, della sua guida e della coalizione su cui si regge”. Con una
“maggiore oggettività nelle analisi e più misura nei giudizi” si deve scorgere il
tratto sistemico della crisi. Il bipolarismo incapace di collocare le forze politiche
“all’altezza dei problemi da sciogliere”, adottando un’ottica “di medio e lungo
periodo”, marcia insieme alla decrescita, a indicatori sociali di diseguaglianza nel
reddito che vanno anche al di là del Pil e si insediano negli “stati soggettivi e
negli aspetti qualitativi della condizione umana”. Il problema immediato
(recupero di affidabilità per gestire le insidie del debito pubblico con stabilità
finanziaria) va, secondo il capo dello Stato, ricondotto a una visione di lungo
periodo capace di declinare crescita ed equità per affrontare le diseguaglianze
sorte “dopo una marcia secolare in senso opposto”. Oltre le indicazioni analitiche
di ordine generale, Napolitano stende un vero programma di governo. Per questo
dinanzi a “difficoltà serie, complesse, che per molti aspetti non sono recenti” egli
auspica misure che devono declinare crescita, federalismo, liberalizzazione di
50
Esposito, Diritto costituzionale vivente, cit., p. 69.
assetti economici, correzioni di “assetti inadeguati anche del mercato del lavoro”.
La forma degenere del bipolarismo che ostacola una “visione più complessiva e
avanzata degli orizzonti di lungo termine” incide sul sistema sociale, sulla
crescita economica. Per questo occorre “liberarsi da approcci angusti e
strumentali” e favorire la ripresa di una cultura politica in dardo di coniugare
rigore, crescita, equità. “Non credo a una impenetrabilità della politica che possa
durare ancora a lungo, sotto l’incalzare degli eventi”.
Sullo sfondo delle considerazioni del presidente si ravvisa l’insofferenza per il
peso straripante assunto dai media nelle forme nuove della politica. Sono i media
che attraggono nella loro orbita i politici e li inglobano in un gioco che li obbliga
a indossare una maschera e a ignorare il rigore del confronto e la responsabilità
della proposta. Napolitano censura l’eccessiva presenza dei politici nei media e
rimane convinto che il codice della politica non sia affatto riconducibile agli
schematismi spettacolari dei media. Politico di scuola realista, egli cura i dettagli
della comunicazione che adotta una struttura fortemente razionale e si distende
senza indulgere a semplificazioni e a cadute demagogiche51. La confirmatio,
ossia l’attitudine a suffragare con argomenti solidi le asserzioni e a confutare
affermazioni poco rigorose, è molto accurata nella comunicazione di Napolitano.
Contro ogni corto circuito dell’argomentazione egli pesa gli aggettivi, misura le
parole per evitare sfumature e zone di ambiguità. Nel tempo della politica ridotta
irreparabilmente a spettacolo e a immagine seducente con simboli in gran parte
costruiti, artificiali, con una oratoria rigonfiata di iperboli e ossimori, il capo
dello Stato difende un altro stile del comunicare che non disdegna contenuti a
costruzione sintattica complessa. L’actio del presidente è quella di un oratore
politico d’altri tempi che proprio perché carico di storia rinuncia alla rigonfiata
costruzione di sé, all’immagine studiata e alle parole attribuisce non già un
arcano magismo ma la forza di penetrazione dei buoni argomenti. La verifica
empirica delle proposizioni, la capacità semantica delle parole è in Napolitano
una forte reazione a un linguaggio politico che non è orientato al reale,
all’argomentazione ma alla fascinazione, alla declamazione vuota senza alcun
referente. La comunicazione di Napolitano con le nomenclature tecniche del
discorso rifiuta il luogo comune dei tempi attuali che postulano un pubblico
degradato, che è indifferente dinanzi alla palese assenza di riscontro e disprezza
gli argomenti, il paziente lavoro della dimostrazione, la concatenazione logica
delle frasi. Nel lessico, nella sintassi, oltre che nella costruzione delle figure, la
comunicazione del capo dello Stato è refrattaria ad ogni cedimento populistico e
a ogni semplificazione del messaggio. Il suo stile si contrappone apertamente a
una comunicazione leggera e imbottita di costruzioni colloquiali e sorretta con
una narratio assai debole, a tratti surreale, priva di una esposizione obiettiva. Il
linguaggio di Napolitano non solo non abbandona la codificazione normativa di
un testo scritto, ma respinge gli inconfondibili tratti morfo-sintattici del neo
standard parlato nell’età della videopolitica. Il presidente non concede ospitalità
eccessiva allo stile uniproposizionale con scarso valore informativo. Il suo stile di
comunicazione è una esplicita reazione alla decadenza linguistica della cosiddetta
seconda repubblica.
Una regolarità pare emergere nel comportamento del capo dello Stato in un
sistema bipolare senza solide ancore di partito: i grandi vuoti della dialettica
governo-opposizione assegnano al presidente un funzione inedita sia nella
confezione dell’indirizzo legislativo (con poteri cresciuti di informale
condizionamento) sia nel potere evocativo-simbolico che ricade sulle scelte delle
opposizioni invitate a prove di coesione. L’equilibrio dinamico tra poteri separati
e esigenze di coordinamento, ma anche una funzione di legittimazione del
51
Sulla continuità del linguaggio di Napolitano con le forme espressive della prima repubblica cfr.
S. Grimaldi, L’Italia nella narrazione del Presidente Napolitano, in “Comunicazione politica”,
2011, n. 1. Egli non manca tuttavia di comprendere il ruolo dell’opinione pubblica e di esaltare il
contributo delle “sfere sociali” (ivi, p. 84).
sistema istituzionale che non conta più su solide di partito, ricadono sulle spalle
del presidente. Il capo dello Stato si trasforma così in una riserva simbolica
preziosa che opera in un sistema che vede forze in via di sgretolamento e non
condivide le culture istituzionali, che è attraversato da linee di frattura anche
interne alle singole formazioni politiche. I due presidenti, uno espressione del
circuito elettorale e però sempre più debole e screditato l’altro che invece attinge
la propria forza dalla autorevolezza personale e da un legame con l’opinione
pubblica sprovvista dalle sponde di un governo prestigioso, coesistono. Una
potenza reale, quella che dovrebbe essere super partes, e una solo apparante,
quella del premier in crisi, che svelano la sola connessione istituzionale tra i vari
organi in cui è ripartito il potere politico quando soluzioni politiche diverse sono
ostruite e non è ipotizzabile, per il Quirinale, né lo scioglimento-sanzione né un
lavoro sotterraneo per in necessario ricambio. Un sistema maggioritario non
normalizzabile appare quello vigente. Il mito del premierato, che avrebbe dovuto
circoscrivere le competenze del presidente della repubblica, si converte in una
coabitazione indispensabile per la stessa sopravvivenza dell’esecutivo in
mancanza di alternative parlamentari percorribili. L’impossibilità di sciogliere le
camere (in presenza di reiterati voti di fiducia che formalmente accertano la
presenza del vincolo fiduciario) e l’evidente stato di ingovernabilità
dell’assemblea inducono il capo dello Stato non ad ampliare un potere di
intervento di carattere sostantivo (lo scioglimento esige una condizione non già
di mero cattivo funzionamento dell’aula ma di acclarato non-funzionamento) a
una estensione del proprio ambito d’azione e di consiglio. Si accenna una
concezione dualistica del governo in cui gli schematismi classici del governo
parlamentare coesistono con il rapporto fiduciario dell’esecutivo con il capo dello
Stato in un quadro di informale diarchia. La fiducia parlamentare diventa un
rituale che non rafforza l’esecutivo e tutti (anche l’opposizione) ricercano nel
Colle un sostegno o una guida che consente di superare il corto circuito nel
rapporto tra parlamento e governo. Anche se il capo dello Stato interviene con
disegni o con pressioni nel quadro politico, è sempre il sistema politico a
calibrare le forme e il ruolo del presidente della repubblica quale organizzazione
funzionale dei diversi organi costituzionali. La politicità di una struttura
garantista è diversa da quella di un soggetto politico di governo ma è pur sempre
una funzione politica che si esprime nelle forme della garanzia. Essere politico
senza lasciar sfumare l’abito garantista ed incarnare una veste di garanzia senza
irrigidire la funzionalità del sistema: questa è l’attitudine richiesta al capo dello
Stato.