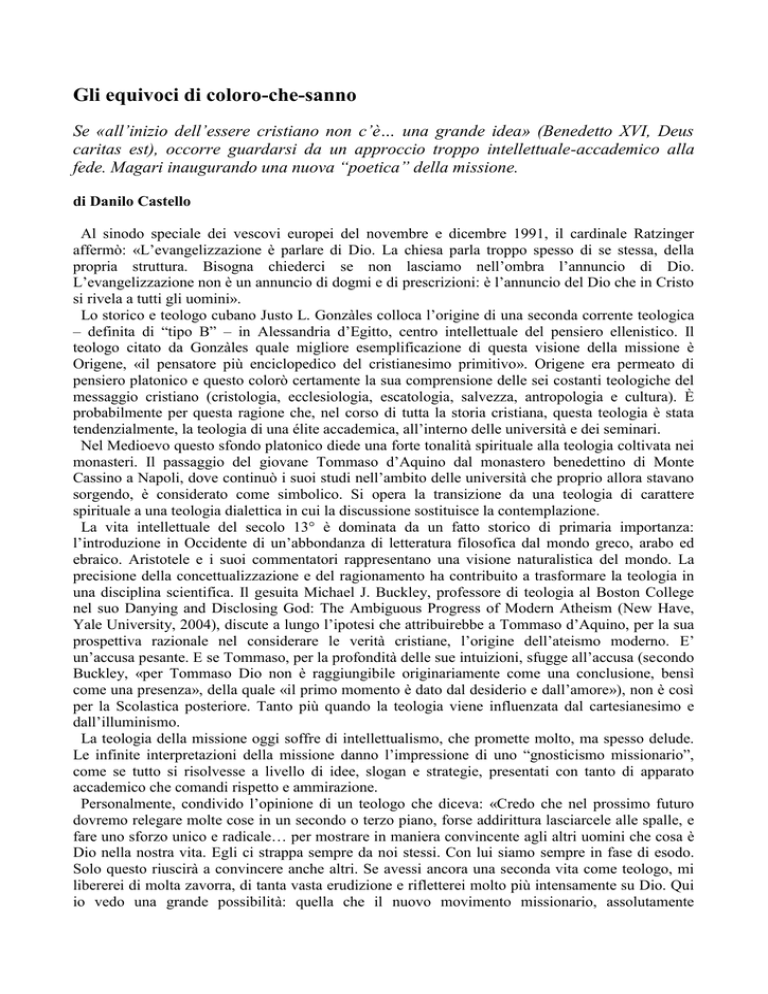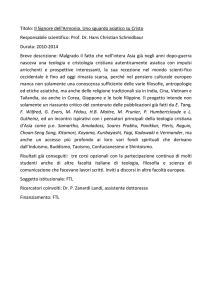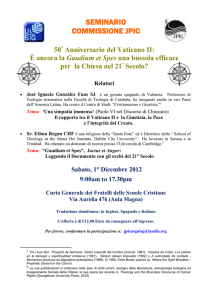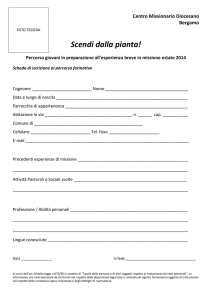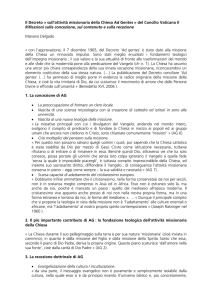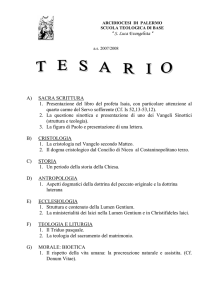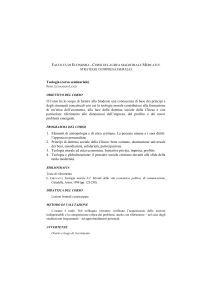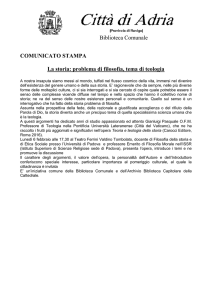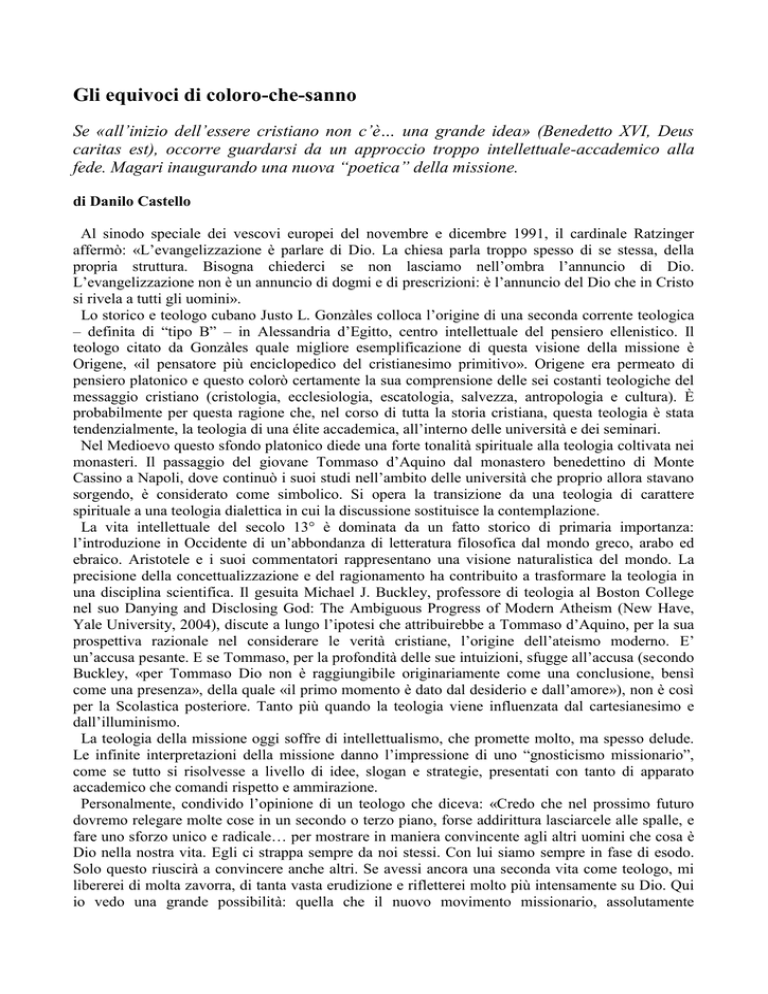
Gli equivoci di coloro-che-sanno
Se «all’inizio dell’essere cristiano non c’è… una grande idea» (Benedetto XVI, Deus
caritas est), occorre guardarsi da un approccio troppo intellettuale-accademico alla
fede. Magari inaugurando una nuova “poetica” della missione.
di Danilo Castello
Al sinodo speciale dei vescovi europei del novembre e dicembre 1991, il cardinale Ratzinger
affermò: «L’evangelizzazione è parlare di Dio. La chiesa parla troppo spesso di se stessa, della
propria struttura. Bisogna chiederci se non lasciamo nell’ombra l’annuncio di Dio.
L’evangelizzazione non è un annuncio di dogmi e di prescrizioni: è l’annuncio del Dio che in Cristo
si rivela a tutti gli uomini».
Lo storico e teologo cubano Justo L. Gonzàles colloca l’origine di una seconda corrente teologica
– definita di “tipo B” – in Alessandria d’Egitto, centro intellettuale del pensiero ellenistico. Il
teologo citato da Gonzàles quale migliore esemplificazione di questa visione della missione è
Origene, «il pensatore più enciclopedico del cristianesimo primitivo». Origene era permeato di
pensiero platonico e questo colorò certamente la sua comprensione delle sei costanti teologiche del
messaggio cristiano (cristologia, ecclesiologia, escatologia, salvezza, antropologia e cultura). È
probabilmente per questa ragione che, nel corso di tutta la storia cristiana, questa teologia è stata
tendenzialmente, la teologia di una élite accademica, all’interno delle università e dei seminari.
Nel Medioevo questo sfondo platonico diede una forte tonalità spirituale alla teologia coltivata nei
monasteri. Il passaggio del giovane Tommaso d’Aquino dal monastero benedettino di Monte
Cassino a Napoli, dove continuò i suoi studi nell’ambito delle università che proprio allora stavano
sorgendo, è considerato come simbolico. Si opera la transizione da una teologia di carattere
spirituale a una teologia dialettica in cui la discussione sostituisce la contemplazione.
La vita intellettuale del secolo 13° è dominata da un fatto storico di primaria importanza:
l’introduzione in Occidente di un’abbondanza di letteratura filosofica dal mondo greco, arabo ed
ebraico. Aristotele e i suoi commentatori rappresentano una visione naturalistica del mondo. La
precisione della concettualizzazione e del ragionamento ha contribuito a trasformare la teologia in
una disciplina scientifica. Il gesuita Michael J. Buckley, professore di teologia al Boston College
nel suo Danying and Disclosing God: The Ambiguous Progress of Modern Atheism (New Have,
Yale University, 2004), discute a lungo l’ipotesi che attribuirebbe a Tommaso d’Aquino, per la sua
prospettiva razionale nel considerare le verità cristiane, l’origine dell’ateismo moderno. E’
un’accusa pesante. E se Tommaso, per la profondità delle sue intuizioni, sfugge all’accusa (secondo
Buckley, «per Tommaso Dio non è raggiungibile originariamente come una conclusione, bensì
come una presenza», della quale «il primo momento è dato dal desiderio e dall’amore»), non è così
per la Scolastica posteriore. Tanto più quando la teologia viene influenzata dal cartesianesimo e
dall’illuminismo.
La teologia della missione oggi soffre di intellettualismo, che promette molto, ma spesso delude.
Le infinite interpretazioni della missione danno l’impressione di uno “gnosticismo missionario”,
come se tutto si risolvesse a livello di idee, slogan e strategie, presentati con tanto di apparato
accademico che comandi rispetto e ammirazione.
Personalmente, condivido l’opinione di un teologo che diceva: «Credo che nel prossimo futuro
dovremo relegare molte cose in un secondo o terzo piano, forse addirittura lasciarcele alle spalle, e
fare uno sforzo unico e radicale… per mostrare in maniera convincente agli altri uomini che cosa è
Dio nella nostra vita. Egli ci strappa sempre da noi stessi. Con lui siamo sempre in fase di esodo.
Solo questo riuscirà a convincere anche altri. Se avessi ancora una seconda vita come teologo, mi
libererei di molta zavorra, di tanta vasta erudizione e rifletterei molto più intensamente su Dio. Qui
io vedo una grande possibilità: quella che il nuovo movimento missionario, assolutamente
necessario, ma da tempo in crisi, non potrà mettersi in moto senza un nuovo slancio nella questione
di Dio, uno slancio che ci faccia di nuovo gioire molto di più a motivo della nostra fede».
GNOSTICISMO MISSIONARIO
«A causa della divisione e della confusione che si era prodotta tra i cristiani di Corinto. Paolo inviò
loro una lettera nella quale spiegava che, per quanto lo riguardava, il suo annuncio si concentrava
sul “Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani” (1Cor 1,23). I corinzi che
avevano formato gruppi o “partiti”, non avevano posto la loro adesione in primo luogo nella
persona di Cristo, bensì nelle idee di questo o quel predicatore. Per questo potevano dire: “Io sono
di Paolo”, “Io invece sono di Apollo”, “Io invece sono di Cefa”. Quei corinzi commisero un errore
che, nel corso della storia, non ha mai cessato di ripetersi: confondere l’insegnamento con la
predicazione, le idee o le dottrine con la fede… E’ ciò che conosciamo come gnosticismo, che più
tardi sarebbe stato condannato come eresia: credere che la salvezza è questione di concetti, idee,
dottrine, cioè conoscenza (gnosis). Importanti sarebbero le dottrine, gli insegnamenti, non la
persona del maestro. È nell’ambito comunitario gli insegnamenti di questo o quel leader ecclesiale
erano più importanti delle persone e delle relazioni personali. E proprio per questo si deprezzavano
e si divisero! Non è forse un quadro che risulta familiare anche oggi?» (E. Arens,
www.giovaniemissione.it).
«La nostra situazione odierna, non è diversa da quella denunciata da Paolo. Una delle ragioni per
cui l’evangelizzazione oggi manca di forza è perché si spendono troppe energie… in formulazioni
dottrinali… Ogni volta che si sono anteposti i concetti, le idee e le teologie alla persona di Gesù
Cristo, si sono verificate tensioni e divisioni. E tutte le volte che ciò è successo,ne hanno sofferto la
fiducia e la speranza, cioè la credibilità del Vangelo stesso» (ibid.).
Il mio lavoro mi ha costretto a vivere per molti anni in due mondi completamente diversi: quello
della comunità ecclesiale, con l’impegno di animarla missionariamente, e quello della scuola, in cui
mi sentivo quasi costretto a coltivare le virtù concernenti il lavoro accademico, con l’occhio sempre
rivolto alla documentazione e alla ricerca di quell’apparato scientifico con cui dovevo presentare
agli studenti il frutto del mio lavoro. I due mondi mi sono apparsi sempre più distanti l’uno
dall’altro, tanto da avere la netta sensazione di una polarizzazione delle due comunità: quella di chi
parla, propone paradigmi missionari e fa progetti sulla missione, e quelli di chi “fa missione”. I
missionari vengono prima formati nel mondo accademico, poi, una volta “inviati in missione”,
entrano in contatto con un mondo che parla un’altra lingua e pone domande nuove.
Provate a paragonare un incontro di carattere accademico sulla Bibbia e un gruppo di preghiera
che si confronta con la Parola di Dio. Tra i due atteggiamenti c’è un abisso. La teologia accademica
può diventare un ostacolo alla fede. Il credente ordinario vive lontano da discorsi fatti di teorie e
sottili distinzioni. Il problema è molto serio. Enfatizzando l’aspetto dottrinale, si allarga sempre più
il divario che separa i due mondi. Il rischio è di fare discorsi artificiosi, distanti dalla realtà e dalla
vita. È necessario tornare a una teologia della missione in cui ci sia un chiaro riscontro tra la
cattedra e il pulpito (Jürgen Moltmann). Una conoscenza che rimane intellettuale e non diventa
esperienziale, non nutre e non stimola all’azione.
TESTIMONIANZA DI VITA
Una teologia della missione eccessivamente intellettualizzata si espone a delle critiche che ne
mettono in luce i limiti.
La prima critica è che essa tende a operare un divorzio con l’esperienza. Parlo dell’esperienza
primaria dell’evangelizzatore, portatore di un dono di cui egli stesso vive, che gli suscita sentimenti
di “sorpresa” e “gratitudine” e lo carica di “urgenza”. Se l’evangelizzazione si riduce solo a
discorsi, conferenze e pubblicazioni, per molti continuerà a essere parole-parole-parole, non però
“la parola della croce”, così come Paolo la predicava e la spiegava ai corinzi. Sarà inefficace,
perché non sarà potenza e sapienza di Dio. «La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che
si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di dio. Sta scritto infatti:
“Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l’intelligenza degli intelligenti”» (1Cor 1,18-19).
In altre parole, l’evangelizzazione deve essere avallata dalle azioni e dalla vita stessa del
predicatore. Dev’essere coerentemente accompagnata dalla testimonianza della sua efficacia
salvifica nella vita del predicatore stesso. Paolo VI colpì nel segno, quando, nella sua esortazione
apostolica Evangelii nuntiandi (1975), osservò: «La testimonianza della vita è divenuta più che mai
una condizione essenziale per l’efficacia profonda della predicazione» (EN 76).
La seconda critica è molto più radicale e riguarda il linguaggio – definito “oggettivo ed
essenzialista” – usato per riflettere sul mistero dell’evangelizzazione, che invece richiederebbe un
approccio ben diverso. La nostra relazione con Dio (in fondo, è di questo che si tratta quando si
parla di evangelizzazione), espressa con categorie ontologiche, viene distorta e alterata. Nel
processo di evangelizzazione è Dio stesso vuole entrare in rapporto interpersonale con il suo
popolo. Questo dono di Dio, profondamente personale, quando è presentato con categorie
oggettiviste risulta sempre off center (fuori bersaglio). Si tratta, invece, di un mistero che va
accostato con le categorie personaliste dell’incontro e della intersoggettività. Più che il
ragionamento chiaro e distinto d’ispirazione filosofica, è la psicologia che può fornire valide
analogie per la comprensione di questa relazione.
Come terza osservazione critica, parlerei di assenza di stimoli e di motivazioni di carattere
esistenziale. Una teologia che manca di passione per una visione integrale del mistero della vita
cristiana – e capace di abbracciare mente, cuore, immaginazione ed emozioni – lascia indifferenti.
Troppo spesso la teologia accademica della missione si è focalizzata molto sulla mente e poco sul
cuore. Si è parlato – e tutt’ora si parla – di “priorità”, mentre si dovrebbero avvertire delle
“urgenze”. «Già dall’inizio del mio pontificato ho scelto di viaggiare fino agli estremi confini della
terra per manifestare la sollecitudine missionaria, e proprio il contatto diretto con i popoli che
ignorano Cristo mi ha ancor più convinto dell’urgenza di tale attività» (Giovanni Paolo II,
Redemptoris missio, 1).
La teologia non è solo un fatto cognitivo che si occupa di idee disincarnate come puro esercizio
intellettuale: deve diventare anche un fatto di relazione. Si è arrivati alla divisione artificiale tra
teologia e preghiera. Il grande Karl Barth aveva l’abitudine di incominciare le sue lezioni con una
preghiera, se non con il canto di un inno. I grandi teologi non hanno mai avvertito alcuna tensione
tra l’esplorazione intellettuale della fede cristiana e la sua attuazione pratica nella spiritualità, nella
predicazione, nel ministero e nella cura pastorale. La vera conoscenza di Dio porta a un
cambiamento che non è solo intellettuale ma di tutta la persona. Bellissima l’affermazione di
Benedetto XVI nella sua enciclica Caritas in veritate: «Il fare è cieco senza il sapere e il sapere è
sterile senza l’amore» (30).
RITORNO AL “RACCONTO”
Diceva bene Edward Schillebeekx (1914-2009), grande teologo olandese, uno degli ispiratori del
Concilio Vaticano II: «L’evangelizzazione è il riportare un “evento” che gli apostoli raccontano».
La Prima lettera di Giovanni gli dà ragione: «Quello che era da principio, quello che noi abbiamo
udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello contemplammo e che le nostre mani
toccarono del Verbo della vita – la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo
testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi –
quello che abbiamo veduto e udito,noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in
comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste
cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena» (1,1-4). David Bosch, in La trasformazione
della missione, invita a diffidare dal fare “teorie” sulla missione («La theoria comporta
osservazione, resoconto, interpretazione e valutazione critica») e suggerisce, invece, di delineare i
contorni della missione attraverso la poiesis, «che comporta la creazione o rappresentazione
immaginativa di immagini evocative». Secondo questo missiologo sudafricano, non si deve trattare
della missione in modo teorico, ma in “maniera poetica”.
Anche Aristide Fumagalli, in Mi sarete testimoni (Emi 2002), afferma che «la teoria deve cedere il
posto alla poetica della missione». Il che non significa fare della poesia sulla missione o mettere la
missione o mettere la missione, in versi. Si può fare anche questo, perché “la missione è bella”.
Poetica sta a indicare, invece, quella creatività che nasce dal far memoria della morte-risurrezione di
Cristo, gesto di donazione totale che ha reso bello il mondo in maniera radicale, a dispetto di tutte le
apparenze,. La Pasqua di Gesù sprigiona quella forza creativa che fu anticipata dalla profezia di
Ezechiele: «Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo» (Ez 36,26).
Un modello classico di questa teologia “poetica” è quello seguito da Agostino nella Confessioni. Il
Vescovo di Ippona dichiara espressamente l’intento e il procedimento “narrativo”: «Ignori, forse,
Signore, per essere tua l’eternità, ciò che ti dico, o vedi per il tempo ciò che avviene nel tempo?
Perché, dunque, ti faccio un racconto particolareggiato di tanti avvenimenti? Non certo perché tu li
apprenda da me. Piuttosto eccito in me e in chi li leggerà l’amore verso la tua persona… Ecco,
perché ti do molti fatti».
La teologia di Agostino “non parla di Dio”, ma “parla a Dio”, e a lui si volge con un fiducioso
“Tu”. «Confessandoti le nostre miserie e le tue misericordie su di noi, noi manifestiamo i nostri
sentimenti verso di te, affinché tu possa completare la nostra liberazione già da te iniziata» (ib.).
Commenta Giampiero Bof: «La teologia che qui si delinea è diaconia della Parola e del prossimo;
diaconia della Parola, per amore e in servizio del prossimo».
Una teologia missionaria deve diventare narrativa. Purtroppo, l’Occidente pare abbia perduto
“l’innocenza narrativa”. Alberto Maggi e Antonio Thellung, nel loro libro scritto a quattro mani, La
conversione dei buoni (Cittadella 2004), affermano: «Si potrebbe dire che la cosa più negativa del
cristianesimo reale, nel passato come nel presente, sia la preoccupazione di trasmettere dottrine,
catechismi, proposizioni dogmatiche, anziché far sperimentare significativi momenti dell’affetto
divino. Pensare secondo Dio non è mai legato a elaborazioni teorico-dottrinali, ma è scambio di
esperienze vissute, è condivisione generosa di quello che si ha e ancor più di quello che si è».
Gli autori di La Teologia della Missione oggi affermano: «Il dialogo è, naturalmente, l’unica
opzione disponibile nell’odierno mondo globalizzato e policentrico; esso include e deve includere
un momento di annuncio – di ciascun interlocutore all’altro». Questo dialogo deve essere preceduto
dal dialogo dell’evangelizzatore con il suo Dio, che lo manda a evangelizzare. È un dialogo reso
concreto in Gesù di Nazareth. Se questo dialogo esiste, la creatività che ne deriva saprà mettere in
movimento la dinamica d’”infinita traducibilità” del Vangelo, rivissuto nell’esperienza di contesti
culturali diversi. Di qui sorgeranno altre “narrazioni”, nuove teologie, in una inarrestabile processi
d’inculturazione. In questa prospettiva, possiamo sottoscrivere quanto scrivono Stephen B. Bevans
e Roger P. Schroeder: «Dal successo dell’inculturazione dipenderà il futuro della chiesa».
Se la teologia accademica non si rinnova, potrebbe trovarsi sempre più esiliata dalla comunità di
fede. le discussioni teoriche sulla missione sono incapaci di esercitare un ruolo profetico, perché
troppo legate a una impostazione scientifica. Pertanto, la teologia della missione, se vuole
sopravvivere, ha bisogno di una visione più integrale e organica. Se è vero che «all’inizio
dell’essere cristiani… non c’è una grande idea» (Benedetto XVI), allora diventa imperativo passare
da una “chiesa-comunità-di-coloro-che-sanno” a una “chiesa-comunità-di-coloro-chetestimoniano”.