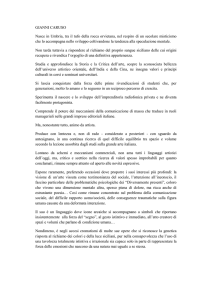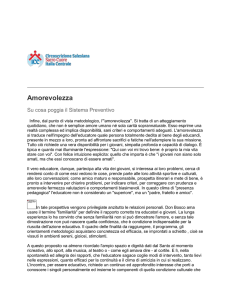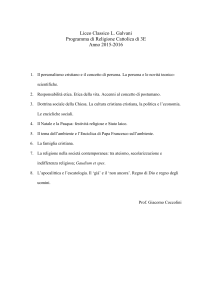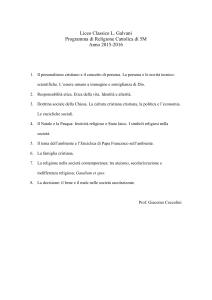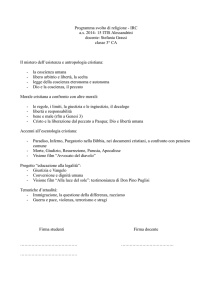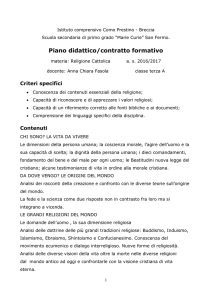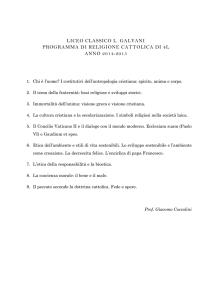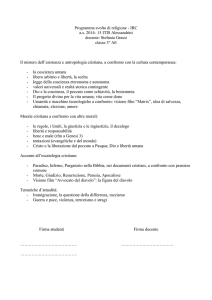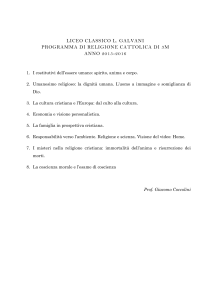Tra mentalità individualistica e voglia di comunità: una sfida per l'educazione
(Giuseppe Mari)
Tutti sappiamo che – all'inizio del suo percorso evolutivo – c'è un periodo nel quale l'essere
umano dice ripetutamente “no”. Si verifica attorno ai 2-3 anni di vita e viene ricondotto al
primo strutturarsi in forma consapevole della propria identità. In effetti, il rifiuto infantile,
opposto a un oggetto oppure a un invito, sembra voler marcare l'irriducibile “diversità” del
bambino, il suo essere “alterità” rispetto a chi ha di fronte. Si tratta di una tappa importante
nella crescita che fa incontrare il profilarsi della individualità in tutta la sua forza
dirompente. Non che prima il bambino non fosse un individuo, ma ora lo rende manifesto
attraverso un atto linguistico che demarca esplicitamente la sua persona da quella degli altri.
Il nostro “io” è sempre pronto a fare la sua comparsa, ne sentiamo e subiamo il richiamo al
punto che – nella coniugazione dei verbi – costituisce la “prima” persona, quella con la
quale si dà corso all'intera flessione verbale. Se tirassimo le somme, resteremmo
probabilmente sorpresi da quante volte – in una giornata oppure semplicemente in una
conversazione – diciamo “io” o comunque lo sottintendiamo. Non c'è da stupirsi, del resto
sono io che penso, parlo, agisco... Eppure un fatto ci prende immediatamente in contropiede
e ci costringe a riflettere: per tanto che il nostro “io” ci stia ordinariamente a cuore, nei
momenti straordinari tendenzialmente subentra il “noi”. Pensiamo, ad esempio, alla festa
(che ha una ricchissima densità antropologica): avrebbe senso viverla nell'isolamento? In
effetti, ci rendiamo immediatamente conto del fatto che la nostra “privacy” è importante, ma
senza un profilo anche pubblico non possiamo vivere. Oggi lo attesta, in modo improprio
ma sintomatico, il ricorso al mezzo televisivo per “mettere in piazza” situazioni e sentimenti
anche delicati, come pure l'analoga disinvoltura con cui su Facebook e affini si condividono
esperienze e valutazioni anche intime... Su un piano sicuramente molto più serio (anche se
non meno esposto al rischio), cioè in ambito affettivo, troviamo analoga conferma:
nonostante le molteplici attestazioni letterarie, artistiche, cinematografiche e – purtroppo –
anche esistenziali delle “pene d'amore”, è rarissimo il caso di qualcuno che deliberatamente
e progettualmente rinunci all'affettività, nella quale – com'è noto a tutti – l'“io” vive una
dinamica totalmente “estroflessa”, essendo alla ricerca del “tu” con cui fare coppia.
Perché accade questo? Perché l'“io” – per una paradossale e strutturale esigenza – aspira a
convertirsi in “noi”. Si tratta di un richiamo profondo, antropologico, che Agostino ha
sinteticamente espresso in una densa frase delle sue Confessioni: “Non c'era altro allora che
mi piacesse di più che amare ed essere amato”1. Quello che il santo Vescovo di Ippona
scrive dei suoi 16 anni, vale – anche se con sfumature diverse – per ogni età. Come mettere
1
1
Ordinario di Pedagogia generale, Università Cattolica del Sacro Cuore ([email protected]).
AGOSTINO D'IPPONA, Le confessioni, II, 2 (Milano, Paoline, 1987, p. 74).
insieme l'aspirazione ad affermare se stessi con l'istanza di superarsi nel “noi”? Come
interpretare l'accentuato richiamo che l'“io” esercita su di noi oggi? In quale modo
raccoglierlo per “educarlo” (cioè condurlo) a coniugarsi con il “noi” comunitario? Il breve
percorso che svolgeremo insieme intende raccogliere queste domande e offrire delle risposte
che, senza alcuna pretesa di esaustività, sono però guidate da una precisa aspirazione:
alimentare la speranza nel fatto che l'agire dell'educatore in generale e del catechista in
particolare può fronteggiare le sfide di oggi esattamente come è accaduto ieri.
1. LA “MENTALITÀ INDIVIDUALISTICA” COME ESPRESSIONE EMERGENTE DEL MONDO
ODIERNO
Il mondo odierno è esplicitamente connotato dal richiamo dell'“io”. Evidentemente non si
tratta di una novità, ma è nuova probabilmente la disposizione a manifestare questo
richiamo come se fosse in se stesso un valore, cioè mettendolo in primo piano rispetto alla
dimensione sociale e comunitaria che tradizionalmente soverchiava l'affermazione del “sé”.
In effetti, la martellante propaganda – nelle denominazioni dei prodotti e nei messaggi
pubblicitari – svolta nei confronti dell'“io” è piuttosto inedita. Non soltanto si estrinseca in
oggetti – dall'I-pod all'I-phone – che già nel nome s'indirizzano tematicamente al singolo,
ma si mettono anche sul mercato beni e offerte tarati sul “single” la cui prevalenza numerica
nel tessuto urbano (è di pochi mesi fa l'annuncio del fatto che a Milano sono la maggioranza
degli abitanti) viene celebrata come un traguardo sociale. Mai nel mondo antico questa
condizione sarebbe stata festeggiata né la mentalità cristiana la considera un valore perché,
se è vero che l'essere umano è creato a immagine e somiglianza di un Dio che è “relazione
sussistente”2, evidentemente per il cristianesimo non è nell'isolamento ma nella relazione
comunitaria che si esprime la pienezza della condizione umana. Del resto, come sappiamo,
la stessa condizione del consacrato non viene interpretata dalla Chiesa come corrispondente
a quella di chi sia celibe oppure nubile nel senso di “non” sposato, ma allude ad una
coniugalità di tipo spirituale. Donde viene questa inedita disposizione?
Probabilmente dal percorso storico degli ultimi tre-quattro secoli, nel quale si è venuta
configurando e – da ultimo – imponendo la civiltà liberale. Si tratta di un fenomeno di
grande rilevanza perché vi è correlata la democrazia come la conosciamo oggi. Dopo che
l'antica Grecia ha introdotto – ad Atene – questa pratica ma secondo una modalità “ristretta”
riservata a una minoranza di cittadini e il cristianesimo l'ha dilatata in forma corale
(pensiamo, ad esempio, al passo della Regola benedettina che prescrive di assumere anche il
parere del più giovane3), tra Sei e Settecento – in polemica con il potere monarchico,
l'“antico regime” – la democrazia liberale è stata contrapposta alle arbitrarie discriminazioni
sovrane (tra “stati”, ad esempio) in nome della originaria uguaglianza di tutti in quanto
individui nati da altri individui. Ne fanno fede le antiche Dichiarazioni dei diritti (a partire
da quella americana del 1776) che hanno introdotto in quella che Bobbio ha chiamato l'“età
2
Cfr. TOMMASO D'AQUINO, Somma teologica, I, q. 29, a. 4, resp.
3
Cfr. Regola di San Benedetto, in Regole monastiche antiche, III, 1 (Roma, Studium, 1990, p. 141).
2
dei diritti” a cui è correlata “La dottrina filosofica che ha fatto dell'individuo e non più della
società il punto di partenza per la costruzione di una dottrina della morale e del diritto”4.
Si è trattato – merita sottolinearlo – di una conquista perché, rivendicando l'uguaglianza
individuale, si è aperto un orizzonte che ha permesso l'emancipazione e molteplici
opportunità di cui abbiamo goduto ieri e continuiamo a godere oggi. Sennonché, il tempo ha
reso sempre più evidente il problema correlato a questa condizione, consistente nella
crescente solitudine da cui è afflitta una società che si concepisce come somma di interessi
individuali. Proprio la solitudine costituisce una delle cifre del presente, resa più manifesta
dal crescente disagio psicologico (pensiamo solamente al fenomeno della depressione,
piuttosto sorprendente se lo affianchiamo agli indubbi vantaggi della vita odierna) che
trasmette una fatica profonda, radicata nella contraddizione tra uno stato di crescente
isolamento nel quale ci troviamo (ancorché nascosto dal diffuso accesso ai molteplici
“media”) e l'intima domanda di relazione che abita il cuore della persona. Dove saremmo
arrivati, lo ha intuito con impressionante lucidità un grande intellettuale cattolico che fu
anche educatore di valore: Romano Guardini. In un volume del 1950 scrive questo: “Dal
momento che la realtà si espande al di là di ogni misura, si dissolvono gli elementi sui quali
riposava la rappresentazione medievale di un ordine: principio e fine, circonferenza e
centro. E insieme scompaiono i gradi e le corrispondenze gerarchiche che si stabiliscono fra
di loro ed anche i simboli che li sottolineano e li presuppongono. Ne consegue un insieme di
rapporti che procedono senza fine in tutte le direzioni e che da un lato garantiscono un
libero spazio, dall'altro rifiutano all'esistenza umana un suo proprio luogo obbiettivo.
L'esistenza ha ora uno spazio libero dove muoversi, ma non più una sua dimora”5.
In effetti, la rivendicazione della individualità come matrice dell'identità ha portato – oltre
agli indubbi vantaggi – l'esplosione del “narcisismo” (su cui tornerò tra breve) cioè della più
completa autoreferenzialità nel pensare e nell'agire. L'idolatria dell'“io” ha alimentato la
“me generation” – come la chiama Charles Taylor6 – cioè l'onnivora disposizione a tutto
ricondurre a quella che l'allora card. Ratzinger – nella omelia tenuta per la Missa pro
eligendo pontifice (18.4.2005) – chiamò “dittatura del relativismo che non riconosce nulla
come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie”. Come
bambini inseguiamo la nostra soddisfazione, essendo in difficoltà ogni volta che si tratta di
compiere scelte definitive (pensiamo alla crisi delle vocazioni di speciale consacrazione che
va di pari passo con quella della vocazione matrimoniale), viviamo nel vortice di un
continuo disordinato desiderare che ci consuma perché – inseguendo il piacere – non siamo
capaci di porci dei limiti. Il disagio giovanile è esemplare di questo, perché registra il
richiamo ingovernabile di esperienze dissipatrici la cui attrattiva consiste nell'alterazione
della percezione spazio-temporale. Che cosa, infatti, accomuna l'alcolismo e il consumo di
stupefacenti (per fare solo due esempi), se non il piacere correlato alla presunta
cancellazione del limite percettivo connotante la comune esperienza della realtà?
4
N. BOBBIO, L'età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990, p. 57.
5
R. GUARDINI, La fine dell’epoca moderna, Brescia, Morcelliana, 1954, p. 38.
6
3
Cfr. C. TAYLOR, Il disagio della modernità, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 7.
Molto recentemente, in un volume dello psichiatra laico L. Zoja, si trova una riflessione
nella quale sembra risuonare la già citata frase guardiniana: “Da dove ci siamo allontanati,
se tutti siamo lontani? Ci siamo allontanati dai contenitori universali. Non siamo più protetti
da pareti. Il rapporto Io-Tu era la parete più vicina di una serie di fortezze, una interna
all'altra. Se non ci sono più bordi, né le mani di Dio e del prossimo, forse, come dice la
poesia di Rilke (Herbst) stiamo tutti cadendo. La differenza è che non sappiamo da dove, né
verso dove”7. È questa la condizione “liquida” di cui parla il sociologo Bauman,
evidenziando come l'identità oggi sia fragile perché – come accade a ciò che è liquido – non
ha forma propria ma assume quella del contenitore, inoltre è difficile raccoglierla ed è
sempre esposta al rischio della dispersione8.
Di fronte a questa condizione di ampia e diffusa dissoluzione rischiamo di essere presi dallo
sconforto e – come educatori – di essere spiazzati, sentendoci impari al compito, al punto
che – come ricorda il nostro Vescovo alla fine della sua Lettera Tutti siano una cosa sola –
“qualcuno teorizza addirittura l'impossibilità di educare oggi”9. É sempre lui, però, a
ricordarci che i cristiani sono stati redenti cioè riscattati rispetto a questa e a tutte le altre
“paure”: “Cristo ha preso possesso delle loro esistenze e le plasma con la forza del suo
amore, del suo Spirito. Siccome credono all'amore di Dio, sono strappati fuori dagli egoismi
del mondo; siccome vivono nel mondo, essi modificano il mondo secondo la logica
dell'amore di Dio. Insomma il compito della Chiesa è offrire il mondo a Cristo come suo
corpo e donare Cristo al mondo come suo capo; in altre parole, animare e trasformare il
mondo secondo lo Spirito di Cristo”10. Ci vuole, quindi, fiducia. La fiducia è essenziale per
l'educatore perché educare significa “trasformare”, cioè interpretare il dato come mandato.
Non si tratta, quindi, di arrendersi alla “evidenza”, ma di scrutare – dentro il fenomeno – ciò
che vi si trova in forma virtuale, suscettibile quindi di manifestarsi. L'educazione, infatti,
movendo dal “dato”, sviluppa un duplice vettore. Per un verso esprime educĕre cioè “fa
emergere” dall'educando le sue virtualità inespresse, per l'altro educāre cioè “alimenta”
l'educando con stimoli culturali che lo scuotono. Non ci dobbiamo, di conseguenza,
arrendere allo “spirito del tempo”, ma dobbiamo chinarci su chi ci è affidato per riconoscere
“chi” solo lui può diventare e offrirgli quel contributo d'umanità (in questo consiste la
cultura) che ci viene dalla tradizione ed è in grado di stimolare la riuscita di un profilo
umano del tutto inedito.
Dove sta il “punto critico” su cui fare leva? Evidentemente in ciò che ci connota come
essere umani ovvero la nostra libertà.
2. QUALE LETTURA DARE DEL FENOMENO DALLA PROSPETTIVA EDUCATIVA?
7
L. ZOJA, La morte del prossimo, Torino, Einaudi, 2009, p. 43.
8
Cfr. Z. BAUMAN, Modernità liquida, Roma-Bari, Laterza, 2006; ID., Amore liquido, ivi, 2006.
9
L. MONARI, Tutti siano una cosa sola, conclusione.
10
Ivi, 14.
4
Per introdurmi in una sintetica lettura critica della sfida implicata nell'individualismo
odierno, traggo spunto da un testo di Benedetto XVI il quale, in risposta all'invio del volume
Perché dobbiamo dirci cristiani di Marcello Pera, esponente della cultura liberale, ha scritto
all'autore una breve lettera dove svolge un'osservazione che a me è parsa fondamentale.
Confrontandosi con l'“essenza” del liberalismo, il Papa aderisce al riconoscimento della sua
radice cristiana e osserva che “il liberalismo, senza cessare di essere liberalismo ma, al
contrario, per essere fedele a se stesso, può collegarsi con una dottrina del bene, in
particolare quella cristiana” (4.9.2008). In effetti, dal momento che la cultura liberale
riconosce alla radice della dignità di ciascuno la configurazione di individuo da individuo,
professa l'esistenza di una “natura umana” cioè di qualcosa a tutti comune per nascita. Ecco
il “bene”, cioè non il riconoscimento di ciò che vale in ragione di un avvaloramento (il
“valore”) ma di ciò che vale per se stesso. Si tratta di una riflessione che il Pontefice ha
svolto con chiarezza e ampiezza nella lettera enciclica Caritas in Veritate (29.6.2009), ad
esempio dove afferma: “Occorre (...) che l'uomo rientri in se stesso per riconoscere le
fondamentali norme della legge morale naturale che Dio ha inscritto nel suo cuore” 11. La
riflessione del Papa trae origine dalla convinzione che l'essere umano presenti una intima
configurazione che si rende riconoscibile nella comune nascita individuale, ma – in realtà –
rimonta alla originaria creazione personale da parte di Dio. In altre parole: l'espansione
onnivora della individualità, adducente all'affermazione egoistica dell'“io”, costituisce una
degenerazione di qualcosa che – se ben guidato (cioè educato) – porta alla fioritura di un
essere umano che, mentre afferma la propria singolarità, è anche capace di riconoscere che
questa riguarda tutti gli altri esseri umani, ciascuno secondo il proprio originale profilo.
Che cosa permette questo? Che cosa fa sì che l'essere umano – a differenza degli altri
animali – non si perda nella impersonalità della specie ma sappia esprimere la propria
irripetibile originalità? La libertà. E proprio sull'idea di libertà si è consumato l'equivoco che
ha portato – in modo unilaterale e contraddittorio rispetto all'intima natura comunionale
dell'essere umano – alla solitudine intesa e praticata come isolamento, con cui oggi
facciamo i conti. Infatti, la tendenza che ha prevalso in seno alla civiltà modellata
dall'ideologia liberale, è stata quella della libertà come affermazione della propria
assolutezza, da parte dell'essere umano, come se l'essere umano bastasse a se stesso, fosse
padrone di sé e del suo destino. Ma questo ha condotto a sperimentare una crescente
solitudine che negli studi è stata da tempo associata al già evocato “narcisismo”.
Uno studioso statunitense – Christopher Lasch – ha fatto da pioniere affrontando una
trentina d'anni fa la questione che oggi è al centro della riflessione pedagogica. Egli, in
particolare, ha svolto due osservazioni che mi sembrano assai pertinenti. Ha denunciato la
fragilità del narcisista che “attende da altri la conferma della sua autostima. Non può vivere
senza un pubblico di ammiratori. La sua apparente libertà dai legami familiari e dai vincoli
istituzionali non lo rende più autonomo, o fiero della propria individualità. Al contrario, essa
alimenta l'insicurezza”12. Inoltre, ha concluso che il narcisismo è “la fede di chi non ha più
fede”13. In effetti, quando viene meno la fede nell'“Altro”, la fede in Colui con il quale la
11
12
13
5
BENEDETTO XVI, Caritas in Veritate, 68.
C. LASCH, La cultura del narcisismo, Milano, Bompiani, 1981, p. 22.
Ivi, p. 66.
libertà umana esprime anche tensione (pensiamo solamente alla “lotta” di Giacobbe con
Dio: Gn 32,23-33), l'“io” si attacca all'unica cosa che gli rimane, cioè se stesso, ma – in
questo modo – si condanna all'immaturità. Il problema, infatti, consiste in questo: stante
l'intima conformazione relazionale della persona non solamente la libertà vissuta in chiave
individualistica condanna alla solitudine, ma anche sul piano psicopedagogico alimenta la
sofferenza di chi vede frustrata la propria aspirazione ad amare e farsi amare, per riprendere
la frase agostiniana.
Come affrontare il narcisismo? Da cosa è stato incoraggiato nella pratica educativa? Il
problema è complesso, ma si può dare almeno una indicazione. Il bambino, come tutti
sappiamo (e come sapeva anche Freud che coniò l'espressione “narcisismo” proprio
movendo dalla considerazione del vissuto infantile), ha un profilo radicalmente narcisistico
nel senso che persegue la soddisfazione dei suoi bisogni. Egli è, però, intimamente portatore
di libertà come capacità di limitare e guidare il desiderio. Ma, affinché questa disposizione
fiorisca nel segno dell'indispensabile decentramento, occorre che incontri l'autorità come
fattore limitante. Negli ultimi decenni sul concetto (che oggi è fatto segno di crescente
interesse dalla prospettiva pedagogica) si sono appuntate critiche di ogni tipo, alimentate
essenzialmente da due equivoci. Anzitutto la convinzione che la libertà sia già matura
all'inizio della parabola esistenziale (con il conseguente rifiuto di ogni limitazione alla sua
espressione), quindi la confusione tra la pratica corretta dell'autorità (che domanda
all'educatore di essere testimone coerente dei limiti che pone) e la sua degenerazione in
forma autoritaria (quando chi educa pone agli altri limiti che rifiuta per sé).
Il corretto esercizio dell'autorità avviene in chiave relazionale, cioè all'interno di un rapporto
personale nel quale l'educatore pone limiti che egli stesso rispetta. In questo modo rende
l'educando capace di conseguire gradualmente il controllo di sé, limitando il richiamo
narcisistico. Ne segue la maturazione di identità capaci di guidare il proprio desiderio, per
questa ragione dotate di stima di sé (proprio quella che manca a tanti adolescenti e giovani
di oggi abituati a ricevere tutto senza conquistare mai niente) e capacità di interazione con
gli altri. Chi ha fruito di questo indispensabile tirocinio non si comporta da individuo, ma
come individuo-in-relazione cioè persona.
3. COME AFFRONTARE LA SFIDA NARCISISTICA ASPIRANDO A DECLINARE L'INDIVIDUALITÀ IN
CHIAVE COMUNITARIA?
L'idea di “persona” è essenziale per guidare l'individuo a riconoscersi un profilo relazionale.
Si tratta probabilmente del contributo più rilevante che il cristianesimo ha dato alla cultura
perché ha permesso di evidenziare come l'individualità debba evitare sia di assolutizzarsi
nell'individuo sia di stemperarsi nel collettivo. In effetti, il mondo pagano, che pure ha
scorto l'originalità dell'essere umano, ha sempre oscillato tra due estremi: da una parte il
riconoscimento (ma solo a pochi) del diritto di affermare se stessi (pensiamo, ad esempio,
alla concezione aristocratica dell'educazione che riservava alle élite la possibilità di formarsi
e coltivare la propria umanità condannando la massa ad una esistenza anonima), dall'altra la
totale subordinazione del bene individuale a quello comunitario ritenuto egemone (infatti i
primi cristiani vennero perseguitati come sovvertitori dell'ordine civile in quanto, a
differenza di altri credenti, non accettavano di conformarsi a un universo religioso che
6
cresceva per accumulazione sincretistica di divinità accomunate solamente dalla
funzionalità all'ordine politico). Il cristianesimo, introducendo l'idea di persona, afferma che
ciascuno è amato singolarmente da un Dio che intimamente è Comunione (la SS. Trinità),
che è Emmanuele cioè “Dio con noi” (Is 7,14 e Mt 1,23), un Dio “solo ma non solitario” 14
come afferma il padre della Chiesa Pier Crisologo. Si tratta, cioè, di un rapporto religioso
che coniuga singolarità e comunità come il Dio di cui l'essere umano è immagine (Gn 1).
Non è casuale che l'antropologia cristiana abbia esercitato un ruolo di primo piano, nella
prima metà del Novecento, quando si profilò la sfida del confronto tra due modelli antitetici:
quello individualista occidentale e quello collettivista orientale. Di fronte alla presunta
drasticità dell'alternativa, il personalismo pose una prospettiva diversa, quella di riconoscere
l'individualità dell'essere umano come ordinata alla costituzione di relazioni solidali e quella
di interpretare l'aggregazione collettiva come non l'annientamento della singolarità
personale ma il suo esito sinfonico. In effetti, l'idea di persona, essendo anzitutto associata
al Dio trinitario predicato da Cristo (e solo in un secondo tempo all'essere umano creato a
Sua immagine), pone l'identità come strettamente correlata all'alterità e viceversa. La fede
cristiana ha insegnato all'essere umano che è amato singolarmente da Dio, ma – così
facendo – non ha inteso dare libero corso all'egocentrismo di ciascuno perché questo Dio è
intimamente Comunione, quindi offre e domanda amore. Ecco perché l'educazione cristiana
si è espressa nella forma della paternità/maternità spirituale, come osserva Marrou – il più
grande studioso dell'educazione antica –, introducendo una radicale novità nel costume
pedagogico antico: “È in questa stretta associazione (...) e nella sintesi del maestro (o del
professore) e del padre spirituale nella persona d'un precettore, che mi sembra risiedere
l'essenza stessa della scuola cristiana – dice –, della pedagogia medievale, in opposizione
all'antica”15.
Come fare a rilanciare questa lezione nel contesto attuale, reso asfissiante
dall'“intossicazione individualistica”? Benedetto XVI pone con frequenza una esigenza che
merita considerare dalla prospettiva pedagogica: l'allargamento del concetto di razionalità16.
Cosa significa? La stagione liberale ha preso forma all'interno della modernità la quale ha
registrato l'imporsi di una modalità particolare di considerare la razionalità umana: quella di
tipo descrittivo-strumentale. In altre parole, è stato sempre più posto l'accento su ciò che –
all'interno della conoscenza umana – è suscettibile di descrizione oggettiva e traduzione
strumentale. Si tratta di caratteristiche sicuramente apprezzabili, ma che hanno un comune
limite: riducono tutto ciò che conta solamente a ciò che serve. Una precisazione s'impone:
ciò che “serve” non rimanda al “servizio”, ma alla “servitù”. Mi spiego. Quando la
modernità sostiene questo, intende porre l'esigenza di perseguire una conoscenza funzionale
cioè utile. Nulla da eccepire, se non che l'essere umano – in quanto persona – non serve a
14
PIER CRISOLOGO, Omelia LVII, 3 (in Omelie per la vita quotidiana, Roma, Città Nuova, 19902, p. 190).
15
Cfr. TOMMASO D'AQUINO, Somma teologica, I, q. 29, a. 4, resp. Si tratta di un concetto ripreso dal
CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes, 24: “l'uomo, il quale in terra è la sola creatura che Iddio abbia
voluto per se stesso”.
16
Cfr. BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, 33.
7
niente, ma è fine in sé17 (perché immagine di Dio che sarebbe blasfemo considerare
“utile”), quindi non si può riconoscere in un sapere ridotto solo a ciò che pragmaticamente è
utilizzabile. Se è fine in sé, l'essere umano non può essere associato a una conoscenza
“servile”: da Cristo è chiamato a “servire” ma perché liberamente – cioè per amore –
intende donarsi, non perché utilitaristicamente (per tornaconto, paura, interesse...) vuole
farsi usare. Ciò ha determinato una crescente estraneità tra la conoscenza e la persona, la
quale infatti oggi molto spesso si trova ad avere molteplici conoscenze che le risultano
insignificanti. Non è questo il problema di tanti adolescenti e giovani, molto dotati di
conoscenze strumentali ma – appunto per questo – incapaci di darsi un progetto di vita, di
condurre un'esistenza positiva e bella? Non c'è questo dietro a tanto disagio?
Allargare l'idea di razionalità, quindi, significa reintrodurre nell'orizzonte della conoscenza
umana anche quella componente (legata, ad esempio, al sentimento) che non si connota per
la sua funzionalità ma perché esprime la singolarità dell'identità personale, sottrarla
all'irrazionalità e trattarla per quello che realmente è: un modo tipicamente umano di
conoscere. Del resto, l'educazione cristiana è stata sempre attenta all'interezza dell'essere
umano, sottolineando come una pluralità di vettori – che si rispecchiano in una razionalità
multiforme e variegata – concorrano a educare, come attesta – ad esempio – il gesuita
Baltasar Gracián: “Non si nasce già completi: ci si perfeziona ogni giorno nella persona e
nelle azioni fino a che, con l'acquisizione di doti eminenti, si giunge alla pienezza
dell'essere. Questa si riconoscerà dalla raffinatezza del gusto, dalla purezza del pensiero,
dalla maturità di giudizio, dalla linearità della volontà”18. Non possiamo misconoscere che,
negli ultimi decenni, abbiamo abbracciato una pratica educativa troppo sbilanciata in senso
cognitivo, nella quale all'allestimento intellettuale non corrisponde un'adeguata formazione
della volontà, e il dilatarsi della razionalità strumentale emargina fino a farla scivolare nella
irrazionalità la dimensione affettivo-relazionale. Forse bisogna riprendere in considerazione
la più ampia dimensione comunicativa della ragione, mirando a coniugare fattori (come
l'intelligenza e la volontà, la funzionalità e l'affettività) che sono stati impropriamente
contrapposti.
4. QUALI ATTENZIONI SPECIFICHE NELLA PRATICA EDUCATIVA?
Come mostra la ripresa del concetto di persona all'interno del personalismo, l'idea racchiude
in sé il riconoscimento della singolarità e la sua declinazione in forma plurale. Prendere le
mosse, quindi, da questa ispirazione antropologia significa essere in grado di affrontare la
tensione tra “mentalità individualistica” e “voglia di comunità” in chiave non ideologica,
cioè senza demonizzare questa polarità che è presente da sempre nel cuore umano, ma
operando perché giunga a composizione matura. Alcune avvertenze possono guidarci nel
nostro compito educativo – anche di catechisti – e su queste sinteticamente concludo.
17
Cfr. la spiegazione etimologica di persona come per se una in TOMMASO D’AQUINO, Somma teologica,
I, q. 29, a. 4, resp.
18
B. GRACIÁN, La forza della prudenza, Milano, O. Mondadori, 2009, p. 19.
8
a) Il richiamo della persona come vivente e concreta unità di anima e corpo, intelligenza e
volontà, strumentalità e affettività comporta la pratica di un intervento educativo che non si
limita all'allestimento della sola dimensione cognitiva. Dobbiamo riuscire ad attivare tutta la
persona, ad esempio anche la sua dimensione estetica, sensoriale, emozionale. In proposito,
occorre valorizzare le forme comunicative che ci stimolano globalmente, dalla musica
all'arte in genere, dal rapporto con la natura all'esperienza del raccoglimento.
b) Forse dobbiamo ridimensionare la nostra aspirazione didascalica. È vero che veniamo
dopo l'illuminismo, quindi ci sentiamo impegnati a offrire le più ampie spiegazioni in merito
a quello che facciamo allo scopo di non apparire arbitrari, ma il fatto è che non tutto può
essere spiegato perché – come osserva Marcel19 – non tutto è problema, c'è anche (per noi –
in quanto credenti – soprattutto) il mistero. Sul piano pedagogico, la medesima convinzione
porta Maritain a dire: “Non è vero che tutto possa essere insegnato”20. Cosa significa? Che
esiste anche una comunicazione – sul piano pedagogico – che supera la didattica intesa
come pratica formale dell'insegnamento. Prendiamo, ad esempio, l'empatia su cui oggi molti
studi insistono: riuscire a sentire le emozioni dell'altro, mantenendo la differenziazione da
lui che deve accompagnare l'azione dell'educatore (chiamato sempre a non confondersi con
colui che sta guidando), permette di attivare una comunicazione profonda che fa apprendere
senza che ci sia insegnamento. Domandiamoci, quindi, quanta attenzione rechiamo
all'esigenza di alimentare il senso del mistero all'interno della nostra prassi catechistica e di
praticare una relazione empatica.
c) Prima richiamavo la necessità di non farsi sequestrare da una visione angusta della
razionalità, quella di tipo meramente o prevalentemente cognitivo. Noi non siamo
intelligenze angeliche, siamo anime incarnate e corpi animati: la dimensione pratica, fisica,
fattuale ci è intimamente congeniale. Forse, da questo punto di vista e allo scopo di
contenere la deriva intellettualistica da cui è affetta l'educazione occidentale, dovremmo
valorizzare di più la carità, intesa come il tirocinio pratico che permette, attraverso il
servizio concreto, di cimentarci per tutto quello che siamo: intelligenza, sentimento,
emozione.
d) Un analogo rischio di unilateralità corriamo sul versante della socialità. Se è vero che
l'essere umano è connotato dalla vocazione alla libertà, intesa come l'aspirazione a
riconoscere, scegliere e praticare il meglio, allora non possiamo ridurre la relazione con gli
altri a mero adattamento. Forse, in realtà, proprio questo è avvenuto non infrequentemente e
questo spiega perché, dopo decenni di continuo richiamo alla socializzazione, facciamo i
conti con generazioni segnate da un tracimante narcisismo: si può essere, infatti,
perfettamente egoisti e perfettamente integrati basta aver imparato a non pestarsi
reciprocamente i piedi. La vera socialità rimanda a qualcosa d'altro: non l'adattamento ma la
19
Cfr. G. MARCEL, “Diario metafisico”, in ID., Essere e avere, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1999,
pp. 79-80 (il problema sta di fronte all'essere umano, mentre questi nel mistero è immerso).
20
J. MARITAIN, L'educazione al bivio, Brescia, La Scuola, 1963, p. 39.
9
disposizione a migliorare noi stessi e a migliorare il gruppo in cui siamo inseriti
manifestando – ancora una volta – la natura etica della sfida educativa.
e) Infine, ma non perché sia la cosa di minor conto: se è vero che intimamente rechiamo
un'istanza comunicativa (per i credenti, correlata al Mistero della SS. Trinità), allora
dobbiamo seriamente interrogarci su quanto – all'interno della nostra pratica educativa –
siamo capaci di costruire relazioni significative con i nostri destinatari. In mancanza di
queste, infatti, il nostro intervento – anche quando sia motivato e preparato – rischia di
rimanere superficiale, quando non di scivolare verso forme camaleontiche di confusione e
complicità del tutto improprie quando si educa.
10