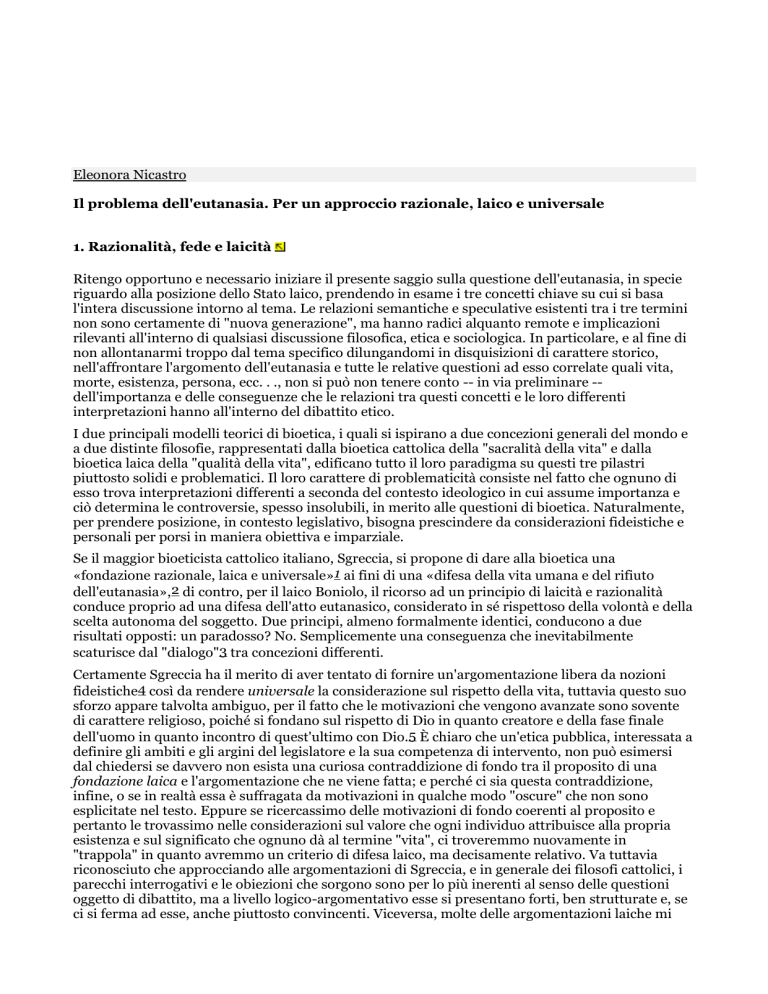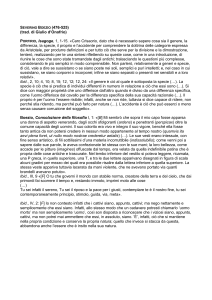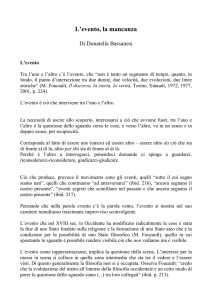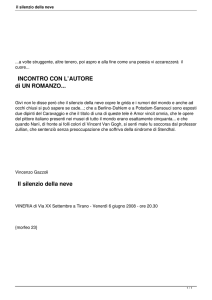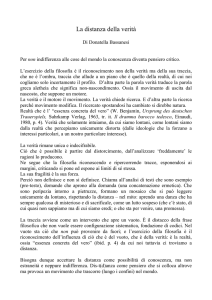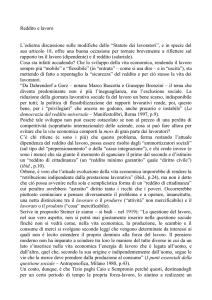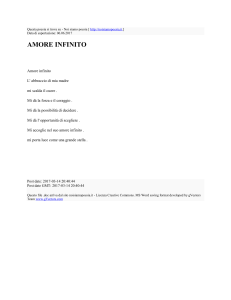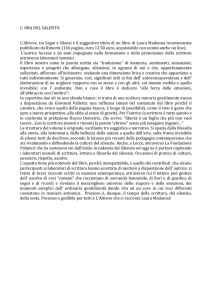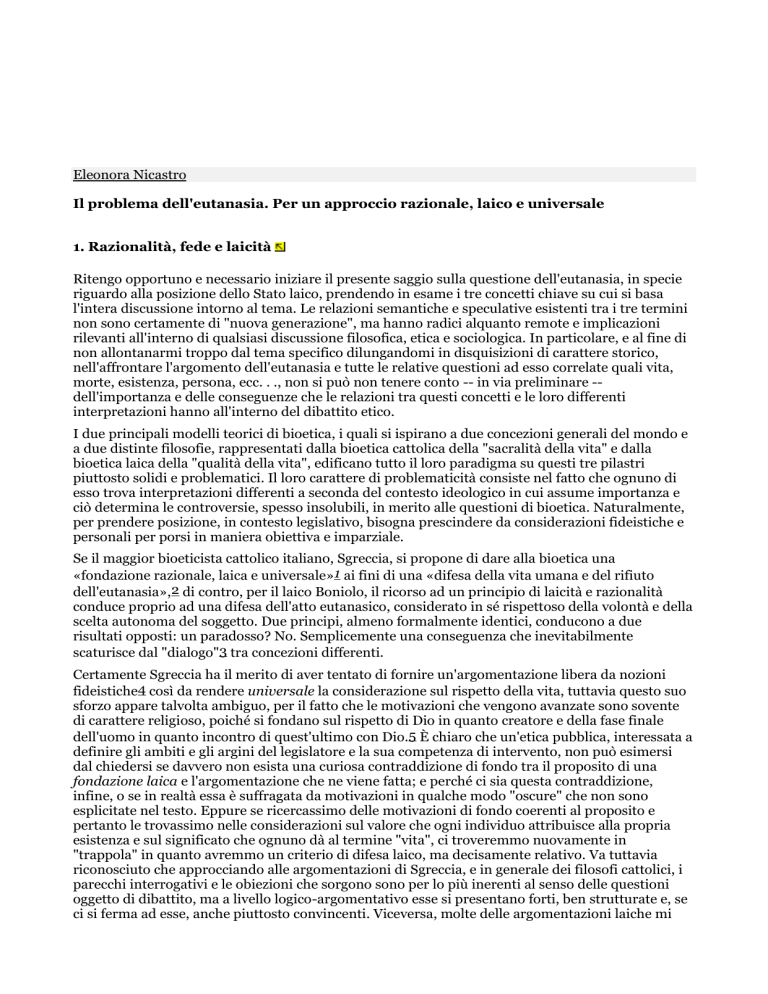
Eleonora Nicastro
Il problema dell'eutanasia. Per un approccio razionale, laico e universale
1. Razionalità, fede e laicità
Ritengo opportuno e necessario iniziare il presente saggio sulla questione dell'eutanasia, in specie
riguardo alla posizione dello Stato laico, prendendo in esame i tre concetti chiave su cui si basa
l'intera discussione intorno al tema. Le relazioni semantiche e speculative esistenti tra i tre termini
non sono certamente di "nuova generazione", ma hanno radici alquanto remote e implicazioni
rilevanti all'interno di qualsiasi discussione filosofica, etica e sociologica. In particolare, e al fine di
non allontanarmi troppo dal tema specifico dilungandomi in disquisizioni di carattere storico,
nell'affrontare l'argomento dell'eutanasia e tutte le relative questioni ad esso correlate quali vita,
morte, esistenza, persona, ecc. . ., non si può non tenere conto -- in via preliminare -dell'importanza e delle conseguenze che le relazioni tra questi concetti e le loro differenti
interpretazioni hanno all'interno del dibattito etico.
I due principali modelli teorici di bioetica, i quali si ispirano a due concezioni generali del mondo e
a due distinte filosofie, rappresentati dalla bioetica cattolica della "sacralità della vita" e dalla
bioetica laica della "qualità della vita", edificano tutto il loro paradigma su questi tre pilastri
piuttosto solidi e problematici. Il loro carattere di problematicità consiste nel fatto che ognuno di
esso trova interpretazioni differenti a seconda del contesto ideologico in cui assume importanza e
ciò determina le controversie, spesso insolubili, in merito alle questioni di bioetica. Naturalmente,
per prendere posizione, in contesto legislativo, bisogna prescindere da considerazioni fideistiche e
personali per porsi in maniera obiettiva e imparziale.
Se il maggior bioeticista cattolico italiano, Sgreccia, si propone di dare alla bioetica una
«fondazione razionale, laica e universale»1 ai fini di una «difesa della vita umana e del rifiuto
dell'eutanasia»,2 di contro, per il laico Boniolo, il ricorso ad un principio di laicità e razionalità
conduce proprio ad una difesa dell'atto eutanasico, considerato in sé rispettoso della volontà e della
scelta autonoma del soggetto. Due principi, almeno formalmente identici, conducono a due
risultati opposti: un paradosso? No. Semplicemente una conseguenza che inevitabilmente
scaturisce dal "dialogo"3 tra concezioni differenti.
Certamente Sgreccia ha il merito di aver tentato di fornire un'argomentazione libera da nozioni
fideistiche4 così da rendere universale la considerazione sul rispetto della vita, tuttavia questo suo
sforzo appare talvolta ambiguo, per il fatto che le motivazioni che vengono avanzate sono sovente
di carattere religioso, poiché si fondano sul rispetto di Dio in quanto creatore e della fase finale
dell'uomo in quanto incontro di quest'ultimo con Dio.5 È chiaro che un'etica pubblica, interessata a
definire gli ambiti e gli argini del legislatore e la sua competenza di intervento, non può esimersi
dal chiedersi se davvero non esista una curiosa contraddizione di fondo tra il proposito di una
fondazione laica e l'argomentazione che ne viene fatta; e perché ci sia questa contraddizione,
infine, o se in realtà essa è suffragata da motivazioni in qualche modo "oscure" che non sono
esplicitate nel testo. Eppure se ricercassimo delle motivazioni di fondo coerenti al proposito e
pertanto le trovassimo nelle considerazioni sul valore che ogni individuo attribuisce alla propria
esistenza e sul significato che ognuno dà al termine "vita", ci troveremmo nuovamente in
"trappola" in quanto avremmo un criterio di difesa laico, ma decisamente relativo. Va tuttavia
riconosciuto che approcciando alle argomentazioni di Sgreccia, e in generale dei filosofi cattolici, i
parecchi interrogativi e le obiezioni che sorgono sono per lo più inerenti al senso delle questioni
oggetto di dibattito, ma a livello logico-argomentativo esse si presentano forti, ben strutturate e, se
ci si ferma ad esse, anche piuttosto convincenti. Viceversa, molte delle argomentazioni laiche mi
appaiono carenti nell'aspetto logico-razionale tanto che più volte ho avuto l'impressione che i
discorsi fossero stati lasciati in sospeso come se ci fosse un seguito che spetta ad ognuno trovare.6
Da un incontro vis à vis con il bioeticista cattolico le motivazioni "oscure" (di cui sopra) sono
emerse insieme ad una sua "definizione" di razionalità per cui «il fatto che una persona assuma un
atteggiamento di rispetto della vita altrui e della propria è razionale di per sé, ed è quindi
condivisibile» e ancora
la razionalità sta nel fatto che la vita fisica, corporea, non ce la siamo data noi e nessuno, credente o
non, può dire di essersi dato la vita da sé [...] anche il dire che la vita è stata creata da Dio è
razionale in quanto alla creazione si ci arriva con la ragione e non solo con la rivelazione. Che la
vita deve avere una causa superiore, questo è frutto di un ragionamento: fin qui è tutto laico.
L'argomentazione sembrerebbe ora più chiara e completa se non fosse per l'apparizione del
contradditorio il quale, con una altrettanto articolata e convincente esposizione, smonta
nuovamente le considerazioni appena citate. Così dalla stessa perplessità, avanzata adesso a
Boniolo, emergono nuovi spunti e nuove definizioni per cui ciò che prima era universalmente
«condivisibile e razionale di per sé» adesso diviene relativamente accettabile e suscettibile di
confutazione:
non è detto che l'equivalenza tra razionalità e laicità valga sempre: dipende molto dalle definizioni
di laicità e di razionalità che si prendono in considerazione. Per esempio secondo l'individualismo
metodologico, razionale è quel comportamento che è mirato a raggiungere un certo scopo.7 Di
conseguenza, secondo questa definizione, anche il suicida mette in atto un comportamento
razionale in quanto il suo scopo è porre fine alla sua vita e per raggiungerlo attua tutti i mezzi che
gli permettono di farlo.
Successivamente Boniolo sposta l'accento sul rapporto creazione -- razionalità ed è proprio a
questo punto che la definizione di «argomento razionale» assume un significato completamente
opposto in quanto
per poter dire che la vita c'è stata data da qualcuno, per poterlo affermare, dobbiamo di certo
argomentare in maniera razionale, ma ad un certo momento dobbiamo anche dire che esiste questo
Qualcuno e di questo Qualcuno non è giustificabile razionalmente l'esistenza. [...] Dall'altra parte
per essere effettivamente razionale nella sua completezza un argomento non deve far capo a
nessuna nozione fideistica.
Da queste argomentazioni risulta piuttosto evidente come anche il concetto stesso di laicità8 sia
caratterizzato da una sorta di ambiguità speculativa per cui non è del tutto chiaro il suo significato
né tanto meno è esente da classificazioni erronee e fuorvianti. Riprendendo le parole di Fornero
innanzitutto
si dovrebbe specificare preliminarmente in che senso ci si definisce laici, ossia se con questo
vocabolo si intende alludere ad un semplice metodo di coesistenza e di ricerca (che può
accomunare credenti e non credenti) oppure ad un metodo e [...] ad un atteggiamento dottrinale
non religioso. Fermo restando che non-religioso non significa necessariamente anti-religioso.9
E credo che tale distinzione sia necessaria considerato il fatto che, a seconda di come viene inteso,
il termine laico determina alcune incongruenze. Infatti, se considerassimo il laico come colui il
quale «non usa argomenti che rimandano a un principio d'autorità [...] esterno al processo
discorsivo stesso»,10 allora anche Sgreccia (e tutti i «filosofi cattolici»),11 appellandosi alla ragione
quale strumento universale di difesa della vita, sarebbe un laico e di conseguenza svanirebbe anche
la distinzione tra cattolici e laici che nella realtà dei fatti esiste ed è impossibile negare. D'altro
canto l'equivalenza laicità = non religiosità non renderebbe giustizia al «laico (in senso forte) »12 il
quale «ragionando "come se Dio non fosse" nelle sue argomentazioni non tiene conto né della
possibile esistenza e "volontà" di Dio, né di un eventuale "progetto divino sulla vita"»13 e ciò non
implica, per dirla con Mori, «né l'agnosticismo né l'ateismo, ma solamente l'esclusione di premesse
metafisiche o religiose che pretendano di valere per tutti».14
Di fronte a considerazioni così distanti tra loro è inevitabile provare un sorta di sensazione di
smarrimento per cui sembra quasi che si stia parlando di tutto e di nulla e che ognuna delle
argomentazioni possa avere un proprio valore di verità. Forse perché in merito a questioni di
bioetica, e nello specifico di eutanasia, non può esistere una verità assoluta? Forse perché è
imprescindibile il fatto che nel momento in cui entrano in gioco coordinate esistenziali non si può
stabilire un unico modello di riferimento a cui tutti devono conformarsi?
Tutta la questione dell'eutanasia ruota attorno a questo relativismo15 di valori inteso non
negativamente come perdita di un orientamento morale o come mancanza di punti di riferimento
per un'esistenza disciplinata, bensì positivamente come possibilità proficua di apertura al dialogo e
di confronto tra realtà e concezioni differenti. Non credo che sia un fine necessario quello di tentare
di trovare una soluzione condivisa e universale, anche perché sarebbe praticamente impossibile e
sfocerebbe soltanto in «forme serpeggianti di supremazia -- quando non di espressa prevaricazione
-- delle ragioni religiose su quelle secolari»16 e viceversa. Per dirla con Habermas:
lo stato Laico può comunque assicurare imparzialmente la tolleranza solo se garantisce che nella
sfera pubblica politica il pluralismo di visioni del mondo possa liberamente dispiegarsi -- senza
normative pregiudicanti il contenuto -- sulla base del rispetto reciproco.17
Per cui, stando a queste considerazioni, ogni concetto racchiuso in una definizione, che si configura
necessariamente come soggettiva e relativamente condivisibile, dovrebbe essere liberamente
interpretabile e questa interpretazione non dovrebbe costituire un motivo di esclusione o di
condanna, ma essere considerata come "altra" rispetto a quella iniziale e perciò passibile di
considerazione e rispetto. Di conseguenza nel termine vita è racchiuso un mondo di visioni
differenti che possono scaturire da una stessa definizione: se «la forma superiore di vita è quella
che si dà alla coscienza»18 e se «chi non è disposto a scegliere la vita cosciente come paradigma
dell'interpretazione della vita in generale è costretto a disconoscere all'essere vivente il suo
carattere di essere vivente e a ridurlo a una struttura "oggettiva" di un essere materiale»19 poiché
«il problema della vita non è un problema biologico, ma è l'orizzonte, il senso all'interno del quale
situiamo ogni altro problema»,20 un uomo può intendere come difesa e rispetto della propria vita
quel rifiuto di determinate condizioni «invalidanti» proprio in quanto ha deciso di scegliere la vita
cosciente come paradigma dell'interpretazione della vita in generale; una scelta che prende forma
partendo dal senso che egli ha attribuito alla propria «esistenza»21 e che egli ritiene ormai perso
nel momento in cui questa sua vita non ha più quella «capacità di azione immanente»22 che la
contraddistingue come tale; viceversa un altro uomo il quale considera la vita cosciente come «il
luogo dove emerge la sua origine da Dio e la sua destinazione a Dio»23 avrà attribuito alla propria
esistenza il «valore della sacralità»24 e in virtù di ciò la difesa della sua vita sarà assoluta e senza
possibilità di "morte anticipata" anche in condizioni invalidanti. Due diversi punti di vista per due
risultati altrettanto differenti, ma entrambi accettabili. Per cui coloro che, ad esempio, non sposano
la seconda accezione di vita non per questo devono essere tacciati di irrazionalità. Riportando le
parole di Sgreccia emerse dall'intervista:
non tutti la intendono così perché non tutti ragionano! Non tutti hanno la lucidità, non tutti hanno
sempre la serenità, molti sono stati colpiti da disgrazie. Ciò renderà più o meno scusabile un gesto
di disperazione, ma non lo rende vero o falso» (e io aggiungerei) così come non si può ritenere vero
o falso un orientamento ideologico.
25. Autonomia come dipendenza?25
La questione dell'autonomia rappresenta un punto focale all'interno del dibattito etico
sull'eutanasia. Dico focale in due sensi: sia perché si configura come il "punto" in cui tutte le "linee"
argomentative ed esistenziali convergono, sia in quanto costituisce un nodo inestricabile, ma di
fondamentale importanza intorno al quale ruota tutta la discussione sull'eutanasia. Qualunque
argomentazione, di "stampo" laico, cattolico, ateo o religioso (nel senso più ampio del termine),
s'imbatte in questo concetto quasi "labirintico" nel quale sembra non esserci (e forse non c'è!)
possibilità di scampo. Ciò è dovuto, in primis, alla complessità e problematicità del termine stesso
al quale non può essere attribuito un senso univoco considerati i contesti in cui viene "chiamato in
causa" e il soggetto (l'uomo) a cui viene riferito. Già partendo dall'etimologia del termine insorgono
le prime perplessità: il termine autonomia deriva dal greco ed è composto da autòs e nòmos che
rispettivamente significano se stesso e legge quindi, per dirla con la voce filosofica dell'
Enciclopedia, l'autonomia sarebbe la libertà di vivere con le proprie leggi, oppure ciò «che si
governa da sé».26 È evidente che se ci fermassimo a questa definizione e al suo significato letterale
il senso dell'essere autonomo potrebbe facilmente venire travisato in essere anarchico il che non
renderebbe giustizia né al suo alto valore filosofico né tantomeno al suo rilievo in ambito etico.
Innanzitutto credo sia interessante riportare i tre differenti significati che Botturi attribuisce al
termine libertà e le rispettive analisi compiute da Sgreccia: questa viene intesa come
«autodeterminazione»27 per cui «gli atti del soggetto sono misurati solo su se stessi»28 e di
conseguenza «si presuppone una perfetta autonomia»;29 come «autorealizzazione»30 e quindi
secondo questa prospettiva
libertà significa cammino verso un/il compimento dell'agente; ha [...] il senso di liberazione dalla
povertà e dalla schiavitù dell'imperfezione, dell'incompiutezza, ecc» [di] «adesione al bene,
realizzazione [...] del soggetto».31 [E infine] «come rapporto con gli altri, e più precisamente con
altra libertà. [...] La libertà è bisogno costitutivo dell'altro come libertà. L'uomo e-siste in forza del
riconoscimento che riceve; ha bisogno di riconoscimento [...] per esistere da persona, cioè [...] per
raggiungere un intenso e stabile senso della propria identità.32
Ho ritenuto utile partire da questi tre significati in quanto sono convinta che essi racchiudano
l'essenza33 di ciò che può essere inteso per libertà e autonomia. Tutte le altre considerazioni sono,
a mio avviso, dei corollari che offrono un supplemento e arricchiscono la discussione. Ovviamente
le tre "definizioni" non devono essere considerate come escludentesi a vicenda, bensì come
interdipendenti in quanto aspetti diversi di una stessa medaglia.
Detto ciò, per entrare nel merito della questione, bisogna considerare in che modo questi concetti si
intrecciano e dialogano tra loro all'interno del dibattito sull'eutanasia e soprattutto è interessante
notare le sostanziali differenze, non tanto a livello semantico quanto a livello prioritario, che li
caratterizzano a seconda che ci si riferisca ad un contesto cattolico o laico.34 Infatti, se per Sgreccia
è «la vita» ad essere «presupposto dell'autonomia in quanto se non ci fosse un fatto ricevuto io non
potrei essere autonomo neppure nelle azioni», e la conseguenza di ciò è che «non si ha diritto a
disporre, in nome della libertà di scelta, della soppressione della vita»,35 al contrario, secondo la
posizione di Boniolo al di sopra di qualsiasi ragionamento o principio sta proprio «il diritto» di
ognuno «di gestire la propria vita e anche la propria morte come pensa sia meglio, e aldilà di
costrizioni legali o religiose» con la diretta e ovvia conseguenza che il giudicare l'eutanasia come
atto moralmente illecito è un fatto religioso tout court.36 Inutile dire che per Sgreccia (e per
«chiunque si professi "veramente cattolico"»)37 «la fede avanza solo delle ragioni in più» che
rinforzano l'argomento razionale fondamentale il quale già basterebbe a giustificare il fatto che «la
libertà viene dopo la vita dal punto di vista dei presupposti, è al vertice, è il frutto maturo della vita,
però per essere liberi bisogna prima essere vivi». Ora, se dal punto di vista del bioeticista cattolico
il concetto di autonomia è un concetto legato agli atti per cui «la libertà che mi è stata data da Dio è
una libertà quanto alle azioni» e per tale motivo «togliersi la vita è contro la libertà stessa in quanto
si recide la possibilità di compiere qualsiasi atto successivo», è lecito chiedersi: ma se un individuo
si trova in uno stato vegetativo persistente e pertanto in quel momento pur essendo vivo non
possiede quella autonomia legata alle azioni, su cui insiste Sgreccia, proprio perché impossibilitato
a «compiere qualsiasi atto» "volontario", a quest'uomo sarà pure concesso di aver ritenuto la sua
stessa condizione come priva di qualsiasi forma di libertà? Credo che la miglior risposta a questa
domanda sia rintracciabile nel testo stesso di Sgreccia e precisamente in quell'argomentazione che
fa appello ad un principio di libertà -- responsabilità limitata e limitante allo stesso tempo e che
racchiude l'intera questione problematica dei confini entro i quali si muove l'attività dell'uomo
sull'uomo, non solo in campo bioetico, ma anche e soprattutto nella vita in generale:
[...] lo stesso principio di libertà -- responsabilità del paziente, se viene delimitato dal principio di
difesa della vita fisica [...] limita a sua volta la libertà e la responsabilità del medico, il quale non
può trasformare la cura in costrizione [...] . Bisogna sempre ricordare che la vita e la salute sono
affidate prioritariamente alla responsabilità del paziente e che il medico non ha sul paziente altri
diritti, superiori a quelli che ha il paziente stesso nei propri riguardi. Qualora il medico ritenesse
eticamente inaccettabili le pretese o le volontà del paziente può, e talora deve, scindere le proprie
responsabilità, invitando il paziente a riflettere e a riferirsi ad altri ospedali o ad altri medici. Né la
coscienza del paziente può essere violentata dal medico né quella del medico può essere forzata dal
paziente: entrambi sono responsabili della vita e della salute sia come bene personale sia come
bene sociale.38
Dunque, non una libertà che si riduca al suo contrario e neppure una libertà intesa come
autonomia illimitata, bensì una "sovranità" su se stessi che allo stesso tempo trovi «una limitazione
nell'eguale diritto altrui»39 e che di conseguenza non abbia influenze negative e nocive sulla
società. Praticamente un'utopia direbbe qualcuno! In effetti la questione non è poi così semplice
non solo nella pratica, ma anche in teoria perché, ad esempio, non basta dire che «i seguaci del
paradigma laico insistono tutti [...] sulla libertà e l'autodeterminazione degli individui, cioè sulla
loro capacità di autoplasmarsi secondo un modello o uno stile di vita "da loro stessi scelto"», 40 ma
bisogna capire fino a che punto per i seguaci del paradigma laico dovrebbe spingersi tale
autonomia e se si tratta di una libertà da o di una libertà di. Difatti, quello promulgato dal
Manifesto di bioetica laica è certamente un principio del primo genere in quanto libero da
«autorità superiori che possano arrogarsi il diritto di scegliere» per l'individuo «in tutte quelle
questioni che riguardano la sua vita e la sua salute»,41 mentre nell'ottica di Demetrio Neri si tratta
dell'autonomia del singolo di «definire e ridefinire per sé lo stile di vita che intende perseguire, i
valori che intende condividere [...] . Nessuno può arrogarsi il diritto di decidere»42 al posto suo
«ciò che è bene»43 per sé.
Il principio di autonomia asserito con impeto da Giovanni Boniolo racchiude in sé entrambi gli
aspetti tanto che da un primo approccio all'argomento, così come da lui esposto, si ha l'impressione
che nel momento della malattia l'uomo si trovi solo con se stesso e diventi quasi un "egoista
incallito" che vive a prescindere dalle strutture e dalle "figure" che lo circondano .44
"Fortunatamente" in seguito si comprende bene che quello teorizzato da Boniolo non è un cieco
individualismo che sfocia in anarchia assoluta, al contrario è un principio di autonomia che tiene
rigorosamente conto del contesto, delle influenze esterne e dei pregiudizi che inevitabilmente
condizionano la sfera decisionale dell'individuo.45 Allora in cosa consiste realmente questa
autonomia dell'essere umano, nello specifico, del paziente? Non significa più agire «in conformità a
riflessioni del tutto indipendenti e autonome, ma [...] in base a riflessioni filtrate attraverso la
capacità» dell'individuo «di valutare criticamente l'influenza dell'ambiente esterno».46 Il problema
sta nel capire quando e se l'auto riflessione del paziente è una buona riflessione, è davvero critica, è
realmente libera. Tuttavia, visto e considerato che una persona non è mai totalmente
incondizionata nelle situazioni della vita in generale, a maggior ragione le influenze e i
condizionamenti possono essere più consistenti e dominanti in caso di patologie invalidanti per
cui questo argomento, che Boniolo denomina «argomento della depressione»47 e contro il quale
muove una critica per dimostrarne la debolezza,48 potrebbe essere utilizzato, e in effetti lo è, da
tutti coloro che sostengono «l'indisponibilità della vita»49 in quanto rafforza maggiormente il
principio per il quale il malato decide di porre fine alla propria vita perché influenzato da una
enorme sofferenza che lo priverebbe anche di una certa lucidità mentale e lo farebbe agire
irrazionalmente. A questa "obiezione" Boniolo risponde, e lo fa anche in sede d'intervista, in un
modo piuttosto chiaro e conciso: « Nel momento in cui io sono, decido. E a chi sta giudicare? A me!
Certo magari sarò indotto a quell'atto perché sto soffrendo enormemente e non ho più voglia di
farlo, ma è una mia scelta».
È però doveroso sottolineare anche che Boniolo afferma che questo diritto dell'uomo «di gestire la
propria vita e anche la propria morte come pensa sia meglio aldilà di costrizioni legali o religiose» è
pur sempre vincolato al dovere di rispettare la società in quanto un individuo «è libero fintanto che
il suo agire non ha influenze negative sulla società tali da danneggiare gli altri». Potremmo
sostenere a questo punto di aver trovato finalmente proprio in questo principio, che potremmo
chiamare di rispetto della società, un punto di contatto fra le due posizioni "antitetiche" se non
fosse per il fatto che, secondo quanto sostiene Sgreccia, la decisione di porre fine alla propria vita in
determinate condizioni costituisce esattamente quel danno alla società tanto "scongiurato" da
Boniolo in virtù del fatto che «la vita è un bene della società e questa ha come ragione primaria
quella di difendere il suo bene pertanto non può abbandonarlo all'arbitrio delle persone».
Ecco che per l'ennesima volta ci troviamo davanti a concetti che si ripetono ma la cui priorità
reciproca si inverte e si ribalta a seconda del contesto ideologico in cui vengono chiamati in causa.
A questo punto credo sia ulteriormente interessante considerare il problema anche da un punto di
vista genuinamente filosofico perché ritengo che ciò non significhi (come potrebbe pensare
qualcuno) perdersi in disquisizioni teoriche a scapito di una riflessione autentica sulla questione; al
contrario, valutare l'aspetto filosofico del problema, e con ciò intendo prendere in esame le
argomentazioni stesse di alcuni filosofi in merito a questioni quali eutanasia, suicidio e morte,
conduce a risultati interessanti che a loro volta offrono spunti per una riflessione più completa e
ricca. L'idea di un approfondimento filosofico della questione prende le mosse dal colloquio avuto
con Sgreccia il quale in risposta alla domanda sui limiti dell'autonomia umana cita Kant e afferma
che
nel primo capitolo di Lezioni di filosofia morale egli risponde negativamente alla domanda 'se è
lecito per l'uomo togliersi la vita' in quanto 'una cosa per essere lecita deve essere passibile di
universalità. Pertanto se tutti si suicidassero finirebbe l'umanità'.50 E anche lui che si muoveva con
criteri del tutto razionali e che voleva prescindere, non solo dalla religione 51 ma da ogni
metafisica, cava subito che l'uomo non è libero di togliere e togliersi la vita la quale è condizione
dell'esserci nel mondo
e inoltre Sgreccia sostiene che questa idea di universalità, e dunque questo criterio razionale, a
Kant «bastava per dire 'non posso perché non è mio'».52 Tuttavia è doveroso dare a Kant quel che
è di Kant e rendere note, di conseguenza, anche quelle sue considerazioni sulla vita e sulla morte
che presentano caratteristiche del tutto laiche e che sono ben lontane dal condannare il suicidio in
sé e per sé:
Non si può invocare la conservazione della vita, quando si sia d'animo vile e si tema la morte che il
destino rende ormai fatalmente incombente [...] La vita non va assolutamente stimata in sé e per
sé, ma al contrario va conservata solo nella misura in cui si è degni di viverla. Non si deve
confondere il suicida con chi deve la perdita della sua vita alla sorte. Chi si abbrevia la vita per
intemperanza è colpevole [...] indirettamente della sua morte, ma non direttamente, perché egli
non intendeva uccidersi e la sua non è una morte premeditata.53
Anche gli Stoici hanno basato la loro difesa dell'eutanasia proprio su un argomento razionale tant'è
vero che la parte dei loro frammenti dedicata a questo argomento è intitolata appunto «la morte
conforme a ragione»;54 ne consegue che:
il saggio, secondo ragione, si esporrà alla morte per la patria e per gli amici, e anche nel caso che sia
vittima di dolori acuti, o di menomazioni o di malattie insanabili55
e ciò deriva certamente dal loro modo di concepire la morte non come evento da cui fuggire, ma
come incontro al quale prepararsi durante il corso della vita. La possibilità di scegliere il momento
e il modo in cui quest'incontro si presenta costituisce proprio «una forma di libertà assoluta»56
ostentata ancora più apertamente da Seneca il quale, se volessimo riportarlo all'interno del
dibattito bioetico odierno, non solo potrebbe essere inequivocabilmente "collocato" tra i sostenitori
della qualità della vita,57 ma costituirebbe a buon diritto il maggior difensore della libertà umana
intesa nel doppio senso sopraccitato e cioè come libertà di e da, un'autonomia individuale che non
ammette intrusioni né giudizi esterni58 e la cui manifestazione, lungi dal "classificare" l'uomo
come un omicida e un oltraggiatore di qualsivoglia entità superiore lo qualifica come detentore di
saggezza e coraggio.59
Altrettanto interessante è l'argomentazione di Hume il quale, sempre grazie a un nostro atto di
astrazione temporale, si configurerebbe come un deciso sostenitore della 'disponibilità della vita' e
la sua argomentazione è volta a smentire il fatto che chi decide di togliersi la vita commette un atto
di violazione dell'opera della provvidenza e turbi l'ordine naturale dell'universo:
se disporre della vita umana fosse una prerogativa peculiare dell'onnipotente, al punto che per gli
uomini disporre della propria vita fosse un'usurpazione dei suoi diritti, sarebbe egualmente
criminoso salvare o preservare la vita. Se cerco di scansare un sasso che mi cade sulla testa,
disturbo il corso della natura e invado il dominio peculiare dell'onnipotente, prolungando la mia
vita oltre il periodo che, in base alle leggi generali della materia e del moto, le era assegnato. 60
Per non parlare della posizione di Nietzsche in Così parlo Zarathustra che giunge a lodare la morte
«al momento giusto» quale «spina e promessa per i viventi».61 Un vero e proprio elogio alla libertà
umana di scegliere o meglio di volere62 la propria morte.
3. Consapevolezza, intenzione e colpa
Oltre che i concetti analizzati nei precedenti paragrafi il dibattito sull'eutanasia concerne anche un
altro aspetto sostanzialmente legato ad essi e la cui importanza viene spesso sottovalutata e a volte,
come sostiene Sgreccia, omessa. Si tratta della "sottile" distinzione tra eutanasia diretta ed
eutanasia indiretta dalla quale scaturiscono una serie di considerazioni, conseguenze del fatto che
non sempre tale distinzione viene ritenuta realmente consistente e di fatto esistente. Per essere
maggiormente chiari: per parte laica non sussiste alcuna differenza tra sospendere i trattamenti e
somministrare analgesici in quanto entrambi gli atti rispettivamente causano e possono causare la
morte del paziente. La conseguenza è la medesima pertanto non importa quale sia stata
l'intenzione o l'obiettivo reale del medico, bensì il fatto che il paziente sia morto "in anticipo", ma in
modo esente da dolore, conformemente al suo volere. Questa considerazione non è certamente
frutto della mia immaginazione al contrario ha il proprio fondamento teorico in una delle
affermazioni sostenute con linguaggio retorico, semplice e diretto da Boniolo in sede di colloquio:
se io sono un medico e le metto in bocca la pastiglia di cianuro allora io sono la causa della morte,
ma se io sono un medico e le metto in mano una pastiglia di cianuro e lei se la mette in bocca, chi è
la causa della morte? Sono io che gliel'ho causata o lei? In questo caso io sono meno responsabile
della sua morte? Ecco, ad un certo punto si arriva anche a queste sofisticherie più che sofisticazioni
del pensiero: tanto il risultato finale è sempre lo stesso: lei muore. In questi interrogativi retorici è
racchiuso il concetto del «non fare»63 che Veronesi per esempio taccia di ipocrisia in quanto volto
a «riparare le spalle ai medici [...], mettere in pace la coscienza collettiva, non scontrarsi con i veti
religiosi.64
Effettivamente si ha l'impressione di trovarsi di fronte a una sorta di concettualizzazione che nel
porre tali «sofisticherie» o «ipocrisie» (per dirla con i due studiosi sopraccitati) genera una
contraddizione interna che a sua volta determina delle lecite perplessità. Per cui la domanda che si
pone Veronesi sul perché «se inietto nelle vene una dose elevata di narcotici che porta la vita a
conclusione sono colpevole, mentre se tolgo al paziente le terapie che lo tengono in vita [...] sono
invece assolto, anzi lodato»,65 è una domanda non solo lecita, ma anche generalmente
condivisibile.
È chiaro che, per tutte le ragioni che ho in qualche modo dibattuto, questa posizione non può
trovare accoglimento all'interno del magistero della chiesa cattolica, anzi trova in esso una radicale
opposizione. Innanzitutto è opportuno spiegare che nel linguaggio utilizzato anche da Pio XII per
«eutanasia indiretta s'intendeva la 'terapia del dolore', ritenuta lecita a determinate condizioni
anche quando, come conseguenza, poteva abbreviare la vita».66 Questa attribuzione del concetto
di liceità in modo differente ai due diversi "generi" di eutanasia affonda le proprie ragioni nella
convinzione che nel caso della terapia del dolore «né l'azione per sé né l'intenzione sono orientate
alla soppressione della vita e all'anticipazione della morte».67
Le perplessità in merito non mancano di certo. Innanzitutto verrebbe da chiedersi: è realmente
possibile stabilire dall'esterno quale sia l'intenzione di un uomo nel suo agire in un certo modo? Chi
può determinare in maniera obiettiva e verosimile che l'intenzione di quel medico, in quella precisa
circostanza non sia stata effettivamente l'accelerazione della morte del paziente tramite una
somministrazione di dosi massicce di analgesici? Perché il rischio che si verifichino pratiche
occulte di «eutanasia vera e propria»68 esiste, e i bioeticisti cattolici prendono in considerazione
tale pericolo tant'è vero che Sgreccia afferma che «la terapia del dolore non va considerata alla
stregua di un atto eutanasico a condizione che la dose degli analgesici sia proporzionata al dolore».
Eppure non credo che la possibilità di una pratica occulta di eutanasia rappresenti lo specchio di
una società di medici perversi con istinti omicida, bensì penso che si manifesti come una sorta di
"allarme" di una situazione in cui i medici troppo spesso sono costretti a lottare tra un sistema
giuridico carente in tema di eutanasia e la loro coscienza, che a sua volta deve fare i conti con un
impianto ideologico (a volte fin troppo schiavo di un'ideologia).69
Se le cose stanno davvero in questi termini allora mi chiedo: visto e considerato che secondo alcuni
è possibile stabilire l'intenzione del medico e pertanto la liceità di un determinato atto tanto da non
definirlo eutanasico, allo stesso modo si dovrebbe essere in grado di entrare nei suoi "abissi più
profondi", rendersi conto delle motivazioni etiche e ideologiche che lo hanno spinto ad aumentare
la dose di analgesici così da poter comprendere il suo agire e renderlo esente da ogni genere di
colpa. È piuttosto evidente, almeno a mio avviso, che né l'uno né l'altro tentativo è credibilmente
realizzabile e ciò per costituzione ontologica dell'uomo stesso che spesso e volentieri a stento riesce
a conoscere se stesso, figuriamoci le intenzioni e gli obiettivi reali dell'altro! L'intenzione non può
essere scientificamente analizzata e provata, la scienza medica non può stabilirne i confini pertanto
come si può basare su questo concetto un discorso bioetico ed etico sull'eutanasia? Non è credibile
identificare un atto come eutanasico o no e conseguentemente renderlo fonte di colpevolezza o
carico di liceità sulla base dell'intenzione che ne sta a monte.
Ben diverso è, invece, il discorso sulla consapevolezza. Il medico, per esperienza e professionalità,
sa per certo che l'atto di somministrare analgesici di un certo tipo e periodicamente può
determinare come conseguenza la morte anticipata del paziente. La scienza medica può stabilirlo
sulla base di situazioni reali, di casi specifici che per il loro riscontro tangibile e visibile diventano
fonti di discussioni etiche feconde, di analisi, di giudizi più o meno fondati. Dunque tra una morte
causata da una somministrazione elevata di narcotici e una morte determinata dalla sospensione
delle terapie che tengono in vita il paziente c'è una differenza sul piano della consapevolezza? Per
dirla con Veronesi non sussiste differenza alcuna in quanto «tutti e due sono atti consapevoli e
deliberati»;70 per dirla con Sgreccia, invece, esiste eccome perché il può accadere che non
costituisce affatto un «collegamento di causa-effetto» e il medico è «giustificato a fare nel momento
presente quello che gli viene richiesto e cioè cercare in tutti i modi di sollevare il paziente dal
dolore» non essendo «più responsabile degli effetti secondari». Lo stesso Sgreccia adduce un
esempio piuttosto eloquente al fine di comprendere il suo punto di vista in merito alla questione:
«Se devo soccorrere un individuo che sta annegando e per farlo devo lanciargli una corda, ho la
consapevolezza che questa potrebbe anche strozzarlo, eppure io intanto ho il dovere di provare a
salvarlo». Senza dubbio la priorità sta nel tentare di "salvare" il paziente, nel compiere il proprio
dovere di medico, tuttavia, nel caso in cui, ad esempio, ci si trova di fronte ad un malato la cui vita
dipende da un macchinario e la cui ripresa è incerta (non si sa se potrà riprendersi o se resterà
stabile a vita), anche in quella circostanza, così come nel caso dell'uomo in procinto di annegare, c'è
una possibilità sia in un senso che nell'altro. E allora, sulla base di quale considerazione, di quale
sorta di principio, si può stabilire un criterio di azione? La questione si ripresenta come un circolo
vizioso considerando che si riconduce da sé ai concetti di autonomia di azione e di pensiero, di
indisponibilità e disponibilità della vita umana, di fede e laicità quali criteri di giudizio.
Come sostiene Veronesi «qui si delinea il problema cruciale: fino a quando dobbiamo procedere?
».71 Sospendiamo i trattamenti giudicati inutili per il miglioramento del paziente oppure non ne
intraprendiamo alcuno a priori? Perché, come sostiene Gattinoni, si tratta di «due azioni diverse
[...] determinate da osservazioni diverse e che hanno implicazioni diverse [...] . Per tutti i comitati
etici del mondo il non intraprendere e il sospendere il trattamento sono due azioni eticamente
equivalenti. Ma non è così! È molto più facile non intraprendere che sospendere»,72
probabilmente perché per agire in questo secondo modo è necessaria un'elevata e forse eccessiva
"dose" di coraggio, una resistente "armatura" e una forte motivazione e convinzione come "arma",
il tutto per prepararsi al meglio ad una battaglia giudiziaria, moralista e ideologica, senza
esclusione di colpi.
Note
1.
E. Sgreccia, Manuale di Bioetica, Vol. I, Vita e Pensiero, Milano 2007, p. 892.
2.
Ibid.
3.
Se poi tale dialogo viene approfondito e "analizzato" in ogni sua componente, così da trovare possibili punti di
contatto o contraddizioni interne e reciproche, il discorso diventa almeno propedeutico per un legislatore che si
appresti ad affrontare la questione in maniera argomentativa e a proporre "soluzioni" eque e imparziali.
4.
«Per rispetto alla verità [...] va evitato di fondare la polemica contro l'eutanasia unicamente sulle ragioni di fede,
quasi che difendere la vita dei malati e dei morenti sia un dovere soltanto dei cattolici. La vita è un bene e un
valore laico, riconoscibile da tutti coloro che intendono ispirarsi alla retta ragione e alla verità oggettiva». E.
Sgreccia, Manuale di bioetica, Vol. I, cit., p. 892.
5.
«Rispettare la verità della persona nel momento della vita nascente vuol dire rispettare Dio che crea e la persona
umana così come Egli la crea: rispettare l'uomo nella sua fase finale vuol dire rispettare l'incontro con Dio, il suo
ritorno al Creatore, escludendo ogni altro potere da parte dell'uomo, rifiutando sia il potere di anticipare questa
morte (eutanasia), sia quello di impedire quest'incontro con una forma di tirannia biologica (accanimento
terapeutico)». Ivi, p. 893.
6.
In merito a questa mia sensazione di incompletezza delle argomentazioni laiche Boniolo, in sede di intervista a
me rilasciata, afferma :«Ci sono certe argomentazioni che sono costruite bene, ma funzionano solo se si accetta
qualcosa che è fuori dalle argomentazioni stesse. Se io sono all'interno di un contesto cattolico o comunque di
un contesto religioso, il senso profondo del mondo, il significato del mondo, della mia vita sono al di fuori
dell'ambito razionale per cui io riesco a fornire un'argomentazione basata su quel particolare senso del mondo
che mi è dato dalla mia fede, ma che non è argomentabile razionalmente. Se io non ho questa fede il senso del
mondo dove lo trovo? Devo trovarlo necessariamente in me stesso, però è qualcosa di totalmente soggettivo:
ecco perché appaiono meno forti. In realtà non possono essere più forti. Ma anche le altre non dovrebbero
esserlo in quanto io non dovrei chiedere un senso del mondo ricorrendo a un'istanza trascendente perché non è
razionalizzabile».
7.
«Negli esponenti della "Scuola Austriaca" [...] si può ritrovare una teoria dell'azione razionale avente come
premessa la limitatezza del conoscere umano, e come fine la realizzazione di un "bene" che non può essere
insegnato e che non ha una derivazione fisica, metafisica o cosmologica, apparendo, al contrario, proprio della
sfera umana e raggiungibile dall'uomo». AA.VV., L'individualismo metodologico: genesi, natura e applicazioni,
Edizioni Borla, Roma 1993, pp. 33-34.
8.
Al fine di evitare di distaccarmi troppo dal tema centrale mi limiterò qui ad un breve excursus sulle maggiori
definizioni del termine. Per un approfondimento in merito e per una visione chiara e completa delle varie
sfumature del concetto di laicità cfr. G. Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica, Bruno Mondadori, Milano
2005, pp. 62-73.
9.
Ivi, p. 68.
10. G.E. Rusconi, Laici e cattolici oggi, in V. Possenti (a c.d.), Laici o Laicisti? Un dibattito su religione e
democrazia, Liberal Libri, Firenze 2002, p. 28.
11. «Dal loro punto di vista «Dio non è [...] un principio di autorità esterno al processo discorsivo» ma l'esito
razionale (filosoficamente provato) del discorso stesso». G. Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica, cit., p.
64.
12. Ivi, p. 72.
13. Ibid.
14. M. Mori, Prefazione a U. Scarpelli, Bioetica laica, Baldini & Castoldi, Milano 1998, p. 73.
15. Al fine di evitare equivoci e indignazione per l'espressione da me utilizzata, tenterò di chiarire il mio discorso
riportando le considerazioni di Privitera e Mori in merito alla questione, citate da Fornero: «Come relativismo
[...] bisogna considerare quello che afferma [...] l'impossibilità di formulare giudizi morali oggettivi, assoluti e
universalmente validi da tradurre in norme morali che dovranno essere seguite [...] in qualsiasi epoca storica ed
in qualsiasi area geografica»; «L'universalità e l'imparzialità dell'etica non implicano affatto l'immutabilità dei
giudizi morali. Anzi, sembra implichino la variabilità del giudizio rispetto alle circostanze [...] è giusto cambiare
la gerarchia dei valori e dei doveri morali quando mutano le circostanze storiche cambiando le conseguenze
delle azioni». G. Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica, cit., pp. 124-126.
16. L. Risicato, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza
penalistica, Giappichelli, Torino 2008, p. 3.
17. J. Habermas, Tra scienza e fede, tr. it. di M. Carpitella, Laterza, Bari 2006, p. 164.
18. E. Sgreccia, Manuale di bioetica, Vol. I, cit., p. 101.
19. Ivi, pp. 101-102.
20. Ibid.
21. Per un interessante approfondimento sulle relazioni tra vita, senso ed esistenza cfr., G. Boniolo, Il limite e il
ribelle. Etica, naturalismo, Darwinismo, Raffaello Cortina, Milano 2003, pp. 109-122.
22. E. Sgreccia, Manuale di bioetica, Vol. I, cit., p. 103.
23. Ivi, p. 102.
24. «L'essere densa di valore, l'essere dotata di senso, non comporta ancora che la vita sia sacra. La sacralità è solo
uno dei valori che si possono attribuire all'esistenza, è solo uno dei modi con cui si può attribuire senso alla vita
e trasformarla in esistenza, ma non certamente l'unico». G. Boniolo, Il limite e il ribelle. Etica, naturalismo,
Darwinismo, cit., p. 113.
25. A. Musio, L'autonomia come dipendenza. L'io legislatore, Vita e Pensiero, Milano 2006.
26. Enciclopedia di Filosofia, Garzanti, Milano 2004, p. 74 (voce autonomia).
27. E. Sgreccia, Manuale di bioetica,Vol. I, cit., p. 205.
28. Ibid.
29. Ibid.
30. Ibid.
31. Ibid.
32. Ibid.
33. Utilizzo il termine essenza intendendo che da queste "definizioni" possono scaturire tutte le diverse
argomentazioni e le varie sfaccettature della questione.
34. In questo saggio affronterò la questione solo basandomi sui principi di questi due maggiori modelli di bioetica,
in particolare presentando le considerazioni di Sgreccia e Boniolo, esclusivamente per ragioni di chiarezza
espositiva al fine di evitare di fornire un groviglio di informazioni confuse e non adeguatamente approfondite.
35. E. Sgreccia, Manuale di bioetica,Vol. I, cit., p. 224.
36. Dall'intervista a Boniolo: «In che modo potremmo dire no, e' moralmente illecito che tu lo faccia? Quali sono gli
argomenti forti che mi permetterebbero di dire no, è illecito moralmente che tu ponga fine alla tua vita? Io
posso dirlo perché sono cattolico, perché la tua vita non è la tua ma è la vita di Dio, ma se io fossi ateo dovrei
rispondere in maniera diversa».
37. G. Boniolo, Il limite e il ribelle. Etica, naturalismo, Darwinismo, cit., p. 118.
38. E. Sgreccia, Manuale di bioetica, cit., p. 225.
39. D. Neri, Filosofia morale. Manuale introduttivo, Guerini, Milano 1999, p. 184.
40. G. Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica, cit., p. 81.
41. Ibid.
42. Ivi, p. 82.
43. Ibid.
44. «Né Dio, né Stato devono arrogarsi il diritto di intervenire nella decisione della mia morte. [...] Quanto segue
vuole essere l'esempio di una presa di posizione individuale ed esistenziale intorno al non desiderare intrusione
alcuna nella scelta personale relativa alla propria morte nel caso in cui eventi o patologie invalidanti abbiano
ridotto la qualità della vita al di sotto di quello standard che solo la propria decisione personale può identificare
con una soglia». G. Boniolo, Il limite e il ribelle. Etica, naturalismo, Darwinismo, cit., pp. 85-86.
45. « [...] Mai nessuno può riflettere su qualcosa senza pregiudizi, da intendersi in senso ermeneutico, che ne
permettono una prima lettura. [...] Pare proprio che la riflessione sia sullo stato personale sia sugli obiettivi
personali non possa non essere fortemente plasmata, per arrivare a costituirsi come tale, anche da influenze
esterne [...] parimenti non si può agire se non in base a certe motivazione e a certi stati mentali che nuovamente
non possono mai dirsi esenti da influenze esterne. [...] Mai nessuno agisce in modo del tutto indipendente da
influenze esterne e in base a riflessioni del tutto esenti da influenze esterne». Ivi, p. 94-95.
46. Ivi, p. 96.
47. «Vi è qualcuno che dice: "tu affermi che la scelta del suicidio è una tua scelta autonoma, ma non sei veramente
autonomo, dal momento che decidi sotto l'influenza della depressione che il tuo stato, o la previsione del
divenire del tuo stato, ha causato"». Ivi, p. 97.
48. Ivi, pp. 97-98.
49. Nell'espressione è racchiuso un "terreno" di dibattito più ampio e pertanto i sostenitori dell'indisponibilità della
vita non si identificano esclusivamente con i bioeticisti di matrice religiosa/cattolica, ma rappresentano una
sfaccettatura meno rigorosa della dicotomia tra laici e cattolici. Per un dettagliato quadro teorico delle teorie
della indisponibilità e disponibilità della vita cfr. G. Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica, cit., cap. 9.
50. «Chi è giunto ormai al punto di disporre in ogni occasione di se stesso dispone anche della vita di tutti [...]. Chi
si è condotto in modo tale da non rispettare l'umanità e da trasformarsi in una cosa diviene un oggetto del libero
arbitrio altrui, di cui ciascuno può fare quindi quello che vuole». Kant, Lezioni di etica, Del suicidio, tr. di A.
Guerra, Laterza, Bari 1991, pp. 173-174.
51. «Noi intendiamo considerare l'atto solo in se stesso, indipendentemente dall'aspetto religioso [...]. Il suicidio
non è abominevole e inammissibile perché Dio lo ha proibito, ma al contrario Dio lo ha proibito perché,
degradando al di sotto dell'animalità la dignità intrinseca dell'uomo, è abominevole». Ivi, pp. 171-176.
52. «L'umanità nella persona di ciascuno è inviolabile, è qualcosa di sacro che ci è stato affidato; tutto è soggetto
all'uomo, ma egli non può abusare di se stesso [...]. Egli s'accorge, egli avverte che la vita gli è stata affidata». Ivi,
p. 173.
53. Ivi, p.172.
54. Stoici antichi, Tutti i frammenti, tr. di R. Radice, Rusconi, Milano 1998, p. 1343.
55. Ibid.
56. C. Angelino, In difesa dell'eutanasia. Stoici, Seneca, Hume, Nietzsche, Il Melangolo, Genova 2007, p. 13.
57. «Non è opportuno, lo sai, conservare la vita in ogni caso; essa, infatti, non è di per sé un bene; lo è, invece, vivere
come di deve. Pertanto il saggio vivrà quanto a lungo gli compete, non quanto più può [...]; si preoccupa sempre
della qualità, non della quantità della vita [...]. Pensa che non abbia importanza il procurarsi o il ricevere la
morte, se la fine sopraggiunge troppo tardi o troppo presto [...]. Morire più presto o più tardi non conta; conta,
invece, morire bene o male». Seneca, Lettere morali a Lucilio, VIII, 70, tr. di F. Solinas, Mondadori, Milano
1994, p. 204.
58. «In nessuna circostanza più che nella morte dobbiamo assecondare ciò che il nostro animo ci ispira [...]. Ognuno
deve rendere la propria vita accettabile anche agli altri, la morte soltanto a se stesso, e la migliore è quella che
più piace [...]. Si tratta di una decisione con cui le chiacchiere degli altri non hanno nulla da spartire [...]. Per
morire l'unico freno è dato alla volontà. Ognuno pensi ciò che vuole dell'atto di quest'uomo eroico, purché sia
ben chiaro che la più immonda delle morti è preferibile alla schiavitù più decorosa». Ivi, pp. 205-208.
59. «Grande è quell'uomo che non solo si è imposto la morte, ma l'ha anche trovata». Ivi, p. 208.
60. D. Hume, Sul suicidio, in Opere filosofiche, Vol.3, Saggi morali, politici e letterari. Saggi ritirati. L'immortalità
dell'anima, sul suicidio, Laterza, Bari 1987, p. 589.
61. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Parte Prima, Della libera morte, tr. di A.M. Carpi, Newton Compton, Roma
2007, p. 67.
62. «Libero verso la morte e libero nella morte, un santo negatore quando non è più tempo per dire sì: così intende
la vita e la morte». Ivi, p. 71.
63. U. Veronesi, Il diritto di morire. La libertà del laico di fronte alla sofferenza Mondadori, Milano 2005, p. 55.
64. Ivi, p. 60.
65. Ivi, p. 57.
66. E. Sgreccia, Manuale di Bioetica,Vol. I, cit., p. 890.
67. Ibid.
68. Ivi, p. 903.
69. Per rendere più chiara questa mia espressione trovo utile citare una distinzione fatta da Gianteo Bordero,
caporedattore di una rivista online chiamata Ragionpolitica.it, con la quale mi trovo in perfetto accordo: «Ideale
-- si badi -- e non ideologia [...]. Sono due principi opposti, perché l'Ideale è qualche cosa che non si sceglie a
priori, ma che fa parte delle corde più profonde del nostro essere, e viene a galla come in un'alba di verità e di
scoperta di sé, mentre l'ideologia è l'applicazione di uno schema mentale alla realtà, che alla realtà finisce per
fare violenza». www.ragionpolitica.it/cms/index.php/200909181876/attualita/l-ideale-e-la-patria.html
70. U. Veronesi, Il diritto di morire. La libertà del laico di fronte alla sofferenza, cit. p. 57.
71. Ivi, p. 61.
72. Ibid.
Emma Palese
Corpo, progresso, diritti umani nella società dei consumatori
1. Corpo, desiderio, benessere
La nostra contemporaneità -- era dell'esasperata individualità -- assiste ad uno strano rapporto
inversamente proporzionale tra desiderio e suo soddisfacimento: al diminuire delle possibilità di
appagamento di un determinato desiderio, aumentano -- smodatamente -- gli oggetti desiderabili.
Così, sembra che la società dei consumi, o meglio, quella modernità liquida di Zygmunt Bauman,1
abbia innescato un ingegnoso meccanismo si autoriproduzione, il cui tassello essenziale per il
funzionamento è proprio il contemporaneo benessere: non un presupposto che condensa e
racchiude in sé un principio ed un fine ultimo, bensì, un posto di immediato soddisfacimento -- il
più delle volte di immediata illusione -- di momentanee esigenze e bisogni. Bisogni che proiettano
l'uomo contemporaneo in una dimensione isolata in cui la propria singolarità acquisisce l'unica
modalità di esistenza e l'unico traguardo degno di essere perseguito. Se, infatti, sin dai primordi
della comunità il soggetto è riconosciuto solo come membro di una società e la sfera individuale
non trova alcuna legittimazione politica e sociale, nell'epoca post-moderna, l'uomo è inteso nella
sua autonomia rispetto all'autorità, la quale ha, così, precisi confini entro cui estendersi. La sfera
individuale viene sempre più vista come nucleo forte e inviolabile, tutelata da eventuali ingerenze
da parte di altri o dello Stato. A rafforzare una tale concezione è lo stesso ridimensionamento del
ruolo divino -- principio della rivalutazione dell'autonomia dell'individuo -- che giunge ad
esasperare quel laicismo groziano2 e, di conseguenza, apre le porte ad un pericoloso relativismo
etico,3 il quale induce l'uomo e non l'umanità, secondo parametri universali, a ritenersi non solo
unica misura del bene e del male, ma anche unico soggetto agente, capace di autocostruirsi ed
autoaffermarsi. Proprio il desiderio di autoaffermazione si presenta, oggi, come una realtà
ingannevole: essa dà l'illusione di poter essere raggiunta attraverso il consumo, non solo di beni
materiali, ma -- paradossalmente -- del proprio corpo, della propria fisicità. Se, infatti, «il vero
volano dell'economia orientata ai consumatori è costituito proprio dalla mancata soddisfazione e
dal costante rinnovarsi e rafforzarsi della convinzione incrollabile secondo cui il tentativo di
soddisfare quei desideri è almeno in parte fallito»,4 l'autoaffermazione diviene una dimensione che
si getta sul corpo, rendendolo cosa manipolabile, ricreabile, poiché «il corpo umano, considerato
indipendentemente dallo spirito e dal pensiero, viene utilizzato come materiale alla stregua del
corpo degli animali».5
2. Consumo del corpo e laicizzazione dei diritti umani
Ci troviamo, dunque, in un'epoca in cui razionalità, autonomia, libertà di scelta, volontà
costituiscono i termini di uno slogan post-moderno, che, a ben guardare, si configura -- oramai da
tempo -- come slogan post-umano, dato che il nostro stesso essere nudi, la nostra corporeità viene
impregnata di flussi tecnologici capaci di renderci sempre più prossimi a quel desiderio.6
Trasformare il corpo, intervenire su di esso vuol dire scegliere il come si vuole essere, o meglio, il
come si vuole apparire, in una contingenza in cui il rimodellare artificialmente si pone come prima
modalità del consumo. Il corpo, dunque, si trasforma, e nel suo divenire approda ad essere il
principale oggetto di consumo, dato che, quest'ultimo, viene reso cosa sulla quale applicare il
proprio arbitrio, la propria fatticità, in linea con quell'uomo di Sartre che «non è altro che ciò che si
fa».7 Manipolare il corpo ci cala nella dimensione -- di frommiana memoria -- dell'avere,8 tutt'uno
con quella dell'apparire dato che, nella nostra contemporaneità, «l'uomo non è neanche un essere,
ma un divenire in perpetuo mutamento», poiché «può diventare tutto -- ricrearsi a suo
piacimento»,9 assumendo come principio cardine un laicismo inteso, non solo, come ragione
sganciata da ogni trascendenza, ma anche, altamente autonoma, conducente verso un minaccioso
relativismo etico, che, al giorno d'oggi, mette fortemente a repentaglio la stessa sopravvivenza
umana. Proprio l'erronea interpretazione del concetto di laico legittima la gestione autonoma di
ognuno sulla fisicità. E ancora più problematico risulta essere il momento in cui il processo di
laicizzazione investe i diritti umani, dato che da qui si diramano tutte quelle dinamiche conducenti
verso la soggettivizzazione della stessa morale e del diritto. Proprio osservando lo sviluppo storico
dell'idea di diritto umano, ci accorgiamo che essa è qualcosa di relativamente recente poiché, prima
del giusnaturalismo moderno nessuno ne ha parlato esplicitamente. Tale carenza di riferimenti non
deve, tuttavia, essere fuorviante. I diritti umani, infatti, appartengono ad un percorso concettuale
che affonda le sue radici nel mondo antico e nel concetto di natura umana.
Ad esempio, facendo riferimento al volontarismo di Ockam10 ed al razionalismo di S. Tommaso,
possiamo ritrovare i primordi di ciò che oggi identifichiamo come diritti umani, essendo essi
fondati sulla legge naturale e, soprattutto, sull'indipendenza della morale dalla teologia.
Ricordiamo, infatti, che l'epoca medievale, basando tutta la conoscenza umana sulla rivelazione
divina e sull'idea della respublica cristiana in cui confluivano politica e teologia, aveva avviato un
processo di oggettivizzazione della norma sia essa naturale che civile, privando sia diritto che
morale di ogni autonomia. Il volontarismo di Ockam è proprio l'espressione di questa contingenza
del creato e dell'arbitrio assoluto divino, il quale sceglie tra un ventaglio di possibilità atte a
realizzare la condotta pratica dell'individuo, ponendolo si come un essere razionale ma, tuttavia,
con una ragione che diviene strumento col quale Dio fa conoscere la propria volontà.
Indubbiamente, una tale trascendenza svaluta nettamente la legge naturale, intesa come segno
notificativo della volontà divina.
Essendo la legge naturale, legge morale, nell'umano processo evolutivo, si è avvertito sempre di più
l'esigenza di non ridurre quest'ultima ad arbitraria volontà di Dio, bensì, ad un dettame della
ragione presente in qualunque essere razionale, ovvero, l'uomo. Proprio partendo da questa
riflessione, S. Tommaso apre le porte al razionalismo e fa della ragione umana il mezzo di
partecipazione dell'uomo alla legge eterna, cioè alla ragione divina.11 La legge naturale assurge ad
avere una propria autosufficienza ed è in grado di discernere ciò che è bene da ciò che è male,
giungendo, così, all'affermazione di un'autonomia creaturale dell'uomo, che nello Stato trova i
mezzi adatti al perfezionamento del suo essere.
Nello stesso pensiero di Grozio, cui ci si appella per parlare di laicismo, non troviamo nulla di più
"laico"di quanto affermato da S. Tommaso. La polemica groziana è rivolta contro il volontarismo,
poiché Grozio ribadisce solo la differenza, evidenziata già da S. Tommaso, fra diritto naturale,
basato sulla ragione umana, e diritto volontario divino. L'influenza groziana sull'etica e sul diritto è
stata determinata, quindi, non dalle sue convinzioni filosofiche, ma dall'ambiente culturale e dal
periodo storico in cui ha trovato diffusione. Ciò è esplicito nell'affermazione, divenuta celebre, in
cui Grozio asserisce che il diritto naturale conserverebbe la sua validità anche se, per assurdo, Dio
non esistesse. Di conseguenza, il diritto positivo diviene posteriore a quello naturale ma,
soprattutto, posteriore alla morale. La teoria groziana, che possiamo definire un primo passo verso
la concezione di diritto soggettivo, si avvale del principio secondo cui «ius est qualitas moralis
personae competens ad aliquid juste habendum vel agendum»:12 il diritto diviene qualità morale
della persona inerente la possibilità di fare o avere qualcosa nel senso della giustizia.
Fare e agire significa che il soggetto può rapportarsi ad altri in maniera giusta. La giustizia diviene
giustizia naturale, che regola i rapporti tra la comunità di stati, perché rapporti tra gli individui.
Quindi ciò che può tutelare lo status morale degli individui è il diritto oggettivo, che permette il
riconoscimento di ciò e, pertanto, diviene funzionale alla stessa morale e garante di libertà. L'asse
portante di tali concetti, dunque, risiede nell'uomo fondatore della società civile, dato che lo steso
diritto naturale trova il suo fondamento nei comportamenti umani e nella razionalità umana.
Pertanto, stando alla teoria groziana, morale e diritto si compenetrano derivando entrambi dalla
razionalità umana. E quest'affermazione, alla luce dell'attuale progresso scientifico, assume una
particolare rilevanza poiché, proprio rivalutando -- attraverso una giusta interpretazione -- il
razionalismo groziano, verrebbe meno quel relativismo etico, che pone problemi nell'ambito
bioetico e, soprattutto, ostacola la creazione -- quanto mai necessaria -- di un diritto condiviso in
materie riferibili al corpo e alla vita. Del resto, anche quell'etica che assume la definizione di laica,
se contemplasse l'autentico significato groziano di laico, non sarebbe in contrapposizione col suo
termine opposto, ovvero, con l'etica cattolica della vita.
Così, il processo di riconoscimento dei diritti umani si inserisce proprio nel quadro della natura
umana e dell'umanizzazione del diritto naturale conducente ad una razionalizzazione della stessa
legge morale. Infatti, i diritti umani, generalmente, vengono proprio concepiti come diritti
universali di ordine morale, appartenenti in, egual misura, ad ognuno di noi, in quanto parte del
genere umano, portatore, a sua volta, di una dignità inviolabile poiché fondata su diritti
fondamentali derivanti dalla legge naturale, che è legge morale. A conferma di ciò, le teorie
giusnaturalistiche partono proprio da un paradigma comune: gli esseri umani in un ipotetico stato
di natura antecedente alla formazione delle varie forme di governo, sono titolari di determinati
diritti naturali. Questi si configurano come presupposti necessari ad ogni teoria dello stato,
evidenziando origine e limiti dell'autorità di governo.
Fare appello ai diritti umani potrebbe essere, dunque, un valido strumento di preservazione della
nostra corporeità, la quale -- oggi più che mai -- risulta essere messa in pericolo dalla società dei
consumatori, impregnata di vuoto senso di vita e sempre più lontana da valori assoluti di
riferimento, poiché protesa verso uno schiacciante relativismo etico, il quale si riconosce e affonda
le sue radici nella fallacia naturalistica di Hume13 e nella sociologia avalutativa di Weber,14 teorie
che ritengono che non sia possibile ricavare giudizi di valore da giudizi di fatto come non sia
possibile passare dall'essere al dover essere. I fatti naturali sono conoscibili e scientificamente
dimostrabili, mentre, i valori e le norme morali sono semplicemente presupposti e originano
giudizi prescrittivi indimostrabili. Stando alla legge di Hume, infatti, la stessa scienza non dovrebbe
indirizzare le proprie azioni verso un fine moralmente valido, quale, ad esempio, il bene umano, ma
solo perseguire la dimostrabilità di innovative tecniche scientifiche.
Così, l'attuale galoppante progresso scientifico, che ci caratterizza come uomini evoluti, postmoderni, tecnologici, rischia di svilire quell'elevato stadio di umanizzazione consistente nel
riconoscimento e nella tutela dei diritti naturali dell'uomo -- in cui rientra anche la tutela del corpo
--. «Consumare il corpo» -- oramai puro involucro quantificabile e materializzabile15 -- vuol dire,
dunque, pensare la vita umana al di fuori dell'uomo stesso, in una dimensione in cui -- ben presto - sarà un'impresa ardua "sentire" la nostra naturale fisicità.
3. Manipolazione del corpo e diritto alla vita
Autonomia, autoaffermazione, autocostruzione sono termini che passano attraverso la
manipolazione del corpo il quale viene reificato e considerato oggetto su cui dispiegare l'azione del
singolo. Azione che -- espletandosi sulla dimora del flusso vitale, ovvero, sulla corporeità -- ricade,
inevitabilmente, sulla stessa vita minando anche il fine politico dell'aggregazione sociale. Il
progresso tecnologico, infatti, mette a repentaglio, proprio il primo diritto dell'uomo, il diritto alla
vita -- diritto relativo al corpo -- in nome, semmai, di un diritto alla libertà, che si ritiene possa
essere amministrato dal singolo individuo a proprio piacimento.
Ecco che, accanto al riconoscimento, faticosamente conquistato nel corso dei secoli, di tanti diritti,
che nella Dichiarazione universale del 1948 ha raggiunto l'apice, oggi, assistiamo alla richiesta di
altri diritti, che possono essere considerati piuttosto degli pseudo-diritti, come quello di una donna
ad abortire senza motivi fondati, come quello ad avere un figlio ad ogni costo, o quello di morire
quando la vita non è ritenuta più degna di essere vissuta, o persino quello di cambiare il corpo a
proprio piacimento.
Per comprendere al meglio una tale riflessione possiamo fare riferimento alla teoria hobbesiana16
riguardo al diritto alla vita, per poi compararla con la contingenza contemporanea. Hobbes afferma
che nel passaggio dallo stato di natura a quello civile l'uomo cede tutti i diritti presenti in natura in
favore del patto sociale. L'unica eccezione viene fatta per la conservazione di sé. Il diritto alla vita,
alla propria esistenza diviene, dunque, l'unico diritto, o meglio, l'unica legge naturale derivante
dalla stessa razionalità umana. Ma, al fine di comprendere un tale concetto è necessario effettuare
una distinzione tra diritto naturale e legge naturale secondo Hobbes.
Per leggi di natura si intendono quelle qualità dettate dalla ragione umana che, tuttavia, sono
portatrici dell'intrinseco carattere obbligatorio, ma che acquisiscono il valore di legge solo con la
nascita dello Stato, in virtù del fatto che una norma può essere considerata tale solo ed
esclusivamente nel momento in cui è emanata da un potere costituito che si assume il compito di
renderla esecutiva. Il diritto naturale, invece, è quella «libertà che ogni uomo ha di usare il proprio
potere per la preservazione della propria vita», ovvero, la possibilità di ogni individuo di preservare
se stesso dinanzi ai suoi simili. Pertanto, potremmo sostenere che il diritto di natura fonda quel
primordiale status di belligeranza tra gli uomini -- conducente all'inevitabile distruzione della
specie -- ponendo lo stesso individuo come animale solitario sopraffatto dal sentimento della paura
di morire.
Tuttavia, l'uomo è fornito di ragione, e la ragione naturale suggerisce la norma generale da cui
discendono le leggi naturali del vivere civile, che preservano la stessa vita del singolo -- principio,
questo che si pone alla base della legge di natura --. Di conseguenza, nell'hobbesiano stato di
natura esistono dettami della ragione indicanti i modi più sicuri di garantire la sopravvivenza di sé.
La vita viene preservata da una norma razionale, la quale, in Hobbes, diviene il frutto di un calcolo
dell'utilità, essendo, la ragione, atto necessario di rinuncia ad ogni diritto per raggiungere un fine
corrispondente al solo diritto non ceduto: la conservazione della propria esistenza.
Proprio riflettendo su tale asserzione, non può non destare sconcerto il considerare che, al giorno
d'oggi, tale diritto è intaccato nel suo significato più autentico. Sconcerta, infatti, in un'era che
Norberto Bobbio ha definito «l'età dei diritti»,17 e che ha visto lo sviluppo e l'affermazione di tanti
nuovi diritti, veder messo in discussione proprio quel diritto alla vita senza il quale è inutile anche
parlare di tutti gli altri. A distanza di tanti secoli dalle affermazioni hobbesiane, il diritto alla vita
torna, purtroppo, ad essere oggetto di discussioni a causa dell'enorme progresso scientifico avutosi
negli ultimi cinquant'anni. Si pensi, in tal senso, a tutte le problematiche connesse all'aborto, alla
procreazione assistita, all'eutanasia. Di conseguenza, inquietanti sono le domande sui problemi
legati alla nascita, allo sviluppo ed alla cessazione della vita umana, ma, ancor più inquietante, è
l'incapacità di coniugare l'etica al progresso scientifico, poiché tutelare la vita umana significa, oggi,
determinare quali siano gli interventi leciti su di essa e quali no. Il discorso, pertanto, non può non
incentrarsi sull'aspetto etico degli interventi dell'individuo sulla propria vita, i quali sono oggetto
della bioetica, scienza che ha il compito di avanzare una visione olistica della vita umana tentando,
così, di coniugare progresso scientifico e progresso morale.
In tal senso, l'hobbesiana legge naturale, ci aiuta a comprendere i parametri ai quali, nella nostra
epoca, dobbiamo necessariamente fare riferimento per tutelare il diritto alla vita e, di conseguenza,
per comprendere come l'approccio etico debba sforzarsi di interpretare i comportamenti umani
sulla base della loro conformità alla natura ed alla dignità dell'uomo. Dignità, che viene messa in
discussione non solo all'inizio della vita, ma durante e anche nelle sue fasi finali. È emblematico, a
tal riguardo, il pensiero di uno degli esponenti della bioetica laica, A. Singer, il quale distinguendo
gli esseri viventi sulla base di determinate qualità come l'autocoscienza, l'autonomia, il senso
morale, giunge ad attribuire maggiore dignità ad alcuni animali, come ad esempio, gli scimpanzè,
rispetto ad alcuni esseri umani che, in determinate fasi, sono carenti di tali caratteristiche (si pensi
all'embrione o ad un malato nello stato vegetativo).
La difficoltà di difendere l'uomo e di promuovere la sua dignità, risiede proprio nella mancanza di
un comune concetto di natura umana, dal quale si determinano diverse impostazioni etiche che
arenano, ad esempio, il processo di regolamentazione nei confronti dell'aborto, della fecondazione
assistita, dell'eutanasia, ecc... Si assiste, pertanto, ad un relativismo etico, il quale distingue, per
grandi linee, un'etica della sacralità da un'etica della qualità della vita. I sostenitori della sacralità
della vita e, quindi, della sua inviolabilità, ritengono che la vita umana sia un dono di Dio; il primo
e più importante di tutti. Non vi è autorità terrena che possa avocare a sé il potere di sopprimere,
consapevolmente e volontariamente, una creatura umana, in nessun caso, per nessuna ragione al
mondo, neppure quando sia il titolare a farne richiesta. Dall'altra parte, l'etica della qualità della
vita si incentra sul motivo della salvaguardia della dignità umana, inteso come diritto
all'autodeterminazione dell'individuo, perciò, anche come limite alla legittimità di trattamenti
sanitari. Essa, dunque, si riferisce alla qualità effettiva dell'esistere, misurata e valutata giorno per
giorno.
Il bisogno di trovare un punto d'incontro fra posizioni etiche contrastanti, induce a rispolverare il
concetto aristotelico di phronesis, di ragione pratica, che manifesta la superiorità dei fini sui mezzi,
capace di contrastare l'albagia della razionalità scientifica, la quale, se non si pone dei limiti (e la
scienza moderna sembra volerli sempre valicare), finisce con l'anteporre i mezzi ai fini. Proprio
l'uso della ragione, appannaggio dei credenti e non credenti, di un'etica della sacralità e di un'etica
della qualità, può aiutare ad affrontare le situazioni odierne, che minacciano la vita o pensando ad
una sua soppressione o ad una sua manipolazione. Tutelare la propria corporeità può significare,
dunque, riscattare quell'umana razionalità, essendo la ragione matrice della legge naturale, la quale
proibisce la distruzione della vita, la cui preservazione vuol dire ritrovare la nostra identità di
uomini, di esseri razionali. Del resto, Hobbes, aveva ben messo in evidenza tale legge naturale che
accomuna gli esseri umani indipendentemente dalla loro individualità.
4. L'arte di Dedalo: tecnica incarnata
L'individuo contemporaneo al fine di autorigenerarsi e autoricrearsi assume come presupposto il
vuoto, la mancanza di solidi punti di riferimento, il nulla. Proprio il nulla si configura come spazio
aperto, libero, come distesa nella quale poter agire per realizzare se stesso. In quest'ottica il corpo,
inteso nella sua nudità, viene considerato come estensione sulla quale la scelta umana può trovare
completa realizzazione, dato che la continua ricerca, l'ininterrotto divenire non sono solo realtà
contemporanee rivolte ad uno spazio esterno, ma anche alla corporeità. Il corpo viene concepito
come dimensione aperta al contatto, al tocco, all'incarnazione.18 Esso costituisce uno spazio in cui
la fluidità, il mutare si rendono tangibili, superando la classica concezione secondo cui la tecnica
sarebbe un supplemento ad una natura mancante in qualcosa e aprendosi ad un nuovo rapporto
con l'artificio. Rapporto che si basa sull'incarnazione della tecnica,19 la quale si insinua sul e nel
corpo che ingloba e fa proprio l'artificio. E per comprendere al meglio quest'interdipendenza tra
tecnica e corpo20 nella nostra contemporaneità, sembra utile rifarsi ad un mito e -- precisamente - al mito di Dedalo, dato che l'uomo-così come la collettività tutta -- ha in sé quella capacità
mitopoietica che crea, fantastica modella miti, i quali sono tessere dell'immaginario collettivo che,
a sua volta, raccoglie in sé il vissuto dell'uomo.21 Pertanto, l'interpretazione simbolica di un mito
può far luce e spiegare il nostro tempo presente visto che il linguaggio attraverso cui si esprime un
mito è proprio il simbolo. Così, la figura mitologica di Dedalo può illuminare l'uomo post-moderno
su quell'accadere che investe la corporeità, la fisicità, poichè rappresenta una sorta di scienziato
post-moderno che ha come fine ultimo l'incorporazione della tecnica. Infatti, analizzando il mito di
Dedalo -- più conosciuto come quello di Icaro -- emerge una sostanziale differenza rispetto alle
altre narrazioni mitiche, ad esempio, rispetto a quella di Prometeo che svela all'uomo il sapere
tecnico. Dedalo, costruendo le ali per il giovane Icaro -- ma anche per se stesso, al fine di evadere
dal labirinto in cui Minosse rinchiude entrambi a causa della sconfitta del Minotauro -- presenta
una tecnica che si incarna sul e nel corpo umano. Essa non costituisce più un supplemento ad una
natura mancante in qualcosa, ma, diviene essa stessa corpo, in un'inscindibile unità. A differenza
del figlio, Dedalo atterra a Cuma (dove costruisce un tempio al dio Apollo consacrandogli le ali)
proprio utilizzando le ali: fonte di salvezza poiché tutt'uno col suo corpo. Pertanto, questo
particolare mito condensa in sé germi del nostro presente in cui la tecnica si incarna nella nudità,
fino a giungere alla metamorfosi di cui la figura del cyborg22 ne è l'emblema, dato che, oggi, il
corpo è «un corpo mutante mai finito e definito, ibridazione di organico e inorganico, tra biologico
e tecnologico, tra carne e circuiti».23
Così, nella post-modernità, nella fluidità che ci investe, il corpo si mescola al consumo, allo
smaltimento, al cambiamento, alla metamorfosi della quale non conosciamo la totalità degli esiti e
dalla quale possiamo preservarci, custodirci attraverso quelle azioni aventi un significato in se
stesse, ovvero, attraverso la riabilitazione della praxis aristotelica, la quale pone le azioni del libero
agire come aventi lo scopo di perseguire un fine ultimo che è bene sommo, fine razionale e,
insieme, morale: fine umano.
Note
1.
Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma, 2005.
2.
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto. L'età moderna, il Mulino, Bologna, 1968, vol. I, pp. 32-89.
3.
F. Totaro, Natura, artificialità e relativismo etico, in M. Signore (a cura di), Natura ed etica, Pensa Multimedia,
Lecce, 2010, p. 109; E. Agazzi, Natura e etica: come pensare il loro rapporto in una civiltà tecnoscientifica, in
idem, p. 93.
4.
Z. Bauman, Consumo dunque sono, Laterza, Roma, 2007, p. 59.
5.
Giovanni Paolo II, Lettera alle Famiglie, 2 febbraio 1994, Libreria Ed. Vaticana, Città del Vaticano, 1994, n. 19.
6.
E. Palese, Da Icaro a Iron Man. Il corpo nell'era del post-umano, Mimesis, Milano, 2011, p. 74.
7.
J.-P. Sartre, L'esistenzialismo è un umanesimo, Mursia, Milano, 1970, p. 35.
8.
E. Fromm, Avere o essere?, Mondadori, Milano, 2010, p. 37.
9.
R. Esposito, Termini della politica. Comunità, immunità, biopolitica, op. cit., p. 162.
10. G. di Ockham, Commento alle sentenze, in A. Ghisalberti, Scritti filosofici, Cardini Editore, Firenze, 1991, pp.
172-79.
11. Tommaso d'Aquino, La somma teologica, Salani, Firenze, 1949-75, vol. I, pp. 60-62; Tommaso d'Aquino,
L'unità dell'intelletto, in A. Lobato (a cura di), Opuscoli filosofici, Città Nuova, Roma, 1989, pp. 110-11.
12. U. Grozio, De iure belli ac pacis, in P. Negro, I fondamenti del diritto:antologia, Editoriale Scientifica, Napoli,
1998, pp. 373-421.
13. D. Hume, Opere filosofiche, a cura di E. Lecaldano, Laterza, Roma-Bari 1987, vol. I, p. 217.
14. M. Weber, The theory of social and economic organization, Free Press, New York, 1964, p. 88.
15. E. Petrini, Per una filosofia dell'impersonale, in L. Bazzicalupo, Impersonale, Mimesis, Milano, 2008, p. 47.
16. T. Hobbes, in N. Matteucci, Antologia di scritti politici, Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 20-35.
17. N. Bobbio, L'età dei diritti, Einaudi, Torino, 1997.
18. J. L. Nancy, Indizi sul corpo, Ananke, Torino, 2009, p. 7; si veda, inoltre, G. Deleuze, Cosa può un corpo?
Lezioni su Spinoza, Ombre corte, Verona, 2007, p. 48.
19. R. Esposito in D. Calabrò, J.-L. Nancy, Dis-piegamenti, Mimesis, Milano, 2006, p. 86.
20. U. Galimberti, Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica, Feltrinelli, Milano, 2008, p. 255; T.W. Adorno E.
Canetti, A. Gehlen, Desiderio di vita. Conversazioni sulle metamorfosi dell'umano, Mimesis, Milano, 1995, p.
13; R. Galimberti, Il corpo, Feltrinelli, Milano, 2006, p. 46.
21. J. Ries, Il mito e il suo significato, Jaca Book, Milano, 2005, p. 181.
22. Sulla figura del cyborg si veda: P. Bellini, Il cyborg, una nuova mitopia tecnologica, in «Pedagogika», anno XIV,
n. 4, 2010, p. 45; P. Bellini, Cyberfilosofia del potere, Mimesis, Milano, 2006, p. 126.
23. M. Combi, Corpo e tecnologie, Meltemi, Roma, 200, p. 119.
Giuseppe Stinca
Trascendenza e silenzio di Dio.
Un confronto tra E. Levinas e A. Neher
L'intento di questo lavoro è porre in parallelo le categorie che Levinas utilizza per declinare la
trascendenza di Dio con le considerazioni di Neher sul silenzio di Dio e con la sua analisi della
fenomenologia del silenzio come inerzia, energia e sfida, nel suo libro L'esilio della parola.1
Il punto di contatto ci è sembrato essere la concezione di Levinas della trascendenza di Dio fino a
una sua possibile confusione col brusio del c'è, nella quale la parola «brusio» richiama quella che,
nel testo biblico di 1Re 19, 12b, letteralmente ed etimologicamente è resa con «la voce di un tenue
silenzio».
La clavis hermeneutica del lavoro va pertanto individuata in questa vicinanza di termini e di
significati. Facendo perno su tale contatto sono stati individuati dei temi comuni -- espressi con
linguaggio e immagini differenti -- accostabili in una sequenza logica, per la quale l'autore
principale di riferimento rimane Levinas.
1. Il volto nascosto di Dio
1.1. Dio altro dall'essere
Per Levinas «La filosofia riconduce ogni significato e ogni razionalità all'essere»2 inglobando in
tale essere Dio stesso. Tale atto, per Heidegger, pone inizio ad un'epopea che si conclude con la con
la tecnica che segna la fine della metafisica e la morte di Dio, ma non è che un normale sviluppo
dell'onto-teo-logia e, costituisce addirittura una chance per il pensiero dell'essere che non sarà più
ontologia.3
Per Levinas bisogna chiedersi se l'essere sia l'ultima sortente del senso. Opporre Dio all'onto-teologia significa concepire una nuova nozione di senso.4
1.2. Dio insensato
Bisogna chiedersi se l'essere e il pensiero siano la sorgente ultima del senso o se ci sia una
significazione anteriore alla presenza che significhi in maniera eccezionale non oltre l'essere, ma
prima e altrimenti che essere. Una tale modalità sarebbe quella di un linguaggio non dossico, ma
paradossale,5 pensato non come affermazione, ma come domanda, come questione.
In tutta la tradizione occidentale il pensiero è tetico, pone ciò che afferma, e così forma un mondo.
Anche l'idealismo moderno, che punta l'accento sull'attività del pensiero, non si congeda da questa
visione, dalla priorità del mondo; nessuna trascendenza «proprio mentre il Dio della Bibbia
significa in maniera inverosimile [...] l'al di là dell'essere, la trascendenza».6
1.3. Dio Trascendente
Per Levinas il pensiero occidentale si configura come una secolarizzazione dell'idolatria. In esso la
meraviglia diviene filosofia, l'idolatria astronomia, la razionalità ateismo; e tutto ciò appartiene al
gesto d'essere cioè alla fonte dalla quale la razionalità prende senso e fondamento, fa parte del
movimento stesso del sapere che pone l'essere come suo fondamento e che abbraccia il tutto con il
suo sguardo. Tuttavia, a differenza di Heidegger, per Levinas la tecnica non è la fine dello spirito
umano. In questa situazione Dio trova uno spiraglio nella rottura del movimento del pensiero che
riposa sull'essere e che segna il regno dello Stesso.
Secondo Levinas la tecnica ha avuto sull'uomo un effetto di disincanto, ma essa non lo salva da
ogni mistificazione, soprattutto non lo salva dalla mistificazione del pensiero stesso e dell'apparire.
Dunque se si deve ipotizzare una Trascendenza la si deve pensare a partire da qualcosa che sia al di
là del pensiero, al di là del movimento unificatore dello Stesso, della filosofia, della tecnica e
dell'ateismo. Una secolarizzazione della secolarizzazione.7
Tale disincanto del disincanto avviene per Levinas nell'appello crudo della corporeità, della povertà
dei bisognosi, in quella che in una parola egli definisce «fame». Questa trascendenza che ha origine
nella corporeità non è ontologica perché non ha al suo inizio nel pensiero, ma è di colpo
responsabilità per l'altro uomo. Solo tale responsabilità permette di uscire dall'incantamento del
pensiero e dell'apparire, permette di secolarizzare la secolarizzazione,8 e apre una fessura di uscita
in direzione di un al di là nel quale si collocherebbe un Dio trascendente.9
1.4. Trascendenza e silenzio
Nella sua analisi della fenomenologia del silenzio biblico Neher individua tre ambiti di silenzio:
inerzia, energia, e sfida, caratterizzati ciascuno da una coppia di termini che designano la parola
«silenzio».
Tra il silenzio inerte del Nulla e il silenzio energetico dell'Essere si colloca la coppia di termini:
`âlâm e haster panîm. Il primo termine è utilizzato nella Bibbia per indicare il silenzio degli
uomini, anche se i rabbini lo utilizzeranno per il silenzio di Dio; invece il secondo è il termine
maggiormente usato nel testo biblico per indicare il silenzio di Dio.
'Illem, la cui radice è la medesima di `âlâm, significa muto, ma un muto che è tale non per motivi
fisiologici; la chiave di lettura del contesto ce la fornisce l'espressione haster panîm, che significa
letteralmente nascondere il volto, con un travestimento, o una maschera. «Il denominatore
comune di questi due termini, come si vede, è la nozione di gioco teatrale. Nei due casi, il silenzio è
una maschera».10
In questa dinamica teatrale l'uomo e Dio giocano a nascondino in un dramma nel quale rischiano
di perdersi o di dimenticare di essere partners dell'azione. Nella Bibia il mondo è aperto, nessuna
soluzione certa è già scritta. Il silenzio, allora, risulta necessario alla libertà dell'incontro e del
dialogo tra uomo e Dio.11
2. La trascendenza silenziosa del male
2.1. La trascendenza del male
Come può un pensiero andare al di là del mondo, essere trascendente, se il pensiero pretende di
inglobare anche la negazione come proprio momento?12
L'analisi di Levinas si sofferma su un testo di Philippe Nemo che pone l'attenzione alla
trascendenza che interrompe il mondo in una particolare modalità di vissuto: il male di Giobbe.13
Nell'analisi del male Levinas individua tre elementi: l'eccesso, il tu al fondo del male, e il richiamo
al bene.
Nella sua malignità di male, il male è eccesso, la non-integrabilità del non integrabile, e in questo
senso trascendenza!14 La teodicea stessa è un modo di pensare Dio come la realtà del mondo, ma il
male eccede tutto questo, ottiene la sua significazione proprio dal suo opporsi a tale sistema.
Il secondo elemento che emerge dal male è un'«intenzione», come se nel male qualcosa, qualcuno
mi cercasse, come se nel male vi fosse un'intenzione cattiva che mi rivela qualcuno dietro al male,
qualcuno verso il quale va la mia interpellanza, la mia domanda sul perché della mia sofferenza,
una domanda che suppone un Bene dietro il Male. «Il senso comincia dunque nella relazione
dell'anima a Dio a partire dal suo risveglio attraverso il male. Dio mi fa male per sradicarmi dal
mondo in quanto unico ed eccezionale: in quanto anima».15
C'è un terzo momento in questa fenomenologia del male: il mio odio del male.16 In questo senso il
male mi colpisce nell'orrore che ho di esso e nella mia conseguente relazione paradossale al Bene,
una relazione che è una attesa senza mira, non intenzionale, è un'attesa senza atteso, una pazienza.
L'analisi di Levinas si distingue rispetto a quella di Nemo nell'interpretare il tacere dell'uomo di
fronte all'onnipotenza di Dio come appello alla responsabilità verso il mondo, una responsabilità
che trova l'uomo sempre in ritardo, un comandamento primordiale, che può avere senso solo
all'interno di un'umanità solidale. Tale responsabilità è ricollegata da Levinas a quella destata
nell'uomo dall'appello anarchico del Volto d'Altri.
In questo senso, secondo Levinas, la storia sarebbe un dramma nel quale il Medesimo è
scompigliato dal Male e dall'Altro, e tentato di tornare al riposo della tematizzazione del mondo.
Un'alternanza di fratture e ricomposizioni, nelle quali non c'è sintesi, ma rinvio, mira senza
coincidenza, ambiguità, «ma anche l'approssimarsi di un Dio infinito, approssimarsi che è la sua
prossimità».17
2.2. Ponti sospesi e arcate spezzate
L'alternarsi di rotture e ricomposizioni nella storia è ripreso, con linguaggio differente, da Neher
che compie un'analisi del termine biblico sadday il cui primo significato è l'attributo della
promessa con il quale Dio è conosciuto dai patriarchi, una promessa che è ombra e silenzio.18
Questa promessa silenziosa non ha qualcosa di simile a quella che in teologia viene detta prova?
Nella prova, infatti, tutto si svolge come se Dio avesse dimenticato chi è l'uomo che sottopone alla
prova, Egli tace. Eppure la prova è tale perché ha un intervallo di tempo, ha un inizio ed una fine;
in essa Dio prova coloro che Egli sa che reggeranno; in essa Dio non si espone sostanzialmente ad
alcun rischio. Il Dio della prova, diremo noi è il Dio dei ponti sospesi. Tuttavia vi sono nella Bibbia
dei ponti destinati a crollare. È questo il caso dell'esperienza di Giobbe.19
A Giobbe, differentemente da Abramo, non viene chiesto nulla, ma tutto viene sottratto
violentemente. Inoltre mentre per Abramo tutto torna come prima, per Giobbe non è così, c'è una
frattura incolmabile nella sua vita, il filo sottile che unisce Giobbe a Dio si spezza. È come se Dio
avesse assunto per Giobbe il rischio che si era rifiutato di correre con Abramo. Infine, il termine
sadday che non compare nel caso di Abramo è invece utilizzato nell'esperienza di Giobbe.
Per Neher sadday è Colui che basta a se stesso, non l'Esser da cui ci si aspetta tutto, ma l'Essere da
cui non ci si può aspettare nulla. «È il Dio senza eco, senza vigilia e senza domani, il Dio del
Silenzio assoluto».20
L'esperienza biblica parla di due tipi di prova: quella vera e propria, e quella che si potrebbe
definire una falsa prova -- quella di Giobbe. Se il Dio della prova è quello dei ponti sospesi, quello
della falsa prova è il Dio delle arcate spezzate.21
La Bibbia, così costituita, risulta essere il documento teologico più inquietante che sia stato offerto
alla riflessione umana, e la riflessione ebraica non è rimasta refrattaria a tale inquietudine.
Il Dio del silenzio che da essa emerge può essere accostato al Dio che non è compromesso in alcun
modo con l'essere, il cui legame con l'uomo non si declina con le categorie del senso, del pensiero e
della Parola, ma con quelle del Silenzio.
Sono queste le categorie che troviamo nell'esperienza del profeta Elia.
3. Il brusio dell'il y a
3.1. La trascendenza paradossale
Restano per Levinas due domande: se sia possibile pensare un Dio al di fuori dell'onto-teo-logia, e
se un tale modello d'intelligibilità possa essere formulato a partire dall'etica, che costituisce una
significanza senza riferimento al mondo, all'essere e alla conoscenza. In tal modo «la trascendenza
come tale sarebbe una mira che resterebbe mira; in questo senso sarebbe una trascendenza non
dossica, ma para-dossale [...] . Una trascendenza infinita, poiché l'idea di colmare una mira
intenzionale con una visione è qui fuori luogo, fuori proporzione. Una trascendenza sproporzionata».22
3.2. Il disinteressamento dell'etica come fenomeno della trascendenza
Il primo «intrigo» da esaminare è come l'etica possa essere considerata come altro dall'essere,
come dis-interessamento. Ciò che è caratteristico dell'intrigo etico è, infatti, una passività nella
quale il soggetto si trova di colpo all'accusativo, senza che la propria intenzionalità possa in alcun
modo mirare alla sintesi noetico-noematica con Altri. Una passività che impedisce al soggetto di
consolidarsi in quanto tale, ma che costituisce, allo stesso tempo, proprio la soggettività.23
Tale passività è, allo stesso tempo, impossibilità di cogliere l'oggetto come oggetto intenzionale
nell'attesa. In questo senso la pazienza è un'attesa senza atteso, una mira che resta mira, nella
quale l'oggetto non viene a colmare il vuoto dell'attesa, e nella quale non c'è sintesi noeticonoematica, ma uno scoraggiante parallelismo, una pazienza nella quale il tempo si riferisce, si
deferisce all'infinito.
In qualche modo, nell'intrigo etico, la trascendenza «significa» diversamente dalla significazione
legata alla presenza e alla rappresentazione, essa è paradossale e infinita, perché non ha un inizio
né una fine nel tempo, ed è sproporzionata perché l'oggetto della sua attesa si allontana con
l'avvicinarsi a esso in quello che Levinas chiama «approssimarsi».
«Questo paradosso iscrive la gloria dell'Infinito nella relazione abitualmente chiamata
intersoggettività. L'infinito si innalza gloriosamente da tale relazione».24
In questo modo la trascendenza è altrimenti che essere. L'essere in quanto essere, infatti, annoda
un intrigo al quale ogni senso è sospeso. L'essere regna, e la conoscenza dell'essere, in cui l'essere si
manifesta, appartiene alla vita stessa dell'essere. Ma l'intrigo etico ha tagliato con
l'intenzionalità.25
3.3. La soggettività anarchica
Di più. «L'etica taglia corto con l'intenzionalità così come con la libertà [...] . È come se vi fosse
qualcosa prima dell'inizio: un' an-archia».26
Nella relazione con l'altro l'io è chiamato a una responsabilità anteriore a ogni suo a priori, a ogni
possibile rappresentazione. «Abbiamo chiamato ossessione questa relazione irriducibile alla
coscienza».27
Nella significazione anarchica l'io è ossessionato perché non può mai assumere ciò da cui è affetto,
si configura in essa un'eteronomia che «designa l'intrigo o il dramma meta-ontologico dell'anarchia
che disfa il logos» .28
In tale responsabilità senza scelta, anarchica, anteriore alla coppia libertà/non libertà vi è per l'io
una investitura che va al di là dei suoi disegni egoistici, che si pone prima del suo costituirsi come
soggetto, e in ciò è altrimenti che essere. 29
In questo senso l'etica viene prima della libertà, l'io si trova compromesso col Bene prima di averlo
scelto, il Bene deve eleggerlo per primo e esso stesso deve essere in ciò anteriore alla libertà,
anteriore alla bipolarità del bene e del male, prima dell'essere, prima della presenza.30
«In questa relazione del Bene con me, relazione che è assegnazione di me ad Altri, accade qualcosa
che sopravvive alla morte di Dio».31
3.4. La responsabilità come gloria dell'Infinito
«La responsabilità per l'altro in me è un'esigenza che cresce man mano che vi si risponde, un
impeto: un'eccedenza sul presente. Tale eccedenza è gloria; è con essa che l'Infinito si produce
come avvenimento. L'eccedenza sul presente è la vita dell'Infinito [...] . Il modo in cui l'Infinito si
glorifica (la sua glorificazione) non è rappresentazione. Esso si produce, nell'ispirazione, sotto
forma di mia responsabilità per il prossimo o come etica».32
La responsabilità è testimonianza dell'Infinito e si esprime nel Dire. Per ora ci serve sottolineare
l'aspetto di incontro, al di là di ogni rappresentazione, tra l'io come unico e l'Infinito. Incontro che
avviene nella sottigliezza dello pneuma, nella sottigliezza di un soffio, nel quale l'io è chiamato
«fuori dagli angoli bui del quanto-a-sé [...] stanato senza possibilità di fuga».33
3.5. La possibile confusione col c'è
L'il y a è un elemento che rientra nei primi studi del nostro autore, poi scompare per lungo tempo
per fare la ricomparsa in alcuni scritti conclusivi. Il punto di partenza è un'analisi nella quale la
posizione di Heidegger viene superata con l'idea dell'irremissibilità dell'Essere.
Nelle pagine di Il Tempo e l'Altro Levinas analizza l'espressione heideggeriana di Geworfenheit
interpretandola come una derelizione e un abbandono, un essere gettato dentro un'esistenza che è
indipendente dall'esistente.34
Due sono le caratteristiche di questo esistere senza esistente, di questa «irremissibilità dell'essere
puro».
La prima è il suo riferimento al nulla, inteso come impossibilità fenomenologica del nulla «un
brusio che ritorna dopo ogni negazione di questo brusio. Né nulla né essere». 35 Tra le esperienze
che meglio possono fornire un'analogia a questo esistere vi è la situazione dell'insonnia.
La seconda caratteristica è quella della passività, aspetto molto fecondo che attua un'evoluzione
negli scritti di Levinas, fino a un suo ruolo positivo che chiude il cerchio in Altrimenti che essere.
Nei testi giovanili la passività, riguarda l'impossibilità di sottrarsi al campo di forze neutro e
impersonale dell'essere, un essere esposti che comprende anche l'angoscia, che non è angoscia di
fronte al nulla, ma un'apertura all'ignoto.
Tali figure tornano in Altrimenti che essere. Di nuovo l'il y a è caratterizzato dalla sua neutralità,
monotonia, anonimato, insignificanza, dal suo brusio. Questo il y a urta contro l'io che vuole
costituirsi tale nella libertà, che vuole tornare a se stesso come presente, e sfuggire all'inesorabile
c'è.36 Per Levinas il soggetto non può mai liberarsi dall'incombenza del c'è, non può farlo
costituendosi come Io perché «il brusio incessante del c'è urta in modo assurdo l'io trascendentale
attivo-cominciante, presente».37
Però, paradossalmente, è proprio questa passività estrema, questa impossibilità di fuga, questa
esposizione, a costituire, mediante la responsabilità per Altri, il nascere anarchico della
soggettività, che si pone non più in relazione con l'essere, costituendosi come essenza, ma con
l'altrimenti che essere mediante il disinteressamento. «Per sopportare senza compenso gli è
necessario l'eccessivo o la nauseante confusione e l'ingombro del c'é».38
Il brusio del c'è diviene, dunque, luogo-non-luogo in cui è possibile il verificarsi della soggettività
come responsabilità per altri, la soggettività che è luogo-non-luogo dove avviene la trascendenza.
Il brusio dell'il y a avvolge la soggettività esposta urtandola nel suo tentativo di costituirsi come Io
trascendentale, ma nello stesso tempo le offre la possibilità di costituirsi come soggettività
responsabile ed anarchica, cioè il luogo-non-luogo in cui accade la trascendenza. Il fenomeno della
trascendenza è circonfuso dal brusio dell'il y a.
Tale il y a è riconducibile a Dio? Se così fosse Levinas tradirebbe le sue iniziali intenzioni di parlare
di Dio, come un termine significante all'interno di una significazione anteriore alla presenza.
L'il y a possiede, però, delle caratteristiche che hanno molte analogie in comune con quel termine
significante che chiamiamo Dio, e con quello che è il sostrato per la possibilità fenomenologica
della Trascendenza e dell'Infinito: l'impossibilità del nulla, l'irremissibilità dell'essere,
l'esposizione, la passività senza assunzione, la responsabilità anarchica.
3.6. Il brusio del prologo. L'emergere del silenzio
Neher, leggendo le prime righe di Genesi, afferma che quasi tutta la tradizione rabbinica ha sempre
individuato nell'espressione «Dio disse» il primo atto della creazione. In tal modo è con il dire della
Parola che tutto ha avuto inizio. In tale concezione tutto è armonia, ogni lato negativo della
creazione è compreso in una sintesi unitaria. Tutto è Parola e non c'è spazio alcuno per il silenzio e
per il dialogo che esso sottende.39
Ora l'interpretazione rabbinica della Bibbia introduce invece, in questa visione di armonia, la
concezione di un mondo pieno di lacune e di vuoti, creato non tutto d'un colpo perfetto dalle mani
di Dio, ma solo dopo svariati tentativi, e contenente ancora numerose imperfezioni, restando solo
sufficientemente stabile e nel quale trova il proprio adeguato spazio il silenzio. Uno spazio che è
contrappunto della parola, in un'aggressiva opposizione dialettica a essa, che non la accompagna,
ma la precede nella logica del pro-logo.40
Letteralmente prologo significa prima della parola, ma quale è la sua vera identità? Nei primi versi
di Genesi una serie di sostantivi e aggettivi vengono utilizzati per descrivere questa situazione
caotica che i filosofi hanno identificato e bollato subito come Nulla, affermando che la creazione è
ex-nihilo.
In Genesi, tuttavia, questo Nulla non è niente, bensì un ciarpame che il primo colpo di scopa della
Parola disperde ai quattro venti, che esiste da qualche parte in una zona pre-verbale.41
Il Nulla è pertanto qualcosa di gigantesco, una serie di mondi non riusciti che si rovesciano l'uno
sull'altro in abissi senza fondo, un serbatoio di forze negative che l'atto creativo ha respinto nel
passato, ma che non ha rimosso per sempre. Questo Nulla è «pronto anche a rispondere all'appello
dell'Essere qualora questi, all'improvviso, si ricordasse della sua originale parentela con il Nulla.
Appare allora il Silenzio -- il grande solenne silenzio-inerzia -- non come una passeggera
sospensione della parola, ma come il portavoce dell'invincibile nulla. Allora il Silenzio sostituisce la
Parola, perché il Nulla è ridiventato il luogo-tenente dell'Essere».42
3.7. Lô'-dûmmyâ. Il Non-Silenzio
Morte, notte e silenzio sono tra loro collegati e costellano la Bibbia con le loro apparizioni, ma
Neher si sofferma sul Salmo 22 perché esso rappresenta una lotta frontale contro la morte e la
notte e perché l'incantesimo del salmista viene reso con un'espressione -- lô'-dûmmyâ -- la cui
singolare incisività stupisce poiché lô'-dûmmyâ è letteralmente il Non-Silenzio.43
Neher non segue la tradizionale interpretazione dei versi nei quali è inserita questa espressione:
«anche di notte non trovo riposo». Per Neher lô'-dûmmyâ è il non-silenzio che non è la parola, ma
una caduta in un silenzio più silenzioso del silenzio, l'accesso ad una dimensione metasilenziale. Di
giorno Dio non risponde al Salmista «Io sono colui che sono», e di notte, col suo silenzio, sembra
dire «Io sono colui che non sono». «Il Signore appone all'uomo il Dio nascosto. Il Non-Silenzio gli
oppone un Dio il cui Essere non può essere colto se non a partire dalle radici fuggenti del Nulla». 44
Potremmo quasi, forzando la mano nelle analogie e traduzioni, accostare il Non-Silenzio del Salmo
22 al brusio anonimo dell'il y a. Non parola (logos) né silenzio: il Non-Silenzio.
Circondato dal Non-Silenzio il salmista è esposto ai propri nemici fino alla responsabilità del male
che gli fanno.
Ritroviamo tutti gli aspetti dell'il y a, e il Non-Silenzio sembra essere il luogo-non-luogo dove la
passività estrema senza assunzione può divenire relazione con l'Infinito nella responsabilità per
Altri, meta-luogo dell'attuarsi della Trascendenza.
3.8. Lô' ´ašibennu. Non ti risponderò
La responsabilità per Altri diviene possibilità della Trascendenza, ma una tale trascendenza per
attuarsi restando tale, deve ordinare il non-desiderabile, non deve essere mai soggettivata.
In tal modo Dio, il dio biblico che è il Dio dell'assoluta trascendenza, come sostiene Levinas, fa
incontrare l'uomo non solo col silenzio della creazione, col silenzio del nulla, ma anche col proprio
silenzio.
Questo aspetto del silenzio è analizzato da Neher in due brani biblici: l'episodio del re Saul, e quello
del profeta Elia.
Saul è stato investito del suo compito senza alcuna parola da parte di Dio, senza alcuna visione, è
un profeta senza parole. È proprio il silenzio di Dio durante tutta la sua vita che lo spinge a
consultare la pitonessa, perché tale silenzio è percepito come colpa.45
Saul, di fronte all'angoscia del silenzio si rivolge alla magia per ottenere una risposta, pecca
letteralmente d'idolatria, abbandonando il ponte sospeso della trascendenza, abbandonando il Dio
trascendente per rivolgersi agli idoli fatti dalle mani dell'uomo, agli dei della religione teologica,
tematizzante, che non lascia a Dio la sua trascendenza.
Di fronte al silenzio di Dio Saul si sente schiacciato e si uccide, ma non è questa l'unica risposta a
tale silenzio. Nella Bibbia esiste un'altra strategia per esorcizzare il silenzio di Dio ed è quella
dell'ironia, del riso. La stessa ironia che utilizza Elia sul monte Carmelo contro gli idoli. Agendo in
base alla convinzione che gli idoli sono falsi e muti e il Dio vero è il dio della parola e della luce, Elia
gioca il tutto e per tutto: «La divinità che risponderà concedendo il fuoco è Dio! » (1Re 18, 24).
Neher sottolinea come in realtà la tecnica della mantica sia costruita ad arte per funzionare: un
idolo escogitato per parlare parlerà, ma la sua parola non sarà che una parodia della parola reale. 46
Eppure, nell'episodio citato, gli idoli non rispondono mentre JHWH manda il fuoco. E se Dio non
avesse risposto? E ancora: rispondendo non si è forse consegnato anch'Egli alla dinamica della
mantica e degli idoli? A tali interrogativi la Bibbia non è insensibile.47
La vicenda del profeta Elia sul monte Carmelo, infatti, trova il suo completamento con gli eventi
dell'Oreb.
3.9. Qôl demamâ daqqâ. Una voce più tenue del silenzio
Negli episodi del Carmelo e dell'Oreb si ha l'incontro vivo e pieno con l'essenza di Dio, e in questo
gioco Dio rischia il tutto per tutto. Mentre nel caso dei miracoli la posta in gioco era l'intervento a
favore di una richiesta dell'uomo, e il non intervento di Dio poteva essere ascritto alla colpa umana,
qui, invece è in gioco l'esistenza di Dio, un'esistenza legata alla parola.
Se Dio non avesse risposto sul monte Carmelo forse non sarebbe successo nulla. Del resto
l'intervento di Dio non porta nessun cambiamento alla situazione sulla terra se non una
momentanea esaltazione dei presenti.
Sul Carmelo Elia comprende che agganciando Dio alla Parola ha intrapreso la strada sbagliata. Dio
non è nella tempesta, né nel fuoco, ma in qôl demamâ daqqâ (19, 12), nella voce di un tenue
silenzio. La sola voce di Dio è il silenzio. Esso non è più segno della collera divina, ma esprime la
sua presenza meglio della parola.48
In tal modo viene capovolta totalmente la prospettiva del silenzio. Non c'è silenzio che non sia
silenzio di Dio, e l'incontro con Lui è possibile nell'oscurità dell'abisso più totale. L'abisso del
silenzio è il meta-luogo dell'incontro, dell'attuarsi della Trascendenza.
Se si può trovare Dio anche nella sua più totale lontananza, quanto più sarà impossibile sottrarsi
alla sua «presenza» trascendente nella contemplazione del creato. Siamo esposti alla sua
incessante e trascendente «presenza».
Ho scritto la parola presenza tra virgolette perché, seguendo la linea tracciata da Levinas, non
possiamo parlare per Dio di presenza, poiché questa si riferisce al pensiero e al processo
intenzionale e tetico. Dio non può essere presente in tal modo. In tal senso preferisco coniare il
termine in-assenza, nel quale il prefisso in -- come già nell'in-finito levinasiano -- indica un non e
un in. Una doppia negazione che non è posizione, ma una scivolata nel linguaggio dell'altrimenti
che essere. Tuttavia una negazione significante di una significazione anteriore alla presenza, in una
relazione non riconducibile all'ontologia, significante nella sua Trascendenza, nel suo Silenzio!
Di fronte all'in-assenza dalla Trascendenza l'uomo è interpellato nel suo atteggiamento e nel
linguaggio che esso deve assumere. Un linguaggio che in Levinas è descritto con i caratteri del Dire,
in Neher assume l'aspetto drammatico della responsabilità dell'uomo di fronte al Silenzio.
È qui che ci si scontra con un altro silenzio: quello dell'uomo che si estende nei primi undici
capitoli di Genesi, come se una chiave della creazione fosse stata smarrita. «Questa chiave è il
termine stesso che designa la parola nella Bibbia: il termine dabar. Ora, è con l'abracadabrante
avventura del dabar che tutto avrebbe avuto inizio e che, nella Bibbia, il silenzio attinge una nuova
dimensione, perforando l'inerzia per accedere all'energia».49
La nostra analogia si estende alle considerazioni sul Dire senza Detto e alla paradossalità del
dabar.
4. La paradossalità del Dabar
4.1. L'esigenza iperbolica della significazione
Dal fondo dell'il y a il soggetto esposto può risolversi nella responsabilità anarchica verso Altri. Il
soggetto, convocato da Altri, ritrova una nuova identità non al riparo della propria forma, del
proprio concetto di Io, ma come eletto ed unico, votato al non-desiderabile, alla bontà, in un
incremento infinito che è gloria.50
Tale esigenza iperbolica non nasce dall'iniziativa di una sostanza costituita in Io-penso, ma da una
totale inversione di questo movimento, in una passività estrema, dalla quale emerge la
responsabilità della soggettività anarchica. Un'estroversione che porta il nome di sincerità.51
E la sincerità è resa tale solo attraverso il Dire perché in esso vi è una significazione all'Altro che
spicca su ogni altra relazione, una significazione possibile in quanto soggettività. Bisogna
comprendere bene cosa Levinas intende per Dire.
4.2. La significazione anteriore del Dire nell'intrigo della prossimità
In primo luogo possiamo esaminare cosa sia il Dire, e come esso sia possibile
fenomenologicamente a partire dall'esperienza del Detto.
Secondo Lavinas il Detto è inteso come noema di un atto intenzionale, nel quale il soggetto si
restringe in pensiero e fornisce un segno che rinvia ad un significato. Ma il soggetto del Dire non è
il significato di questo segno, e la significazione del Dire non si risolve tutta nel Detto. Essa rinvia a
un intrigo preoriginario della responsabilità che può essere descritto come rovesciamento
dell'intenzionalità.52
Il Dire, infatti, non si risolve nell'invio di segni, perché questo presuppone una preliminare
rappresentazione di questi. Ci troveremmo di fronte a un soggetto già costituito come Io-penso che
traduce i suoi pensieri in linguaggio, in segni. Si tratterebbe, dunque, di un'azione intenzionale.
L'invio di segni, invece, presuppone già una prossimità ad Altri, un intrigo di tipo etico che è
anteriore alla rappresentazione. «L'intrigo della prossimità e della comunicazione non è una
modalità della conoscenza».53
4.3. L'esposizione significante
Nel Dire il soggetto si trova totalmente destitutito, stanato dalla sua permanenza in sé, non
abitando più nessun luogo. Questa non abitazione si risolve non nel dare segno, ma nel farsi segno,
nella totale obbedienza.54
Il Dire è quindi una risposta che sorge come iperbole dalla passività, nella responsabilità per Altri,
una passività che è rovescio dell'intenzionalità, un rovescio senza diritto, un essere come
vulnerabilità. Situazione nella quale il soggetto è vocato come unico.55
Vulnerabilità dell'essere che si espone al rischio del non senso, e così alla possibilità della
Trascendenza che deve necessariamente prodursi come contro-senso. 56
4.4. Il disfarsi dell'essenza in significazione
Si tratta ora di esaminare come il Dire possa seguire l'onda del disinteressamento. Per far ciò
dobbiamo partire dal problema della verità e del suo svelamento.
«La soggettività in quanto sapere si subordina al senso dell'oggettività».57 La soggettività è dunque
sempre chiamata a raccogliere la manifestazione, e ogni gioco che essa giocasse al di fuori di questo
sistema sarebbe velamento dell'essere.
Questo significa che la verità, cioè il rapporto di svelamento tra gli enti non esiste se non all'interno
di un sistema che li vede in relazione tra loro, sciolti dal quale, i soggetti si occultano. Anche la
soggettività è concepita all'interno di questo sistema. Il ruolo che essa svolge è quello di raccogliere
la manifestazione e, così, di rientrare nell'inglobante atto d'essere.
Il soggetto, dunque, verrebbe assorbito totalmente nel Detto e non sarebbe l'origine di alcuna
significazione. E anche la significazione, l'intelligibilità e lo spirito risiederebbero nella
manifestazione, nella presenza.58
Ma nello straordinario del rapporto etico abbiamo intravisto una significazione anteriore alla
presenza. Pertanto la significanza della significazione non si esercita come modo della
rappresentazione, la significazione non riposa nell'essere.59
E la relazione nella quale il soggetto è chiamato come unico è la responsabilità. Essa rompe con
l'anfibologia dell'essere e dell'ente, ma anche con la spiritualità della manifestazione, come
articolazione del senso e avventura dello spirito.60
Nella significazione del Dire il soggetto è liberato in quanto unico cioè come soggettività anarchica
e responsabile.61
In questo senso la significazione è una nascita latente del soggetto62 in quanto unico, latente in
quanto anarchica, in quanto precedente ad ogni rappresentazione, in un obbligo senza impegno
preso. In questa nascita senza inizio, nel disinteressamento, si ode la voce dell'Infinito che viene dal
di fuori dei confini dell'ontologia.63
Sopra abbiamo detto che il soggetto che si costituisce come Io all'interno del sistema della
manifestazione e nella quale la sua soggettività è tale nel suo raccogliere la rappresentazione, si
cristallizza nel Detto. Ora di fronte alla voce dell'Infinito che la disfa in disinteressamento, la
soggettività si apre ad una manifestazione che non si concretizza nel Detto.
«Davanti a questa an-archia -- davanti a questo senza-inizio -- fallisce la raccolta dell'essere. La sua
essenza si disfa in significazione, in Dire al di qua dell'essere e del suo tempo, in dia-cronia della
trascendenza».64
4.5. Il significante dicente il Dire stesso
In Totalità e Infinito Levinas sottolinea come il Dire sia rilevante anche dalla parte dell'Altro, del
Significante. Il Significante non è il significato del segno, ma «è di faccia, nonostante
l'interpolazione del segno, senza proporsi come tema». La significazione è pertanto un atto del
Significante che riprende il segno esponendolo, è un assistere alla donazione di segno.65
In tal senso la significazione è affidata ad Altri, alla sua parola con la quale riprende il segno dato
per illuminarne ciò che nella parola era ancora oscuro. La verità è promessa, e la promessa è
linguaggio, è Dire.
È solo all'interno di questo intrigo che l'oggettività acquista un peso, che la verità può rivelarsi
come promessa, come Dire. Solo questa alterità permette di infrangere l'incantesimo del sistema
segno-significato. Il significante è esteriore, è Altro, Altri.66
4.6. Il Dire come testimonianza dell'Infinito
Il Dire mette quindi l'oggetto in rapporto con l'Altri, con l'esteriorità, con ciò che non può essere
concepito dal pensiero: con l'Infinito. La definizione è tale solo come relazione all'Infinito. Solo a
partire dall'Infinito è possibile definire.
L'Infinito a sua volta si segnala nel Dire come assistente all'iterazione del segno. «L'infinito nel
quale si staglia ogni definizione non si definisce, non si offre allo sguardo, ma si segnala [...]; non si
segnala soltanto, ma parla, è volto».67
L'Infinito, dunque, non solo mi interessa nel disinteressamento della relazione etica, ma mi
significa nel volto d'Altri. Dal brusio dell'il y a emerge la verità come volto che mi guarda guardare.
Questo Infinito è così attestato, è Detto all'interno del mio Dire? E il mio Dire nel suo disdirsi lo
afferma?
Il Dire non è un dare iperbolico. Se così fosse, si resterebbe nell'ambito dell'ontologia e l'Infinito
che il Dire testimonia rientrerebbe nei confini dell'essere come ente eccelso.68
Nel Dire, invece, vi é la fissione dell'ultima sostanzialità dell'Io e l'uscita dall'ontologia nella quale si
attua il rapporto paradossale con Infinito in noi. Infinito che non può apparire perché si
smentirebbe come tema, non può essere aggetto di rappresentazione, ma appartiene a un passato
che non fu mai presente. Questa Gloria, nell'entrare in rapporto col soggetto nel Dire, lacera ogni
logica.69
La soggettività responsabile, senza vie d'uscita, non può dirsi, dunque, in un Detto, quantunque
smentito e reiterato, ma può solo emettere una parola dalla voce più tenue del silenzio:
«eccomi».70
«Eccomi» come testimonianza che non tematizza ciò che testimonia perché esso non è
rappresentazione. E non vi è testimonianza che dell'Infinito. Tutto può essere detto perché appare
a chi lo dice come noema e, pertanto, può essere tematizzato. Non così per l'Infinito. «L'Infinito
non appare a colui che ne fa testimonianza. Al contrario, è la testimonianza che appartiene alla
gloria dell'Infinito. È attraverso la voce del testimone che la gloria dell'Infinito si glorifica».71
4.7. L'infinito all'inverso
L'Infinito non è davanti al suo testimone, non gli appare come Detto, come un noema. Rispetto a
esso il testimone non si pone come soggetto che afferma, ma come accusativo che è chiamato a
obbedire a un comando appartenente a un passato che mai fu presente, mai fu dinnanzi al suo
testimone.72
Il modi in cui l'Infinito non appare a colui che lo testimonia è ordinando attraverso la sua stessa
bocca, divenendo ispirazione e profezia.73
L'Infinito non può che ordinare mediante l'ambivalenza dell'ispirazione per restare tale, infinito,
trascendente. Mediante l'ispirazione la soggettività è chiamata, con tutto il peso della
responsabilità, ad agire di propria iniziativa mediante la responsabilità, come se dovesse essere un
passo avanti all'Infinito che le ordina. «L'infinito non è davanti al suo testimone, ma come al di
fuori o «all'inverso» della presenza, già passato, fuori presa».74
4.8. Debarîm ´ahudîm. Le parole chiuse nel Detto
Le considerazioni che faremo sul silenzio di Dio come energia in A. Neher, ruotano intorno al
significato del termine dabar. Significato complesso e profondo perché dabar ha una doppia serie
di possibilità di significati: cosa, fatto, oggetto, parola, avvenimento, rivelazione, comandamento
ecc.75
Le analisi che Neher compie evidenziano che il termine dabar non compare nei primi capitoli di
Genesi. Ma quando esso appare è con questa espressione: debarîm ´ahadîm. Di qui la
sorprendente lezione che i debarîm erano chiusi.76
Ciò significa che la terra era bloccata, che in essa la Parola non aveva trovato via d'uscita, tutto era
rimasto dialogo abortito. E nella Bibbia si possono trovare i paradigmi di tali dialoghi abortiti: tra
Adamo ed Eva, o Caino e Abele, ma anche tra i progenitori e Dio e Questi e Noè, che esegue solo
pedissequamente le indicazioni che gli vengono date.
Ora il termine debarîm ´ahadîm si trova nell'episodio di Babele, che rappresenta da una parte
l'idea di universo concentrazionario, dall'altra la volontà superba dell'uomo di soppiantare l'ordine
della creazione annullando la distanza terra-cielo.77 Le parole e le cose a Babele divengono solo
oggetti commerciabili, e come tali, secondo la terminologia levinasiana, in-significanti perché la
significazione ha origine dalla primigenia prossimità ad Altri. Qui, invece, l'uomo stesso è ridotto a
cosa.
Di fronte all'iniziativa di Babele Dio reagisce con un evento dissolutivo, cioè disperde le potenzialità
chiuse nei debarîm in diverse lingue, conferendo all'iniziativa umana un'autonomia irreversibile.
Ma Dio non tocca l'alienazione dei debarîm, «e sarà necessario qualcun altro per dissigillare i
debarîm, per provocare l'esodo della parola, la sua redenzione dal di dentro delle cose».78
Un dabar libero: ecco ciò che Dio aspettava dopo aver liberato la sapâ. Un dabar liberato,
dall'interno, dall'uomo, e non dall'esterno, da Dio; ecco il compito per cui si rendeva necessaria la
comparsa di un Prometeo che creasse questo dabar, con un'iniziativa di assoluta libertà umana.
«Questo Prometeo sarà Abramo [...] . Abramo ha dissigillato i debarîm chiusi: ha provocato l'esodo
della parola e la sua redenzione. Abramo è l'inventore della Parola».79
4.9. La Parola divenuta Verbo
Il dabar può essere liberato in tutte le sue potenzialità solo come risposta libera, autonoma e
responsabile, eteronima, rispondente a un appello anteriore alla coscienza, come Dire, come
Profezia.
Abramo è l'inventore del dialogo, quello orizzontale con gli uomini e verticale con Dio. Egli è il
primo uomo nella Bibbia a dare del tu, alla moglie Sara. Quanto al dialogo verticale, esso matura in
Abramo dopo un silenzio abbastanza lungo e, alla sua comparsa, presenta una caratteristica del
tutto nuova, l'iniziativa. Abramo si rivolge a Dio al versetto 2 del capitolo XV «Che mi darai? », e
quando Dio non entra nel gioco della sua domanda, lui non si interrompe, ma riprende il dialogo al
verso 3 «Ecco a me tu non hai dato discendenza... ». È l'uomo a gettare a Dio la sfida del dialogo, e
Dio la raccoglie come se l'avesse attesa da sempre, la raccoglie rivolgendo all'uomo la Promessa.
Abramo osa ledabber a Dio: per la prima volta, Abramo parla a Dio attraverso il dabar. Il dabar
non è fuori di lui, ma dentro, dandogli la forza per ergersi davanti a Dio in un atteggiamento
d'indignazione profetica. Qui grammaticalmente, dabar è un verbo: si potrebbe dire che con
Abramo, la Parola è diventata Verbo. 80
Da dove prende Abramo tutta questa potenza? Paradossalmente dal silenzio. La sua avventura
comincia nell'obbedienza silenziosa ai comandi di Dio, ed anche al vertice del dialogo, nell'episodio
di Mamre, egli cessa all'improvviso di parlare, fermandosi alla clemenza per dieci giusti, forse
credendo che la misericordia di Dio non possa andare oltre una cifra ragionevole, e così rinuncia
alla propria responsabilità lasciando che Dio prosegua la sua opera da solo. Poi è Dio a lasciarlo nel
silenzio della prova quando gli chiede di sacrificare Isacco. Infine, dopo l'episodio della 'aqedâ
entrambi i partners di questo dialogo potente tacciono. Un dialogo nato e terminato nel silenzio.81
4.10. Behibbar'am. Dalla creazione alla storia mediante il dabar
Che cosa segna questo silenzio? Segna un passaggio, una crescita, in questo caso la trasformazione
di Abram in Abramo, il cambio di nome, che non è solo una metatesi nominale, bensì una cosmica.
Neher compie una stupenda analisi di Gen 2, 4 in cui compare il termine toledôt,
generazione/storia. La massora esige che la lettera הdella parola ( בהבראםquando vennero create)
di tale versetto sia scritta in grafia minuscola: «behibbar'am: è per mezzo di hibbar'am che il
mondo creato da Dio possiede una storia.
Ora, le cinque lettere del termine hibbar'am הבראםcostituiscono in ebraico l'anagramma delle
cinque lettere del termine אברהםAbramo. Ma poiché il הè minuscolo, il segreto rivelato dalla
massora diventa evidente: non è mediante Abram, mediante l'esistenza statica di quest'uomo che il
mondo possiede una storia, ma mediante la mutazione dinamica che ha trasformato le quattro
lettere אברהםAbram nelle cinque mhrba Abramo. Questa inopinata introduzione del minuscolo h
ha fatto esplodere la dimensioni del mondo. Passando da Abram ad Abramo, è l'universo intero che
compie un salto: il salto dall'Essere al Divenire. La creazione è ormai Storia».82
4.11. Hitallek lepanay. La pro-vocazione
La seconda caratteristica di questo cambio è la sua irreversibilità. Abramo non è più nominato col
termine Abram in tutta la Bibbia. Il cambio del suo nome ha dato alla storia un indirizzo, una
direzione irreversibile. Dalla Genesi all'Esodo.
Quando Dio chiama Abram gli dice lek-leka, «vattene» (Gen 12, 1); ma quando gli cambia il nome
in Abramo gli dice hitallek lepanay, «cammina davanti a me» (Gen 17, 1). La vocazione dell'Esodo
è quella di camminare davanti a Dio.83
Abramo corre così davanti a Dio come responsabile della Storia. Quando il dialogo tra i due
partners si interrompe, dopo l'aqedà, Abramo viene lanciato da Dio in avanti, verso il silenzio
dell'avvenire. Egli sperimenta, senza afferrarne il perché, ma raccogliendone l'incontestabile
evidenza che, per l'uomo dell'Esodo, gli appuntamenti con la Parola sono ineluttabilmente
appuntamenti mancati.84
Abramo lanciato avanti verso l'avvenire, nei confronti del quale è responsabile in prima persona.
Un avvenire nel quale Dio spesso scompare, lascia solo l'uomo con la sua responsabilità proprio
perché essa resti tale rispetto a una Trascendenza che, per restar tale, ha bisogno di contrarsi, di
interrompersi -- per dirla con Levinas. Una Trascendenza ambigua.
5. L'ambiguità della trascendenza
5.1. La trascendenza nella pro-vocazione
Nel camminare davanti all'Infinito, nella responsabilità, vi è la testimonianza dell'Infinito e della
sua trascendenza. La Trascendenza nella provocazione!
In questo modo Dio non diviene mai tema, ma resta nella sua «terzialità» anche quando viene
nominato.
«Nella frase in cui Dio viene per la prima volta a mescolarsi con le parole, la parola Dio è ancora
assente. Essa non si enuncia in alcun «io credo in Dio». Testimoniare Dio non è precisamente
enunciare questa parola stra-ordinaria, come se la gloria potesse dimorare in un tema e porsi come
tesi o farsi essenza dell'essere. Segno dato all'altro di questa significazione stessa, l'«eccomi», mi
significa in nome di Dio al servizio degli uomini che mi riguardano, senza aver niente con cui
identificarmi, se non il suono della mia voce o con la figura del mio gesto, con il dire stesso».85
5.2. La trascendenza epifenomenica
Mediante l'ispirazione la Trascendenza resta tale entrando in una relazione col soggetto che non è
tetica, e nemmeno sfugge al pensiero come concetto negativo -- che la legherebbe ancora all'essere
e al pensiero. Il soggetto non dice, ma testimonia l'Infinito, nel gioco del linguaggio, nel quale la
testimonianza significa attraverso l'ambiguità di ogni Detto, mediante il farsi segno nella donazione
di segno, nel profetismo che riveste le apparenze di informazioni circolanti come le altre, che
subiscono le influenze dei limiti e delle ferite del soggetto stesso. Ambiguità, ma anche regime di
trascendenza dell'Infinito.86
Così ciò che eccede il pensiero, l'ideatum che infrange la propria idea, che rovescia la coscienza la
quale si disfa in significazione nel Dire, «accade» nella quotidianità mediante la sua interruzione,
nel profetismo e nell'ambiguità di questo. Non è, infatti, profetismo solo quello che sembra eccesso
nel parlare, ma lo sono finanche i limiti e le ferite del soggetto. Ogni ferita è fessura attraverso la
quale l'Infinito irrompe nel tempo, nella vita. Vi irrompe non come fenomeno evidente,
dimostrabile e tematizzabile, ma mediante la propria contrazione rinvenibile tuttavia nelle tracce.
La Trascendenza non come fenomeno, ma come epifenomeno.
5.3. L'ambiguità dell'epifania
La Trascendenza raggiunge la soggettività in modo ambiguo appellandola nella responsabilità
anarchica, infinita, per Altri verso cui si è esposti. Il soggetto entra nei disegni dell'Infinito, vi entra
mediante la propria responsabilità, tale da essere chiamato in prima persona, ad agire non
contando su niente e nessuno, come se tutto dipendesse da sé, dal finito. Ma è proprio questo
l'unico modo in cui l'Infinito può accadere senza smentirsi in quanto Infinito. 87
«L'Enigma dell'Infinito il cui Dire in me, responsabilità in cui nessuno mi assiste, diviene
contestazione dell'Infinito, ma contestazione attraverso la quale tutto m'incombe a me».88
Solo attraverso l'ambiguità fino alla contestazione l'Infinito può entrare nell'intrigo della
soggettività senza smentirsi in quanto Infinito, senza porsi come oggetto infinito della conoscenza.
5.4. La trascendenza che tradisce il senso nel Dire
Il Volto non è segno, ma significante, parla. Eppure, il Volto diviene apparire ed epifania, si pone
anch'esso in una dimensione di ambiguità tra la rappresentazione e la prossimità. Bisogna
chiedersi se, malgrado tutto, la soggettività si enunci nell'indiscrezione del Detto, in una
dissimulazione che la filosofia è chiamata a ridurre, attraverso un abuso che giustifica la prossimità
stessa nella quale l'Infinito avviene come ambiguità dell'ispirazione nella quale la parola Dio entra
come «una parola abusiva».89 È così che fenomenologicamente il Silenzio possiede una voce, non
sonora, ma più tenue del silenzio.
5.5. L'interruzione dell'Infinito nella giustizia
La filosofia è chiamata a ridurre la dissimulazione del Dire nel Detto. Ora se la prossimità
ordinasse solo ad Altri nella sua solitudine non vi sarebbe alcun problema. Essa, invece, è turbata
dall'entrata del terzo, dell'altro, dal prossimo, che pure chiede responsabilità e obbliga alla
giustizia.
E proprio in questo sistema il soggetto rientra, «grazie a Dio», come altro per Altri nella
giustizia.90
Giungiamo quindi alla postulazione della realtà e del suo studio, a partire non dall'Io e dal suo
colonialismo, ma dalla responsabilità verso Altri, e dalla sua ambiguità. Ambiguità che è la
condizione nella quale l'Infinito s'innalza come terzo nella prossimità del prossimo.91 Ambiguità
dell'ordine verso il prossimo che mi ossessiona, nella quale, mediante la mia sostituzione, si innalza
la gloria. Sostituzione nella quale sono però io, responsabile senza possibilità di sottrarmi.
Essere responsabili verso colui che non può rispondermi, essere responsabili che non è un porre
domande. Eppure in questa doppia ambiguità si attua la trascendenza. La trascendenza che si
lascia trovare dal Desiderio che misura l'Infinito, lo misura nella sua impossibilità di essere misura.
«Mi feci ricercare da chi non mi consultava, mi feci trovare da chi non mi cercava. Dissi «Eccomi,
eccomi», a una nazione che non invocava il mio nome» (Is 65, 1).
5.6. L'improvvisazione della libertà umana
Le considerazioni circa il Dire come responsabilità richiamano ad un aspetto biblico del Silenzio,
analizzato da Neher, che è la sua dimensione di sfida. Una sfida doppia, da parte di Dio e
dell'uomo, che prende le mosse fin dalla creazione dell'uomo, concepita come improvvisazione.92
Neher individua questa improvvisazione nell'espressione «facciamo l'uomo» nella quale Dio si
rivolgerebbe a Adam in potenza come a dire «facciamo, io (Dio) e tu (Adam), l'Uomo», in un
rapporto che implica l'intrigo della propria responsabilità e libertà.93
Dio obbliga l'uomo a essere libero di rispondere a una chiamata. È con questa libertà che il silenzio
assumerà anche i connotati di sfida.
5.7. Il problema della libertà
Dio fa tanto appello alla libertà dell'uomo che lo chiama con l'interiezione «Ascolta! ». Con questa
esclamazione l'uomo è creato tale nella sua possibilità di rispondere agli appelli di Dio nella storia.
Dio cerca l'uomo, lo invita a un incontro nella storia.
«Tra gli scambisti efficaci della storia, alcuni hanno voluto sfuggire a questa caccia, a questa
«persecuzione» di Dio. Sono i profeti».94
Tra i grandi profeti, quello che può meritare certamente questo nome è Ezechiele la cui esperienza
è una vera e propria tragedia del silenzio.95 Ezechiele, a un punto della sua vicenda, si trincera in
un ostinato isolamento. Come risponde Dio a tutto ciò? Chiude nel silenzio Ezechiele e anch'Egli si
chiude nel silenzio fino a che, parlerà di nuovo al suo profeta sciogliendogli la lingua per
permettergli di parlare al suo popolo in sua vece.
«Due esseri di cui l'uno tentava di sfuggire all'altro sulla scena luminosa del Faccia a Faccia, si
ritrovano nel rovescio silenzioso dei Volti nascosti [...] . Cessando di essere un rifugio, il silenzio
diventa il luogo della suprema aggressione. La libertà invita Dio e l'uomo all'appuntamento
ineluttabile, ma è l'appuntamento nell'universo opaco del silenzio».96
5.8. L'ambiguo silenzio dell'avvenire
La libertà è legata al silenzio, lo richiede come un palcoscenico nel quale essa può impersonare il
proprio ruolo di libertà. La libertà e il silenzio sono legati tra di loro in molti modi, ma in
particolare in una dimensione, quella del futuro perché l'obiettivo della libertà non può che essere
l'avvenire e davanti a lei propulsano le dimensioni dell'avvenire che sono il sogno, l'utopia e la
speranza.97
L'avvenire è legato al silenzio, perché il passato e il presente possono essere conosciuti, narrati,
interrogati. Solo l'avvenire è silenzioso e ambiguo come il silenzio.98
Ora nella sfida della libertà, della responsabilità, l'uomo ha da dire Sì al Silenzio, hinnenî, Sì io!
Nella storia Biblica è soprattutto Abramo che pronuncia questo eccomi/sì, io nelle interpellanze
che Dio gli fa', fino all'aqedà, all'equivoco e alla svolta della prova.99
Dopo la prova di Moria il dialogo tra Abramo e Dio si chiude, come se per Abramo quell'evento
fosse stato lo spezzarsi di una corda troppo tesa. Due vie si aprono, dunque, davanti a lui, quella del
sogno e quella dell'opera. Entrambe comportano la loro parte di silenzio. Abramo si incammina su
entrambe: il sogno/promessa restituito che è il figlio, e l'opera, concreta e silenziosa, che è la
vita.100
5.9. Il Sì ambiguo della speranza
Il Sì dell'Opera è anche il Sì che pronuncia Giobbe, non suicidandosi e scegliendo la vita. Il rinvio
all'opera sarebbe il mezzo col quale Giobbe trova la via d'uscita pronunciando, nella propria
infermità, un Sì al male.101 Sì che possiede tutta la forza inerziale, energetica e di sfida del silenzio
e dell'ambiguità.
È, infatti, nel bel mezzo del dialogo sfida con Dio che Giobbe pronuncia questo Sì, e lo fa grazie al
procedimento ermeneutico del qerê-ketib, che consente all'orecchio umano di sentire ciò che
dovrebbe leggersi, e allo sguardo umano di leggere ciò che dovrebbe sentirsi.
«In quel versetto infatti (13, 15), Giobbe pronuncia due parole che significano simultaneamente la
speranza e la disperazione:
איחל לו
איחל לא
Spero in Lui, grida, ma anche:
Non spero, facendo di queste grida contraddittorie ma simultanee la matrice di un nuovo
mondo».102
5.10. L'ambiguità dell'alleanza
Giobbe non è, tuttavia, un martire del Silenzio per i maestri della tradizione ebraica, i quali trovano
questo martirio nell'emergenza silenziosa di un intervallo che c'è tra il primo e il secondo versetto
del capitolo XX del libro di Ezechiele. In questo brano alcuni anziani di Israele vanno a consultare
Dio che non si lascia interrogare da loro. Dopo tale affermazione troviamo un rigo bianco e poi
un'esclamazione di Dio, per bocca del profeta, che afferma che non lascerà vivere il suo popolo
come le altre genti, e regnerà su di lui con mano forte.103
Ciò che forse impensierisce gli interlocutori di Dio non è la fine dell'Alleanza, più volte minacciata,
ma le sue perpetue tergiversazioni di fronte alle quali si richiede da Dio una risposta schietta,
oggettiva e inequivocabile. A questa esigenza di tranquillità della coscienza Dio risponde con tutta
l'aggressività del silenzio e dell'ambiguità.104
Neher propone un'altra interpretazione che è quella del Rashi. Ciò che preoccupa gli interlocutori
del profeta è l'eccessiva luce dell'Alleanza; ciò che li stanca è proprio la responsabilità alla quale
sono chiamati davanti a tutti i popoli, il non aver alcun appoggio in un Dio. Quindi ciò che li spinge
a interpellarlo non è il desiderio di una sistemazione borghese, ma la nostalgia di un silenzio che
faccia da barriera tra il loro Io e il mondo, il loro Io e Dio che li ossessiona col suo comando.105
Ed è per questo che Dio li travolge con l'uragano di parole pronunciate dal profeta. Come Giobbe di
fronte all'uragano aveva imparato che non si può artificiosamente parlare davanti a Dio, così,
adesso, essi imparano che non si può artificiosamente tacere davanti a Dio.106
5.11. Hen lâ. Nonostante tutto. La fede ex nihilo
Ancora al Rashi dobbiamo l'ipotesi circa l'identità di quegli uomini. Sono Anania, Azaria e Misaele.
A Nabucodonosor, che vuole costringerli all'idolatria, hanno risposto di essere disposti a subire il
fuoco, sicuri che Dio li salverà. Ora sono venuti a consultare il profeta per essere rassicurati nelle
loro convinzioni. Dio risponde che non li salverà. Proprio loro che sono rimasti fedeli all'Alleanza,
subiscono l'ira riservata agli infedeli. Ebbene, anche se Dio li abbandonasse, essi sono disposti al
martirio.
«NONOSTANTE TUTTO, sappi o re, che noi non adoreremo il tuo! ».
«Questo nonostante tutto [...] . Hen lâ! Strana sfida della lingua ebraica che si prende gioco delle
contraddizioni e dei paradossi ed esegue con essi sorprendenti acrobazie [...]! Hen lâ, formula della
contraddizione, altro non è che la contiguità del sì e del no [...] . È dal di dentro del vuoto,
dall'interno dell'assenza, dal cuore del No che scaturisce il Sì: la fede è una genesi, appare ex nihilo!
».107
La fede e il martirio nascono dal silenzio, perché dovunque si presentasse la parola verrebbe meno
l'esposizione totale del martirio. «Martire è soltanto l'uomo che può ergersi davanti a Dio e lanciare
verso di lui il grido del midrash, con cui il versetto biblico della Presenza: chi è come te fra gli dei,
mî kamôkâ ba'elîm (Es 15, 11), è capovolto da cima a fondo per diventare il versetto dell'Assenza, il
versetto dell'uomo ritto davanti al Silenzio opprimente di Dio: mî kamôkâ ba'illemîm, chi è come te
tra i muti? ».108
L'in-assenza di Dio.
5.12. Qedôšê dummyyâ. I martiri del Silenzio
Costoro sono i martiri del Silenzio: gli uomini che vivono nella storia obbedendo a un comando che
sembra provenire dalla loro coscienza, come profezia, avendo avanti a sé un Dio che li lascia
camminare davanti a Lui, senza nessuna sicurezza, li lascia smarrire, perire. Costoro sono
testimoni della Trascendenza col loro «eccomi», con la loro responsabilità assoluta di fronte al
silenzio di Dio.
Essi camminano-avanti con tutto il dolore della speranza/non-speranza, sollevando a Dio un grido
che, nonostante la loro disperazione non può essere mai rottura dell'Alleanza ambigua, un grido
che rimane una delle possibilità del rapporto faccia a faccia con Dio.
Dopo aver incontrato Dio, l'uomo scende dal Sinai incontro alla storia. La terra è stata promessa,
ma non è assicurata una fine. L'uomo deve combattere con Dio le battaglie della storia, combattere
da solo le battaglie della responsabilità per realizzare l'Opera che solo a lui spetta compiere nel
Silenzio.
Note
1.
Neher A., L'esilio della parola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz, Maretti, Genova 1983 19972; d'ora
in poi citato Neher.
2.
Levinas E., Dieu, la Mort et le Temps¸édition Grasset et Fasquelle, Paris 1993, trad. it. di S. Petrosino e M.
Odorici, Dio, la Morte e il Tempo, Jaka Book, Milano 1996, p. 180; d'ora in poi citato DMT; ecco l'elenco delle
altre abbreviazioni: Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Nijhoff, La Haye 1974, trad. it. di M.T. Aiello e S.
Petrosino, Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, Jaka Book, Milano 1983: AE; De Dieu qui vient à l'idée,
Vrin, Paris 1982, trad. it. di G. Zennaro, Di Dio che viene all'idea, Jaka Book, Milano 1986: DQVI; E. Lévinas,
Éthique et Infini, Feyard, Paris 1982 ; trad. It. di E. Baccarini, Etica e Infinito, Città Nuova, Roma 1984: EI; Le
temps et l'autre, Fata Morgana, Montpellier 1979, trad. it. Di F. Ciglia, Il tempo e l'altro, Il Melangolo, Genova
1987: TA; Totalité et Infini, Nijhoff, La Haye 1961, trad. it. di A. Dell'Asta, Totalità e infinito, Jaka Book, Milano
1980 19902: TI.
3.
Cfr. Ibib., pp. 172-174.
4.
Ibid., pp. 174-175 passim.
5.
Cfr. ivi.
6.
DQVI, pp. 78-79 passim.
7.
Cfr. DMT, pp. 226-229.
8.
Cfr. Ibid. p. 231.
9.
Cfr. Ibid. p. 232.
10. Ibid. p. 58.
11. Cfr. Ibid. pp. 62-63.
12. DQVI p. 151.
13. Ph. Nemo, Giobbe e l'eccesso del male, Città Nuova, Assisi 1981.
14. Cfr. DQVI p. 155.
15. Ibid. p. 158.
16. Cfr. Ibid. p. 161.
17. Ibid. p 162.
18. Cfr. Neher, p. 140.
19. Cfr. Ibid. p. 142.
20. Ibid. p. 144.
21. Cfr. Ibid. pp. 145-146.
22. DMT pp. 190-191 passim.
23. «Questa responsabilità arriva fino alla fissione, fino alla de-nucleazione dell'io. E questa è la soggettività dell'io».
DMT p. 191.
24. Ibid. p. 224.
25. Cfr. Ibid. pp. 221-222.
26. Ibid. p. 235 passim.
27. AE p. 126.
28. DMT p. 237 passim; vedi anche AE pp. 127-128 passim.
29. Cfr. Ibid. p. 238.
30. Cfr. Ibid. pp. 241-242.
31. Ibid. pp. 242.
32. Ibid. p. 265 passim.
33. Ibid. p. 266 passim.
34. Cfr. TA p. 21.
35. EI p. 66.
36. Cfr. AE p. 204.
37. Ivi.
38. Ibid. p. 205.
39. Cfr. Neher pp. 70-71.
40. Cfr. Ibid. p. 72.
41. Cfr. Ibid. pp. 73-74.
42. Ibid. pp. 74-75.
43. Cfr. Ibid. p. 77.
44. Ibid. p.81.
45. Cfr. Ibid. pp. 84-86.
46. Cfr. Ibid. p. 90.
47. Cfr. Ibid. pp. 91-92.
48. Cfr. Ibid. pp. 96-97.
49. Ibid. p. 99.
50. Cfr. DQVI p. 97.
51. Cfr. Ivi.
52. Cfr. AE pp. 58-59.
53. Ibid. p. 61.
54. Cfr. Ibid. pp. 62-63.
55. Cfr. Ibid. pp. 63-64.
56. Crf. DMT pp. 262-263.
57. AE p. 166.
58. Crf. Ibid. pp. 169-170.
59. Crf. Ibid. p. 171.
60. Crf. Ibid. p. 173.
61. Cfr. DMT p. 223.
62. Crf. AE p. 175.
63. Cfr.Ibid. pp. 175-176.
64. Ibid. p. 176.
65. Cfr. TI pp. 91-96.
66. Cfr. Ibid. p. 96.
67. Ibid. p. 98 passim.
68. Cfr. AE p 180 nota 8.
69. Cfr. Ibid. p. 181.
70. Cfr. Ibid. p. 182.
71. Ibid. 184.
72. Crf. DMT p. 274.
73. AE pp. 186-187.
74. Ibid. p. 187; vedi anche DMT p. 274.
75. Crf. Neher p. 103.
76. Cfr. Ibid. p. 105.
77. Cfr. Ibid. p. 115.
78. Ibid. p. 122.
79. Ibid. p. 123 passim.
80. Cfr. Ibid. pp. 127-128.
81. Crf. Ibid. pp. 128-129.
82. Ibid. pp. 129-130.
83. Cfr. Ibid. pp. 131-132.
84. Cfr. Ibid. p. 134.
85. AE p. 187.
86. Cfr. Ibid. p. 191.
87. Cfr. Ibid. pp. 192-193.
88. Ibid. p. 193.
89. Cfr. Ibid. pp. 195-196.
90. Cfr. Ibid. p. 198.
91. Cfr. Ibid. pp. 202-203.
92. Cfr. neher pp. 156.
93. Cfr. Ibid. pp. 156-157.
94. Ibid. p. 160.
95. Crf. Ibid. pp. 168-176.
96. Ibid. p. 178 passim.
97. Crf. Ibid. p. 179.
98. Cfr. Ibid. p. 180.
99. Cfr. Ibid. p. 186.
100. Cfr. Ibid. p. 190.
101. Cfr. Ibid. pp. 203-205.
102. Ibid. p. 209.
103. Cfr. Ibid. pp. 212-213.
104. Cfr. Ivi.
105. Cfr. Ibid. pp. 215-216.
106. Cfr. Ibid. p. 217.
107. Ibid. pp 218-219 passim.
108. Ibid. pp. 219-220.