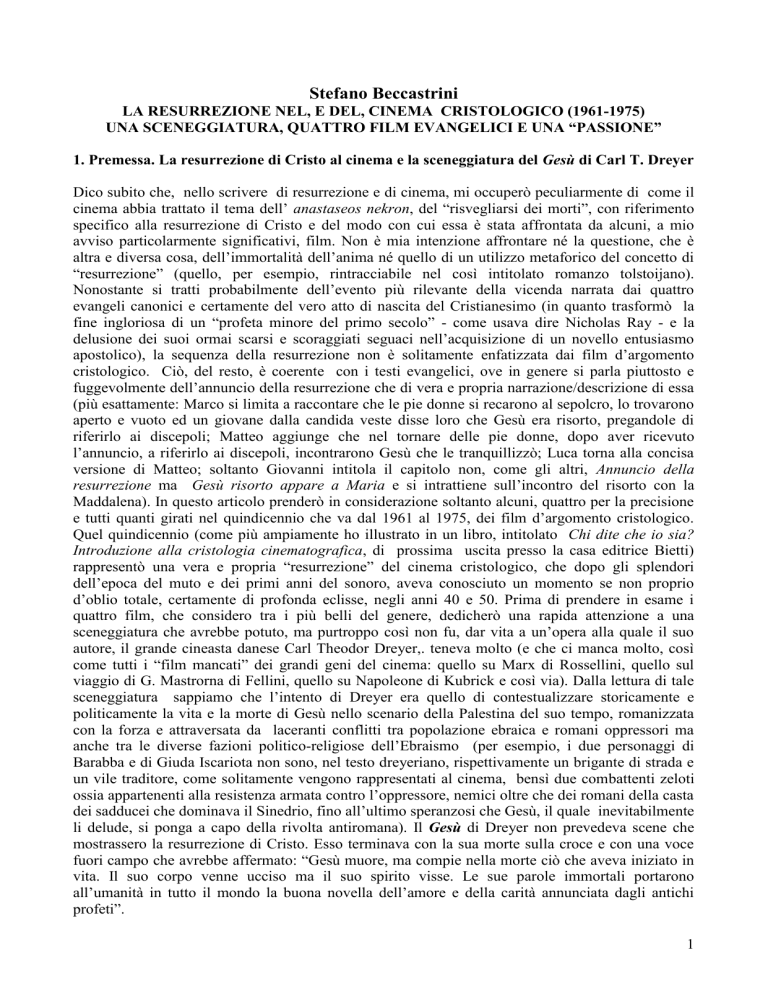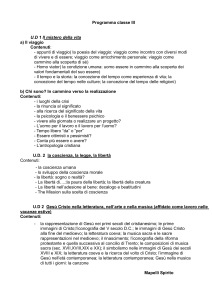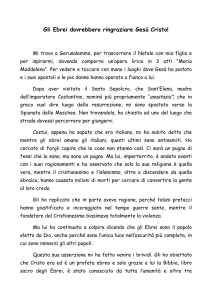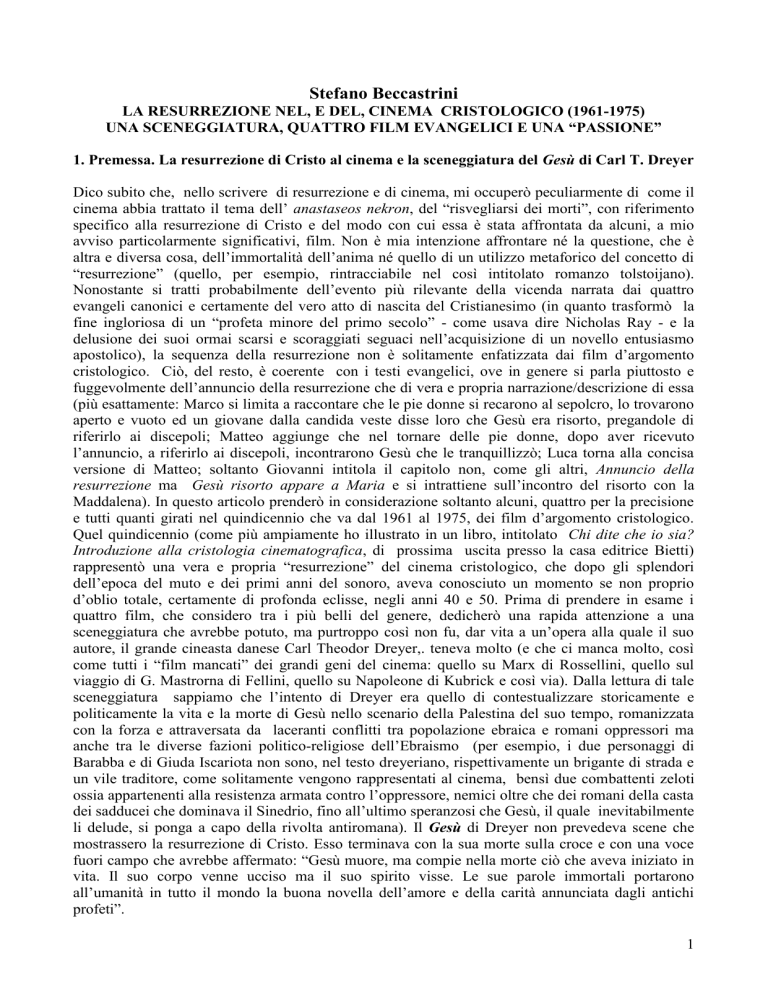
Stefano Beccastrini
LA RESURREZIONE NEL, E DEL, CINEMA CRISTOLOGICO (1961-1975)
UNA SCENEGGIATURA, QUATTRO FILM EVANGELICI E UNA “PASSIONE”
1. Premessa. La resurrezione di Cristo al cinema e la sceneggiatura del Gesù di Carl T. Dreyer
Dico subito che, nello scrivere di resurrezione e di cinema, mi occuperò peculiarmente di come il
cinema abbia trattato il tema dell’ anastaseos nekron, del “risvegliarsi dei morti”, con riferimento
specifico alla resurrezione di Cristo e del modo con cui essa è stata affrontata da alcuni, a mio
avviso particolarmente significativi, film. Non è mia intenzione affrontare né la questione, che è
altra e diversa cosa, dell’immortalità dell’anima né quello di un utilizzo metaforico del concetto di
“resurrezione” (quello, per esempio, rintracciabile nel così intitolato romanzo tolstoijano).
Nonostante si tratti probabilmente dell’evento più rilevante della vicenda narrata dai quattro
evangeli canonici e certamente del vero atto di nascita del Cristianesimo (in quanto trasformò la
fine ingloriosa di un “profeta minore del primo secolo” - come usava dire Nicholas Ray - e la
delusione dei suoi ormai scarsi e scoraggiati seguaci nell’acquisizione di un novello entusiasmo
apostolico), la sequenza della resurrezione non è solitamente enfatizzata dai film d’argomento
cristologico. Ciò, del resto, è coerente con i testi evangelici, ove in genere si parla piuttosto e
fuggevolmente dell’annuncio della resurrezione che di vera e propria narrazione/descrizione di essa
(più esattamente: Marco si limita a raccontare che le pie donne si recarono al sepolcro, lo trovarono
aperto e vuoto ed un giovane dalla candida veste disse loro che Gesù era risorto, pregandole di
riferirlo ai discepoli; Matteo aggiunge che nel tornare delle pie donne, dopo aver ricevuto
l’annuncio, a riferirlo ai discepoli, incontrarono Gesù che le tranquillizzò; Luca torna alla concisa
versione di Matteo; soltanto Giovanni intitola il capitolo non, come gli altri, Annuncio della
resurrezione ma Gesù risorto appare a Maria e si intrattiene sull’incontro del risorto con la
Maddalena). In questo articolo prenderò in considerazione soltanto alcuni, quattro per la precisione
e tutti quanti girati nel quindicennio che va dal 1961 al 1975, dei film d’argomento cristologico.
Quel quindicennio (come più ampiamente ho illustrato in un libro, intitolato Chi dite che io sia?
Introduzione alla cristologia cinematografica, di prossima uscita presso la casa editrice Bietti)
rappresentò una vera e propria “resurrezione” del cinema cristologico, che dopo gli splendori
dell’epoca del muto e dei primi anni del sonoro, aveva conosciuto un momento se non proprio
d’oblio totale, certamente di profonda eclisse, negli anni 40 e 50. Prima di prendere in esame i
quattro film, che considero tra i più belli del genere, dedicherò una rapida attenzione a una
sceneggiatura che avrebbe potuto, ma purtroppo così non fu, dar vita a un’opera alla quale il suo
autore, il grande cineasta danese Carl Theodor Dreyer,. teneva molto (e che ci manca molto, così
come tutti i “film mancati” dei grandi geni del cinema: quello su Marx di Rossellini, quello sul
viaggio di G. Mastrorna di Fellini, quello su Napoleone di Kubrick e così via). Dalla lettura di tale
sceneggiatura sappiamo che l’intento di Dreyer era quello di contestualizzare storicamente e
politicamente la vita e la morte di Gesù nello scenario della Palestina del suo tempo, romanizzata
con la forza e attraversata da laceranti conflitti tra popolazione ebraica e romani oppressori ma
anche tra le diverse fazioni politico-religiose dell’Ebraismo (per esempio, i due personaggi di
Barabba e di Giuda Iscariota non sono, nel testo dreyeriano, rispettivamente un brigante di strada e
un vile traditore, come solitamente vengono rappresentati al cinema, bensì due combattenti zeloti
ossia appartenenti alla resistenza armata contro l’oppressore, nemici oltre che dei romani della casta
dei sadducei che dominava il Sinedrio, fino all’ultimo speranzosi che Gesù, il quale inevitabilmente
li delude, si ponga a capo della rivolta antiromana). Il Gesù di Dreyer non prevedeva scene che
mostrassero la resurrezione di Cristo. Esso terminava con la sua morte sulla croce e con una voce
fuori campo che avrebbe affermato: “Gesù muore, ma compie nella morte ciò che aveva iniziato in
vita. Il suo corpo venne ucciso ma il suo spirito visse. Le sue parole immortali portarono
all’umanità in tutto il mondo la buona novella dell’amore e della carità annunciata dagli antichi
profeti”.
1
2. Gesù, il Poeta dello Spirito, e Il re dei re, 1961, di Nicholas Ray
Il film Il re dei re, 1961, di Nicholas Ray fu quello che aprì la moderna rinascita (una vera e propria
“resurrezione”, verrebbe da dire) del cinema cristologico avvenuta negli anni 60 e 70 e Settanta del
900, non a caso in coincidenza con il Concilio Vaticano II e i suoi primi effetti sulla comunità
cristiana e sulla società in generale. Uno dei non pochi pregi del film fu, così come avrebbe voluto
Dreyer, di inquadrare la vicenda di Gesù sullo sfondo politico e sociale della Palestina del tempo:
travagliata da molte lacerazioni politiche e religiose nonché dall’opprimente occupazione militare
romana (non saprei dire, in assenza di qualunque fonte informativa in merito, se Ray conoscesse le
intenzioni e le riflessioni di Dreyer sull’argomento). Ma perché Ray volle fare un film su Cristo?
Personalmente sono convinto che, come del resto nel caso di altri profondi e originali film
cristologici quali quello di Pier Paolo Pasolini e quello di Roberto Rossellini, non sia da
sottovalutare la motivazione autobiografica, il considerarsi in qualche modo una Figura Christi..
Ray fu certamente un ribelle, un uomo alieno da ogni forma di potere e di arroganza sociale; spesso
perseguitato per il suo anticonformismo; appassionato educatore di giovani (per esempio,
insegnando cinema a tanti futuri cineasti). In fondo, come il Cristo del suo film. Il senso di esso è
di mostrare non tanto, aldilà del titolo imposto dalla produzione, il mito del Re dei Re quanto
piuttosto la vicenda terrena di un umile profeta, tutto sommato con scarso seguito, della Palestina
romanizzata. Il Gesù di Ray è davvero, per citare il teologo John P. Meier, un “ebreo marginale”
che, nel suo pretendere di farsi profeta in una Palestina che ormai di profeti era alquanto povera pur
avendone molto bisogno, fu osteggiato dalla casta sacerdotale, suscitò qualche speranza di alleanza
da parte dei ribelli armati al potere romano ma fu poi da loro disconosciuto e considerato quasi un
traditore, venne alfine crocifisso dai romani per decisione di un governatore imperiale che aveva
intuito la portata sovversiva seppur pacifica del messaggio di quel giovinastro che gli parlava,
durante il colloquio/processo intrattenuto con lui, d’una incomprensibile e come tale pericolosa
Verità. Il film è caratterizzato da uno splendore formale, ingigantito dal Technirama e reso saturo di
colore da uno sfolgorante Technicolor, degno della grande pittura seicentesca di Vermeer e di
Poussin. Raggiunge il proprio culmine nell’episodio del Discorso della montagna, altrettanto
suggestivo ma profondamente diverso - più laico, verrebbe da dire, ossia meno solenne e sacrale –
rispetto a quello, bellissimo nel suo bianco e nero, de Il vangelo secondo Matteo, 1964, di Pier
Paolo Pasolini. Nel film di Pasolini, Cristo lo pronuncia per gli spettatori di tutto il mondo, non per
i personaggi ebraici in scena. .Egli è sempre filmato in primo piano, non si rivolge a nessuno che gli
stia dattorno, pronuncia le sue pacifiche ma tremende frasi da un luogo e un tempo astratti, ora di
giorno ora di notte, ora nel sole ora nel vento. Il Cristo di Ray, invece, parla in un luogo e in un
tempo ben determinati, si rivolge al pubblico dei personaggi – e delle tante comparse – che
appaiono nel film, scende a dialogare con quanti gli stanno dattorno.. L’aspetto più profondo del
film, tuttavia, resta il fatto che Ray sceglie, quale simbolo della figura di Gesù e del valore del suo
messaggio, la croce. Ciò si mostra esemplarmente nel finale del film. stesso quando, ormai risorto
(ma la scena delle resurrezione è, in sé e per sé, alquanto sbrigativamente mostrata) egli raggiunge
per un ultimo e istruttivo saluto i propri discepoli, radunati sul litorale del mare di Galilea (o lago di
Tiberiade che dir si voglia). Saranno proprio loro, poveri ignoranti diventati portatori d’un
messaggio di salvezza per il mondo, a portare la forza della croce nel mondo stesso. L’ombra di
Cristo, resa lunghissima dalla luce radente del tramonto, proiettata sulla sabbia dal sole calante, va a
formare appunto una croce intersecando verticalmente la rete, posta orizzontalmente, che i discepoli
hanno steso sulla spiaggia. Nella filmica cristologia di Nicholas Ray è la croce che fa del profeta
minore del primo secolo un maestro di vita per tutti gli uomini della Terra e che farà dell’ebreo
marginale Gesù il punto di riferimento di una rivoluzione spirituale di carattere universale. Gesù ha
cessato d’essere un profeta minore nel momento in cui è stato crocifisso. E’ diventato, come fu Ray,
un Poeta dello spirito. La sua croce è come quella che sempre porteranno quanti rifiutano il
conformismo, le regole ipocrite d’una società ingiusta, la sofferenza socialmente ineguale
dell’umanità.
2
3. Gesù, il Figlio dell’uomo, e Il vangelo secondo Matteo, 1964, di Pier Paolo Pasolini
Nel suo Ateismo nel cristianesimo, Ernst Bloch ha valorizzato, facendo notare come sia stata la più
usata da Gesù nel definire se stesso, l’espressione Figlio dell’uomo Essa è di derivazione biblica e
compare soprattutto nel libro di Ezechiele, rappresentando il modo con cui Dio chiama il proprio
profeta. Il fatto che ricompaia nel Nuovo Testamento tende a istituire un legame profondo tra
l’esperienza evangelica e quella profetica. L’espressione sottolinea l’umanità di Cristo, il suo
essere, anche, uomo tra gli uomini, figlio d’una madre terrena, persona fatta di carne e sangue e
dunque capace di comprendere e anzi personalmente provare la voglia di riscatto che gli ingiusti
dolori del mondo suscitano negli esseri umani. Questo Gesù, che inverte i valori del mondo presente
e preannuncia un altro mondo senza oppressione, è proprio quello de Il vangelo secondo Matteo,
1964, di Pier Paolo Pasolini. La spinta a girare un film evangelico, Pasolini la ricevette durante un
soggiorno ad Assisi: “E’ un’opera di poesia che voglio fare. Non un’opera religiosa nel senso
corrente del termine…Io non credo che Cristo sia figlio di Dio, perché non sono credente, almeno
nella coscienza. Ma credo che Cristo sia divino: cioè che in lui l’umanità sia così alta, rigorosa,
ideale da andare al di là dei comuni termini dell’umanità…”. Ma perché, nel suo rileggere i
Vangeli in quel di Assisi e nel suo invogliarsi a trarne un film, scelse quale fonte di diretta
ispirazione il testo di Matteo? Perché è il Vangelo del Discorso della montagna, quello delle
Beatitudini, quello della valorizzazione e del riscatto dei “poveri di spirito”. Nel film, risulta
evidente il ruolo centrale che tale Discorso svolge sullo schermo: Pasolini l’ha enfatizzato fino a
farlo durare oltre il tempo quotidiano, oltre le perturbazioni atmosferiche, oltre il passare del giorno
e della notte, della luce e dei venti. Il Cristo pasoliniano predica infatti, solo e solenne sulla
montagna, col sole e con la luna, con la tempesta e con la calma meridiana, così che sembra parlare
per ore, per giorni, per sempre: in quanto proponente un messaggio metastorico che resta vivo e
attuale nella storia, quello del risarcimento degli oppressi e dei diseredati, della sofferenza di quanti
– la gran parte dell’umanità, in passato e tutt’oggi – hanno avuto sete e fame di giustizia non
ricevendo da nessuno né acqua né cibo né tanto meno giustizia. Nonostante che il film cristologico
di Pasolini venga, nei manuali di storia del cinema, presentato come l’opera cinematograficamente
più demitizzante e de-divinizzante il personaggio, credo che tale interpretazione non corrisponda né
alla “lettera” del film medesimo (uno dei più solenni e sacrali che il cinema del 900 abbia dedicato
alle vicende evangeliche) né alle espresse intenzionalità del suo autore. Pasolini non vuole affatto
demitizzare la storia di Cristo (lo vorrà invece, una decina di anni dopo, Rossellini col suo Il
Messia). Pasolini accetta pienamente, nell’avvicinarsi al testo evangelico, la dimensione mitica,
sublime, del suo protagonista, che raffigura nella sua rappresentazione più solennemente
progressiva, poeticamente rivoluzionaria, artisticamente escatologica . C’ è dunque, a monte di tali
scelte, una precisa intenzione di veicolare, col film, un messaggio profondamente lirico (tale è, in
fondo, l’approccio cristologico di Pasolini, tragicamente commosso dalla figura di Gesù, giungendo
a identificarsi con essa) e a un tempo politico (i segni di tale spessore politico del film sono tanti e
diffusi in ogni suo episodio: da quello – quasi mai portato sullo schermo - dell’incontro di Gesù col
ricco giovane che chiede cosa fare per poter accedere al Regno e si sente rispondere che è più facile
che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco vada in Paradiso, a quella della strage
degli innocenti, che mostra i turpi sicari di Erode addobbati da fez fascisti). Tale intento liricopolitico pasoliniano .è ben esemplificato dalle conclusioni del film. Dopo la scena della
resurrezione (che si attiene alla lettera del testo evangelico e, in tal caso, più nella versione di Marco
che di quella di Matteo: un boato scoperchia il sepolcro, le pie donne lo vedono vuoto, un angelo
annunzia loro che Cristo è risorto), la sequenza finale non mostra affatto il ritorno di Gesù in
Galilea, per dare le ultime istruzioni ai propri discepoli (come avviene nel film di Ray), bensì Gesù
risorto che, in un luogo aldilà di ogni precisa connotazione spazio-temporale, accoglie a sé una
torma di persone – di povera gente, di sfruttati, di lavoratori, di donne e di bambini – che accorrono
a lui, in cerca di pace, di giustizia, di salvezza.
3
4. Gesù, il Cristo cosmico, e La più grande storia mai raccontata, 1965, di George Stevens
George Stevens, negli anni 30, fu autore di commedie brillanti e musical molto allegri. Poi, dopo lo
sbarco in Normandia, comandò una troupe di militari/cineasti con il compito di documentare
l’avanzata alleata su Berlino. Così, ebbe a filmare per primo l’orrore dei campi di sterminio nazisti:
entrò infatti a Dachau il 29 aprile 1945 (le sue immagini furono utilizzate quale prova a carico al
processo di Norimberga). Dopo, il suo cinema cambiò, si fece cupo e affascinato dal tema della
morte. Da ciò prese origine anche La più grande storia mai raccontata, 1965, il suo maestoso film
cristologico. Inizia con le parole d’apertura del Vangelo di Giovanni, pronunciate sullo sfondo del
cielo stellato: “In principio era il Verbo…”. Esse dichiarano subito che, nel film, il riferimento al
testo giovanneo resterà preminente ispirativo. C’è un episodio che, soprattutto, lo dimostra: quello
della resurrezione di Lazzaro, l’unico (o quasi: i tre vangeli sinottici parlano anche della
resurrezione della figlia di Jairo e il solo vangelo di Luca di quella del figlio della vedova) atto
prodigioso di Gesù che non riguardi soltanto le sue doti di taumaturgiche bensì anche quella di
vincere la Morte, di annullarne la fatalità, l’universalità, l’irreversibilità. Si tratta di un episodio
narrato dal solo testo giovanneo. Nel caso del figlio di Giairo e del figlio della vedova di Nain, i due
giovani ammalati erano morti proprio mentre Gesù di recava da loro per guarirli: l’intervento
risvegliatore si configurava quindi come un proseguimento, appena oltre la soglia della morte, della
sua attività di taumaturgo e non suscitarono particolari reazioni, se non quelle di confermare la
crescente fama di guaritore del Cristo, nella folla. Tutt’altro ruolo gioca, in Giovanni, la narrazione
della resurrezione di Lazzaro: essa è il culmine dell’azione pubblica di Gesù in quanto rappresenta
il momento in cui egli prefigura la propria morte e resurrezione, dimostrando di essere il Signore
della Morte. Giovanni, studiatamente, non riporta notizia alcuna degli altri due risuscitamenti: essi
avrebbero attenuato l’eccezionalità della vicenda concernente Lazzaro. Trovandosi quest’ultimo,
suo amico, gravemente ammalato, le sorelle Marta e Maria avevano mandato messaggeri per
pregare Gesù di accorrere al suo capezzale. Egli, tuttavia, aveva preso tempo, aveva lasciato che
Lazzaro morisse, si era recato a Betania quand’egli era già sepolto da vari giorni. Gesù, nel testo
giovanneo, sa che è venuto il momento di dare un segno solenne, che meni stupore e scandalo, che
sia di ammonimento per tutti quanti dubitino di lui ma anche di spinta ad accrescere la loro ostilità
nei suoi confronti. Prega quindi le due sorelle di condurlo al sepolcro e colà ordina al cadavere di
uscirne: “Lazzaro, vieni fuori”.. Soltanto così, richiamando alla vita un corpo morto ormai da vari
giorni, si afferma pienamente come il Signore della vita e della morte e, nella resurrezione
dell’amico, prefigura la propria, che verrà di lì a poco. In tal senso, nella narrazione giovannea, il
miracoloso evento di Betania costituisce la svolta cruciale nel destino di Gesù ed è proprio a seguito
di esso che si mette in moto quella trama ai suoi danni che lo condurrà sul Calvario. Così come nel
vangelo di Giovanni, la prodigiosa vicenda della resurrezione di Lazzaro acquista in La più grande
storia mai raccontata (ben oltre la scena della resurrezione dello stesso Gesù, comunque ispirata
anch’essa alla narrazione giovannea) un eccezionale significato e un particolare rilievo. La
sequenza, davvero emozionante, è filmata, e dunque anche vista dallo spettatore, da lontano e in
una situazione di crescente tensione, quale fosse la soggettiva di un umile ebreo, Bar Amand. Anche
noi spettatori la vediamo, appunto, con i suoi occhi sempre più spaventati e poi stupiti, da lontano e
con tensione crescente. La scena dura a lungo, è sapientemente costruita, raggiunge un acme
drammaturgico solenne (poi sciogliendosi nell’Hallelujah di Haendel). Stevens sa rendere lo
spettatore partecipe dell’evento ma appunto da lontano – come certamente sarebbe stata, rispetto
alla tomba di Lazzaro e a Gesù, la gente di Betania accorsa verso il cimitero della cittadina - ma al
tempo stesso sa fargliene cogliere l’assoluta straordinarietà, la totale impensabilità, la tremenda
eccezionalità. Per vari minuti, noi che vediamo il film ci identifichiamo in Ben Amand, come lui
tratteniamo il respiro, come lui abbiamo paura e curiosità a un tempo, come lui assistiamo a un
prodigio mai verificatosi nella storia del mondo, come lui siamo spinti alfine a liberarci della
tensione accumulata correndo a gridare al mondo ciò che abbiamo visto.
4
5. Gesù, il Rabbi, e Il messia, 1974, di Roberto Rossellini
Piero Martinetti scrisse nel suo Il Vangelo “…un mistico tedesco ha scritto un libro che ha per
titolo ‘Il Cristo ignoto’. Per quanto strano ciò possa parere, bisogna con lui convenire che la
maggior parte dei cristiani non conosce affatto Gesù Cristo…” Tale constatazione si pone a
fondamento del film su Gesù di Roberto Rossellini, quel Il Messia che per un verso entrava
pienamente a far parte del grandioso programma rosselliniano di educazione permanente tramite gli
audiovisivi e per l’altro, dato il cruciale rilievo del personaggio alfine affrontato, acquistava,
all’interno della filmografia rosselliniana, una collocazione speciale, più intensamente sentita.
Rossellini considerava, infatti, questo film quale il suo più caro. In esso, si era posto di fronte alla
figura di Cristo in maniera, in fondo, alquanto diversa da quella di tutti i cineasti che avevano prima
di lui affrontato il tema cristologico. Pur proclamandosi non credente, egli era convinto che “…non
c’è messaggio più necessario e più attuale di quello dei Vangeli…” Secondo lui, Gesù era stato
ucciso perché insegnava agli uomini a pensare con la propria testa, dando loro dignità etica e
intellettuale qualunque fosse la loro collocazione nella scala socialmente gerarchica. Non a caso, il
“rabbi” Rossellini decise di portare sullo schermo, unico tra i cineasti e dandogli un particolare
risalto, l’episodio - narrato dal solo vangelo di Luca, - di Gesù che, ragazzino, viene perduto dai
propri genitori, recatisi in pellegrinaggio a Gerusalemme, e ritrovato poi, nel Tempio, a discutere
con i dottori circa le interpretazioni della Bibbia. Quel ragazzino rappresenta già il futuro educatore
di adulti liberi e non assoggettabili dal sapere/potere costituito. Il messaggio centrale di tale suo
impegno educativo è la non necessità del potere, il fatto che gli uomini possono vivere anche senza
le sue costruzioni e costrizioni, le sue bardature istituzionali, le sue strutture di oppressione e
soggezione. Ciò è mostrato chiaramente nel Prologo del film, liberamente tratto dall’Antico
Testamento. In esso viene illustrato come, desiderosi d’avere un re come tutte le altre nazioni, anche
gli ebrei trasferirono il potere sui propri destini, fin dai tempi dell’Esodo gestiti dalla comunità nel
suo insieme e legati a deliberazioni collettive, ad un re. Così facendo, rinunciarono alla loro
peculiarità di popolo asservito soltanto a Dio. Da quella delega, vennero ad Israele potenza ma
anche disgrazia, forza ma anche nostalgia del passato. Anche da ciò nacque, molti anni e molto
sangue versato dopo, l’utopia, presto diventata eresia, di Gesù. Il film di Rossellini si ispira a tutti e
quattro i vangeli canonici ma in particolare a quello di Marco, il vangelo del “segreto messianico”.
Di tale testo, ove pure svolgono un ruolo rilevante, Rossellini espunge peraltro quasi tutti i miracoli,
salvando soltanto quelli, come la pesca miracolosa o la distribuzione dei pani e dei pesci, ove
prevale la componente simbolica dell’equità distributiva e della condivisione comunitaria delle
risorse. Ciò che connota poeticamente la versione rosselliniana della vita di Gesù sono altre due
scelte narrative assai significative: quella di mostrare quella raccoltasi dattorno a lui come una
comunità di giovani e pacifici “comunisti primitivi” (capaci, cioè, di condividere riflessioni, gioie,
sofferenze, decisioni, cibo, lavoro) e quella dell’ispirazione mariologica. Ci soffermeremo soltanto
su quest’ultimo aspetto. La sua dolce, sempre giovanissima Madonna, ricorda quella della Pietà di
Michelangelo in San Pietro, più adolescenzialmente toccante del defunto figlio che tiene in grembo.
Coerente con l’assunto di non mostrare fatti miracolosi, Rossellini non mostra neppure la
resurrezione di Gesù. La scena finale, infatti, mostra il sepolcro vuoto, Maria che corre verso di esso
e poi, col volto alfine rasserenato dopo tanto pianto, alza gli occhi verso il cielo azzurro, ove vanno
lentamente navigando alcune candide nuvole. Ancora una volta, come in altri momenti del film, è
dal volto dolcissimo di Maria che Rossellini fa esprimere ciò che sta accadendo a Gesù. In tal caso,
il suo non essere più morto, almeno per l’amore di sua madre, almeno per la crescita e la libertà dei
suoi discepoli, almeno per quelle nuvole vaganti nel cielo azzurro. Rossellini, insomma, non filma
direttamente la resurrezione di Cristo né lo filma mentre, risorto, torna a mostrarsi ai propri seguaci,
dando loro nuove ed estreme istruzioni. Il film si chiude, invece, sul tenero sguardo rivolto al cielo
di Maria, consapevole che suo figlio vive ancora, con loro e per loro. Scelta originalissima, diversa
da quella di tutti i film cristologici precedenti.
5
6. La scena della resurrezione ne La passione di Mel Gibson. Conclusioni
A differenza degli altri quattro film, più il quinto ma mai realizzato di Dreyer, di cui abbiamo
parlato sinora, La passione di Cristo, 2004, di Mel Gibson non è dedicato all’intera vicenda di
Cristo ma alle vicende dei suoi ultimi giorni di vita, dall’arresto alla flagellazione, dalla
crocifissione alla morte e, appunto, alla resurrezione. Qual è il senso cristologico che Gibson ha
voluto assegnare a questo suo film? Partiamo, per capirlo, dalle sue fonti ispirative. Esse sono
soltanto assai superficialmente i vangeli: più in profondità, sono le visioni della tedesca Anna
Katharine Emmerick, proclamata nel 2004 beata da Giovanni Paolo II, in non casuale fratellanza
con la proclamazione a beato di Padre Pio e di altri santi veggenti, stimmatizzati e orientanti a un
cristianesimo piuttosto mitico-mistico che conciliare. Varie visioni della Emmerick, per esempio
quella della passione di Cristo, furono trascritte dal poeta romantico Clemens Brentano e ad essi è
esplicitamente ispirato il film di Gibson. In tali testi, e non nei Vangeli che all’episodio dedicano
poche pagine,, egli ha per esempio trovato l’interminabile, minuziosa, macabra descrizione della
flagellazione. Il messaggio cristologico del film credo sia, ancorché per me negativamente
inquietante, piuttosto forte e si riveli appieno nel finale, dopo che il povero corpo sadicamente
martoriato del Cristo viene deposto dalla croce, lavato e pulito, condotto nel sepolcro rivestito da un
candido panno. A questo punto, noi spettatori - ultimi testimoni di quel che accade, essendo finiti
fuori scena tutti i personaggi - - siamo fatti penetrare dalla macchina da presa dentro l’antro oscuro
della tomba e assistiamo al momento in cui il lenzuolo funebre, prima rigonfio del corpo defunto di
Gesù, si affloscia. Vediamo dunque, per pochi ma intensi istanti, illuminato di scorcio, un Dio bello
come un atleta greco il quale silenziosamente, e sdegnosamente, esce di scena. La sequenza è molto
suggestiva però esprime la totale estraneità di Gesù, una volta risorto, nei confronti dell’umanità,
rea di averlo torturato e ammazzato. Nessun precedente film su Gesù era terminato così duramente:
tutti, seppur in maniera assai differente tra loro, avevano rappresentato (salvo Rossellini, ma per
tutt’altri motivi e intenti) un Gesù redivivo e tornato, seppure per breve tempo, tra noi. Nulla di ciò
nel film di Gibson: a oltre due ore di offese sanguinariamente crudeli, Cristo risorto risponde con
mezzo minuto di splendida resurrezione e di sdegnoso allontanamento dal mondo ossia dal film, dai
suoi personaggi, dagli spettatori. Ho trovato terribile - bella ma, proprio in quanto tale, tremenda questa scena, che racchiude in sé anche il desolante messaggio cristologico del film.
.
6