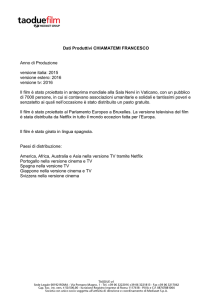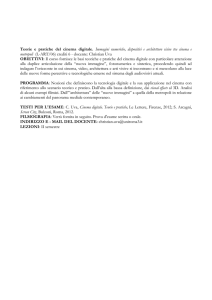Stefano Beccastrini
MAPPE DELL’UMANO DOLORE
LA GEOGRAFIA DELLA MEMORIA OFFESA
NEL CINEMA DI LUIGI FACCINI
La memoria è un elemento perturbante nel flusso della vita,
insidia i contorni di ciò che vediamo
confondendoli con i ricordi di quel che abbiamo già visto,
mescola le emozioni del presente con quelle trascorse.
Eppure, in questa contesa estenuante,
la memoria cerca di tenere insieme
i diversi volti del nostro racconto nel tempo
Antonella Tarpino, “Geografia della memoria”
INTRODUZIONE. ALLA RICERCA DELLA MEMORIA OFFESA
Non so se l’arte cinematografica abbia una propria, specifica Musa e, nel caso, se anch’ella sia,
come tutte le altre, figlia di Mnemosine, dea del ricordo o meglio della memoria (che non è il
semplice ricordo bensì la sua ricerca attiva e la sua conservazione amorosa, per così dire
celebrativa). Quel che so, per certo, è che una simile Musa ce l’ha, quale sua sapiente ispiratrice, il
cinema di Luigi Faccini: tutti o quasi i suoi film sono, infatti, dedicati a luoghi o situazioni ove
persiste il ricordo del dolore umano, sono percorsi di ricerca sulle tracce dell’umana sofferenza (e
dell’umano lavoro, e dell’umana dignità spesso offesa), sono insomma esplorazioni (egli, non a
caso, si autodefinisce “esperto di ricerca umana, soprattutto nelle…sue…implicazioni storicoantropologiche”) d’una geografia della memoria ferita, da riscattare e redimere o almeno da
ritrovare e conservare contro l’incuria del tempo e della sempre colpevole smemoratezza umana, da
mantenere viva dentro di noi, da celebrare e tramandare alle generazioni future. Nel suo insieme, i
film di Luigi Faccini disegnano una vera e propria mappa (“A volte una mappa parla usando i
termini della geografia fisica ma in altrettante occasioni indugia sul terreno sconnesso del cuore, i
distanti panorami della memoria, i fantastici paesaggi dei sogni” ha scritto il cartografo americano
Miles Harvey) della vita “faticosa, straziata dai lutti, sempre generosa” (sono parole di Marina
Piperno, compagna di vita di Faccini e produttrice dei suoi film, riferite alle donne di Le mani
raccontano. Donne del levante ligure fra passato e presente, 2007, ma riferibili a tutti i personaggi
e i testimoni facciniani) dei vinti, dei senza potere, dei non riconciliati. La memoria non è ciò che
resta, nel nostro ricordo, del nostro e dell’altrui passato, ciò che residua dopo l’attivo lavoro
dell’oblio. Anche la memoria è lavoro attivo: essa non è, appunto, il semplice ricordare ma la sua
ricerca intenzionale, il mettersi sulle sue tracce, il rivisitare testardamente i luoghi ov’esso si è
formato ma rischia continuamente di cancellarsi, anzi di essere cancellato. Il cinema di Lugi Faccini
è tutto quanto votato alla missione di questa ricerca, al percorso su queste tracce, all’esplorazione di
una geografia, fatta di luoghi e persone, dell’umanità offesa. Quello che, all’ inizio degli anni 70,
avrebbe potuto essere il suo primo film, tuttavia mai realizzato perché l’idea non piacque alla RAI
cui era stata proposta, si presentava già come un viaggio alla ricerca del tempo perduto. Narra lo
1
stesso Faccini: “Il borgo marinaro che avevo lasciato da bambino…mi frugava il cuore
insistentemente. I vecchi della mia infanzia morivano. La lontananza mi impediva persino il pianto.
Immaginai così di sprofondare nel mio borgo perduto, compiendo un viaggio per mare, fantastico,
in compagnia d’un vecchio cugino, maestro d’ascia, che mi aveva insegnato ogni segreto di baie,
scogliere e anfratti. Era molto in là con gli anni e presto se ne sarebbe andato. Desiderai che la sua
bara fosse a forma di barca”. Come si vede, la spinta proustiana a utilizzare l’arte (in tal caso il
cinema invece della letteratura) per far rivive e celebrare il passato si connota più esplicitamente e
radicalmente come viaggio nella memoria storica e collettiva degli oppressi, come meditazione
sulla morte, come solenne tentativo di mantenere vivo il ricordo di personaggi i quali, a differenza
di quelli proustiani, non appartengono all’alta società e al gran mondo bensì agli strati umili della
società, al piccolo mondo del lavoro, dello sfruttamento, dell’operosità intelligente ma sconosciuta
(il vecchio cugino era un maestro d’ascia, un lavoro manuale che va scomparendo, e gli aveva
insegnato una competenza che, probabilmente, anch’essa va scomparendo in un mare di chiacchiere
turisticheggianti ossia l’arte di conoscere davvero baie, scogliere e anfratti). Luigi Faccini, col suo
cinema di ricerca, di investigazione, di recupero della memoria per conservarla e riscattarla, col suo
costante interesse ai soggetti antichi e nuovi della società italiana, così alieno e così lontano dai
moduli tradizionali, vincenti, sempre più impoveriti del cinema italiano dei tempi nostri, continua la
sua escavazione nella memoria offesa, col suo sguardo a un tempo di storiografo del passato e di
antropologo del presente, che fa tesoro dell’asciuttezza estetica e del rigore morale del cinema di
Robert Bresson così come della trattenuta commozione, e della voglia di testimoniarne, celebrarne e
riscattarne cinematograficamente il senso, che di fronte alle vite dolorose del passato, soprattutto a
quelle femminili, esprime Kenij Mizoguchi. E un cinema, a un tempo, astratto e concreto, fondato
su idee metafisicamente profonde ma anche capaci di mordere sul reale, filosofico e politico. Di
molti film del nostro tempo, ricordiamo soltanto inquadrature, battute, spunti comici o drammatici,
episodi più o meno divertenti o più o meno commoventi, ma del cinema di Faccini ricorderemo,
prima d’ogni altra cosa, luoghi di sofferenza, soggetti offesi ma dignitosi e spesso ribelli, persone
che hanno saputo fare della loro vita quotidiana un’umile ma grandiosa epopea di opposizione a
come va il mondo.. Il cinema di Faccini (il quale è “uomo di sinistra, incorreggibile ribelle ai
margini dell’industria” come scrive di lui Alain Bichon) si pone, in tal senso, quale autobiografia
alternativa dell’Italia del 900. Con lui, il cinema italiano ritrova quell’ansia di conoscenza sociale
(appunto, di disegno della geografia del dolore e della dignità degli italiani) oltre che di ricerca
stilistica (ma, del resto, per chi abbia una concezione a un tempo etica ed estetica del cinema, è
impensabile separare le due cose) che fu di Roberto Rossellini e di Pier Paolo Pasolini e che è, oggi,
di pochi quali Ermanno Olmi, Vittorio De Seta o Gianni Amelio: un cinema che sappia essere,
contemporaneamente,. cognitivo e poetico, documentaristico e creativo, bello e severo, capace
d’essere in una volta strumento di conoscenza delle cose e di celebrazione (in senso rilkiano) del del
loro farsi passato e ricordo.
FILM, LUOGHI, STORIE, PERSONE
La geografia della memoria offesa che, col suo cinema, Luigi Faccini va disegnando, comprende
borghi montani e città più o meno grandi, periferie urbane e carceri, fabbriche e manicomi, case di
cura e cimiteri. Nell’esplorarla, seppur non compiutamente, vale la pena di partire dal modo
contadino, misero e sempre più spopolato, dei borghi sperduti, lontani dalla civiltà contemporanea,
della Lunigiana, ove Faccini ambienta il suo esordio filmico: Niente meno di più, 1971. E’ la storia
(ispirata a un fatto vero, avvenuto negli anni 60 ossia l’invio per punizione, da parte del vescovo di
Sarzana, di don Sandro Lagomarsini, parroco di Ameglia, nel remoto borgo di Scurtabò di Cassego,
in Val di Vera: qualcosa di simile a quanto fatto dall’arcivescovo di Firenze a danno di don Lorenzo
Milani, mandato per analoga punizione a Barbiana, nel Mugello) di don Leandro, un giovane prete
scomodo che, confinato dal vescovo in un paese di poveri contadini, cerca di offrire ai loro figli,
facendo scuola, un po’ di cultura scientifica, letteraria e persino cinematografica, insegnando loro a
2
usare una piccola macchina da presa, ma scontrandosi così con l’atavica ignoranza, dovuta a un loro
colpevole abbandono da parte della società, degli adulti del posto, che vorrebbero i ragazzi al
lavoro nei campi invece che a scuola, non capendo che soltanto attraverso la cultura essi potranno
forse avere un futuro meno tetro e penoso. Faccini sperimenta per la prima volta una sorta di
cinema-verità, largamente utilizzante il piano-sequanza e orientato a fare della macchina da presa
uno strumento d’indagine sociale, di ricerca storica e antropologica, che segnerà poi tutta quanta la
sua carriera di cineasta instancabilmente curioso e “non riconciliato”.
La geografia della memoria offesa può comprendere, tuttavia, anche un’intera città e un’intera
generazione, per esempio la Siracusa e la generazione del protagonista, Alessio, de Il garofano
rosso, 1975, tratto dal meno amato, ma saputo trasformare in un film del tutto facciniano, tra i – da
lui amatissimi - libri di Elio Vittorini. E’ il fascismo, forma tutta italiana di degradazione della
politica e di depravazione del costume, con la propria carica di aggressiva diseducazione di massa e
di asservimento delle coscienze, a stringere nella propria soffocante morsa la città e i suoi giovani.
Alessio tuttavia, dopo un momento d’incertezza e di sbandamento, riesce a liberarsi dall’oscuro
fascino del fanatismo e della violenza e a maturare dentro di sé, anche scoprendo il sesso e l’amore,
una personale, ma forse prima o poi anche collettiva, libertà dal ricatto fascista. Il film, pur
ambientato negli stessi anni del romanzo da cui è tratto ossia nei primi anni 20 del 900, mostra un
mondo e una società che è assai più lontana da noi, rispetto a quegli anni 30, dunque ancora in
pieno fascismo, in cui il libro fu scritto e a quel 1948 in cui il libro fu pubblicato. Lo sguardo di
Faccini è dunque, necessariamente, più distante, più archeologico, cerca nel passato remoto le radici
dell’oppressione e quelle della liberazione, conserva la memoria di come si possa cadere e di come
si possa imparare a rialzarsi.
Anche in Nella città perduta di Sarzana, 1979, il passato rievocato è quello degli anni 20, anche in
esso il cinema facciniano va in cerca d’una memoria offesa da recuperare e di cui dare testimonia,
anche in esso a portare l’offesa è il fascismo (un tema ricorrente, e del resto sempre attuale nel
nostro Paese, del suo cinema) ma questa volta senza mediazioni letterarie e senza allontanarsi dalla
sua terra nativa, la Liguria orientale (che Faccini preferisce chiamare il Levante ligure. E’ un
episodio non molto noto e mai raccontato dai libri di scuola, quello rievocato nel film: gli scontri
sanguinosi che ebbero luogo, appunto a Sarzana e dintorni, nel 1921, tra squadracce fasciste da una
parte e soldati italiani e braccianti locali dall’altra. Ci furono morti, il governo mandò a investigare
un abile poliziotto, il migliore che avesse a disposizione, il questore di Roma Vincenzo Trani.
Poteva essere l’occasione per trovare prove schiaccianti contro il fascismo, per incastrarlo, per
fermarlo. Così non fu ma Faccini s’interroga, indaga, si fa investigatore storico, continuamente
mescolando quanto è avvenne in Lunigiana con quanto avvenne a Roma, nell’aula del Parlamento e
fuori di essa. Poteva andare diversamente? Poteva essere evitata la marcia su Roma? Poteva, lo
stato liberale, bloccare sul nascere lo sviluppo del fascismo invece che crollare davanti a esso? C’è
chi dice che la storia non si fa con i se e con i ma e tuttavia i cercatori di memoria offesa la fanno
invece proprio così, perché soltanto così essa può servire da lezione, può ammonire il futuro.
In Sassalbo, provincia di Sidney, 1982, diventa nuovamente luogo della memoria offesa un piccolo
borgo dell’Appennino, posto sul crinale che fa da spartiacque (come scrisse a suo tempo Mario
Soldati) tra Liguria, Toscana Emilia. Poche case, da sempre, ma con sempre più rari abitanti.
Faccini scoprì Sassalbo quando girovaga per le montagne di Lunigiana per girare il suo primo film,
il già ricordato Niente meno di più. In questo suo attento girovagare, scoprì questo luogo,
apparentemente fuori dalla storia ma invece, seppur con maggior lentezza e dunque meno
immediata percezione, della storia del mondo facente parte totalmente e spesso dolorosamente. Nel
borgo montano la vita sociale era ancora improntata a un modo di esistere comunitario, semplice e
solidale, ove mestieri e competenze antiche, quali il suonare la fisarmonica, risultavano ancora di
quotidiana applicazione ed espressione. Faccini si ripromise di tornare in quel borgo e di ascoltare
ancora, e usare cinematograficamente, le ataviche capacità musicali dei suoi abitanti. Lo fece
davvero, seppur dopo vari anni; per fare un altro film, per testimoniare e celebrare e redimere una
vita di stenti che sapeva, però, anche essere epica, libera, solenne. Crudele come spesso le capita di
3
essere, la storia aveva toccato anche quel borgo apparentemente fuori del tempo e della geografia.
La geografia della memoria offesa arriva anche laddove non arrivano gli atlanti scolastici. Anche a
Sassalbo: “E poi il lavoro nei boschi – scrive Faccini – abbattere faggi, costruire carbonaie,.
vivendo in capanne a fianco con il maiale, la capra…E il fascismo. L’Abissinia. La guerra. La
deportazione in Germania. L’emigrazione… Bisognava che quel dolore diventasse film”. Fare film
per testimoniare del dolore del passato, di quello lontano e di quello recentissimo. La maggior parte
della gente originaria di Sassalbo è emigrata in Australia: questo è un fatto, a un tempo straziante
ma forse anche foriero di qualche gioia e di qualche soddisfazione, di cui nessuno, se non gli
abitanti di quel borgo sperduto, sapeva nulla. Oggi lo sappiamo, grazie a Luigi Faccini: ma non
sappiamo soltanto ciò che è accaduto agli abitanti di Sassalbo, sappiamo quanto è accaduto agli
abitanti di molti altri borghi italiani, sappiamo del loro soffrire nel lasciare il paese nativo e del
dolore di quanti, sempre più soli, vi sono restati. Soprattutto, possiamo tematizzare, far fruttare,
rendere coscienza etica e politica ciò che Luigi Faccini ci ha permesso di sapere, conoscere, capire.
La montagna, ma questa volta è l’Amiata, entra di nuovo nella mappa della memoria di Luigi
Faccini col film, anch’esso un documentario antropologico, L’Amiata è anche un fiume, 1983. Con
Marina, avevano comprato una casa, ove tuttora tornano ad ogni estate, nell’Alta Maremma,
appunto sulle pendici dell’Amiata, montagna d’origine vulcanica e in qualche modo sacra nella
percezione sociale dei toscani, in quanto terra un po’ folle, di minatori che – scavando in cerca del
mercurio – si ammalavano d’idrargirismo e impazzivano, di profeti come David Lazzaretti. che
predicava un cristianesimo comunisteggiante e fu ammazzato dai carabinieri e come padre
Balducci, prete pacifista, predicatore della fratellanza tra gli uomini e della giustizia sociale. Dopo
la chiusura delle miniere di mercurio, avvenuta nel corso degli anni 40 del 900, i paesi dell’Amiata
restarono senza lavoro e si spopolarono. Il film narra d’un progetto, finalizzato a sviluppare sulle
terre amiatine una vasta rete di cooperative agricole finalizzate all’allevamento intensivo di animali
da macello e alla lavorazione delle loro carni. Molti giovani si entusiasmarono, .la Regione Toscana
mise dei soldi, per qualche tempo un fiume d’idee (il “fiume” del titolo) sgorgò dal sacro monte che
parve sul punto di voltare pagina, dopo anni di immiserimento, di abbandono, di desolazione. Il
progetto, poi, si arenò ma le energie giovanili a quel tempo messe in moto hanno, anche in anni
recenti, dato frutti importanti.
In Immaginando cinema,1984, è nuovamente un’intera generazione di giovani d’una città
dell’Italia meridionale, Foggia, a vedere la propria esistenza ferita, sciupata, costretta a perdersi nel
nulla. Non per colpa del fascismo come in Garofano rosso, questa volta, ma d’una società incapace
di offrire loro speranze, ideali, posti di lavoro, méte di sviluppo economico e sogni di umana
creatività. E tuttavia, come sempre nei film di Faccini, i protagonisti, in tal caso un gruppo di
ragazzi impegnati nella realizzazione di un film, non si limitano a subire l’offesa loro arrecata,
cercano di reagire con dignità e fantasia, si ribellano al fato e all’oppressione sociale, cercano di
sfuggire alla morsa che s’è stretta intorno a loro.
Anche il manicomio è un luogo di memoria offesa. Lo è stato a lungo, soprattutto per i diseredati,
gli appartenenti alle classi subalterne, quegli anelli deboli della catena sociale la cui rottura interiore
veniva chiamata follia ed era allontanata, anzi rimossa, dalla comunità della razionalità e della
produttività, ingabbiandola in quei terribili luoghi di reclusione che, prima della rivoluzione
basagliana, erano appunto i manicomi. Luigi Faccini conosceva bene questa realtà, quando decise di
realizzare Inganni, 1986, storia dell’internamento, nel manicomio di Castel Pulci presso Firenze,
del grande poeta Dino Campana, uno dei maggiori, più romanticamente ribelli r rimbaudianamente
allucinati, lirici del 900 italiano. Egli, infatti, aveva lavorato, come animatore culturale e addetto
alla documentazione audiovisiva, presso l’ospedale psichiatrico provinciale di Arezzo negli anni in
cui, dietro la spinta politica dell’assessore Bruno Benigni (un cattolico comunista di grande
lungimiranza e immensa generosità) e sotto la direzione scientifica di Agostino Pirella (che di
Basaglia era stato collaboratore a Gorizia), lo si stava aprendo, trasformandolo da luogo di
reclusione a luogo di ospitalità e di cura, appunto aperto alla città, finalmente comunicante con essa.
Nel film vennero coinvolti, per interpretare i degenti di Castel Pulci, anche i degenti dell’ospedale
4
psichiatrico di Santa Maria della Pietà (il secolare manicomio di Roma, costruito nel XVI secolo e
alfine chiuso dopo le dimissioni del suo ultimo ospite, nel febbraio del 1999). Il film, centrato sul
rapporto – d’incontro/scontro, di complicità e ostilità – tra il poeta “folle” e lo psichiatra Carlo
Pariani (che su Campana scrisse poi un libro piuttosto interessante) è bellissimo, caratterizzato da
un’austerità stilistica e morale degna d’un Bresson ma anche d’una capacità d’indagare nelle pieghe
più profonde dell’anima umana e di quei suoi recessi ove s’annidano sia la poesia che
l’autodistruttività, sia la creatività che l’aggressività, degna d’un Bergman.
Anche un’intera regione d’Italia, chiamata negli anni più oscuri e tristi della sua storia, a tirar fuori
le unghie e schierarsi nella lotta, può diventare, in un film di Faccini, luogo della memoria offesa: è
la Toscana, protagonista, con i suoi eroismi ma anche con i suoi immani lutti, della Resistenza al
nazifascismo negli anni tra il 1943 e il 1945 e il film è C’era una volta gente appassionata, 1986,
un’elegia solennemente dolente che, dietro un amorevole titolo alla Ioselani, narra le gesta
coraggiose e gli atroci lutti subiti da un intero popolo, dalla vittoria del settembre 1943 nella
battaglia di Piombino (già narrata da Roberto Rossellini nell’ultimo episodio de L’età del ferro,
1964) alle terribili stragi che insanguinarono i paesi toscani (nell’aretino, nel grossetano, sulle
Apuane) fino all’ingresso degli angloamericani nella città di Carrara già liberata dai partigiani.
Nella geografia della memoria offesa del cinema di Faccini i luoghi della resistenza, e dei dolori
causati dal fascismo e dall’occupazione tedesca, rappresentano un tema importate, ricorrente,
emblematico.
Quali sono i luoghi della mappa del dolore in Donna d'ombra,1988? La persona portatrice
soggetto portatore di memoria dolente è Carla, una coreografa che, mentre sta approntando una
versione danzata dell’Antigone (non a caso, un’altra “donna d’ombra”, combattiva, trasgressiva,
ribelle alle leggi della città),. viene informata che suo padre sta morendo. Corre in ospedale, assiste
all’ultimo tentativo del medico – col massaggio cardiaco – di salvare la vita al paziente ma tutto è
inutile: l’uomo da lei più amato le muore tra le braccia. Il dolore la invade, la costringe a fuggire, a
cercare di perdersi in uno strano viaggio senza méta che è, anche, un viaggio nella memoria, in un
passato che il film mostra attraverso vari, straordinari, toccanti flashback. Il luogo è forse il suo
studio di coreografa, ove istruisce giovani danzatori e ove niente l’avrebbe mai costretta a
interrompere una prova se non la telefonata triste, temuta, attesa? O quell’autostrada che, superando
Genova, la porta chissà dove? O forse è il luogo, anzi i luoghi (la sinagoga, la casa del padre con il
candelabro a sette braccia e così via), della tradizione e della cultura ebraica? O forse, più
semplicemente, è il cuore stesso, o l’anima, della donna, luogo profondo e insondabile, santuario
d’amori e dolori, scrigno di creatività e di depressione, urna di memoria cara e offesa a un tempo.
Faccini si accosta a Carla con commozione e rispetto, con comprensione e pudore, con la partecipe
e distaccata maestria dei grandi registi di storie femminili: Dreyer, Mizoguchi (non mi sentirei,
invece, di evocare Antonioni, come fa Mereghetti nel suo Dizionario dei film: le donne di
Antonioni, salvo forse la protagoniste di Cronaca di un amore, sono donne erranti nel vuoto,
sperdute nella nebbia, prive d’un progetto di ricostruzione del proprio passato e di un’intenzionalità
di ricavarne una maggior comprensione del presente e un impegno futuro. Non così Carla, donna
volitiva e, al pari di O’Haru e di Gertrud, intenzionalmente in cerca di sé e d’una propria
spiegazione del dolore e dell’amore, del mondo e della vita). Va detto che, in realtà, le coreografie
dell’Antigone che il film attribuisce al personaggio di Carla, sono di Elsa Di Laudadio Piperno,
pioniera della danza moderna in Italia, ove per prima introdusse i metodi di Marta Graham, e al cui
Centro di Danza di via del Gesù, a Roma, Faccini ha dedicato il cortometraggio Addii, 1988/1990:
anche questa è una caratteristica del suo cinema ossia il fatto che i diversi film sono legati tra loro,
ei rimandano l’un l’altro, vivono in continuo e reciproco dialogo perché l’uno nasce dall’altro.
Un luogo, un pezzo di geografia, di memoria offesa, di dolore umano, di morte è anche la Villa
Glori di Aids. Viaggio nelle risposte possibili (Villa Glori), 1989, ma, a un tempo, è un luogo di
speranza, di dignità ritrovata, di solidarietà e sapienza. La storia, a suo tempo, fu su tutti i giornali:
la Caritas di Roma, coraggiosamente guidata da don Luigi Di Liegro, aveva aperto una casafamiglia per ammalati di AIDS sulla collina di Villa Glori, proprio all’interno dei Parioli, una delle
5
zone più borghesi della città. Gli abitanti del quartiere le fecero subito guerra, ci furono
manifestazioni, polemiche, proteste sulle quali la destra xenofoba e razzista si insinuò, gettando
benzina sul fuoco. Ma l’esperienza di quella casa-famiglia andò avanti lo stesso, sapendo imporsi
come un’occasione straordinaria d’incontro tra esistenze, professioni, credenze diverse ma tutte
quante accomunate dalla volontà e dalla capacità di mantenere aperto e acceso il dialogo tra la vita e
la morte, tra i vivi e coloro che sono destinati presto a non esserlo più. Il film, oltre che testimoniare
ancora una volta della carica di indignato e commosso umanesimo col quale Faccini si accosta
all’esperienza del dolore, rappresenta uno dei tanti, intensi ritratti cinematografici che egli, laico, ha
voluto e saputo disegnare di sacerdoti impegnati nell’esprimere il loro cristianesimo tramite
l’impegno sociale e la prossimità coi miseri e gli afflitti.
Nella mappa del dolore umano che Faccini è andato costruendo col suo cinema non poteva mancare
quel luogo di sofferenza e di esclusione che è un carcere minorile: in Ladro di voci, 1990, i
protagonisti sono infatti i reclusi dell’istituto penale per minori di Casal del Marmo, a Roma, la
“città dei ragazzi” dietro le sbarre, come argutamente l’ha definita un cronista.. Luogo di pena,
appunto, e non soltanto in riferimento alla pena da scontare ma anche e soprattutto alla pena quale
umano dolore, quale condizione esistenziale: si approda a Casal del Marmo perché la vita, quella
fuori dal carcere, è già, spesso fin dalla nascita, una pena, un processo continuo di emarginazione
ed esclusione, di privazione e sconforto Qui giunge, dopo un percorso generalmente già lungo di
guai con la giustizia, quello che viene definito lo “zoccolo duro” della devianza giovanile ossia
ragazzi, in prevalenza tossicodipendenti, che hanno alle spalle esperienze di affidamento ai servizi
sociali o alle comunità di volontariato e hanno di fronte, prima o poi, il carcere per adulti, Rebibbia
o Regina Coeli. Faccini passò quattro mesi a Casal del Marmo, tenendo un seminario sugli
audiovisivi per i giovani reclusi. Fu in quell’occasione che conobbe Carlo e Fabrizio, due carcerati,
e fu seguendo le tracce della loro esistenza, fino al quartiere di origine, Tor Bellamonaca, che egli
s’addentrò nel mondo delle “periferie invisibili” (simili ma anche storicamente e socialmente
diverse dalle borgate sottoproletarie già portate sullo schermo da Pasolini) e conobbe la comunità
di Capodarco, fondata da don Franco Monterubbianesi (uno di quei preti coraggiosi per scoprire i
quali Luigi ha un particolare e testardo fiuto) e il Centro di Integrazione Sociale, da tale comunità
gestito, di quel desolato e misero quartiere romano. Lavorò a lungo con i ragazzi del centro, imparò
a conoscerli e insegnò loro (spaesati, poveri di linguaggio, preda di miti consumistici, privi di
progetti e di speranze) a conoscersi attraverso il cinema. Nacque così, in lui, l’idea di fare un film
su quell’ambiente, quel mondo, quei personaggi.
Il film fu Notte di stelle, 1991: con esso, le “periferie invisibili” (ai cui giovani abitanti il film è
dedicato) entrarono a far parte, del resto con pieno diritto, della facciniana geografia del dolore
umano. Il film, interpretato proprio dai ragazzi della comunità di Capodarco (ancora una volta, un
film rimanda a un altro), narra di tre giovani, Luana, Lucio e Carlo, che provengono da esperienze
diverse e difficili (Luana, fuggita di casa, cantava in una misera orchestrina di liscio fino a quando,
per essersi stufata e aver cantato in inglese un pezzo dell’amatissimo rock venne presa a schiaffi dal
clarinettista e fuggì di nuovo; Lucio è un assistente sociale che aspira a conoscere il mondo
attraverso il cinema, Carlo è un pittore di murales, tossicodipendente e appena uscito dal carcere),
s’incontrano, si legano, decidono di dare vita a un progetto (a un “sogno”: come quello dei ragazzi
amiatini in L’Amiata è anche un fiume,, come quello dei ragazzi di Foggia in Immaginando
cinema: soltanto simili “sogni” danno voglia e forza di vivere, pensa Faccini): realizzare un film sul
mondo delle periferie, sulla sua violenza, sull’impegno a uscirne. Sarà Carlo a interpretare il
personaggio del film, un giovane pugile che finisce col morire sul ring, e sarà Lucio il suo regista e
Luana l’anima del gruppo, che dona energia e passione agli altri due. Il sogno, tuttavia, si infrange
presto: Carlo ricade nella dipendenza e nella delinquenza e muore in un incidente d’auto, Luana
fugge di nuovo, piangendo, e torna a cantare in un’orchestra, Lucio resta fermo sul proprio
proposito di imparare ad ascoltare la gente, filmandola. E’ il proposito, anche, di Luigi Faccini, in
questo film come nel resto del suo cinema. Lucio è portatore di un’idea del cinema che somiglia,
seppur a un livello più elementare, a quella di Faccini (è forse il suo personaggio maggiormente
6
autobiografico): quella d’un cinema a un tempo documentativo e poetico, di ricerca antropologica e
di passione politico, per il quale l’etica non sta soltanto nel messaggio ideologico dal film narrato e
offerto agli spettatori ma nel suo intimo farsi, prodursi, realizzarsi. Un cinema sempre resistente,
orientato alla volontà, intellettuale e morale, di dar voce ai deboli (che sono, in realtà, gli unici
forti), agli addolorati (perché il dolore, saputo affrontare, è anche occasione di crescita, di sviluppo,
di pensiero), ai perdenti: “I perdenti, i vinti, gli ultimi! Bisogna maneggiare con cura queste parole –
egli ha scritto - Si perde e si finisce in fondo alla classifica sociale per ragioni spesso
decifrabilissime. Mi chiedevo: fare un film sui perdenti per costringerli a conoscere i meccanismi
che li afferrano e li abbattono? O farne un’elegia malinconica, un’esortazione alla bontà? Il quadro
fosco di una realtà immodificabile? Scelsi la prima strada. Il pubblico si sarebbe sentito in colpa?
Complice e responsabile dei meccanismi che producono l’emarginazione? Il rischio era serio. Ma io
non sostituisco mai l’illusione alla realtà”.
Con Canto per il sangue dimenticato, 1997, la geografia della memoria offesa torna in Toscana,
torna alla Resistenza, torna all’eroismo e al dolore di quanti seppero opporsi al fascismo ma ancor
prima seppero mantenere dignità e coraggio pur nella fatica del lavoro e nella servitù dello
sfruttamento. Il film narra d’una strage nazifascista. La sera di 14 giugno 1944, a Castelnuovo
Valdicecina presso Larderello, furono fucilati 83 minatori, prelevati la notte precedente dal
villaggio operaio di Niccioleta. L’accusa era quella di aver aiutato i partigiani. Di loro ha scritto
padre Ernesto Balducci, nativo di Santa Fiora (il borgo amiatino dal quale molti di essi provenivano
e che avevano lasciato, dopo la chiusura delle miniere di mercurio, per andare a lavorare, per la
Montedison, nella zona delle colline metallifere): “Ho sotto gli occhi l’elenco…(dei fucilati)…e
leggo, con lo sgomento che sempre provo quando ripenso all’episodio, il nome delle vittime. Segno
con il lapis quelli dei miei compaesani…La metà sono dei miei compagni d’infanzia e alcuni dei
miei compagni di classe o almeno di scuola: Battisti Eraldo, Bertocci Sergio, Mondani Rinaldo…
Più giù Moretti Luigi, che stava nel banco dietro di me, nell’aula dalla cui finestra si vedeva il
profilo di Monte Labbro, con la torre diroccata di David Lazzaretti, il profeta fantasioso dei dannati
di quelle terre. Eravamo, a Santa Fiora, quasi tutti figli di minatori. Se non avessi seguito un’altra
strada sarei stato sicuramente anche io nell’elenco delle vittime...”. Ricordo tuttora con
commozione l’effetto angoscioso che mi fece, la prima volta che entrai nel cimitero di Santa Fiora
(al quale, da allora, torno spesso), ove le tombe dei martiri di Niccioleta stanno a fianco, all’ombra
dei castagni, di quelle di David Lazzaretti, di padre Balducci,e del senatore comunista Fernando Di
Giulio, notare come le loro lapidi mostrassero vecchie foto di volti assai diversi tra loro e date di
nascita parimenti tutte diverse tra loro ma una sola, martellante, ossessiva al mio sguardo data di
morte, ripetuta eguale per decine e decine di volte: 14 giugno 1944, il giorno della vergogna, il
giorno della ferocia assassina, il giorno della strage. Il film di Faccini non si limita a narrare il
tragico evento poiché esso rappresentò, in fondo, il culmine straziante e crudele d’una lunga storia
d’oppressione, di vessazione, di prepotenza non soltanto fascista ma anche padronale. Un’indagine
serrata, incalzante, indignata ripercorre cinematograficamente la vita di quei minatori ma anche,
parallelamente, della Montedison, che espanse il proprio potere e il proprio profitto servendo il, ma
anche servendosi del, regime e sfruttando gli operai (nel 1953, non molto distante da Niccioleta, in
quel di Ribolla, ci fu un’altra strage in una miniera Montedison ma là gli assassini non furono i
nazifasisti bensì il colpevole disinteresse padronale per la sicurezza del lavoro, come denunciarono
subito, su “L’Unità” e poi nel libro Minatori di Maremma, Luciamo Bianciardi e Carlo Cassola).. Il
film narra anche del processo che si fece, per i fatti di Niccioleta, a Pisa nel 1948 e in appello a
Firenze l’anno successivo: ci furono alcune condanne ma i veri mandanti e i veri esecutori
sfuggirono alla giustizia. e “Un processo inutile, la giustizia offesa, l'umanità offesa” sono le parole
con cui Faccini chiude. Canto per il sangue dimenticato. Il film, che fu progettato nel corso di un
laboratorio cinematografico che Faccini condusse con i giovani di Selvena e Castell’Azzara, si fa
testimonianza straziante e implacabile di quella giustizia offesa, di quell’umanità offesa, di quella
memoria offesa.
7
Con Giamaica, 1998, la geografia del dolore umano disegnata sullo schermo da Faccini torna nelle
periferie urbane d’Italia ma entrano in essa nuovi soggetti: gli immigrati, la gente di colore, i nuovi
emarginati d’una nazione che sta diventando multietnica in maniera incosciente e spesso persino
insensata. “C’era una volta un ragazzo che aveva un sogno” si legge nella didascalia iniziale.
Faccini apprezza i ragazzi, e non soltanto i ragazzi, che sanno avere sogni e ne fa spesso i
protagonisti dei propri film: quando un essere umano non ha più alcun sogno, la sua vita si spenge,
si annichila, muore nell’anima ancor prima di morire definitivamente, fisicamente. Il film narra
appunto d’un ragazzo, figlio d’un italiano e d’una africana, che ama la musica e la danza del
mondo caraibico e che sogna di poter andare, un giorno, in Giamaica, ai suoi occhi la terra della
libertà e della musica. Finalmente decide di partire e si reca, coi suoi amici, a una cabina
fotografica: le foto gli serviranno per il passaporto, per il grande viaggio della sua vita. Invece,
quella notte stessa, muore, bruciato nell’incendio doloso del centro sociale in cui viveva, in una
borgata romana. Straziante la sequenza in cui il fuoco distrugge pian piano la sua immagine
fotografata, ridente, felice. I suoi amici, dopo il tragico evento, in una lunga notte vanno in giro per
la città, con un autofurgone coloratissimo di fantasiosi graffiti. Dove vanno? Forse in cerca degli
assassini, forse di se stessi e della propria amicizia, forse del ricordo del ragazzo morto, forse
viaggiare è per loro - come lo era stato per la coreografa di Donna d’ombra – una meditazione sulla
morte, una celebrazione della memoria, un rito di ricordo e di amore per l’amico ammazzato. Il film
è ispirato a un fatto vero: Auro, un giovane che Faccini aveva conosciuto al tempo in cui preparava
Notte di stelle e che amava il reggae e voleva andare in Giamaica, così fuggendo dalla squallida
borgata romana ove tirava a campare, era effettivamente stato ucciso nell’incendio d’un centro
sociale di periferia. Racconta Faccini, rievocando il fascino che Auro era capace di sprigionare dal
proprio corpo quando danzava::“Feci appena in tempo ad immaginare un folletto danzatore che
tentava di sfuggiva alla desolazione delle periferie, per diventare ’persona’, che Auro era già stato
cancellato dalla vita…. ai suoi amici che proseguirono con me l’avventura di Notte di stelle promisi
che avrei scritto un film per lui. Perché Auro non venisse dimenticato, perché della sua giovane vita
non si perdesse il segno. Con Giamaica ho adempiuto a quella promessa. Un film per rabbia e per
affetto. Un film perché il sentimento adulto del ricordare si stabilisse per sempre nella mente e nel
cuore dei suoi amici. Ma anche di coloro che Auro non hanno mai conosciuto”. Ancora una volta,
un film sulla memoria offesa, sulla geografia del dolore. Un postmoderno viaggio al termine della
notte (“primo banlieu-film italiano” l’ha definito acutamente Alain Bichon), triste ma vitale, non
cinico e nichilista come quello di Celine: in Giamaica la morte è presente e angosciante ma non
domina, non comanda, non distrugge la vita che, anzi, si rinnova con la nascita del figlio d’uno del
gruppo, chissà in quale ospedale, probabilmente maschio ma va bene anche se è femmina: una
nuova vita, un evento bergmanianamente miracoloso anche quando avviene in una società caotica,
in una città crudele, in un’umanità ferita, .
La fabbrica è stata un luogo importante, nella mappa geografica del dolore umano della modernità.
Le mani raccontano. 2007, racconta, facendo parlare le operaie stesse, del lavoro femminile così
come s’è svolto, nel 900, nel levante ligure. “Donne del levante ligure fra passato e futuro” è infatti
il sottotitolo del film: donne forti nonostante che per anni e anni abbiano svolto lavori faticosi ed
usuranti, donne dignitose nonostante che per anni e anni siano state sfruttate e oppresse, donne
intelligenti nonostante che la scuola e la società borghese non abbia investito nulla nel loro sviluppo
culturale (ma la fabbrica è, o forse sarebbe meglio dire “era”, a suo modo una scuola: di esperienza
umana, di solidarietà tra poveri, di fratellanza tra oppressi). Scrive Faccini, nel libro che
accompagna il film:“Una ricchezza umana profonda, a lungo nascosta, indocile e commovente,
gorgogliava, chiedendo di affiorare, pretendendo ascolto e rispetto. Il tesoro di un tempo e di una
esperienza che solo gli uomini avevano fino ad allora posseduto e comunicato…La tormentata
esperienza e la sentimentalità delle donne che avevano fatto i lavori usuranti nelle fabbriche del
Levante ligure, contribuendo non solo alla produzione di ricchezza ma all’evoluzione storica del
nostro paese, poteva, finalmente, essere raccontata…(Lasciavo che)…il flusso della memoria
8
infantile e famigliare, delle sofferenze e delle gioie, delle umiliazioni e delle affermazioni,
sgorgasse liberamente”.
Nella mia mente e nel mio cuore le tante donne operaie del Levante ligure si confondono con
l’unica donna che è protagonista di Il pane della memoria, 2008: Elena Servi. Due geografie della
memoria del dolore si toccano, si confrontano e dialogano, si sovrappongono (Faccini stesso ha
detto che il moto profondo del suo cinema “sta nell’armonizzare cose distanti, ripristinare il
continuo della realtà che si è frantumato”). Pitigliano è lontano dal Levante ligure, Elena Servi non
ha mai lavorato in fabbrica e tuttavia due mappe del cinema di Faccini in questo film si incontrano:
quella che scava nella tradizione e nella cultura dell’ebraismo (a Pitigliano è esistita da secoli una
comunità ebraica perfettamente integrata, salvo rigurgiti persecutori durante la signoria medicea e
durante il fascismo, nella vita sociale della città) e quella che scava nell’universo femminile della
fatica quotidiana, del lavoro, della dignità trovata persino nell’indigenza e nell’umiltà poiché
fondata sulla forza necessaria per andare avanti in un mondo difficile, non amico, davanti alle
offese del quale occorre saper resistere (credo che la passione politica di Luigi per la Resistenza
vada ben oltre il suo significato storico e ne comprenda l’emblematicità, la simbologicità: l’uomo e
la donna che resistono al fato, all’oppressione sociale, alla stupidità e crudeltà umana sono eroi di
un’altra storia, che va ritrovata, testimoniata, ricostruita, fatta comprensibile, offerta alla memoria di
chi vuol ricordare, alla sapienza di chi vuol sapere, alla coscienza di chi vuole farla fruttare nel
mondo). Il luogo, uno dei santuari della memoria e della geografia del dolore del cinema di Luigi
Faccini, è Pitigliano, appunto, e in particolare il suo cimitero ebraico. Si trova in esso un piccolo,
delizioso monumento funebre: è quello di una bambina ebrea di nome Carla (come la protagonista
di Donna d’ombra), precocemente morta e poi sepolta, appunto, nel cimitero ebraico di quella
piccola, antica città toscana. Il fatto che in un cimitero ebraico, ove secondo la Legge le immagini
sono proibite in quanto nemmeno Iddio ha un volto, sia presente questa statuetta testimonia come,
laddove l’umanità sia colta e civile, le diverse memorie dei popoli della Terra sappiano anche
dialogare e influenzarsi a vicenda senza opprimersi. In fondo, questa è la vita che si oppone alla
morte, quella culturale se non quella, insuperabile, biologica. Memoria vivente della storia degli
ebrei di Pitigliano è oggi una donna dal volto dolce e austero, specchio anzi vetrina d’un’anima
coerente e coraggiosa, tenera e ferma, bella e severa come soltanto i vecchi che sanno essere tali
senza timore, in quanto nulla hanno da vergognarsi della propria lunga vita, possono essere: Elena
Servi, appunto. Ella ricorda, nel film, che quel cimitero esiste da cinque secoli e che, dunque,
“…costituisce una stratificazione impressionante di generazioni e generazioni di morti…” ma
subito aggiungendo che ciò, “a pensarci bene, rappresenta anche un conforto…”. Elena Servi
impara la morte, e si prepara ad affrontare la sua, in quel conforto, dialogando ogni giorno con
l’immensa stratificazione di morti del cimitero ebraico di Pitigliano. Nel suo animo ciò significa
che, quando verrà il tempo, non andrà incontro alla morte da sola bensì accompagnata, o meglio
accolta, da tutte quelle generazioni di ebrei pitglianesi che l’hanno preceduta in quelle tombe di
tufo. Quel giorno, speriamo ancora lontano, la sua personale memoria di cinque secoli di storia della
comunità ebraica di Pitigliano non scomparirà con lei poiché ella stessa l’ha affidata a un film, ricco
di enfasi umanistica e rigore civile, di Luigi Faccini, il regista della memoria indignata. Di fronte
alla dilagante negazione sociale dei morti e alla crescente affermazione, nel mondo, dei “cimiteri
invisibili” (di cui Jean-Didier Urbani ha scritto: “Può darsi, in effetti, che al termine dell’operazione
di negazione dei morti da parte dei viventi si trovi la morte della stessa scrittura funeraria: un
silenzio grafico assoluto. Il silenzio dell’inesistente”), chi lavora a conservare la memoria, orale e
scritta, dei morti è un benefattore dell’umanità. Anche chi lo fa col cinema, come Luigi Faccini.
Forse la battaglia contro la smemorizzazione del mondo è anche una battaglia per la funzione, e
dunque necessariamente la qualità e persino il senso sociale, del cinema. Il cinema quale memoria
del mondo lotta contro l’affermarsi aggressivo di un cinema che mira invece all’intrattenimento
superficiale e dunque alla consumistica dimenticanza. Ha scritto, nel suo bellissimo “Le scritture
ultime”, il paleografo Armando Petrucci “Una scrittura dei morti continuerà ad esserci…(finchè)
… continuerà ad esserci nei viventi l’esigenza di ricordarli: che è poi l’essenza stessa di una
9
visione storica della vita e della specie…”. Anche il cinema può contribuire utilmente a tale
scrittura, a tale ricordo, a tale visione storica.
ANCHE I MORTI NON SARANNO AL SICURO. CONCLUSIONI
Verso l’inizio di questo testo, parlando di geografia della memoria offesa, ho detto che le
esplorazioni cinematografiche di Luigi Faccini, sulle tracce dei luoghi dell’umano dolore e
dell’umana dignità ferita, miravano forse, quella geografia, a riscattarla e redimerla oltre che, più
umilmente, a celebrarla, a tramandarla, a conservarla viva dentro di noi e tra noi. Entrambe queste
motivazioni stanno probabilmente a fondamento della sua scelta di farsi ricercatore del passato, il
quale “di quel passato, riemerso, voleva fare patrimonio indistruttibile per chi nulla o poco ne
sapeva. C’era un’offesa che… (da esso)… emergeva…” (queste parole, Luigi le ha dette a proposito
de Le mani dimenticate ma credo possano essere riferite a tutta la sua opera cinematografica e non
soltanto cinematografica). Credo che il tema del riscatto e della redenzione della memoria offesa
(ho avuto un sussulto quando questa parola, “offesa”, che già io già stavo usando nello scrivere
questo testo per connotare la memoria da lui testardamente indagata e portata alla luce, l’ho alfine
trovata da lui stesso posta in relazione col ricordo delle operaie liguri), sia stato inizialmente
presente, poeticamente e politicamente, in Faccini. Riscattare e redimere la memoria offesa
significa farla fruttare nella storia del mondo, affinché sia possibile immaginare che quel tipo di
offesa non avvenga mai più, proprio grazie alle sofferenze ma anche alle lotte di quanti hanno
conosciuto un mondo di dolore e di sfruttamento che un giorno si potrà alfine cancellare per sempre
proprio perché mai dimenticato, tenuto continuamente presente, fattosi patrimonio di
consapevolezza delle generazioni future. E’, anzi era, una prospettiva escatologica di natura laica, in
fondo il “sogno di una cosa” (Traum von einer Sache) di cui parlava il giovane Karl Marx in una
celebre lettera all’allora amico e compagno d’impegno Arnold Ruge. Il senso di tale prospettiva è
bene espresso, nelle sue Tesi di filosofia della storia (oggi, in italiano, in Angelus Novus) da Walter
Benjamin, quando scrive che “nulla di ciò che si è verificato va dato perduto per la
storia…(ma)…solo all’umanità redenta tocca interamente il suo passato. Vale a dire che solo per
l’umanità redenta il passato è citabile in ognuno dei suoi momenti”. Non credo sia ancora questa, in
un tempo e in una società sempre meno capaci di sognare escatologiche redenzioni e storici riscatti,
la concezione, etica ed estetica, cinematografica e politica, con cui Luigi Faccini guarda al suo
lavoro di cercatore/custode di memoria (ma posso sbagliarmi e mi piacerebbe discuterne con lui,
non appena ci incontreremo da qualche parte). Forse oggi essa è piuttosto quella delineata da
Vladimir Jankelevitch quando scrive, nel suo Corso di filosofia morale: ”L’uomo è morale nella
misura in cui possiede il culto del passato e si rammenta di esso…L’uomo, nel ricordarsi, protesta
contro la materia e l’annichilimento del tempo, principio della dimenticanza… Il culto del passato
manifesta l’attaccamento dell’uomo alle cose invisibili. La protesta contro la dimenticanza ha un
valore morale. L’uomo che dimentica fa il gioco delle forze materiali e cieche del tempo: possiamo
dire che egli uccida un morto per la seconda volta”. Caduta la speranza escatologica di riscattare e
redimere il passato, resta insomma il dovere morale di mantenerne vivo il ricordo poiché, ma qui
torna di nuovo utile ricorrere alla ribelle sapienza di Benjamin, “…anche i morti non saranno al
sicuro dal nemico, se egli vince. E questo nemico non ha mai smesso di vincere”.
“Per capire la vita, occorre ricordare la morte” (l’ha affermato, giustamente, lo stesso Faccini)
nonché ricordare, difendendoli dall’oblio non soltanto personale ma anche sociale, i morti, gli
oppressi, i vinti della storia. Luigi lo sa e agisce (filma) di conseguenza. Grazie, Luigi.
10