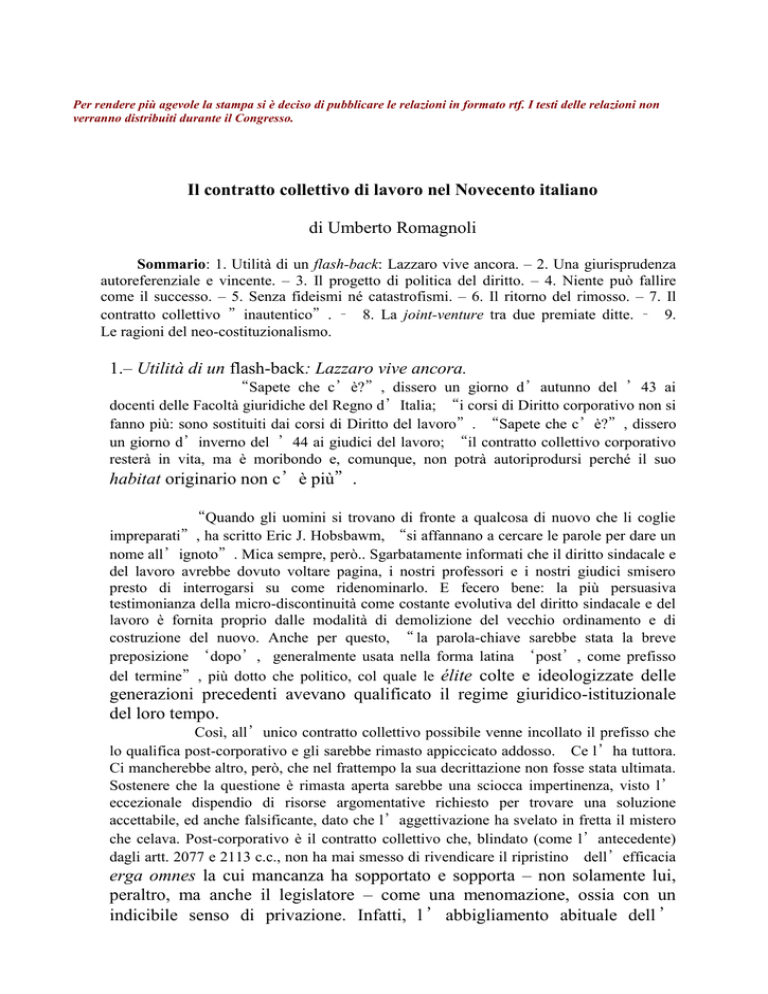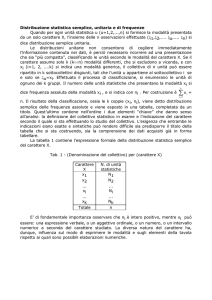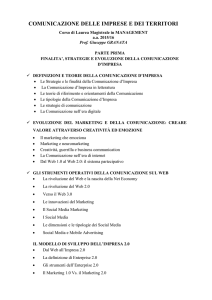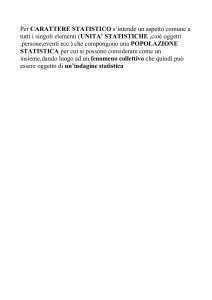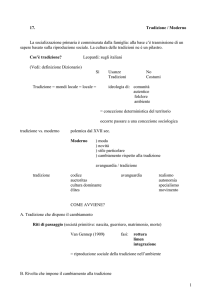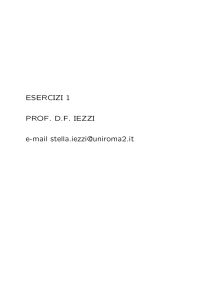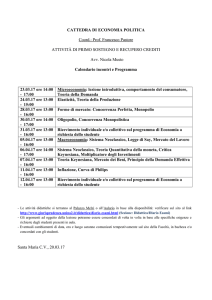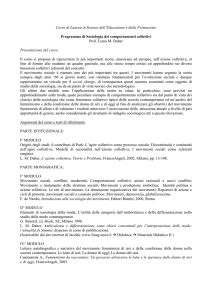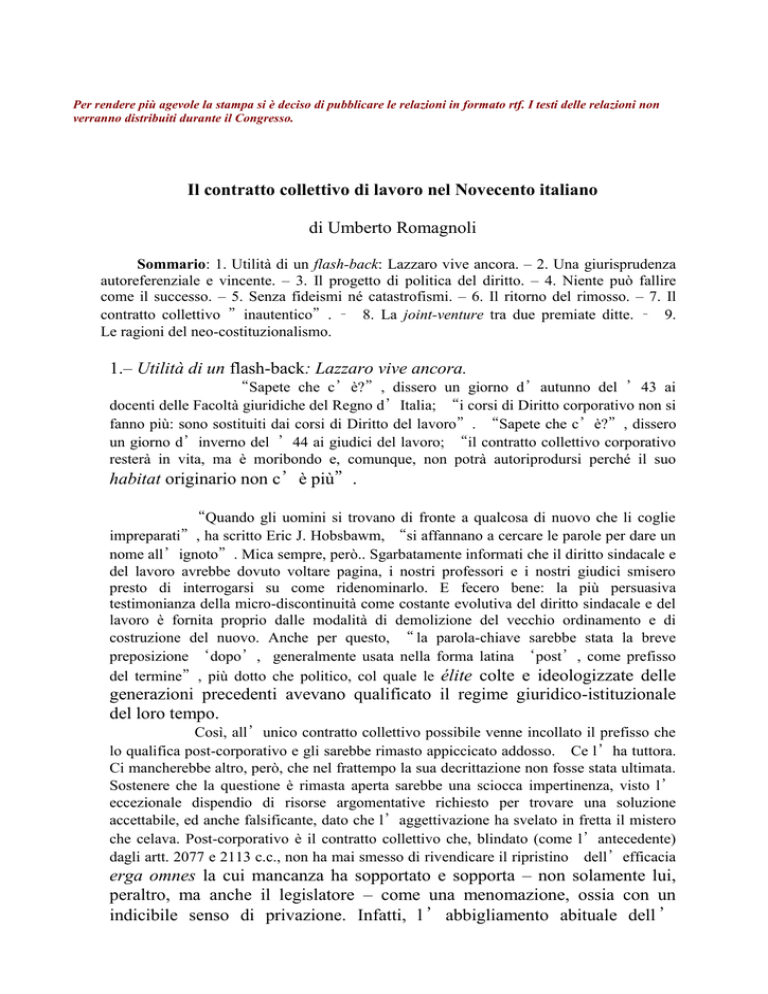
Per rendere più agevole la stampa si è deciso di pubblicare le relazioni in formato rtf. I testi delle relazioni non
verranno distribuiti durante il Congresso.
Il contratto collettivo di lavoro nel Novecento italiano
di Umberto Romagnoli
Sommario: 1. Utilità di un flash-back: Lazzaro vive ancora. – 2. Una giurisprudenza
autoreferenziale e vincente. – 3. Il progetto di politica del diritto. – 4. Niente può fallire
come il successo. – 5. Senza fideismi né catastrofismi. – 6. Il ritorno del rimosso. – 7. Il
contratto collettivo ”inautentico”. – 8. La joint-venture tra due premiate ditte. – 9.
Le ragioni del neo-costituzionalismo.
1.– Utilità di un flash-back: Lazzaro vive ancora.
“Sapete che c’è?”, dissero un giorno d’autunno del ’43 ai
docenti delle Facoltà giuridiche del Regno d’Italia; “i corsi di Diritto corporativo non si
fanno più: sono sostituiti dai corsi di Diritto del lavoro”. “Sapete che c’è?”, dissero
un giorno d’inverno del ’44 ai giudici del lavoro; “il contratto collettivo corporativo
resterà in vita, ma è moribondo e, comunque, non potrà autoriprodursi perché il suo
habitat originario non c’è più”.
“Quando gli uomini si trovano di fronte a qualcosa di nuovo che li coglie
impreparati”, ha scritto Eric J. Hobsbawm, “si affannano a cercare le parole per dare un
nome all’ignoto”. Mica sempre, però.. Sgarbatamente informati che il diritto sindacale e
del lavoro avrebbe dovuto voltare pagina, i nostri professori e i nostri giudici smisero
presto di interrogarsi su come ridenominarlo. E fecero bene: la più persuasiva
testimonianza della micro-discontinuità come costante evolutiva del diritto sindacale e del
lavoro è fornita proprio dalle modalità di demolizione del vecchio ordinamento e di
costruzione del nuovo. Anche per questo, “ la parola-chiave sarebbe stata la breve
preposizione ‘dopo’, generalmente usata nella forma latina ‘post’, come prefisso
del termine”, più dotto che politico, col quale le élite colte e ideologizzate delle
generazioni precedenti avevano qualificato il regime giuridico-istituzionale
del loro tempo.
Così, all’unico contratto collettivo possibile venne incollato il prefisso che
lo qualifica post-corporativo e gli sarebbe rimasto appiccicato addosso. Ce l’ha tuttora.
Ci mancherebbe altro, però, che nel frattempo la sua decrittazione non fosse stata ultimata.
Sostenere che la questione è rimasta aperta sarebbe una sciocca impertinenza, visto l’
eccezionale dispendio di risorse argomentative richiesto per trovare una soluzione
accettabile, ed anche falsificante, dato che l’aggettivazione ha svelato in fretta il mistero
che celava. Post-corporativo è il contratto collettivo che, blindato (come l’antecedente)
dagli artt. 2077 e 2113 c.c., non ha mai smesso di rivendicare il ripristino dell’efficacia
erga omnes la cui mancanza ha sopportato e sopporta – non solamente lui,
peraltro, ma anche il legislatore – come una menomazione, ossia con un
indicibile senso di privazione. Infatti, l ’ abbigliamento abituale dell ’
antecedente lui lo può indossare soltanto nei giorni di festa e soltanto se lo ha
rubato, con la destrezza occorrente per non farsi arrestare in fragranza di
reato; diversamente, sarebbe processato e condannato per furto, magari con
scasso.
Nondimeno, ciò che il diritto comune dei contratti nega è
affermato dalla vulgata corrente. Insomma, sono in pochi a sapere che il
contratto collettivo post-corporativo vivacchia in uno stato di minorità, come
un’anatra azzoppata.
Anzi, si può tranquillamente scommettere che la gente non ci crederebbe se
le dicessimo che i contratti collettivi i cui periodici rinnovi, come informano i
mass-media, costano in genere mesi di trattative e molte ore di sciopero sono
paragonabili ad uno smisurato serbatoio idrico sprovvisto dell’impianto atto
a trasformare l’enorme energia potenziale dell’invaso in energia cinetica
ed assicurare la distribuzione della corrente elettrica anche nelle abitazioni
situate nelle più remote contrade. Ci prenderebbero sul serio soltanto i
poveri-cristi a cui è toccata l’esperienza di restare al buio e, a causa del loro
isolamento, per farsi un po ’ di luce hanno dovuto accontentarsi di
accendere il cerino della contrattazione individuale. Tutti gli altri, invece, è
probabile che non ci darebbero retta.
Dal loro punto di vista, non hanno torto. Vaglielo a spiegare
che l’autonomia contrattuale collettiva non dispone di mezzi espressivi
meno precari di quelli allestiti con forbici e colla da una giurisprudenza
creativa; che esiste una madornale sproporzione tra la regolazione del
contratto collettivo che c’è e una prassi contrattuale che è un eufemismo
definire orgiastica; che bisogna avere il gusto del paradosso per pensare che l
’esuberante vitalità del contratto collettivo sia dovuta proprio alla segnalata
carenza di regole appropriate. Vaglielo a spiegare che, nonostante la
propaganda del regime, nemmeno il contratto collettivo corporativo apriva le
porte del Paradiso del garantismo, perché quello era un contratto che faceva
parte integrante dei coevi “ scenari decorativi” caratterizzati, secondo
Piero Calamandrei, da un “congegno di doppio gioco sistematico” simile
al fondo nascosto delle valigie dei contrabbandieri. Vaglielo a spiegare che
soltanto nel periodo compreso tra la caduta dell’ordinamento corporativo e l
’ entrata in vigore dell ’ art. 6 della legge 533/1973 “ il rapporto di
consequenzialità tra inderogabilità delle norme e l’invalidità del negozio”
dispositivo posto in essere dal lavoratore-creditore (G. Giugni) ha potuto
ricostituirsi con una durezza di poco inferiore a quella che conobbe all’
epoca del divieto dei patti contrari formulato dall’art. 17 della legge sull’
impiego privato (R. De Luca Tamajo); e ciò perché i sindacati
post-corporativi, vittime di un esasperato formalismo giudiziale, non erano
considerati idonei ad esercitare un ruolo di assistenza efficace nei confronti
dell’autonomia privato-individuale in sede di conciliazione stragiudiziale
delle controversie di lavoro.
In effetti, nemmeno la più sofisticata disquisizione teorica dipanata sul filo
del “ mi spezzo, ma non mi spiego ” che troppo spesso cinge le fronti dei
giuristi-scrittori dello star system accademico può sciogliere in maniera
persuasiva l’enigma della relazione che intercede tra l’art. 2077 e il
vigente art. 2113, ossia tra una norma con la quale la colonizzazione del
contratto collettivo ad opera della legge raggiunge uno dei suoi punti più alti
per azzerare la negoziazione a livello individuale delle condizioni di lavoro e
una norma che, per riammetterla sia pure in un contesto tonificato da
rassicuranti presenze istituzionali, affievolisce il legame tra inderogabilità del
contratto collettivo e indisponibilità dei diritti economici individuali che ne
derivano; diritti che, se tutto ciò non bastasse, fino ad una pronuncia della
Corte costituzionale della seconda metà degli anni ’60 erano soggetti anche
a prescrizione in pendenza del rapporto e la cui prescrittibilità, ad avviso della
stessa Corte, è controversa dopo l ’ entrata in vigore dello statuto dei
lavoratori.
Ciononostante, il good-bye al contratto collettivo corporativo è
stato uno dei più sofferti della storia giuridica e la sua eco non si è mai spenta
del tutto, come sa anche chi non abbia l’udito per decifrarla con la finezza di
Mario Rusciano o di Gaetano Vardaro (e pochi altri, in verità).
Infatti, nessuna opzione di politica del diritto sindacale è stata
assistita da una convergenza di consensi superiore, per ampiezza e
spontaneità, a quella realizzata dalla decisione governativa di sancire,
unitamente alla soppressione delle organizzazioni sindacali dell ’ epoca
corporativa, la sopravvivenza delle norme che esse avevano negoziato, “
salvo le successive modifiche”.. Un inciso, questo, che col trascorrere del
tempo avrebbe acquistato un sapore oracolare; mentre, nell’immediato, il
suo significato sembrava univoco e trasparente: le “successive modifiche”
sarebbero state introdotte col consenso del soggetto che – parafrasando una
formula testuale del decreto del ’44 – “dimostrerà di avere legalmente
la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dall ’
associazione disciolta”. Come dire che venne scritto per mantenere aperto o
riaprire un ciclo che, viceversa, si era interrotto.
Insomma, in materia di lavoro e delle sue regole, non ci furono break
risolutivi. In compenso, non ci fu nemmeno il black-out.
Non so i vostri, ma i miei studenti mi guarderebbero
stralunati se li introducessi allo studio del contratto collettivo descrivendone
lo stato a cui lo ha ridotto la dogmatica giuridica con le sue sottigliezze:
penserebbero che è una categoria logico-concettuale immobile e inanimata,
come un esemplare faunistico impagliato.
Affinché si formino un’idea sufficientemente precisa e concreta di
come sono andate le cose, se sono in vena di humour, magari un po’ nero,
preferisco raccontare (ah, cosa non farebbe un docente per farsi seguire a
lezione!) una short story che ha la velocità e l’immediatezza comunicativa d
’uno sketch. Racconto che gli operatori giuridici e sindacali della transizione
– in un paese devastato dalla guerra nel quale era da irresponsabili alimentare
il clima di incertezza che stava attraversando – giurarono a se stessi di non
farsi impressionare dagli innumerevoli segni della morte annunciata del
contratto collettivo corporativo e stabilirono di fare anche l’impossibile per
minimizzare le conseguenze del trapasso, tappando buchi e stuccando crepe.
Detto e fatto. Dato che il destino del contratto collettivo corporativo era
segnato, si comportarono come quando scompare un personaggio di cui il
mondo intero pensa di non potersi assolutamente privare: gli si infila sul naso
un paio di occhiali neri, lo si mette seduto e si tiene segreta la notizia del
decesso finché non si trova il legittimo erede del caro estinto o, perlomeno, un
continuatore affidabile delle sue prodezze.
Il comportamento era necessitato. Soprattutto la
disposizione-ponte del ’44, diretta a conservare integro il complesso di
norme contenuto nei contratti collettivi vigenti, “fino a quando non (fosse
stato) possibile adeguarlo alle nuove esigenze” era dettata dall’emergenza
e la sua “utilità sociale”, come avrebbe certificato la Corte costituzionale,
era indiscutibile.
Tutti erano di questo parere. I comuni mortali, in primo
luogo. Ma anche il ceto professionale degli operatori giuridici. Anche la
neonata Cgil unitaria di Giuseppe Di Vittorio; anzi, non è da escludere che l
’adozione del provvedimento corrispondesse ad una sua pressante richiesta.
Come dire che a nessuno venne il sospetto che la misura legislativa, per
quanto socialmente opportuna, avrebbe preso in ostaggio il sindacato,
condizionato i lavori della Costituente e orientato gli sviluppi della
costituzione materiale. Il che non può sorprendere: la massima di ragion
pratica “ciò che è urgente prevale sempre su ciò che è importante” è
troppo suadente per non riuscire a catturare il pensiero che, nel
dopo-Liberazione, presiede alla riattivazione del più popolare istituto del
diritto sindacale. Peraltro, neanche in epoca posteriore alla costituzione la
realtà effettuale permetterà di registrare significativi scostamenti.
Il flash-back può terminare qui, perché il mio dovere l’ho fatto. I
miei studenti sono abbastanza preparati per capire che quella post-corporativa
è la stagione delle reticenze, delle rimozioni e delle manipolazioni condivise.
En attendant Godot.
2. – Una giurisprudenza autoreferenziale e vincente.
Ovviamente, ciò che venne taciuto non poteva essere l’irreversibilità del
coma profondo in cui era caduto il contratto collettivo corporativo come costrutto storico.
Piuttosto, si preferì farne un dato ontologico, svalutando il dato dell’ascrivibilità di
alcune delle sue connotazioni più caratterizzanti –
efficacia reale ed efficacia cogente
erga omnes – ad un ordinamento giuridico che negava la libertà sindacale
quanto quella civile e politica.
Difatti, come denunzierà Gaetano Vardaro con la lucida
passionalità che lo distingueva, è all’enfatizzazione dell’accidentalità
(ininfluenza, insignificanza) di tale connessione che si deve l’incontrastato
successo della tesi secondo la quale la configurazione dell’istituto risalente
alla legge Rocco del ’26 esprime un’idea intramontabile che ne è slegata e
dunque è politicamente neutra, culturalmente incontaminata. L’idea, a cui si
riconobbe anche in sede costituente la proprietà di imporsi col nitore
accecante delle intuizioni auto-evidenti che zittiscono tutti, è scomponibile in
due proposizioni.
La prima: allorché si manifesta in una dimensione collettiva ed
assume una massiccia rilevanza sociale, anche l’autonomia negoziale dei
gruppi privati acquista la valenza dell ’ eteronomia ed esige perciò il
sacrificio totale o parziale dell’autonomia degli individui. Diversamente, si
finirebbe per distruggere l’essenza di ogni tipo di contratto collettivo, non
solo quello di natura pubblicistica. Come dire che l ’ art. 2077 c.c.
esprimerebbe un principio transtipico inerente al modello di struttura della
norma collettiva: non essendo circoscrivibile al contratto collettivo
corporativo, inerisce al contratto collettivo inteso come istituto
decontestualizzato. In effetti, è indubitabile che “ciò che dava ai movimenti
operai la loro forza originale era la convinzione giustificata dei lavoratori che
gente come loro non poteva migliorare la propria sorte con l ’ azione
individuale, ma solo con l’azione collettiva” (E. J. Hobsbawm).
La seconda: i rappresentanti sindacali ritengono irrealizzabile
la loro massima aspirazione, che è quella ad accreditarsi a livello di
eccellenza come portatori dell ’ interesse collettivo della generalità dei
lavoratori dipendenti, se non si vedono riconosciuta anche dallo Stato la
legittimazione a generalizzare l’applicazione delle regole che pattuiscono in
aree (geografiche, merceologiche, professionali) di crescente estensione; aree
che, come è naturale, risultano tanto più vaste quanto più le regole fissano
standard minimi la cui uniformità riflette l ’ omogeneità di condizioni
esistenziali suscettibili di generare, tra quanti le condividono, l’uso del
pronome “ noi ” . Che, direbbe un sociologo, esprime il desiderio di
considerare il luogo di lavoro a stregua di una comunità e l’orgoglio di
appartenervi.
Condivisa dagli esponenti più autorevoli del sindacalismo migliore e
della migliore dottrina non solo del nostro paese, l’idea appena sunteggiata preesisteva all
’avvento del fascismo giuridico: perché, allora, farla morire con lui? perché buttare via l
’acqua sporca col bambino dentro?
Se lo chiedeva anche il governo Badoglio. Dice un suo ministro: “il
governo non intende distruggere tutto ciò che ha trovato. Quel che oggi ci preme è
evitare ogni brusca frattura nell’ordinamento sindacale, sia pure con gli adattamenti
richiesti dalla nuova situazione politica” (L. Piccardi). Queste parole, riportate sul
Giornale d’Italia del 5 agosto del ’43 sono prudenti; come le decisioni che saranno
prese poco dopo. Così, il 9 agosto un decreto legge si limiterà a stabilire, con la sciatteria
lessicale di chi ha una fretta maledetta, che i contratti collettivi non potranno diventare
vincolanti per le categorie di riferimento se non “ quando siano approvati dall ’
esecutivo, previe le modificazioni del caso”.
Se lo chiederanno anche i padri costituenti. Ritenendosi obbligati ad
assomigliare più a Nestore che ad Achille, disegneranno nel quarto comma dell’art. 39
del documento costituzionale l’identikit del sindacato in maniera che tutti ne captassero al
volo la diversità rispetto alle altre società intermedie. E’ la diversità che sospinge il
sindacato ad inoltrarsi nell’area del diritto pubblico con la pretesa, o la fiducia, di non
restarvi imprigionato; è la diversità che fa di lui un “libero soggetto di autotutela in una
sfera di diritto privato e, nello stesso tempo, soggetto di una funzione pubblica” (V. Foa),
perché sa che, senza la libertà dei privati, non si conquistano i diritti sociali fondamentali,
ma sa anche che la libertà dei privati non basta da sola a garantirne l’effettività. Può darsi
che ai padri costituenti non fosse chiaro il ruolo del sindacato in condizioni di normalità.
Anzi, tenuto conto che i ruoli si definiscono soltanto nel vivo del loro esercizio concreto, è
vero senz’altro (A. Accornero). Infatti, il ruolo della Cgil unitaria coeva all’avvento
della Repubblica ed alla Costituente si definisce non tanto sul terreno della contrattazione
collettiva – che non decolla se non nel corso del ’47 e “presenta gli stessi vizi del
metodo corporativo” (G. Giugni) – quanto piuttosto sul terreno delle alleanze coi
partiti antifascisti per il perseguimento di fini a lunga o lunghissima scadenza e non
negoziabili. Come dire che, per la Cgil dell’epoca, astenersi dal ricercare una identità
distinta da quella dei partiti che l’hanno fatta nascere non equivale ad una dolorosa
rinuncia. E ciò perché identifica come suo compito primario ed assorbente quello di
contribuire alla riapertura d’un ciclo risorgimentale che veda il popolo non più spettatore
della costruzione dello Stato degli altri, bensì partecipe della progettazione d’uno Stato
che sia finalmente la casa di tutti. Per questo, il più prestigioso leader della Cgil, quando
parla in qualità di deputato alla Costituente, prende la parola come “rappresentante delle
masse lavoratrici che fanno parte dello Stato e che non sono contro lo Stato
”.
Tutto vero; ciò non toglie che l’automatica sostituzione delle
clausole collettive alle clausole individuali difformi non è sancita in tutti gli
ordinamenti e che l’efficacia generale del contratto collettivo è ottenibile
anche senza impiegare tecniche che presuppongono o promuovono l ’
inserimento del sindacato non solo nello Stato-ordinamento, ma anche nello
Stato-apparato, ad una tale profondità e con tali ramificazioni che ad un certo
punto un maestro del realismo giuridico italiano (M. S. Giannini) non potrà
più esimersi dal qualificare seccamente i maggiori enti esponenziali degli
interessi delle categorie economico-professionali, incluse quelle degli
imprenditori, come amministrazioni pubbliche parallele alle amministrazioni
statali.
Per questo, se accendi un pc con programmi aggiornati all’
ultimo anno del Novecento e clicchi in rapida successione sulle icone “
sindacato ” e “ contratto collettivo ” , sullo schermo appariranno in
corrispondenza diciture di questo tenore:
“ Associazione più virtuale che virtuosa, in bilico tra le
istituzioni pubbliche e le istituzioni private, ma sbilanciata più verso il
pubblico che verso il privato” e
”Auto-regolazione sociale con caratteri irriducibili sia alle
fonti come categorizzate dal diritto pubblico sia al contratto come definito
dalle codificazioni” (G. Giugni), che dà origine al “rebus di un contratto
privatistico con gli effetti tipici di un atto normativo” (T. Treu). Ormai,
anzi, non è neanche più un contratto: è un’emicrania. Infatti, “non si sa più
con certezza cosa sia e anzi non si sa se il contratto collettivo che un tempo si
diceva ‘di diritto comune’ esista ancora o sia mai realmente esistito”
(A. Tursi).
Ci pensi un po ’ sopra e ti convinci facilmente dell ’
esistenza di una correlazione biunivoca; la bipolarità inscritta nel patrimonio
genetico del sindacato si coniuga con quella di un “ibrido che ha il corpo
del contratto e l’anima della legge” (F. Carnelutti) e, più latamente, si
rispecchia nelle “due anime” del diritto del lavoro: quella privatistica,
conflittuale, egoistica e quella "pubblicistica, partecipativa, attenta alle
interferenze tra la disciplina del rapporto di lavoro ed il funzionamento dell’
impresa e del complessivo sistema economico” (A. Vallebona).
Ad ogni modo, quando l ’Aidlass scelse come tema del suo III congresso
nazionale il contratto collettivo di lavoro – trent’anni fa – i giochi erano ormai fatti.
La giurisprudenza aveva sgominato la dottrina e l’aveva trascinata sul suo terreno. Il che
era stato più facile di quanto non si creda, perché né l’una né l’altra avevano in mente
“un contratto la cui efficacia normativa non rinviasse ad altro che al contratto medesimo,
cioè alla stessa libertà negoziale delle organizzazioni” stipulanti (A. Tursi). Infatti, i
giuristi-scrittori dello star-system accademico non contestavano che il collettivo prevalesse
e dovesse prevalere sull ’individuale: rimproveravano alla magistratura la spericolata
accondiscendenza con cui avvalorava la loro gerarchizzazione. E’ infrequente, però, che
la giurisprudenza si lasci intimorire dalle critiche della dottrina. E ciò per molti motivi: non
ultimo quello attinente alla possibilità concreta di svolgere un ruolo di supplenza
legislativa avvalendosi di un potere decisionale del cui esercizio risponde unicamente a se
stessa. La giurisprudenza, insomma, dispone delle risorse per “edificare come se la
sabbia fosse pietra ” , direbbe Jorge Luis Borges, e consentire alle sue profezie di
auto-adempiersi. Per questo, la comune accezione del contratto collettivo invalsa nell’
esperienza è stata quella che la creatività giurisprudenziale aveva riplasmato.
Vero è che il tratto distintivo del mestiere del giurista è non tanto la bontà
dei risultati caldeggiati quanto piuttosto la persuasività degli itinerari percorsi per arrivarci.
Tuttavia, si può seguitare a trascurare una dilagante e compatta giurisprudenza? Per questo,
con l ’ equilibrio e la ragionevolezza che gli sono abituali, Gino Giugni avanzò
prudentemente l’ipotesi di un onorevole armistizio tra dottrina e giurisprudenza.
Preso atto che la costante interpretazione giurisprudenziale ne aveva “
ingenerato la certezza” nelle stesse parti contraenti, Giugni propose di qualificare l’
inderogabilità degli effetti del contratto come “un elemento naturale dell’assetto pratico
degli interessi” che integra la pattuizione individuale ex art. 1374 c.c.
L’ipotesi venne immediatamente respinta con aristocratico distacco da
esponenti dello star-system accademico come Luigi Mengoni e Giorgio Ghezzi; ma
nettamente più pronunciata era la proclività di altri giuristi-scrittori ad accettare il ruolo di
glossatori della giurisprudenza.
Probabilmente, la tendenza apologetica raggiunse il culmine con la folta
schiera dei giuristi-scrittori i quali, pur censurando l’uso giudiziario dell’art. 2077 c.c.,
ne approvavano incondizionatamente la finalità al punto di infatuarsi di una concezione
dell’interesse collettivo che può essere definita magico-religiosa. Viceversa, se avessero
adottato un atteggiamento un po’ più laico, si sarebbero accorti che un interesse
corrispondente a quello che si immaginavano – un Giove signore dei fulmini – non c
’è. Non c’è mai stato, tranne che nei testi di mitologia giuridica. Se poi avessero avuto
qualche esperienza personale delle dinamiche che si sviluppano nei processi di formazione
del consenso sociale, avrebbero scoperto che la pluralità degli interessi collettivi dà origine
ad una specie di Olimpo dove ciò che manca – come scrisse con graffiante arguzia
Massimo Severo Giannini a proposito degli interessi pubblici – “sono proprio gli dei
maggiori, anzitutto Giove, capaci di mettere un po’ d’ordine” non solo nei loro
apporti interni, ma anche nei rapporti coi comuni mortali e con lo Stato. Ai comuni mortali
non rendono conto di come li sostituiscono nelle scelte che li riguardano e lo Stato, che si
vuole tenuto a sanzionarne l’assoggettamento alla disciplina conforme all’interesse
collettivo, non ha la possibilità di verificare la legittimazione dei portatori di quest’ultimo
a disporre degli interessi individuali.
Alla fin dei conti, il tentativo a mio avviso più riuscito di razionalizzare l’
operato d’una giurisprudenza contraria all’opinione secondo la quale “tutti gli articoli
che il codice dedica al contratto collettivo (sono) talmente vincolati all ’ordinamento
corporativo da non poter essere considerati in vigore”, e propensa ad annoverare l’art.
2077 tra gli “articoli ‘sganciabili’ dall’ordinamento corporativo, nel presupposto
che il contratto collettivo non deve mancare di efficacia reale per essere propriamente tale
” (L. Riva Sanseverino), è stato sviluppato in una monografia che non risulta dagli Atti
del Congresso Aidlass del 1967 sia stata mai citata nel dibattito –
presumibilmente, all’epoca era fresca di stampa o ancora in bozze e l’
autore (pardon, l’autrice) era assente o silente.
Il metodo usato – come si dice anche oggi, ma allora si pretendeva di più
– è rigorosamente tecnico-giuridico. E’ lo stesso metodo di cui si sarebbe servito una
diecina di anni più tardi Francesco Galgano per dimostrare che gli “accordi tra gli
associati” a cui si richiama l’art. 36 c.c. non esauriscono la disciplina del contratto
associativo. E ciò perché è dato rinvenire norme che, pur costituendo parte integrante del
nucleo formato dagli artt. 14-35, appaiono legislativamente formulate per l’associazione
riconosciuta in quanto associazione. Pertanto, essendo estranee alla finalità
della specifica disciplina che consegue al riconoscimento, esse costituiscono
il contenuto minimo legale del contratto associativo e sono applicabili anche
alle associazioni non riconosciute come persone giuridiche.
Non dissimile è la razionalità del criterio selettivo proposto da
Cecilia Assanti con riferimento alle norme contenute nel capo III del tit. I del
Libro V del codice civile.
Anche lei muove dalla premessa, che la giurisprudenza considera ius
conditum, della immutabilità della funzione sociale del contratto collettivo
come “ specie essenzialmente unitaria ” , di cui la versione di diritto
corporativo e quella c.d. di diritto comune non sono altro che un ’
articolazione tipologica. Coerentemente, anche lei setaccia una manciata di
norme codificate allo scopo di individuare quelle che, apparendo dettate
legislativamente per il contratto collettivo corporativo in quanto contratto
collettivo, si limitano ad effettuare il fissaggio degli elementi costitutivi del
modello ideal-tipico e pertanto conservano intatta la loro vitalità. In
particolare, possiedono tale capacità di resistenza le norme che, come l’art.
2077, non rinvengono il presupposto diretto della loro applicazione nell’
efficacia generale del contratto collettivo, fermo restando che non sono da
considerarsi abrogate, ma soltanto sospese temporaneamente anche le norme
che presuppongono l’efficacia erga omnes; e ciò perché quest’ultima non è
conciliabile col pluralismo sindacale se non attuando l’art. 39.
Al termine della sua rivisitazione, quindi, l’Assanti trova non
tanto quel che voleva cercare, ma esattamente quel che voleva trovare prima
di iniziare la ricerca, ossia la conferma che il contratto collettivo
post-corporativo è fecondato nel grembo del codice civile e perciò ritiene di
poterlo costruire per differenza specifica su quello codificato; una differenza
di natura più quantitativa che qualitativa (G. Pera) che, essendo perfettamente
compatibile col principio costituzionale di libertà sindacale, non può
precludere al c.d. diritto comune di concedere al contratto collettivo che ne
reca il nome spazi meno avari di quanto non si possa supporre.
In piena sintonia con la giurisprudenza, insomma, il contratto collettivo c.d.
di diritto comune sarebbe in realtà un contratto collettivo corporativo di seconda
generazione, che rispetto all'omologo scomparso si distingue – come
sembrava anche a Giuseppe Suppiej – soltanto in ragione del suo nanismo:
poiché la sua efficacia è soggettivamente limitata, è un contratto collettivo
corporativo in formato-bonsai.
Così, dopo averla tanto censurata per la sua trasgressiva
creatività, la dottrina presta un’argomentazione elegantemente assolutoria ad
una giurisprudenza che aveva sempre pensato che bisognasse riporre in
frigorifero tutte le norme legificate riguardanti il contratto collettivo e aveva
sempre creduto o sperato –
raramente temuto –
che sarebbero
gradualmente maturate le condizioni opportune per servirle come un
surgelato, nella misura in cui si fosse venuta formando una situazione
sostanzialmente equivalente al tipo contrattuale diventato in apparenza un
reperto archeologico.
L’efficacia erga omnes, però, restava un sogno proibito: le mani
fatate d’un’estetista diplomata non bastavano a compiere il miracolo.
Ciò non significa che magistratura e Parlamento si limitassero ad aspettare
Godot. Coscienziosamente ontologizzato, il contratto collettivo corporativo era ormai
diventato il paradigma delle regolamentazioni-tipo di rapporti di serie quali sono i rapporti
di lavoro e l’erga omnes un traguardo poco meno che ossessivo, un tabù, un
feticcio. Certo, sapevano che era dura sfidare la collera e lo sdegno provocati
da ogni tentativo di violare i sacri confini del potere di rappresentanza
esercitabile dai contraenti collettivi secondo i principi civilistici. Per giudici e
legislatori, infatti, il problema maggiore è sempre stato, più che altro, quello
di agire con discrezione, di non essere colti platealmente con le dita nella
marmellata, di non essere così insolenti da risultare indifendibili.
Esemplare è il bon ton esibito dal Parlamento in occasione dell ’
approvazione della famosa legge delega del ’59.
Sostenuti dal comprensibile intento di non esporla al rischio di una
bocciatura ad opera della Corte costituzionale, i suoi autori fingeranno che l’attuazione
dell’art. 39 fosse imminente. Le leggi delegate, scrivono nell'art. 6, "saranno emanate (...)
entro un anno (…) o nel minor termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa
dell’art. 39 della costituzione”. L’affermazione era palesemente farisaica; ma la Corte
dovette prenderla per buona e, per salvare la legge, concluse che il regolamento legale dei
rapporti di lavoro instaurato con un metodo alternativo a quello caro ai padri costituenti
aveva il carattere della transitorietà, con ciò dimostrando che l’ipocrisia non è soltanto
“l’omaggio che il vizio rende alla virtù” – come pensava quel moralista di La
Rochefoucault. Talora, anche l’ipocrisia può essere virtuosa; e noi che non siamo dei
moralisti sappiamo che è vero.
Quella è stata l’unica volta che un legislatore dell’Italia repubblicana,
invidioso della libertà di manovra che il suo balbettante predecessore aveva potuto
prendersi tra il ’43 e il ’47, confessò che la ritardata inattuazione del quarto comma
dell’art. 39 cost. era – anche per lui – una sciagura. E’ stata la prima volta. Ma
sarebbe stata l ’ ultima. Dopo, infatti, non si è mai discostato da uno stile di
comportamento di rara compostezza. Uno stile che ricorda quello dei generali francesi
dopo Sedan: “pensarci sempre, ma non parlarne mai”.
La giurisprudenza, no. Disinibita e sbrigativa anche a costo di apparire
rozza – come è testimoniato, inter alia, dal dominante orientamento che identifica la giusta
retribuzione sacralizzata dall’art. 36 cost. in quella prevista dai contratti collettivi
post-corporativi – optò per la linea del “si fa, ma non si dice”. E non solo la
giurisprudenza di merito. La stessa Corte di cassazione – che pure era “tanto ferrea e
inamovibile nel difendere il principio dell’applicabilità del contratto (post-corporativo) ai
soli iscritti” – non è mai stata severa quando si trattava di “convalidare le acrobazie
che i giudici di merito (si erano allenati a) compiere per disattendere in concreto tale
principio” (P. Ichino).
Dal canto suo, nemmeno la Corte costituzionale si è mai tirata indietro
quando è stata chiamata a coonestare la funzione para-legislativa del contratto
post-corporativo. E, al riguardo, vale la pena di rammentare che hanno cominciato
prestissimo ad interpellarla: subito dopo il suo insediamento istitutivo.
La vicenda ha inizio con un quesito consistente nel sapere se fosse
costituzionalmente corretto che un giudice condannasse un imprenditore non iscritto ad
alcuna delle associazioni che avevano stipulato un contratto collettivo post-corporativo per
inosservanza del medesimo. Vero è, si lamentava l’imprenditore, che una legge del ’
55, non priva peraltro di precedenti analoghi, vietava che il salario degli apprendisti fosse
inferiore a quello previsto dai contratti collettivi; però, i contratti a cui essa rinviava erano
sprovvisti di efficacia generale. Non senza un fraseggio visibilmente impacciato, la Corte
respinse l’argomento, sentenziando che la legge non intendeva attribuire al contratto
post-corporativo un’efficacia impropria mediante una surrettizia attuazione dell’art. 39
cost.; piuttosto, era il contratto che permetteva alla legge di produrre l’efficacia che le è
propria ed era a questo fine che la legge denunciata per incostituzionalità gli assegnava la
rilevanza di un fatto il cui verificarsi integra e perfeziona il precetto legale.
Nel gennaio del 1957 pochi potevano supporre che lo schema di
ragionamento seguito dall’Alta Corte fosse destinato ad affinarsi e articolarsi fino a
diventare uno dei pilastri che hanno sostenuto il peso dei rapporti di cooperazione
funzionale tra legge e contratto collettivo nel dopo-costituzione. E ciò perché incontrava
ancora animosità, incredulità o chissà che altro l’opinione per cui l’inattuazione del
quarto comma dell’art. 39 cost. si sarebbe protratta sine die e Godot non sarebbe mai
arrivato. Solamente quando è apparso evidente che, col succedersi delle legislature, i
rapporti tra legge e contratto collettivo c.d. di diritto comune acquistavano sistematicità e si
arricchivano in maniera impensabile pur restando indefiniti, (non solo) l’Alta Corte si
renderà conto che piegarsi al pragmatismo della regola non scritta per cui la legge non può
fare a meno del contratto collettivo era un atto dovuto.
Quanto, invece, alle “acrobazie” giudiziarie – poco più di piccole
astuzie, tutto sommato, al confronto con quelle in cui si esibivano e si sarebbero esibiti i
Parlamenti – che permettevano di dilatare, alla spicciolata e furtivamente, la sfera di
efficacia soggettiva del contratto collettivo post-corporativo, generalmente incontravano
indulgenza. Un’indulgenza che l’inclinazione dei giudici ad imitare Robin Hood non
basterebbe a giustificare. Essa, in realtà, è troppo estesa e istintiva per non alimentarsi della
incrollabile persuasione che è inutile resistere alla tendenza del contratto collettivo ad
allargare il proprio ambito di operatività: è inutile, perché corrisponde ad una diffusa
aspettativa.
Sarà un atteggiamento volpino, ma quando nel nostro mestiere
ci capita di registrare che una somma di forzature o deviazioni, di finzioni o
espedienti si è tramutata in un solido e costante orientamento di pensiero, è
consigliabile trattarlo per ciò che è: ravvisarvi l’espressione compiuta di un
progetto di politica del diritto, ricostruirne la logica e misurarne l’impatto.
Per questo, ho molto apprezzato che uno dei più disincantati
giuristi-scrittori dello star-system accademico non abbia saputo trattenersi dal
compiere un gesto di riparazione, sia pure tardiva. Riconoscendo alla “
spregiudicata” ed ”eclettica” giurisprudenza del periodo qui considerato
il merito di avere realizzato “le condizioni regolative eteronome necessarie,
ma anche sufficienti per un ordinamento sindacale di fatto”, Tiziano Treu ne
ha celebrato l’ elogio postumo. Dopotutto, l ’efficienza regolativa del
contratto collettivo della seconda metà del Novecento italiano è un portato
innovativo del conservatorismo di un ceto giudiziario che non esitò a calare il
contratto collettivo post-corporativo nel modello del contratto collettivo
codificato in Italia nella prima metà del medesimo secolo.
3. – Il progetto di politica del diritto.
Il progetto giurisprudenziale di politica del diritto è
strutturalmente binario. Riguarda il contratto collettivo e, al tempo stesso, il
conflitto collettivo. Pertanto, sarebbe arbitrario spezzarne la coesione interna,
smontarne i pezzi ed esaminare separatamente gli sviluppi applicativi di
ciascuno di essi. La chiave di lettura non può non essere unificante, perché lo
impone la stessa chiave di volta dello statuto epistemologico del diritto
sindacale, dove il giudizio di disvalore che colpisce il conflitto non ha mai
nemmeno sfiorato il contratto collettivo; uno statuto che celebra l’apologia
del contratto collettivo come profilattico del conflitto. Infatti, quello in cui
avrebbero voluto vivere gli ideatori dell’abc e della grammatica del diritto
sindacale nell’Occidente europeo era “il paese dove non si sciopera” e
dove la contrattazione collettiva assomiglia alla “contrattazione di borsa
(che) si apre e si chiude con fulminea rapidità e senza tante discussioni”,
come auspicava Francesco Carnelutti. Ad ogni modo, l ’ esperienza
giuridico-sindacale (anche) comparata sta lì a testimoniare che la
desiderabilità del contratto collettivo aumenta in misura inversamente
proporzionale alla conflittualità che accompagna i processi di formazione del
consenso e l’apprezzamento della sua attitudine regolativa è una variabile
dipendente dalla sua affidabilità come base di calcolo dei costi di produzione
fino alla scadenza prevista.
Era inevitabile, quindi, che la medesima asimmetria valutativa si
riproducesse nel progetto di politica del diritto accarezzato per decenni
dal ceto giudiziario.
La valorizzazione giurisprudenziale dell ’ autonomia contrattuale
collettiva ha proceduto contestualmente alla demonizzazione del
conflitto e anzi la ri-regolazione di quest’ultimo, pur rivelando il
medesimo atteggiamento acritico e inerziale che i giudici prediligevano
quando si occupavano del contratto collettivo, è l ’ esito di un
maquillage assai più leggero e superficiale delle preesistenti regole
repressive. Proprio per questo, però, non solo a me è sempre sembrata un
’ ingenuità qualificare tout court un “ errore felice ” l ’ innesto
giudiziario dell’art. 2077 sul contratto collettivo post-corporativo. Vero
è che, fondando sul diritto positivo il principio della prevalenza del
collettivo sull’individuale a cui consegue l’automatica applicazione
delle clausole collettive al posto di quelle divergenti del contratto
individuale, la giurisprudenza ha impedito che “la stessa funzione delle
associazioni sindacali (fosse) gravemente pregiudicata ”
(A.
Cataudella). Anzi, tenuto conto dell ’ epoca del predetto innesto
giudiziario – un’epoca nella quale il potere del movimento sindacale
è così tenue da non riuscire ad imporre la regolare periodicità del
rinnovo dei contratti nazionali neanche nella categoria-pilota dei
metalmeccanici, che dovrà attendere due lustri per rinegoziare il suo
primo contratto post-corporativo – non è mica da visionari parlare di
atteggiamento promozionale o di sostegno ante litteram.
Questa però non è che una mezza verità. Essa va completata osservando
che la giurisprudenza – pur senza sbandierare l’esistenza di un nesso di
corrispettività, perché teorizzare non è il suo mestiere – considerava la
garanzia dell ’ automaticità dell ’ efficacia regolativa del contratto
collettivo come una moneta di scambio politico. Come dire: il suo
contributo ad impedire l’indebolimento dell’autoregolazione sociale
equivaleva al pedaggio che il supplente del legislatore era disposto a
pagare per prevenire incendi, ossia per soddisfare la medesima esigenza
di ordine pubblico che
sospingeva il medesimo supplente del
legislatore a mantenere quanto più possibile sul collo delle associazioni
sindacali le briglie che il codice Rocco aveva confezionato per loro –
con buona pace dell’art. 40 cost., ma con la fondata presunzione che il
supplito se ne rallegrasse.
Se è giusto riconoscere alla giurisprudenza consapevolezza
del ruolo da svolgere e coerenza decisionale, non le si fa un torto asserendo
che non poteva certo essere lei il fattore più adatto ad incentivare il
cambiamento del corpus normativo, la cui ossatura essa medesima andava
cementificando, e ad incoraggiare la crisi degli equilibri che essa medesima
stava diligentemente stabilizzando; equilibri che erano garantiti proprio dalle
gabbie del contratto collettivo nazionale di categoria, l’unico che potesse
operare a giudizio delle stesse parti sociali sicure, almeno in questo, di non
tradire le attese dei padri costituenti.
4. – Niente può fallire come il successo.
In un manuale che ha avuto un discreto successo (più di
critica che di pubblico, come si dice d’un film di classe con modesti
borderò) si rileva che, proprio negli anni coincidenti con la fase del
rinnovamento del diritto sindacale, il protagonismo della giurisprudenza
improvvisamente si smorza. L’annotazione è esatta. Ma sarebbe sbagliato se
fosse formulata col tono sarcastico che è familiare ad uno dei co-autori del
manuale. Piuttosto, è giusto interrogarsi sulle ragioni della diminuita
influenza dei giudici sul destino del contratto collettivo.
Come è noto, l’innovazione più dirompente che è dato
registrare nel dopoguerra sul versante delle regole collettive del lavoro è
costituita dall’ascesa di “un modello di contrattazione aziendale articolato
sulla base delle specifiche condizioni delle singole unità produttive”. E’ il
contratto collettivo di impresa. Il suo avvento non solo movimenta un
paesaggio monumentalmente plumbeo – quello formatosi per effetto di una
contrattazione centralizzata che si era sviluppata, secondo i canoni della
cultura sindacale egemone, “nell’ambito indifferenziato di una classe
operaia livellata alla soglia del pauperismo” (G. Giugni) – ma schiude
una prospettiva ricca di potenzialità estranee alla tradizione rivendicativa e
giuridica.
“Se non vorrà ridursi a mero fatto tattico” – presagisce
Gino Giugni con largo anticipo – la contrattazione aziendale potrà costruire
“una nuova e più efficiente rete di istituzioni aziendali che dal loro nascere
dalla concretezza di rapporti e situazioni materiali ” ricavano la
legittimazione a correggere penalizzanti distorsioni: da quella che fa del
contratto collettivo un etero-comando avente la natura di un sostituto
funzionale della legge e ne mitizza i caratteri di regolamento imperativo a
quella che comprime la fase di amministrazione del contratto collettivo all’
interno di una cornice processuale che, quanto alle controversie individuali,
non solo esalta la separazione, contestabilissima anche sul piano della teoria
generale, tra ius dicere e ius dare, ma concede rilevanza al solo interesse dell
’ attore, distruggendone il nesso d ’ interdipendenza con l ’ interesse
collettivo di cui i processualcivilisti chiacchierano coi brividi del neofita fin
dall’inizio del secolo, perché “la controversia è collettiva non solo quando
sia immediatamente colpito l’interesse comune ai componenti del gruppo,
ma anche quando sia immediatamente colpito l ’ interesse del singolo
appartenente al gruppo” (F. Santoro Passarelli).
Bisogna convenire che l ’ inventiva eccitabile da
problematiche del genere non può sbocciare in un’aula giudiziaria. Questo,
anzi, è l’ambiente meno favorevole, perché proprio la propensione dei
giudici a tutelare le posizioni individuali nei confronti del potere
collettivo-sindacale, ed a premiare l’abilità con cui “l’avvocato di parte
che si prenda gioco della faticosa e sovente improba attività negoziale svolta
dai rappresentanti sindacali per raggiungere un equilibrio che contemperi gli
interessi di tutti" (G. Giugni), “ha contribuito a precludere in Italia lo
sviluppo di forme di giurisprudenza industriale” (T. Treu).
Neanche fuori, del resto, la voglia di innovare trova una
dimora adeguata; né l’avrebbe trovata in seguito, perché i trend della
contrattazione aziendale avrebbero smentito gli oroscopi più promettenti e
lusinghieri in ordine alla qualità dei suoi contenuti. Vero è che essa nasce in
polemica col contratto collettivo nazionale e che per parecchi anni si stenterà
a controllarne l’effetto-urto, ma la competizione tra centro e periferia
raramente è uno scontro tra culture alternative delle relazioni industriali. E’
documentabile, infatti, che la contrattazione aziendale si è allontanata
episodicamente e il meno possibile dalla logica redistributiva che pervade di
sé la contrattazione del livello superiore e, specializzandosi nelle impennate
salariali, si è consumata come una torcia che cerca, famelica, la direzione del
vento proveniente dai luoghi in cui si produce ricchezza.
Come dire che il contratto collettivo nazionale abbandona le sue
antiche pretese di omnicomprensività ed esclusività, ma niente sembra
poterne sbiadire il pathos custodito e venerato nella memoria storica di intere
generazioni di operatori (non solo) giuridici come si addice all’espressione
più significativa dell’autonomia privato-collettiva.
Insomma, col contributo dell’ideologia della sinistra che lo
sovraccarica del compito di salvaguardare l’unità della classe, il contratto
collettivo nazionale di categoria resta l’architrave del sistema delle fonti
regolative dei rapporti di lavoro e il contratto collettivo di impresa,
sconosciuto all’ordinamento sindacale corporativo, sarà a lungo percepito
come atipico anche nell’ordinamento sindacale post-corporativo.
Non è affatto casuale, quindi, che le cautele con cui (non solo)
la giurisprudenza lo ha inizialmente accolto non avessero una motivazione
diversa da quella che, una ventina d’anni dopo, la proliferazione di contratti
individuali di lavoro divergenti dal prototipo legificato, giurisprudenziale e
negoziato dai sindacati solleciterà all ’ arroccamento difensivo il ceto
professionale degli operatori giuridici (tranne isolate eccezioni) e sindacali.
In effetti, se gli operatori giuridici e sindacali del Novecento
hanno interiorizzato il colossale pregiudizio favorevole al lavoro dipendente
che li inchiodava all ’ idea che il sistema normativo intorno ad esso
edificato potesse agglutinare, inglobare, omologare tutte le figure contrattuali
mediante le quali avviene l’integrazione del lavoro nei processi produttivi,
non può sorprendere che non abbiano prestato la minima attenzione alla
determinatezza storica del contratto collettivo nazionale di categoria.
Dopotutto, l’affinità esistente tra quest’ultimo e il contratto di lavoro
stabile a tempo pieno è troppo stretta per non provocare reazioni identiche di
fronte alla crisi di entrambi. Quella affinità sussiste proprio perché, figlio
legittimo del Novecento, il diritto del lavoro ha fatto quel che doveva.
Per soddisfare la domanda di sicurezza che nella civiltà
industriale scaturisce anzitutto dall’impossibilità di procurarsi da vivere
onestamente se non lavorando alle dipendenze altrui e, al tempo stesso, per
rendere “ possibile l ’ organizzazione della produzione su scala mai
conosciuta e quindi la stessa riproduzione del capitale” (G. Giugni), ha
inventato il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Che sarebbe
diventato il simbolo giuridificato della concezione del diritto al lavoro che
accompagnò la formazione delle costituzioni post-liberali e gli è rimasta
abbarbicata con l’aiuto di un collante che pareva indistruttibile: il dogma
interpretativo del patto costituzionale che fa del lavoro salariato il passaporto
per la cittadinanza. Infatti, la disciplina limitativa del licenziamento è stata
una tête de chapitre del diritto novecentesco del lavoro proprio perché era un
modo – insufficiente quanto si vuole e, forse, oggettivamente, ma
incolpevolmente distorsivo – per onorare la cambiale del diritto al lavoro
inteso come promessa rivolta a “tutti i cittadini di vivere dignitosamente
grazie all’occupazione stabile nel lavoro subordinato” (M. D’Antona).
Il suo valore paradigmatico si lega all’inconfessata
grandiosità dell’obiettivo che si propongono le classi dirigenti delle società
industriali: generalizzare un codice di riferimento culturale che i comuni
mortali, non avendo la possibilità né di sceglierlo né di rifiutarlo, possono
soltanto interiorizzare. Il diritto del lavoro del Novecento possiede per l’
appunto il dosaggio della prescrittività necessaria (anche se, da sola, non
sufficiente) a determinare l’effetto atteso, sia perché riflette fedelmente l’
atteggiamento verso il lavoro che corrisponde al fabbisogno dell’economia
capitalistica nell ’ era fordista sia perché il sistema dominante della
produzione di massa non produce soltanto vetturette ed elettro-domestici:
prefigura un modello di organizzazione sociale.
“L’industrialismo”, scriveva Herbert Spencer nel
tardo Ottocento, “non deve essere confuso con l’industriosità”.
A differenza del secondo, il primo vocabolo non designa situazioni
caratterizzate soltanto dalla diligente erogazione di ingenti quantità di lavoro, dalla
disponibilità diffusa a darsi da fare, dalla generale condivisione di un’etica del lavoro
come misura della responsabilità di ciascuno verso se medesimo e la comunità. Piuttosto,
designa un certo modo di produrre che diventerà in fretta anche un certo modo di pensare.
L’industria, infatti, è stata uno dei grandi laboratori della socializzazione moderna di cui
tutti finiranno per enfatizzare l’ubiquità, considerandola come un luogo non solo fisico,
ma anche mentale, perché è in fabbrica che si impara a comprendere come il benessere
personale dipenda da quello collettivo e ad apprezzare il legame esistente tra l’interesse
individuale e l’interesse del gruppo omogeneo di cui si fa parte; perché è lì che l’
ubbidienza è premiata e la soggettività degli individui che non si esprima attraverso schemi
di comportamento gregario è soffocata, cancellata, repressa..
Insomma, è come se il diritto del lavoro non dovesse adempiere
soltanto il non facile compito di risolvere i problemi esistenziali dei comuni
mortali compatibilmente con le esigenze di funzionamento della fabbrica, ma
si fosse anche sobbarcato al ruolo pedagogico di trasmettere all’intera
società gli input necessari per risolvere i propri. L’autore di un classico della
storiografia contemporanea (La rifondazione dell ’ Europa borghese) si
attribuisce, non a torto, il merito di essere stato “uno dei primi a segnalare il
ruolo del taylorismo e del fordismo come elementi ideologici della stabilità”
e del consolidamento di un ordine sociale dove tutto è prestabilito (C. S.
Maier). Ma è mia opinione che, se non fossero stati trattenuti da preclusioni di
natura metodologica, i giuristi del lavoro siano sempre stati nelle condizioni
ideali per precedere tutti, perché nessuno scienziato sociale era più di loro
avvantaggiato dalla professione per poter acquisire la certezza che l ’
ordinamento dell’industria era diventato l’ordinamento della società con la
mediazione dell’ordinamento giuridico. E’ questa la principale tappa
raggiunta dal diritto del lavoro nel suo secolare tragitto. Una tappa che, pur
non essendo il suo capolinea, ha del prodigioso. Per questo, Renato
Scognamiglio ha potuto definirlo “il” diritto del secolo.
Per rendersene conto, occorre sapere che il diritto del lavoro non sarebbe neanche
venuto al mondo se nell’Ottocento europeo non ci fossero state moltitudini crescenti di
poveri che bisognava togliere dall ’ emarginazione per integrarne vasti strati nei
meccanismi della produzione capitalistica; che, se non ci fosse stato il diritto del lavoro del
Novecento, la povertà non avrebbe avuto le incentivazioni né temuto le sanzioni più adatte
per educarsi alla laboriosità; che, se la povertà non si fosse trasformata da oziosa o
pericolosa in laboriosa, non sarebbero maturate le condizioni di base per legittimarla a
rivendicare che la cittadinanza diventasse il diritto di tutti che è oggi e lo Stato monoclasse
lo Stato pluriclasse che conosciamo. In effetti, sebbene i mendicanti e i vagabondi siano
sempre esistiti, nella storia delle nazioni dell’Occidente europeo presto o tardi è arrivato
il momento in cui, non bastando più né la pietà né la forca, bisogna imparare a trattarli
coerentemente con una riprogettazione della società aderente alle esigenze dello sviluppo
economico e sociale in regime liberal-democratico.
Benché cronologicamente sfasato, il momento coincide con la presa d’atto da parte
delle singole borghesie nazionali che le cose si sono messe in modo tale per cui povero non
è più soltanto il marginale o il deviante; è anche l’operaio della manifattura, come
testimoniano “le condizioni di vita quotidiana, la situazione abitativa, lo stato di salute, le
famiglie numerose, l’aspetto esteriore” (B. Geremek) che lo trattengono in fondo alla
scala sociale. Senonché, la proletarizzazione conferisce un carattere nuovo al fenomeno
antico della povertà. Per certo, lo rende ingovernabile con le pratiche dell’Ancien
Régime, sia quelle caritatevoli-assistenziali che quelle repressive. Infatti, la pietà e la forca
simboleggiano una politica di esclusione sociale, mentre proprio questo è l’obiettivo non
più desiderabile né desiderato, perlomeno con l’intensità di prima, sia per nobili ragioni
di principio che per calcoli d’interesse, peraltro sensati e non miopi. Anzi, diventa
importante e urgente individuare “una via per far accedere anche i poveri al diritto” (G.
Procacci) e, poiché costoro non possiedono che il proprio lavoro, è soltanto nei dintorni del
lavoro che prestano alle dipendenze dei proprietari dei mezzi di produzione che si formerà
l’unico diritto accessibile da loro: un diritto che è del lavoro nella stessa misura in cui è
sul lavoro, perché concede al lavoro la parola, ma contemporaneamente gli vieta di alzare
troppo la voce.
Quello del lavoro, però, non è soltanto il diritto del secolo. E’ anche il più
eurocentrico dei diritti, perché è figlio del compromesso che ha maggiormente avvicinato l
’Europa alla soluzione del problema della “quadratura del cerchio” ossia, come dice
Ralf Dahrendorf, della coesistenza delle tre esigenze fondamentali delle società evolute:
benessere economico, coesione sociale, democrazia politica. Senza il diritto del lavoro, il
tentativo di rifondare l’Europa borghese alla fine della Grande guerra e dopo la Grande
crisi del ’29 non avrebbe avuto gli esiti che conosciamo, perché i meccanismi di governo
non sarebbero stati lubrificati nella misura necessaria e sufficiente ad impedire che la
disperazione di masse di sfruttati, perdenti, disadattati superasse la soglia critica,
rischiando così la catastrofe.
La catastrofe non c’è stata. Ma non chiedete chi ne abbia il merito, sia perché la
paternità del diritto del lavoro del Novecento è, non senza buone ragioni, controversa –
“qualunque sia la concezione del mondo a cui abbiano di volta in volta aderito”, ha
scritto Federico Mancini, “i legislatori europei si sono sempre proposti di modificare (…)
la condizione dell’uomo che vende la sua forza lavoro”, obbedendo così “a una
comunque motivata tensione riformatrice ” –
sia perché la questione non è
appassionante quanto ci terrebbe ad apparire.
La questione della paternità ideale interessa meno di quella consistente nel sapere
quale sia stata l’efficienza pratica del compromesso che ha generato il diritto del lavoro
del Novecento. In ultima analisi, molto altro non dovrebbe interessare in presenza di un
insieme di regole che, per quanto robustamente marcata sia la sua inclinazione a coniugarsi
con progetti di alto profilo (“modelo para armar”, lo ha definito Antonio Baylos), si
nutre più di pragmatismo che di ideologie. Infatti, ha potuto sopravvivere perché ha saputo
adattarsi – poco per scelta e molto per obbligo – ai cambiamenti della società.
Entro questi limiti, il suo ruolo è stato salvifico perché ha contribuito a “quadrare il
cerchio ” ossia a realizzare un equilibrio soddisfacente. Un equilibrio che è stato
sostenibile quando e finché tutti gli indicatori macro-economici – dal volume della
produzione alla massa di ricchezza ridistribuita, al livello occupazionale – hanno potuto
convergere nella medesima direzione all ’ interno delle coordinate tracciate dall ’
espansione dell’industrializzazione e dalle politiche keynesiane dell’intervento statale.
Ciò significa forse che all’elogio del lavoro bisognerebbe associare l’elogio delle
sue regole novecentesche?
Può darsi, e non è il caso di nasconderlo. Al contrario, in quanto ricomprende il
complesso delle misure compensative adottate per correggere, prevenire, attenuare gli
iniqui effetti dell’economia di mercato con i suoi vincitori e i suoi vinti, il diritto del
lavoro del Novecento è la risposta alla domanda di sicurezza che sale dai piani bassi dell’
edificio sociale. Al tempo stesso, poiché si propone di evitare sfratti traumatizzanti o
sanguinose defenestrazioni degli inquilini dei piani alti, bloccando o frenando le spinte che
minacciano di sgretolare le fondamenta del sistema capitalistico, è l’insostituibile tecnica
di stabilizzazione dinamica degli equilibri storicamente possibili.
Per questo, io morirò persuaso che le democrazie sono debitrici verso il moderno
diritto del lavoro perché - se sono sopravvissute nel secolo della rivoluzione industriale e
anzi si sono estese, consolidate, perfezionate - lo devono anche a lui.
Di strada, dunque, il diritto operaio ne ha fatta tanta. Pur non essendo
né dotto né censitario, ha spiccato il volo; è volato oltre la collinetta che
chiudeva il suo orizzonte e non ha avuto paura di pensare in grande.
Tuttavia, non ce l’avrebbe mai fatta se non avesse potuto giovarsi
stabilmente d’un effetto moltiplicatore delle ferite che il contratto di
lavoro individuale provocava nel diritto codificato dei contratti tra
privati. Per questo, il contratto collettivo è la creatura normativa più
corteggiata e coccolata del Novecento.
Inventato per soddisfare le esigenze delle macro-strutture della
produzione di pianificare l’uso, calmierare il costo e comprare il
consenso d’una forza lavoro etero-diretta e massificata, il contratto
collettivo è stato il simbolo giuridificato del principio di razionalità
incorporato in una tecnica produttiva avente la proprietà di predefinire
un assetto rigidamente organizzato della totalità dei rapporti sociali e
degli stessi programmi di vita degli individui. Un simbolo che era
ingigantito dai più appariscenti aspetti esteriori del contratto collettivo a
cui dovevano uniformarsi i contratti individuali: la dimensione
territoriale era la più estesa possibile, di solito coincidente coi confini
nazionali; la platea dei suoi destinatari era indifferenziata e il suo
baricentro gravitava sulla fissazione delle quantità standard di lavoro e
salario scambiate tra il lavoratore-tipo, capo-famiglia-monoreddito, e
imprese alla ricerca di una cassetta degli attrezzi normativi che
facilitassero l’amministrazione dei rapporti di lavoro.
Per essere efficace, la descrizione del contesto storico-culturale di
cui erano espressione, da un lato, un contratto di lavoro in cui trova alloggio
“l’aspirazione del lavoratore a quel complesso di beni – professionalità,
garanzia e adeguatezza del reddito, prospettive di carriera – che sono
indissolubilmente legati all’occupazione stabile” (D’Antona) e, dall’
altro, un contratto collettivo inteso come sostituto funzionale della legge
dovrebbe servirsi di colori che si stemperano nel grigio e di cadenze
salmodianti.
“Questo era il Novecento”, ha scritto Aris Accornero; “tutti ci
alzavamo alla medesima ora, tutti uniformati negli orari giornalieri,
settimanali, annui” e tutti pensavamo che “la vita lavorativa si svolgesse
su tutto l’orario giornaliero per tutti i giorni feriali della settimana in tutti i
mesi lavorativi dell’anno, fino alla pensione. Questo ci ha dato il Novecento
”.
Il percorso esistenziale poteva non riscuotere unanimità di consensi.
Ma la cosa non impensieriva. Contava che esso fosse preordinato al
raggiungimento della sola forma di cittadinanza sociale che il diritto sindacale
e del lavoro poteva realisticamente promettere al popolo degli uomini col
colletto blù e le mani callose; una cittadinanza sociale che Theodor Marshall
definiva industriale anche perché (suppongo) odorava di petrolio, carbone,
vapore di macchine; una cittadinanza sociale basata sul trittico posto
fisso-salario garantito-pensione pubblica.
La promessa è stata onorata.
Ciononostante, ancora prima di andarsene, il Novecento ha fatto lo
sgambetto a questo diritto del lavoro.
Pertanto, adesso che il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
indeterminato non è più la sua stella polare ed i suoi più consentanei scenari (non solo)
normativi sono stravolti, è ragionevole domandarsi come e quanto il contratto
collettivo del Novecento dovrà trasformarsi per seguitare a proporsi come
fonte regolativa privilegiata anche del lavoro “senza aggettivi” ossia del
lavoro considerabile come “ una specie del medesimo genere al quale
appartiene il lavoro subordinato ” in tutte le ipotesi in cui – “
indipendentemente dallo schema negoziale utilizzato” dalle parti per farne l
’oggetto di un’obbligazione contrattuale – costituisce un “elemento
normale e costante nel ciclo produttivo dell’impresa altrui”, a tal segno che
“le sorti di quest’ultima incidono, oltreché sulle vicende di un contratto,
sul destino e sul progetto di vita della persona” che si è obbligata a lavorare
(M. D’Antona).
5. – Senza fideismi né catastrofismi.
Si può anche rassicurare il sindacato che, guardandosi nello
specchio, non ci vede se non una forma storica di rappresentanza degli
interessi che nessuno può sostituire là per là. Bisognerebbe però anche dirgli,
chiaro e tondo, che sbaglierebbe a trarne motivi per autocompiacersi e pretesti
per limitarsi a governare l’esistente, come se avesse un futuro di cui fidarsi
solamente perché ha un passato di cui gloriarsi.
Il fatto è che la sua funzione dovrà diventare, sta diventando,
quella di rappresentare il lavoratore in quanto cittadino piuttosto che il
cittadino in quanto lavoratore.
Le parole sono identiche, ma gli accenti sono diversamente
distribuiti. Ed è proprio nel tentativo di valorizzare il mutato significato della
relazione di interdipendenza fondativa tra lavoro e cittadinanza che sono
entrate in circolazione proposte di “modelli regolativi capaci di seguire la
persona nelle sue attività, senza che sia il concreto contesto organizzativo nel
quale l’attività si iscrive ad imporre il confine della tutela, perché ci sono
dei diritti fondamentali che non riguardano il lavoratore in quanto tale, bensì
il cittadino che guarda al mercato del lavoro come ambito di chance di vita e
dal lavoro (un lavoro che può anche cambiare nel tempo, un lavoro che può
essere autonomo o subordinato) si aspetta identità-reddito-sicurezza, cioè i
fattori costitutivi della sua personalità” (M. D’ Antona). Si tratta di
tipologie normative che, se non sono riconducibili ad una figura social-tipica
unificante e rappresentativa d ’ un mondo del lavoro irrimediabilmente
disgregato, sono tuttavia irriducibili al referente del lavoratore subordinato
dell’età industriale.
Si può anche non dubitare che nemmeno nel nuovo millennio
sparirà l’esigenza di riequilibrare il gap di potere caratteristico dei rapporti
che attuano lo scambio tra lavoro dipendente e retribuzione. Tuttavia, non
diversamente dal diritto legificato del lavoro, il contratto collettivo dovrà
rispondere alla “ domanda di un assetto normativo più adattabile agli
interessi e bisogni del lavoratore in carne ed ossa che a quelli del lavoratore
astratto e massificato del quale ci parlano leggi e contratti collettivi”;
interessi e bisogni, diceva Massimo D ’ Antona, post-materiali e
post-occupazionali, come tali suscettibili di “complicare lo schema basilare
del rapporto di lavoro, che identifica l’interesse tipico e caratterizzante del
lavoratore nella retribuzione”.
Si può anche ritenere che nemmeno gli antagonismi di classe che abbiamo
conosciuto nel Novecento siano finiti. Ma è sicuro che appena agli inizi è la lotta per l
’uguaglianza “intesa come pari opportunità di scegliere e mantenere,
anche nel rapporto di lavoro, la propria differente identità e come pari diritto
di adattare il lavoro al proprio progetto di vita”; ed essa non potrà proseguire
con le tecniche dell’uniformità garantita (M. D’Antona).
Insomma, le cose si sono messe in modo che il contratto collettivo,
inventato dal Novecento per soddisfare le esigenze tipicamente proprie di
regolarizzazione dell’andamento del sistema di produzione dominante ed
insieme di soddisfacimento di aspettative esistenziali diffuse, non è più la
soluzione. E’ diventato esso medesimo un problema. Difatti, tutte le sue
componenti strutturali sono colpite da fibrillazione o stanno per esserlo.
La più oscillante è l’inderogabilità della norma collettiva sia come
sinonimo di immodificabilità se non in melius delle tutele sia come premessa
maggiore del sillogismo giudiziario. Sotto questo secondo profilo, al giudice
del lavoro non si dice di decidere: “gli si dice di pacificare senza decidere”
(E. Resta), o imponendo rimedi alternativi al giudizio dirimente che dovrebbe
pronunciare o attivandoli lui stesso per far cessare la lite senza porsi super
partes, bensì in mezzo a loro per esserne il tramite tenuto a perdere la sua
terzietà ed insieme a non perderla del tutto. Sotto il primo dei profili, mai
come adesso la sindrome della crisi d’un sistema protettivo incentrato sull’
idea che i contenuti dell’eteronomia sono precostituiti da decisori la cui
volontà non può non sovrapporsi a quella dei lavoratori uti singuli è apparsa
estesa. Tant’è che si fa strada l’idea che “l’inderogabilità è una
possibilità, e non (è più) una necessità” (F. Scarpelli), per ammettere patti in
deroga alle regole-standard sovra-ordinate che, declassate da imperative a
semi-imperative, possono essere deprivate dell ’ efficacia reale coi suoi
inesorabili automatismi espropriativi dell’autonomia individuale (R. Voza).
D’altronde, se è vero (come è vero) che l’autonomia individuale
assistita – ed è corretto chiamarla così perché agisce in un contesto che ne
garantisca un ’ esplicazione effettivamente libera – ha (quasi) sempre
trovato una generosa ospitalità nel diritto del lavoro quanto a dismissione di
diritti già sorti da un contratto conforme alla normativa eteronoma, non è
incoerente ipotizzarne un’ulteriore espansione nella fase di costruzione dello
stesso regolamento negoziale in presenza delle condizioni previamente
individuate dalle parti sociali a ciò autorizzate dallo stesso legislatore che, per
un senso malinteso di valorizzazione dell’autonomia collettiva, l’aveva
trasformata in una fonte di diritto oggettivo. Diversamente, non si saprebbe
come contemperare l ’ autorità dell ’ etero-comando con la libertà
individuale; mentre proprio questo è richiesto dalla “sfida delle differenze,
che hanno fatto irruzione nel mondo del lavoro e premono sui congegni
normalizzatori del suo diritto, chiedendo di essere ammesse e rispettate,
anziché tacitate in nome di un interesse generale selezionato chissà dove e
perché” (M. D’Antona).
Se vi è capitato di udire lo schianto d’un albero stagionato, ricorderete
che è lacerante. Ma ne siete ancora impressionati anche perché eravate
incapaci di sentire il rumore della foresta che gli cresce intorno.
Del resto, l’icona che raffigura il contratto collettivo del Novecento è
divinizzata soltanto da superstiti adoratori del formalismo giuridico
indifferenti sia alla storia che alla pratica dell’istituto.
Ad un’occhiata retrospettiva, infatti, non può sfuggire che l’
immagine raffigurata nell ’ icona è l ’ esito compromissorio d ’ una
razionalizzazione che produsse non poche né trascurabili deformazioni,
perché l’ingresso del contratto collettivo nei blasonati sistemi giuridici
euro-continentali, e segnatamente nel nostro, non venne sponsorizzato gratis.
Anzi, il contratto collettivo non vi entrò se non a condizione di subire una
profonda alterazione delle sue originarie connotazioni e difatti – staccato
dalle sue radici prestatuali, trapiantato in un contesto di relazioni quanto più
possibile aconflittuali e perciò artificiali, rigidamente legificato – gli
improvvisati ed ingenui leader del popolo degli uomini col colletto blù e le
mani callose non avrebbero più potuto riconoscervi il figlio sporco, brutto e
cattivo di un primitivismo che rinomati maîtres à penser paragonavano con
casalingo empirismo a quello osservabile nei “mercati di bestiame (dove) la
figura dei mediatori, uomini tarchiati e violenti, con voci rauche, facce rudi,
randelli e bestemmie, è un simbolo dell’arretratezza” dell’ambiente e dei
suoi abituali frequentatori (F. Carnelutti).
Nell ’ ampia misura in cui è conciliabile con i canoni del
positivismo giuridico ottocentesco la concezione normativista dell ’
autonomia collettiva è diventata due volte anacronistica.
Una prima volta, perché persino i Parlamenti hanno cominciato a
trattare le proprie creature con la premurosa apprensione di cui in passato
erano oggetto le ragazze di buona famiglia in età da marito: temendo che
potessero fare incontri sgraditi, magari a loro stessi più che alle figlie, i
genitori non le lasciavano uscire di casa da sole. Così, a causa dell’
insufficiente protezione carismatica del sigillo di Stato, neanche i Parlamenti
mandano più in circolazione le leggi, perlomeno quelle più a rischio, senza l
’assistenza di un chaperon incaricato non tanto di attuare il diritto scritto –
che in effetti assomiglia ad un semilavorato – quanto piuttosto di scoprire il
diritto che non c’è, disponendo di poteri che permettano l’adattamento
creativo delle regole al mutare delle situazioni sottostanti e di un’articolata
metodologia per la risoluzione delle controversie relative alla loro
applicazione. In Italia, e non solo lì, le chiamano Autorità amministrative
indipendenti. Ma la loro denominazione non ha molta importanza. Qualunque
sia, essa immancabilmente rimanda al ruolo più di amministratori di interessi
che di applicatori-interpreti di norme e dunque designa soggetti istituzionali
selezionati per intercettare, monitorare, gestire gli input trasmessi dal
pluralismo sociale e per completare, perfezionare, implementare la legge della
cui applicazione sono garanti in ragione della loro neutralità unita ai saperi
specialistici di cui sono accreditati.
La seconda ragione per cui l’obsolescenza della concezione del
contratto collettivo che ne fa una fonte ascrittiva di diritti soggettivi
immediatamente giustiziabili ha subito una violenta accelerazione è
rintracciabile negli scenari delle relazioni sindacali del tempo presente.
Mai come adesso, infatti, è emerso con chiarezza che, al di là delle
intenzioni o dei desideri delle parti contraenti, residua normalmente una
zona d’ombra nella quale esse restano in posizione di trattativa anche
posteriormente alla sottoscrizione del contratto un po’ perché, come si
insegnava tanti anni fa, la disseminazione di clausole oscure, ambigue o
lacunose è una costante dei processi di formazione dei contratti collettivi,
ma soprattutto perché è diventato impossibile dominare l’accresciuta
complessità
delle
attività
sviluppabili
nel
quadro
della
procedimentalizzazione del potere aziendale coi soli strumenti del
garantismo, individuale o collettivo che sia. E’ soprattutto in seguito
alla dilatazione dell’area delle materie negoziabili per il tramite di
obblighi di consultazione, informazione, “esami congiunti” con le
rappresentanze sindacali in ordine a vicende dell’impresa – e non
solo dell’impresa in crisi – in passato rientranti nelle prerogative
unilaterali del management che le regole-standard – in ragione della
loro astrattezza, generalità e uniformità – risultano sempre più spesso
inadeguate o per eccesso o per difetto e il baricentro del dopo-contratto è
destinato a spostarsi dalla formalizzazione dall’incontro iniziale dei
consensi alla creazione in periferia dell’habitat adatto a favorire il loro
riformarsi in condizioni mutate o disomogenee rispetto a quelle presunte
da strategie centralistiche.
A Franco Liso è venuta in mente la bella metafora – e dicono che di
metafore io me ne intenda parecchio – di “quelle strutture di cemento
armato maldestramente costruite troppo a ridosso della spiaggia. Una
violenta mareggiata le abbatte, erodendone la base. Esse rimangono
intere, ma del tutto inutili. Sarebbe stato meglio arretrarle e trasformarle,
ma non lo si è fatto”.. Come dire che anche le regolazioni ispirate al
garantismo statico bisognerebbe adattarle e rimodularle. “ Invece,
spesso si è assistito all’intransigente difesa dell’esistente ed alla
conseguente esaltazione della mediazione giudiziaria; e talvolta si è visto
nella valorizzazione del ruolo del sindacato una minaccia per i diritti dei
lavoratori”. Il contratto collettivo, insomma, non è più (dato e non
concesso che lo sia stato) la miniera di granitiche certezze di cui
favoleggia un’agiografia giuridico-sindacale che, pur di non ammettere
l’eventualità che alle questioni risolte ex ante soltanto in apparenza si
sommino quelle non previste da affrontare ex post, si rifugia nel mito
dell’inderogabilità.
Mai come adesso, pertanto, sarebbe raccomandabile un modello
dinamico di relazioni gestite da istituzioni (agili, ma) stabili che, se del
caso, aggiornano e rivedono le regole con la cultura della prassi
occorrente per risolvere problemi, anziché con la logica
concessivo-acquisitiva o lamentoso-accusatoria propria del tradizionale
conflitto industriale i cui attori costruivano la propria identità sulla base
dell’esistenza dell’antagonista. “Noi e loro”: questa, per decenni,
è stata la formuletta verbale corrente per rappresentare in termini icastici
non tanto la questione sociale quanto piuttosto uno scontro tra culture.
Con riferimento alla problematica qui tratteggiata, sono estremamente istruttive le
più recenti evoluzioni dell’ordinamento giuridico del lavoro nella Spagna post-franchista.
Esse ci dicono che non è più lecito fare dell’erga omnes l’alfa e l’omega del
contratto collettivo, perché il livellamento dei trattamenti che questa connotazione
comporta confligge con la diversificazione del mercato del lavoro sia su base territoriale
che dal punto di vista della tipologia aziendale.
L’ordinamento spagnolo prevede un modello legificato di contratto collettivo come
fonte regolativa provvista di efficacia vincolante e generale “que sigue en buena
parte pautas del anterior modelo ‘corporativo’ del franquismo”. Ciò che non
era stato previsto né dagli autori dell’Estatuto de los Trabajadores né, fino a pochi
anni addietro, dagli attori sociali è la tracimazione dell’autonomia collettiva sul
terreno del diritto comune, e dunque oltre i confini della sua tipizzazione legale, ossia
la “ recontractualizaciòn del convenio collectivo ” – come scrive Miguel
Rodriguez-Piñero con un gioco di parole solo apparente – per effetto del crescente
dinamismo dell’economia e del mercato che non permette più ai negoziatori del
contratto collettivo di limitare “ su papel al celebrarlo y firmarlo ” se non
pregiudicando la stessa funzione regolativa.
Senonché, l ’ insieme delle innovazioni di diritto sostanziale e
processuale introdotte nel 1973 ha finito per anestetizzare l ’
autonomia privato-collettiva. E ciò perché, se le associazioni sindacali
del dopo-costituzione hanno potuto finalmente considerarsi, ed essere
considerate, “come il re Mida della leggenda, nella condizione di veder
trasformato in norma inderogabile (…) ogni e qualsiasi istituto su cui
pongano le mani” (G. Giugni), al tempo stesso sono state gratificate
dal riconoscimento del potere di convalidare gli atti dispositivi dei diritti
individuali esercitabile nelle forme dell’art. 411 c.p.c. Come dire che la
stessa riforma legislativa con la quale la legificazione del contratto
collettivo post-corporativo ha compiuto un passo in avanti ha,
contemporaneamente, rimesso in moto lo smottamento dell ’ intero
fronte dei diritti individuali di origine pattizia a cui erano legittimate le
associazioni sindacali dell’epoca corporativa per ristabilire la par
condicio tra soggetti dei quali – secondo la sola lettura anticapitalistica
dei problemi giuridici del lavoro allora consentita, una lettura
deamicisiana – uno è, immancabilmente, poco meno che angelicato e l
’altro “socialmente pericoloso” (F. Liso).
Occhio alle date, però. Nell’arco degli stessi anni l’immagine stereotipata del
lavoratore come moderno capite deminutus era sostituita da quella del lavoratore
come delicatus creditor, specialmente nelle organizzazioni produttive di dimensioni
occupazionali medio-grandi dove una tutela forte contro il licenziamento si veniva
saldando con la robusta tutela sindacale prevista dalla normativa statutaria:
perlomeno in queste realtà, insomma, si disponeva dei correttivi ad uno storico
squilibrio nei rapporti di potere. Ciononostante, neanche lì, malgrado il rigoglio
documentato da un palmarès senza precedenti, l’autonomia collettiva ha avuto l’
orgoglio di rivelare “la sua vera natura, che non è quella di sottoporre il lavoratore
ad una sorta di paternalistica tutela” (G. Giugni). Quindi, è inesatto che soltanto i
più accesi supporter della deregulation, come in Italia Pietro Ichino, “non facciano
riferimento alla storia del diritto del lavoro” (S. Simitis). In realtà, il cattivo
esempio l’hanno dato per primi i loro attuali avversari, ponendo così le premesse
del deprimente dialogo tra sordi a cui stiamo assistendo. C’è da chiedersi peraltro
quale concezione di sé abbia l’autonomia collettiva, dal momento che i suoi
portatori si sono arresi con facilità irrisoria all ’ idea messa recentemente in
circolazione da uno Stato che non si vergogna di confessare la bancarotta della sua
giurisdizione. L’idea è che l’autogoverno della micro-conflittualità corrisponde
all’interesse pubblico a decongestionare il circuito giudiziario, laddove “le forme
di composizione stragiudiziale delle controversie individuali di lavoro assumono, in
un sistema di libertà sindacale quale è il nostro, una ragion d’essere propria che
sussisterebbe anche se la macchina della giustizia funzionasse alla perfezione” (G.
Giugni). E ciò perché, delegando ai giudici il controllo sull’applicazione del
contratto collettivo, il sindacato ci rimette del suo. La ragione più incontestabile per
cui i contraenti collettivi hanno un interesse autenticamente proprio ad assumere e
condividere la responsabilità dell ’ organizzazione dell ’ attività
conciliativo-arbitrale è la stessa che eruppe dall ’ esperienza ottocentesca dei
probiviri industriali e venne lucidamente percepita dai nostri giuristi dell’inizio del
Novecento. Essa si manifesta perché “gran parte delle controversie individuali di
lavoro si collegano, in atto o in potenza, a controversie che sono già sorte o potranno
sorgere” – ossia, per dirla in gergo forense, sono controversie seriali – e,
ciononostante, non può sussistere alcuna garanzia che si affermi un orientamento
decisionale omogeneo e solidale con la pressione alla standardizzazione delle
situazioni giuridiche soggettive esercitata dal contratto collettivo. Il giudice è tenuto
ad emettere responsi vincolati ai canoni dell’ermeneutica giuridica. Quindi, è libero
di elaborare decisioni suscettibili di alterare l’equilibrio degli interessi che ha
permesso il formarsi della norma pattizia. Per questo, “stipulare contratti collettivi,
senza riservarsi la possibilità di controllarne l ’ applicazione, equivale per il
sindacato ad abdicare ad una sostanziale porzione del potere contrattuale” (G.
Giugni).
6. – Il ritorno del rimosso.
E’ fin troppo facile prevedere gli interrogativi di sapore
non propriamente simpatetico a cui mi sto esponendo.
Come si può spargere la voce che il contratto collettivo del
Novecento è un falso idolo dopo che la sua legificazione è stata solennemente
invocata dall’accordo di luglio del ’93, sia pure con riferimento ad ipotesi
delimitate, e il Parlamento se ne sta occupando? Come si può coonestare una
simile insinuazione proprio adesso che il contratto collettivo post-corporativo
è diventato, sia pure nel solo pubblico impiego, un contratto nominato? In
ogni caso, con quale credibilità può sostenere che il contratto collettivo del
Novecento ha imboccato il suo sunset boulevard chi, come me, in qualità di
componente d ’ una commissione di studio ministeriale, Tiziano Treu
consule, ha proposto di inserire in un disegno di legge una disposizione che
attribuisse al ministro del lavoro – su istanza congiunta dei contraenti –
la facoltà di recepire in un proprio decreto il contenuto dei contratti collettivi,
ivi inclusi quelli rivolti a trasporre nell’ordinamento interno le direttive
comunitarie?
Omesso il solo interrogativo a cui mi rifiuterei di rispondere
perché lo considero un insulto all’intelligenza (come si può accreditare l’
idea che il modello fordista ed i suoi elementi caratteristici siano un jurassic
park, laddove è arcinoto che cambiamento e conservazione procedono a
braccetto anche in epoche di transizione permanente?), tutti gli altri
interrogativi sono più opportuni che scomodi.
In primo luogo, sollecitano l ’ indispensabile opera di
chiarimento su alcuni dei più chiassosi avvenimenti degli anni ‘90 che
hanno interessato il contratto collettivo – dall’Accordo sulla Politica
Sociale di Maastricht, poi recepito nel trattato di Amsterdam, al decreto “29
” ripetutamente modificato, al Patto di Natale del 1998 – e sugli ultimi
sviluppi del suo rapporto con la legge, sull’ipertrofia normativa che lo
caratterizza e sulle sue ricadute sul modo d’essere del sindacato
In secondo luogo, mi permettono di precisare il mio pensiero.
Leggendo su manuali ed enciclopedie del diritto che la
produzione di massa ha generato sindacalismo e contrattazione collettiva di
massa, soltanto le più tonte matricole delle Facoltà di Giurisprudenza possono
ritenere che il contratto collettivo non possa vivere senza il
fordismo-taylorismo di cui non sarebbe altro che un retaggio. Tocca al
maestro paziente spiegare che l’affermazione “non va intesa in modo
assoluto, perché potrebbe condurre ad una sopravvalutazione del dato
strutturale” (G. Giugni), come tale viziata da un approccio deterministico
che non aiuta a capire come mai lo strumento continui ad essere
universalmente impiegato. La sua persistente diffusione testimonia come l’
“attitudine del contratto collettivo a porsi non solo sul piano sociale, ma
anche su quello giuridico, come fatto normativo” sia slegata più dalle
variabili forme di organizzazione della produzione che non dalla sua
predestinazione “a realizzare l’interesse del gruppo, sintesi e non somma
di interessi individuali” (M. Persiani). Una predestinazione, però, che non è
data. Non è in rerum natura; è voluta, come è desumibile dalla documentata
circostanza che mai – nemmeno all’epoca del dominio della produzione
di massa – il contratto collettivo del Novecento ha trovato bell’e fatta la
rete delle solidarietà degli interessi. Piuttosto, ne ha promosso l ’
autocoscienza a livello di gruppo fino ad apparire come un suo risultato e ne
ha fatto costantemente oggetto di un’accurata manutenzione.
Infatti, la condizione implicita del successo del contratto
collettivo del Novecento risiedeva nella capacità dei sindacati di organizzare
gli interessi presenti nel mondo del lavoro; il che, in una società dove
ciascuno dei duellanti pensava che l’estinzione dell’avversario potesse
procurare solo vantaggi all’intera società, era relativamente agevole. Di
contro, la crescita del pluralismo degli interessi di lavoro, accentuando le
difficoltà di riorganizzarlo sindacalmente, impone il riordino della cassetta
degli attrezzi regolativi e la ricerca di sensori capaci di sondare gli strati
profondi di una società frammentata e orfana di progetti generali, scarsamente
disponibile ad essere ricompattata e ad “accettare l’imposizione dall’alto
di visioni precostituite” (R. Del Punta).
Poiché il sindacato sta al gruppo dei rappresentati “come la carta geografica
sta al territorio” (B. Caruso), è ragionevole ricontrollare ogni tanto la capacità di
rispecchiare gli interessi di cui si considera ente esponenziale. Per questo, va segnalata
positivamente l’iniziativa avviata di recente dalle principali confederazioni di offrire
forme appropriate di rappresentanza ai lavoratori non equiparabili ai subordinati, ma di
fatto nemmeno classificabili tra gli autonomi.
Di per sé, la scelta è lodevole anzitutto perché postula una corretta analisi
delle ragioni del malessere del sindacalismo storico: neanche la sua cooptazione nei centri
decisionali del potere pubblico è la risposta al suo fabbisogno di rilegittimazione.
Non è detto, però, che la decisione possa senz’altro procurare un valido
strumento per gestire la transizione dal lavoro declinato al singolare al lavoro declinato al
plurale. Anzi, tenuto conto che l’operazione è pilotata dalla medesima cabina di regìa la
cui politica del diritto raffigurava il contratto di lavoro stabile a tempo pieno a stregua di
una stella polare ed i cui occupanti si sono rifiutati più che potevano di sfogliare il libro
della post-modernità, non me la sentirei di escludere a priori che la sindacalizzazione
separata dei presunti residuali, sotto-protetti per definizione, si proponga semplicemente di
fabbricare una specifica arma di pressione in più per reclamare la parificazione di
trattamento rispetto ai lavoratori a cui si applica il diritto del lavoro del Novecento. E se,
invece, fossero dei precursori, sia pure senza volerlo né saperlo?
Paradossalmente, non me la sentirei neppure di escludere a priori un rischio di
segno opposto. Il rischio, cioè, che il curioso apartheid organizzativo sia la spia di
una separatezza di strategie e dunque finisca, al di là delle intenzioni, per sancire e in
qualche modo istituzionalizzare il dualismo che vede i lavoratori regolari, ossia i
protetti “alla vecchia maniera”, contrapporsi agli irregolari.
Nel primo caso, la scelta di rappresentare il diverso e aggregare il disperso
somiglierebbe al buon senso di chi è portato a non disfarsi delle vecchie scarpe, neanche se
sono sfondate, perché non affaticano i piedi. Nel secondo, sarebbe interpretata dalle altre
associazioni sindacali in discorso, benché affiliate alle medesime confederazioni che hanno
preso l’iniziativa, come una tacita autorizzazione a considerarsi esonerate dall’onere di
aggiustare le politiche del diritto finora seguite e dunque dal fastidio di farsi carico di una
domanda sociale eccentrica rispetto alla tradizione rivendicativa: una domanda di tutele più
personalizzate di quanto non sia consentito dalla logica di un rapporto di lavoro standard.
7. – Il contratto collettivo “inautentico”.
Sarà il caso di cominciare col togliere di mezzo una questione
che, invece, vorrebbe apparire intrigante ed è solitamente trattata come se lo
fosse: il contratto collettivo nazionale dei pubblici dipendenti a statuto
privatistico ri-regolato sul finire degli anni ‘90 non può essere utilizzato
come prova dell’inossidabilità del contratto collettivo del Novecento. Esso è
considerabile un masso erratico; niente di meno, ma neanche niente di più.
In primo luogo, le esigenze di varia natura alle quali
ubbidisce la ri-regolazione legale appaiono ancora più insidiosamente
prevaricanti di quanto non lo fossero nella regolazione del’93. Tra di esse
primeggiano quelle di natura economico-finanziaria inconfondibilmente
proprie del datore di lavoro pubblico in qualunque paese che, però, si
inaspriscono quando il datore di lavoro pubblico si distingue per inefficienza,
sprechi e propensione ad indebitarsi. Fatto sta che, con precipuo riguardo a
questi aspetti, gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono
previamente sottoposti al governo, che può esprimere le sue valutazioni, e il
contratto non può essere sottoscritto se la Corte dei conti non certifica
positivamente la compatibilità dei costi che esso comporta con gli strumenti
di programmazione di bilancio, in tal caso prefigurandosi anche la necessità
della riapertura delle trattative.
In secondo luogo, l’accordo Aran-sindacati è “inautentico
”.
Detesto la prosa inflazionata dagli ammiccamenti grafici. Nondimeno,
stavolta uso il virgolettato, che sul lettore fa il medesimo effetto che, nel linguaggio
parlato, produce sull’ascoltatore l’innaturale colpetto di tosse o strizzatina d’occhio,
per lasciare intendere all’interlocutore che ci si aggira nei pressi di una speciale verità
che, se ci si astiene dall’enunciarla, è soltanto perché si preferisce l’immensa ricchezza
del taciuto.
So bene che nella letteratura formatasi con la velocità delle foreste
tropicali ai margini del contratto collettivo ri-regolato non c’è traccia della singolare
autocensura che esorta alla complicità. Per forza.
Incitata da una lesta imprenditorialità soi-disante culturale, c’è in giro troppa
“gente”, direbbe Massimo Severo Giannini, “che racconta come è fatta una legge e
cosa c’è dentro”. Non a caso, i ”raccontini” di corto raggio che essa scrive non
figurano nella lista delle letture che consiglio ai miei studenti.
Casomai, per metterli in condizione di capire, li rimando alla pagina d’uno
scrittore italiano, ove può leggersi un surreale apologo, a modo suo illuminante.
"Un lombrico stava attaccato all'amo. Un pesce lo vide.
- Oh, come soffri, posso fare qualcosa per te?
- Potresti mangiandomi, ma se lo farai finirai mangiato.
- Ti mangerò ugualmente, disse il pesce, perché non posso vederti soffrire così.
Il pesce lo mangiò e finì mangiato”.
Il compendioso brano, che presenta l ’ involontario vantaggio di offrire una
rappresentazione sorridente e, al tempo stesso, accigliata del back-ground dell’incontro
tra legge e contratto collettivo dei pubblici dipendenti, costituisce una buona base di
partenza per chiunque intenda spiegare perché, come e quanto quest’ultimo si distingua
dal contratto collettivo del Novecento.
Mentre la contrattazione collettiva si è sviluppata nel suo territorio elettivo con una logica
schiettamente incrementale, rivelandosi il più efficace strumento di miglioramento delle condizioni di lavoro
e di redistribuzione della ricchezza, nel p.i. i sindacati hanno sempre dichiarato di essere disposti anche a
chance di amministrare in modo socialmente utile ed
economicamente produttivo. Hanno sempre promesso di svolgere un ruolo
salvifico ed insieme sacrificale. Si sono sempre sbracciati a proclamare che
era loro intenzione privilegiare obiettivi eccedenti il loro orizzonte
rivendicativo.
svenarsi pur di dare alla p.a. la
Sparpagliati nelle mozioni dei congressi delle organizzazioni sindacali dall’aprirsi degli
anni ’70 in qua, gli inusuali obiettivi erano in realtà l'indizio non tanto d'una portentosa
vocazione impaziente di essere messa alla prova quanto piuttosto della disponibilità a
sborsare qualunque prezzo per far uscire la contrattazione collettiva, prima, dalla
clandestinità e, in seguito, dal limbo in cui l’aveva trasferita la legge quadro dell’83. I
sindacati del pubblico impiego, scrivevo vent’anni fa e non me ne pento, “sono, e si
sentono e si dicono, legittimati a contrattare riformando la p.a. ovvero a riformare la p.a.
contrattando. Essendo, e sentendosi e dicendosi, investiti del compito di chiedere per
contratto le riforme amministrative più difficili da attuare, essi non potevano non elaborare
una linea destinata ai decenni, se non ai secoli, futuri”.
Alla fine, presumendo che mai e poi mai la p.a. sarebbe riuscita da sola a risolvere la sua endemica
faute de mieux il legislatore ha preso sul serio gli obiettivi del sindacato – ossia, ha
infilzato la p.a. nell’amo per un pesce sventurato, ma benefattore – al punto di giuridificare
la priorità dell’obiettivo consistente nel contenimento delle retribuzioni al di sotto dei tetti
sostenibili dalla finanza pubblica. Come dire che il prezzo richiesto dal legislatore non si
finirà mai di pagarlo, perché i vincoli che dapprincipio potevano apparire imposti
dall'emergenza si sono convertiti, dopo l'ingresso in Europa dell'Italia, in vincoli di natura
permanente per evitarne l’espulsione, perché gli andamenti della spesa pubblica
complessiva rilevano ai fini del rispetto del patto di stabilità dell’Unione Europea; ed è
risaputo che la capacità del nostro paese di onorare gli impegni presi dipenderà anche dalla
moderata lievitazione del costo del lavoro nel settore pubblico e dalla sua
razionalizzazione, dalla migliore utilizzazione delle risorse umane della p.a. e dalla
modernizzazione delle strutture organizzative.
crisi,
Fatto sta che il comune denominatore degli obiettivi a cui è finalizzata la
contrattazione collettiva nel p.i. risiede in ciò: essendo valutabili anzitutto nell'ottica e coi
parametri di cui abitualmente si serve la generalità dei cittadini-contribuenti in qualità di
fruitori delle prestazioni delle p.a., corrispondono senz’altro ad interessi che non possono
appartenere interamente alle parti contraenti.
Per questo, ad uno specialista del calibro di Lorenzo Zoppoli è sembrato che
"nei contratti collettivi del pubblico impiego ci debba sempre essere un orientamento da
stipulazione a favore del terzo", la quale (come stabilisce il codice civile) presuppone la
compresenza di due interessi distinti, ma convergenti: l'interesse dello stipulante e quello di
chi – pur essendo estraneo alla vicenda contrattuale, come per l’appunto la comunità
amministrata – può ricavarne benefici.
Per quanto non fosse tecnicamente impeccabile, il richiamo alla decrepita figura contrattuale era
suggerito e quasi estorto da una norma del decreto 29 avente l’intonazione dell’undicesimo comandamento:
"la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la
tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti". Insomma, è orientata alla promozione dell'interesse del
pubblico.
In effetti, se il legislatore nomina separatamente e distintamente l’interesse
dell'organizzazione pubblica, l’interesse dei dipendenti e l’interesse degli utenti, ciò
significa – come venne prontamente rilevato – che lo stesso interesse dell'organizzazione
pubblica "è un interesse di parte, che non contiene presuntivamente in sé gli altri interessi.
Neppure quello degli utenti" (M. Rusciano), al quale si riconosce la proprietà di esercitare
sulla p.a. la medesima azione di stimolo, controllo e sanzione esercitata dal mercato nei
confronti dell'impresa privata.
Pienamente solidale col medesimo schema di ragionamento è l’autore di una
corposa monografia che amplifica la portata del frammento normativo al punto di
ravvisarvi "il precipitato di tutti gli altri contemperamenti necessari” per attuare il decreto
29 globalmente considerato (C. Russo).
Malgrado le apparenze, un messaggio del genere non era l'acerbo frutto d'una
dottrina minoritaria. Infatti, non c'è documento della prima tornata contrattuale che non
l'abbia enfatizzato al punto di farne il criterio ordinante dell'intero sistema di relazioni
sindacali nel p.i. E' come se l'autonomia collettiva avesse voluto rimarcare spavaldamente
la superfluità della formula legificata. Per le parti sociali, anziché un'intonazione
pedagogica, il limpido enunciato aveva il valore d'una certificazione celebrativa. In
proposito, chi avesse dubbi si vada a leggere il protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del
12 marzo 1997.
Pertanto, adesso che la dizione è scomparsa dal testo legislativo, gli esperti del ramo (Lorenzo
Zoppoli incluso) non hanno motivo per rivedere la direttiva d'interpretazione sistematica che avevano
estrapolato: a metabolizzazione irreversibilmente compiuta della ratio sostanziale dell’esile disposto
normativo, la successiva rimozione di questo è ininfluente. Piuttosto, avrebbero motivo per
domandarsi, da osservatori imparziali e spassionati, se il reclamizzato “contratto per
amministrare, per amministrare in modo diverso” non sia rimasto quel che era vent’anni fa:
”un’utopia un bel po’ nevrotizzante”.
Inautentico quanto alle sue origini, il contratto collettivo dei
pubblici dipendenti lo è altrettanto anche in ragione delle condizioni di
contesto in cui si concretizza la corrispondente fattispecie.
Infatti, mentre il contratto collettivo dei privati è l’esito di “un’attività che trae la sua forza dalla libertà
di forme espressive”, il contratto collettivo dei pubblici dipendenti è assoggettato ad una “iper-legificazione”
che ne soffoca la formazione in un fitto reticolo di procedimenti di autorizzazione burocratico-legalitari e di
controllo finanziario (M. D’Antona). Non è poco. Ma non è nemmeno tutto, perché il quadro dei
distinguo si arricchisce ulteriormente analizzando quel che succede sul
versante dei datori di lavoro pubblico, ove il soggetto che li rappresenta ai fini
negoziali si sta accapigliando da un pezzo col difficile problema della sua
identità, senza poterne padroneggiare i termini come sarebbe desiderabile.
Mi risulta che l’Aran abbia creduto di averlo risolto durante il periodo che, se per lei deve essere
stato il più sereno della sua breve esistenza, per la Repubblica è stato uno dei più cupi, perché di tutti i vertici
politici delle p.a. tutti dicevano il peggio possibile. Esso ha inizio col disseppellimento di Tangentopoli ed ha
la durata del successo del pool
di Mani Pulite. E’ in questo periodo che il legislatore
non può non fare i conti con un’opinione pubblica scossa da una raffica di
scandali di Palazzo e, per rinfrancarla, le darà in pasto la speranza che
l’ingegneria istituzionale sia in grado di costruire luoghi al riparo quanto più
possibile dalle interferenze della politica intesa e praticata nel senso meno
nobile possibile.
Adesso, invece, l’Aran si rende conto che la rappresentanza legale del cui munus è rimasta
formalmente titolare nei confronti delle p.a. è uno strumento approssimato per
eccesso, perché comporta di per sé un’invasione della sfera giuridica altrui di
dimensioni superiori a quelle tollerabili dalle stesse p.a. molte delle quali, per
giunta, sono chiamate ad attuare la riforma federalista dello Stato (L.
Mariucci).
Nel novembre del ’97, infatti, il legislatore ha emancipato in senso tecnico le p.a. riducendone
l’incapacità legale a contrattare a livello di comparto da assoluta a relativa; tant’è che i rispettivi comitati di
settore non solo esercitano un penetrante potere d’indirizzo nei confronti dell’Aran, ma possono persino
delegittimarla, perché ad essi spetta formulare un parere conclusivo sulle ipotesi di accordo raggiunte nelle
negoziazioni di comparto. Come dire che la politicità inscritta nel codice genetico della contrattazione
collettiva è tornata a schizzare in superficie come una palla di gomma sfuggita dalla mano che la tratteneva
sott’acqua e l’Aran farebbe morire dal ridere i suoi rappresentati se si permettesse di ammonirli così: “silete
politici in munere alieno”. In verità, fin dalla sua nascita la sua competenza è quella di un organismo tecnico
e “il tecnico non sceglie i fini; ha soltanto il potere conoscitivo dei mezzi per realizzare fini decisi da altri”
(N. Irti); quando va bene.
Tuttavia, la sostanziale equi-ordinazione dell’Aran rispetto ai comitati di settore ha visibilmente
accentuato la sfrontatezza del legislatore che continua a qualificarne il ruolo in termini di rappresentanza
ex lege delle p.a., come se non fosse cambiato niente. Vero è che
l’incongruità non è stata eliminata per la medesima ragione per cui era stata
introdotta: ossia, perché rende l’inestimabile servigio, apprezzato anche dalla
Corte costituzionale, di un escamotage che consente al contratto collettivo
stipulato dall’Aran di produrre efficacia generale senza scomodare il quarto
comma dell’art. 39 cost. Ciò non toglie che si sarebbe potuto ottenere un
analogo risultato configurando legislativamente il ruolo dell’Agenzia a
stregua dell’assistenza del curatore nei confronti di soggetti limitatamente
capaci di agire, il cui assenso ne integra la volontà e, in quanto è necessario
per il perfezionamento degli atti negoziali, partecipa della stessa natura di
quello prestato dal contraente. Anche questa sarebbe una fictio iuris. Ma,
perlomeno, non pretende di occultare la realtà. Dopotutto, il ruolo che l’Aran
è in grado di svolgere è quello dell’intermediario brevettato che, piazzato tra
dirigenza politica e dirigenza sindacale, può proporsi soltanto o soprattutto di
impedire che il metodo della formazione bilateralizzata delle regole del lavoro
pubblico subisca gli stessi inquinamenti che avvelenavano il metodo della
regolazione unilaterale. Il suo ruolo, insomma, è quello dell’esperto ed
insieme del moralizzatore. Un ruolo curioso. Un ruolo d’insostenibile
leggerezza.
necessaria
Per questo, può succedere (e succede, succede eccome) che l’Aran
presti ascolto alle pretese delle p.a. di gestire con maggiore autonomia le
relazioni contrattuali con l'aria del bravo cassiere di banca davanti al quale
arriva uno che gli chiede di effettuare un bonifico intestato alla Madonna e
all'insistente rivendicazione di un maggiore presenzialismo sindacale
specialmente a livello decentrato reagisca nello stesso modo in cui reagirebbe
chi, giocando a scacchi, si accorge che l'avversario gioca con due Regine.
In effetti, per quanto si possa in astratto ritenere che la scelta
migliore per sconfiggere l'inerzia autoconservativa della cultura del sospetto
consiste nel favorire il superamento delle condizioni che l’hanno determinata,
nella situazione storicamente data l’opinione sconfina nella temerarietà.
Anche il legislatore lo sa. Diversamente, non avrebbe obbligato le p.a. ad
attivare livelli di contrattazione esclusivamente sulle materie e nei limiti
fissati dai contratti nazionali né avrebbe fatto ricorso alla più energica delle
sanzioni civilistiche per invalidare le clausole inserite nei contratti integrativi
che risultino in contrasto coi vincoli posti dai contratti nazionali né avrebbe
minacciato di “prorogare l'efficacia temporale (dei contratti) ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa".
Insomma, pur incentivando il federalismo possibile a costituzione
invariata, il legislatore di fine secolo non ha smesso di flirtare con la logica
repressiva insita in ogni forma di paternalismo che si nutre di valutazioni e
giudizi, a torto o a ragione, poco teneri sulla maturità degli stessi soggetti che
dovrebbero agire da protagonisti della riforma federalista ed è disposto ad
allontanarsene con prudente gradualità per poter continuare a credere che il
biglietto di viaggio “dal disastro verso l’ignoto”, staccato nel febbraio del
1993, fosse di sola andata.
Dite che è illogico stabilizzare regole del lavoro su materie e in
ambiti colpiti da uno sciame di scosse sismiche quando le turbolenze sono
appena cominciate? Dite che non ha senso uniformare e livellare quando,
tutt’al contrario, bisognerebbe valorizzare il carattere multi-organizzativo
delle p.a., il loro policentrismo, la loro diversificazione territoriale,
professionale e di scopo a misura delle utenze di riferimento? Dite che è
contraddittorio legificare il primato del contratto collettivo nazionale dei
pubblici dipendenti e contemporaneamente avviare processi di costruzione
dello Stato autonomista?
Apparentemente assennate, domande del genere sono invece mal
poste. Il fatto è che la routine d’una centralizzazione contrattuale
tendenzialmente incapace di produrre valore aggiunto se non in termini di
moderazione della crescita salariale dei tre milioni di lavoratori è, comunque,
preferibile all’iniziativa di moltitudini di datori di lavoro pubblico alle cui
incursioni corsare è dovuto il formarsi della giungla normativa dei trattamenti
dei loro dipendenti che la contrattazione di comparto è tenuta a bonificare.
8. – La joint-venture tra due premiate ditte.
Il metodo di produzione delle regole del lavoro alle dipendenze
delle p.a. non è altro che la punta dell’iceberg ossia la manifestazione
estremizzata d’una tendenza di lungo periodo che ha convertito il binomio
legge-contratto collettivo in una matassa arruffata.
Il tentativo di dipanarla hic et nunc avrebbe due gravi difetti:
sarebbe privo di originalità e introdurrebbe un’inammissibile digressione.
Quindi, me ne astengo. Tuttavia, suggestionato dal caso-Italia che è
considerabile un caso clinico, non posso trattenermi dal banalizzare le
acquisizioni della più accreditata sociologia del diritto, osservando che tutto
nasce dal fatto che la legislazione in materia sindacale e di lavoro – un po
’ per garantirsi un livello passabile di funzionamento fisiologico e un po’
per diminuire “l’esposizione politica dei centri di decisione statuali” (M.
D’Antona) o (il che non è molto diverso) per rendere più tollerabile una
evidente crisi regolativa da “sovraccarico funzionale” (G. Vardaro) –
ha bisogno del contratto collettivo più di quanto non ne abbia di lei il
contratto collettivo.
La segnalata tendenza di lungo periodo non è mai stata sotterranea;
tutt’al più, può dirsi che aveva l’andamento di un fiume carsico. Il ceto
giuridico italiano non la individuò soprattutto perché il suo provincialismo
culturale unito ad una discreta ottusità non glielo permise.
Incuranti non solo della lezione ricavabile dall’esperienza giuridico-sindacale d’
oltre Manica – icasticamente sunteggiata da Otto Kahn-Freund: “ciò che lo Stato non
ha dato nemmeno può togliere” – ma anche della saggezza immortalata nell’aforisma
di Melchiorre Gioia secondo il quale “gli errori delle generazioni passate riescono utili al
legislatore come la storia de’ naufragi al marinajo” o in proverbi del tipo “il gatto
che si è scottato con l’acqua bollente ha paura anche dell’acqua tiepida”, gli operatori
giuridici del dopo-costituzione accreditavano una versione diametralmente opposta,
dissipando il loro patrimonio di energie “nell’inutile indagine sui modi in cui l’art. 39
(avrebbe potuto) essere attuato” (F. Mancini).
Tuttavia, la tendenza non era sconosciuta.
Era infatti opinione di un “sindacatino”, come la Cgil fino agli anni
’50 inoltrati spregiativamente chiamava i sindacati costituitisi dopo la
scissione del ’48, che l’intero movimento sindacale italiano, col suo
cumulo di ritardi storici quanto ad esperienza di libertà, dovesse
autonomamente costruirsi la sua, emancipandosi attraverso la dialettica e la
competizione proprie del pluralismo organizzativo garantito dal primo comma
dell’art. 39.
Nettamente contraria all’attuazione del quarto comma dell’art. 39
che, privilegiando la regola strumentale al principio di maggioranza per cui
ciascuno dei sindacati seduti al tavolo negoziale conta unicamente in
proporzione al numero degli iscritti, “ svaluta apertamente la pretesa
egemonica di contare in base alla qualità della capacità rappresentativa degli
interessi ” (M. Napoli), l ’ opinione radicalizzò le divisioni sindacali.
Ciononostante, in un arco temporale tutto sommato breve sarebbe diventata l
’opinione del sindacato “nel suo complesso”, come annoterà nel 1963
Federico Mancini, anche perché ebbe la straordinaria fortuna – sissignori,
la fortuna – di sostentarsi con copiosi argomenti dotati di inusitata
rispettabilità accademico-scientifica.
L’opinione infatti potè nutrirsi del pensiero giuridico legato ai nomi di Francesco
Santoro Passarelli e Gino Giugni. A proposito dei quali non mi stancherò mai di ripetere
che ciò che li unisce supera ciò che pure li divide. Benché Santoro Passarelli fosse uno
degli ultimi esponenti della grande scuola civilistica dell’Ottocento, mentre Giugni “
non saprà mai” (come disse una volta di se medesimo) “se è un politico prestato al
diritto o un giurista prestato alla politica”, ciò che li accomuna è anzitutto la piena
consapevolezza unita alla fiduciosa operosità che le loro interpretazioni ricostruttive
miranti a valorizzare l’autonomia privato-collettiva avessero l’attitudine ad influenzare
lo sviluppo del diritto sindacale vivente, come effettivamente sarebbe accaduto, in ragione
della lungimiranza politico-culturale di cui erano espressione.
Ovviamente, come sta scritto nel destino dei protagonisti di
vicende che lasciano il segno, Francesco Santoro Passarelli non poteva sapere
che la sua teorizzazione privatistica del fenomeno sindacale avrebbe
incentivato una politica del diritto che, raffigurando il rapporto tra contratto
collettivo e legge nei termini teatralizzanti della lotta della luce contro le
tenebre, ingigantiva il pericolo che, per assegnare al contratto collettivo la
rilevanza giuridica endo-statuale nelle forme volute dall’art. 39 cost., la
legge finisse per divorare la sostanza pre-statuale della contrattualità. Né Gino
Giugni poteva sapere che, dopo l’Introduzione allo studio della autonomia
collettiva, il diritto sindacale del dopo-costituzione non sarebbe più stato un
personaggio in cerca d’autore. Non poteva sapere nemmeno quante fossero
le probabilità di realizzazione del suo progetto. Fatto sta che esso non ha
trovato riscontri se non entro i margini di adattabilità dell’esistente, ponendo
progressivamente in evidenza un décalage tra le linee direttrici del lavoro
culturale del giurista e le linee della politica del diritto praticata dalle
principali forze in campo. Come dire che queste ultime si sono discostate non
di rado dall’ispirazione di fondo del progetto e non hanno saputo (potuto?
voluto?: ecco un altro bel tema per gli storici delle istituzioni) interconnettere
i vari segmenti del medesimo se non con gli occhi inumiditi dalla nostalgia,
che è la forma di vecchiaia più penalizzante che ci sia.
Infatti, riletto in controluce con gli occhi asciutti, il diritto sindacale
del dopo-costituzione può dare l’impressione d’un collage eseguito da chi
sta imparando proficuamente il mestiere dell’intarsiatore per comporre con
materiali vecchi un disegno nuovo. Per questo, lo stesso Giugni che ha
educato numerose generazioni di operatori giuridici a considerare il nostro
sistema di auto-regolazione sociale a stregua di un ordinamento iure proprio,
originario e sovrano, ammetterà sul finire degli anni ’80 che “quest’
ordinamento di fatto oggi è un po’ sgangherato”, pur rivendicando (con
tono sommesso, ma) con giustificata fierezza il merito che la sua visione
giuridica “è valsa se non altro a dimostrare che, anche in assenza di un
intervento legislativo regolatore e attuativo del particolare tipo di contratto
previsto dalla costituzione, il sistema contrattuale non era extra legem e tanto
meno contra legem”.
Nondimeno, il contratto collettivo post-corporativo non ha troncato il
feeling col diritto pubblico; il processo civile davanti al giudice ordinario
come metodo per la composizione delle liti individuali generate dall’
amministrazione delle norme collettive è rimasto oggetto di culto; il
sindacato – un sindacato che “contratta per tutti” e si erge in difesa
del “lavoratore come singolo individuo titolare di diritti soggettivi
prima che come componente di un gruppo sociale portatore di interessi
collettivi” (A. Accornero) – non ha mai smesso di comportarsi più
da tutore che da mandatario nell’ampia misura in cui tratta il singolo,
“più che con riguardo alla sua veste di socio, con riguardo a quella di
destinatario degli effetti dell’azione sindacale” (M. Rusciano).
Neanche lo Statuto dei lavoratori ha eliminato le aporie più
vistose dell’evoluzione del diritto sindacale. Non solo ha suggellato l’
incompiutezza della transizione dalla rappresentanza sindacale di tipo
politico-istituzionale e dunque di diritto pubblico, acquistata a prezzi
proibitivi
in
età
corporativa,
alla
rappresentanza
di
tipo
privatistico-associativo, ossia particolaristica, e dunque di diritto comune
privilegiata nell’età successiva (M. Rusciano). Per di più, ha persuaso il
sindacato che non era affatto necessario cambiare rotta e che era, invece,
redditizio lasciare le cose come stavano, perché intanto incamerava risorse
(non solo) normative da un potere pubblico tutt ’ altro che avaro, più
permissivo che esigente, più schierato che neutrale. Il fatto è, scriveva Gino
Giugni nel 1972, che “occorre un investimento di sostegno nei confronti
dell’azione sindacale al fine di tonificarla e di consentire al sindacato di
riguadagnare quello che sta perdendo a causa di incontrollate esplosioni
sociali”.
E’ certamente un errore da sofisti spiegare con il dopo quel che è accaduto
prima, stabilendo concatenazioni causali là dove può esserci soltanto una successione
cronologica di eventi. E’ tuttavia indubbio che, rigettando reiteratamente le eccezioni d
’incostituzionalità che fino alle soglie degli anni ’90 piovono sull’art. 19 st. lav., la
Corte costituzionale farà quello che i più si aspettavano da lei per rendere produttivo l’
investimento. Dopotutto, non c’era ragione al mondo perché dovesse fidarsi più delle
neo-formazioni sindacali di base coi loro effetti destabilizzanti che non del sindacalismo
storico riunificato nel club della maggiore rappresentatività, luogo delle grandi saldature
organiche e sede privilegiata delle “sintesi tra istanze di tipo micro-economico e di tipo
macro-economico ” . Pertanto, è un ’ ingenuità ritenere che, solamente perché si
proponeva di offrire un sostegno al pluralismo conflittuale, il diritto promozionale di cui lo
Statuto dei lavoratori resta la più significativa espressione non potesse far maturare anche
da noi le premesse d ’ un trade-off tra potere pubblico e potere sindacale che
rappresenta il cuore d’una strategia riformista ricalcata, mutatis mutandis, sul patto
newdealista degli anni ’30. Infatti, in cambio del minimo storicamente possibile di
regolazione eteronoma del potere sindacale, il potere pubblico a sua volta incasserà il
massimo storicamente possibile di consenso sociale diffuso.
Se fosse stata una partita a poker, si sarebbe compreso subito chi era il
professionista.
Opporsi all’integrale attuazione dell’art. 39 cost., sapendo che
la legislazione sindacale e del lavoro orfana di contratti collettivi di natura
para-legislativa somiglia ad un veicolo con le ruote quadrate, è come stringere
Montecitorio e Palazzo Madama nella morsa di un assedio che ne rende
difficoltoso l’approvvigionamento. E’ infatti per non morire d’inedia
che gli assediati si specializzano nell’arte dell’auto-inganno e ai loro numi
tutelari, vestiti da giudici costituzionali, non resta che rassicurarli che possono
campare egualmente con le gallette di cui dispongono.
Poco meno che patetica, al riguardo, ma emblematica è la
contorsione con la quale il Parlamento ha ritenuto di poter evitare che la legge
146/1990, la cui attuazione ha affidato in via pressoché esclusiva ai “
contratti collettivi”, sia scritta sull’acqua, guadagnandosi così la commossa
approvazione dell’Alta Corte.
Insomma, a dispetto della sua estrema informalità, la costituzione
materiale ha avuto il sopravvento. Però, si potrebbe anche dire che, come ogni
tanto gli capita, il tempo è stato galantuomo.
E’ stato galantuomo perché, addestrando il sindacato a prodursi nella
performance di sommare ai vantaggi di cui gode come “libero soggetto di
autotutela in una sfera di diritto privato” i vantaggi di cui si appropria come
“soggetto di una funzione pubblica”, ne ha demistificato l’ideologia
anti-legalitaria, anti-formalista, anti-istituzionale provocatoriamente protesa
ad esorcizzare il diritto pubblico. E’ l’ideologia dell’alterità del contratto
collettivo rispetto alla legge; un’ideologia che, nell’ultimo quarto del
Novecento italiano, si è ossificata. Infatti, ormai è lo Stato che attribuisce all
’autonomia collettiva la licenza di assumere movenze che mimano quelle
della legge, riservandosi di fissarne le regole d’uso – con una diligenza
tanto scadente da rasentare in qualche caso la cialtroneria – oppure –
quando è in vena di comportarsi in maniera più decorosa – di “
predisporre le nervature istituzionali dei processi di autoregolazione sociale”
(L. Mengoni) od anche di determinare condizioni o presupposti di legittimità
dell’autorità law making delegata a soggetti privati.
Se è ragionevole congetturare che questo stadio evolutivo è stato raggiunto
perché, pur non possedendo la dignità dell’atto avente l’efficacia promessa dal quarto
comma dell’art. 39, quella che era in qualche modo riconosciuta al contratto collettivo
post-corporativo aveva familiarizzato il sindacato del dopo-costituzione alle frequentazioni
col diritto pubblico senza andare troppo per il sottile, bisogna convenire che la
spregiudicatezza e l’eclettismo del legislatore hanno finito per mettere in solare risalto il
dilettantesco conformismo dell ’ alma mater del contratto collettivo
post-corporativo unanimemente identificata nella giurisprudenza degli anni
’50. E ciò perché quest’ultima non poteva percepire né la necessità né l’
opportunità di mettere in discussione il “pregiudizio concettuale” della
configurazione monistico-unitaria del contratto collettivo (G. Vardaro),
muovendo dall’assunto “che vuole che al contratto collettivo corrisponda
una, e una sola, disciplina; e che qualunque disciplina non possa non
riguardare il potere dell’organizzazione sindacale di regolare i contratti di
lavoro nell’ambito del gruppo rappresentato ” (M. D’Antona). L’
insoddisfazione e la voglia di superarla sarebbero venute assai più tardi, a
percorso inoltrato dell’itinerario della “via italiana alla giuridificazione del
contratto collettivo” (G. Vardaro).
Se la sensibilità predittiva che permise a Giuseppe Ferraro, in una non
dimenticata monografia la cui elaborazione si situa a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni
’ 80, di assegnare una rilevanza ordinamentale alla diversificazione delle funzioni
social-tipiche del contratto collettivo desumibile dalla varietà tipologica delle sue forme dì
uso da parte del legislatore appare condizionata da una lettura sostanzialmente apologetica
delle medesime, nessuno tuttavia può negare che si stavano creando le premesse e le
condizioni favorevoli all’introduzione di regimi giuridici differenziati.
“E’ possibile”, ammetterà Gaetano Vardaro in uno scritto del 1987, “
che ad una qualche forma di diversificazione strutturale del regime giuridico dei contratti
collettivi si arriverà in tempi anche relativamente brevi”.. Ma non è la prospettiva in sé a
motivare il disagio del giovane giurista-scrittore cooptato nello star system accademico. Lo
preoccupa che la selezione degli agenti della contrattazione privilegiata da sequenze di
rinvii legislativi sia camuffata come sviluppo applicativo della medesima linea di sostegno
sindacale inaugurata dallo statuto dei lavoratori. Secondo lui, adottare un’ottica del
genere significa falsificare i dati di realtà e svuotare la garanzia costituzionale del
pluralismo. Per parecchi motivi.
Primo. I sindacati riconosciuti come autorità normativa dallo Stato devono
la loro legittimazione al loro grado di integrazione nel sistema politico-istituzionale e l’
ordinamento iure proprio del quale sono artefici e garanti stabilisce con l’ordinamento
statale un rapporto di simbiosi più antagonistica che mutualistica, perché ne ricava
vantaggi più che altro apparenti.
Secondo. L’erga omnes, che la giurisprudenza non ha mai cancellato dalla
sua agenda, subisce un mutamento di senso: smarrito per strada “il senso tradizionale di
estensione ai non organizzati dei trattamenti conquistati dagli organizzati”, acquista il
senso di vincolare anche i dissenzienti, singoli individui o gruppi minoritari (M. D’
Antona)
Terzo. In presenza di conflitti endo- o intersindacali che minacciano la
tenuta dell’autoregolazione sociale, non si può reagire come se non fosse disponibile la
regola per governarli. Sul tema mi soffermerò nell’ultimo pgr. Intanto, però, vale la pena
di osservare che finora si è potuto disapplicarla semplicemente “perché, non essendoci
conflitti, non c’era neanche bisogno di ricorrervi” (G. Giugni).
Infatti, a poco a poco si è realizzata nell’ordinamento la compresenza di una
pluralità di modelli di disciplina del contratto collettivo, diversificati per contenuto e
regime della sua efficacia, per finalità e tasso di legificazione o, meglio, per incisività dell
’imprinting legislativo.
Il primo è quello su cui giurisprudenza e dottrina hanno esercitato la propria
creatività nei decenni centrali del secolo: è il contratto collettivo del quale ho finora
parlato; è il contratto collettivo di tipo normativo-accrescitivo, la cui logica non può essere
che “quella del ‘concreto’ e del ‘possibile’, onde la previsione di un controllo di
razionalità da parte del giudice altro non sarebbe che abilitare il giudice a sostituirsi alle
parti” (M. Persiani)”. Insomma, è il contratto collettivo del Novecento italiano che, per
una incorreggibile inclinazione alla vivacità espressiva, ho definito in precedenza contratto
collettivo corporativo formato-bonsai.
Il secondo gli si contrappone perché, pur costituendo l’esito d
’ un ’ attività autonomamente deliberata, la legge ha rigorosamente
conformato il contratto collettivo a stregua di un ’ autonormazione
assoggettata a pesanti vincoli funzionali e finalistici: è il contratto collettivo
“inautentico” dove “di negoziale, alla fine, non resta che la genesi
consensuale dei suoi precetti normativi” (A. Tursi).
Tra quest’ultimo e il contratto collettivo del Novecento non
esiste una graduazione di tonalità: esiste un vero e proprio salto qualitativo,
perché il legislatore ha disegnato il secondo modello di disciplina adottando
come parametro di riferimento di fatto prevalente interessi che, nonostante la
loro generale condivisione, sono ascrivibili in via diretta ed immediata allo
stesso legislatore.
Il terzo modello si colloca in una posizione intermedia, anche se
non equidistante perché è più vicino al secondo che al primo nella misura in
cui gli sono “ assegnate funzioni o finalità che ne collocano il senso
giuridico ultimo in una dimensione meta-negoziale” (A. Tursi).
Esso corrisponde ai contratti collettivi – la cui testa di serie è costituita dal
contratto collettivo stipulato in attuazione della legge 146/1990 – ove auto-determinazione
e prospettiva funzionale coesistono, fermo restando che – “pur esercitando un apparente
self restraint” (M. D’Antona) – è lo Stato che, come può e sa, pone le
condizioni subordinatamente alle quali è disposto a conferire rilevanza nel suo
ordinamento al contratto collettivo. Così, se è vero che la Commissione di
garanzia “non ha poteri correttivi o modificativi degli accordi stipulati”, è
pure vero – come si premura di puntualizzare la Corte costituzionale –
che “ una valutazione negativa da parte della stessa Commissione li
priverebbe di efficacia”. Come dire: l’ideologico ottimismo secondo il
quale l’autonomia collettiva dovrebbe poter strumentalizzare la legge rischia
di cedere il posto alla retorica apocalittica secondo la quale il contratto
collettivo “da ordo ordinans si trasforma in ordo ordinatus“ (S. Simitis).
Soltanto l’ostilità, peraltro non del tutto destituita di fondamento, alla
funzionalizzazione dei poteri privati (individuali o collettivi che siano) al soddisfacimento
di interessi che non possono essere esclusivamente privati (né di singoli né di gruppo) può
giustificare l’assunto per cui il contratto collettivo riconducibile al primo e meno recente
modello di disciplina avrebbe la forza immanente di un concetto-spugna capace di
assorbire e digerire ogni possibile modello ulteriore, sovrapponendosi alla stessa realtà
normativa, come se fosse irrilevante che sia stato costruito indipendentemente da essa (M.
Persiani). Irrilevante, viceversa, è l’argomento secondo il quale non possono esserci
contratti collettivi che non “compongano conflitti di interessi tra capitale e lavoro”.
Questi, sì, sono immanenti, pur riproponendosi in forme e termini rinnovati. E’ ovvio.
Ma è altrettanto ovvio che, in mancanza di una mediazione legislativa, vi sono conflitti che
il contratto collettivo del Novecento italiano non può risolvere. Difatti, non li ha neanche
affrontati. Et pour cause.
Come fenomeno di autonomia privata operante in regime di rappresentanza
volontaristico-associativa, quel contratto non è in grado né di dettare discipline
vincolistiche di dinamiche conflittuali il cui presidio corrisponde ad un interesse pubblico
in quanto coinvolgono moltitudini di terzi estranei né di flessibilizzare la legislazione
garantista né di promuovere e/o condizionare la ristrutturazione in senso federalista del
sistema delle p.a. Oltretutto, si tratta di materie sottratte alla disponibilità delle parti sociali;
come dire che la mediazione legislativa non può essere saltata. Casomai, si dissente sulla
forme della mediazione, che molti vorrebbero più grintosa, e sugli esiti consensuali, che
molti vorrebbero legislativamente precostituiti con margini di approssimazione più esigui.
Ut erat in votis, si dovrebbe concludere.
L ’ approccio interpretativo dal quale mi sono permesso di
divergere è sostanzialmente identico a quello che Stefano Rodotà, nel suo
magistrale commento all’art. 42 cost., rimprovera alle dottrine giuridiche
attestate in difesa delle ragioni proprietarie che l ’ ordinamento
pre-costituzionale qualificava esplicitamente “inviolabili”.
“Ci si può legittimamente domandare”, scrive Rodotà, “se,
per effetto dell’introduzione della funzione sociale nell’ordinamento, si
possa ancora parlare della proprietà come di un diritto soggettivo; ma non si
può escludere l’operatività della nozione di funzione sociale assumendo la
pregressa natura giuridica del diritto di proprietà”.
Orbene, come quest ’ ultimo è cambiato in seguito al “
passaggio da un regime in cui il principio di diritto positivo è quello dell’
assolutezza della proprietà ad uno di proprietà funzionalizzata”, così “il
diritto sindacale italiano sta facendo i conti con la propria ‘anomalia’:
mentre le tipologie e le funzioni della contrattazione collettiva tendono a
differenziarsi sul terreno sociale, il regime giuridico del contratto collettivo
resta ancorato ad una soltanto di esse, quella sulla quale è stato storicamente
edificato con materiali compositi e di incerta affidabilità” (M. D’Antona).
Come dire che il giurista del lavoro non può ingessare l’
autonomia collettiva in schemi concettuali superati da interventi variamente
conformativi o preformativi della stessa, i quali testimoniano come l’utilità
sociale tenda ad acquistare la valenza di un principio ordinatore degli
svolgimenti dell ’ autonomia collettiva (M. Mariani), accelerando un
processo di “compenetrazione” tra sfera statuale e sfera dell’autonomia
collettiva la cui “istituzionalizzazione è corrispettiva alla devoluzione ai
sindacati di funzioni pubbliche ” (M. D ’ Antona) che finiscono per
retro-agire sulla struttura del principale strumento utilizzabile per svolgerle. E
’ il medesimo processo l’assenza del quale negli anni in cui un giurista del
calibro di Carlo Esposito si collocava su posizioni contigue le faceva apparire
perlomeno oniriche, con ciò dimostrandosi ancora una volta che anche la
ragione può avere torto quando sceglie il momento sbagliato per esprimersi.
Vero è che il dato della doverosità della corrispondenza degli
svolgimenti dell ’ autonomia collettiva con gli obiettivi legislativamente
prefissati, come del loro adeguarsi a condizioni o presupposti anch’essi
legislativamente prefissati, ha un carattere episodico e circoscritto. Tuttavia,
proprio questi sono i modelli regolativi emergenti che sembrano orientati ad
impadronirsi di crescenti spazi nel sistema delle fonti normative. Pertanto,
tenuto conto dell’intrinseca ambiguità della descritta politica del diritto
tempestivamente percepita e segnalata da Gaetano Vardaro, vale la pena di
sorvegliarne con attenzione gli sviluppi piuttosto che negarne l’esistenza:
anche don Ferrante credeva che non fosse peste e di peste morì. La
reminiscenza manzoniana, mi affretto a chiarire, non intende suggerire chissà
quali perversi parallelismi tra il flagello abbattutosi sulla Milano seicentesca e
la fine dello “stallo pluralistico” ossia della conversione del pluralismo da
conflittuale in cooperativo (L. Mengoni). Nondimeno, le più recenti esibizioni
della coppia pubblico-collettivo lasciano di stucco.
Così, mentre nelle aule universitarie si comincia ad insegnare che la formula
dottrinale per cui lo sciopero è un diritto individuale ad esercizio collettivo è un dogma
fondato più sulla ragione che sullo ius conditum perlomeno nell’area dei servizi
pubblici essenziali, nelle aule giudiziarie si comincerà presto a dubitare che
possa ancora parlarsi di inderogabilità delle norme protettive dei pubblici
dipendenti, benché provengano da contratti collettivi legificati.
A questo proposito, mi riferisco non solo e non tanto alla circostanza che,
assumendo come preminente l’interesse a decongestionare il circuito giudiziario, il
legislatore abbia sdoganato l’arbitrato (obbligatoriamente preceduto, anch’esso, dal
tentativo di conciliazione, come nel settore privato) in modo da suscitare più problemi di
quanti non possa risolverne; mi riferisco anche e soprattutto alla circostanza che, per
privilegiare l’esigenza di garantire l’immodificabilità dell’equilibrio degli interessi di
cui è espressione il singolo contratto di comparto per tutta la sua durata, il legislatore abbia
manifestato l’intenzione di emarginare doppiamente il giudice togato. Una prima volta,
revocandogli la delega dell’interpretazione esclusiva delle clausole contrattuali; una
seconda volta, vietandogli di disapplicare clausole in contrasto con disposizioni imperative
di legge. Infatti, “quando per la definizione di una controversia individuale (…) è
necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l ’ efficacia, la
validità o l ’ interpretazione delle clausole di un contratto o accordo
collettivo nazionale (…), il giudice con ordinanza non impugnabile (…) fissa
una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni”, per dare
ai contraenti la possibilità di riprendersi il controllo sul destino della clausola
controversa o definendone consensualmente il significato oppure
rinegoziandola tout court e dunque modificandola. Solamente nel caso in cui
il procedimento incidentale si concluda senza esito alcuno, il giudice può
decidere “andando oltre (ossia superando il testo oscuro con lo strumento
dell’interpretazione) o contro il contratto (ossia sostituendo il disposto
contrattuale ritenuto invalido o inefficace) ” (M. D’ Antona); ma l ’
eventualità è tanto temuta da indurre il legislatore a ridisegnare lo scenario
processuale, complicandolo con barocchismi e affollandolo con frotte di
interlocutori.
Ad ogni modo, estote parati: la proliferazione dei modelli di
disciplina del contratto collettivo è il sintomo dell’appartenenza di questa
figura iuris alla razza dei mutanti. Mario Rusciano, del resto, ci aveva
avvertito: la contrattazione collettiva è come “un fiume che attraversa molti
e diversi territori: ha un solo nome, sgorga da una sola fonte, l’acqua è la
stessa, ma il suo alveo si conforma alla struttura geologica della terre
attraversate”. Ci sono però dei limiti. E’ stata la Corte costituzionale la
prima a dircelo. Invitata a pronunciarsi sulla natura di una decisione
concertata, essa reagì come se l ’ avessero apostrofata con parole che,
aggredite da una malattia incurabile, soffrono di una eccedenza di significati e
pertanto ostacolano la comunicazione nell’ampia misura in cui sollecitano i
parlanti a prese di posizione che – assai più nette dell’oggetto a cui si
riferiscono – somigliano a pregiudizi, favorevoli o sfavorevoli che siano.
“Per quanto lo si esorcizzi col prefisso ‘ neo ’ e con l ’ aggettivo ‘
liberale’”, è il lapidario giudizio di Luigi Mengoni, “il modello corporativo della legge
del 1926 in qualche modo viene sempre fuori”. Neanch’io ho mai nascosto disagio e
inquietudine. Ma, come dirò un po’ più avanti, questo è uno dei casi in cui semplificare
un fenomeno complesso espone al rischio de deformarlo.
Sono grato perciò al giovane studioso che, avendo imparato a
coniugare l’originalità e la freschezza delle idee con l’obbligo di tradurle
in un linguaggio abbordabile da tutti, ha saputo dimostrare che la
pluri-valenza del contratto collettivo non è illimitata. Antonio Lo Faro infatti
ci ha spiegato, senza indulgere nei riti iniziatici cari agli esperti di diritto
comunitario del lavoro, che la contrattazione collettiva europea – partorita
con taglio cesareo a Maastricht e innalzata dal nuovo trattato dell’Unione al
rango di un metodo di produzione normativa alternativo a quello delle
direttive unilateralmente e discrezionalmente adottate dal Consiglio – non è
che una forma evoluta della prassi procedurale che negli Stati-nazione
chiamano concertazione sociale. Anche la contrattazione collettiva europea è
una risorsa; ma è una risorsa più di legittimazione che di regolazione. Il suo
normale mezzo espressivo, infatti, è l’accordo con funzione ancillare e
complementare rispetto al c.d. legislatore comunitario. Un accordo che viene
suicidato mediante la decisione del Consiglio; mentre l’accordo c.d. libero,
che non è ancora sbucato dalle nebbie del Nord-Europa e chissà quando ne
vedremo un esemplare, viene fatto sostare in una zona limbica proprio perché
è “ più vicino al concetto di autonomia collettiva intesa come potere
originario dei gruppi privati di autoregolarsi” (M. D’Antona).
La residua, ma ragguardevole indeterminatezza della concertazione
sovra-nazionale fornisce una ulteriore, ma eloquente giustificazione ex post dell’
atteggiamento adottato dalla nostra Corte costituzionale nei confronti della
concertazione nazionale. Nell ’ occasione menzionata, infatti, la Corte
sembrò più che altro interessata ad escludere la prospettiva che si trattasse di
un additivo o di un farmaco ricostituente di cui la contrattazione collettiva
potesse imbottirsi al punto di risultare “ancora più estesa e garantita di
quanto non potrebbe esserlo in base all’inattuato quarto comma dell’art. 39
”. Oggi, avrebbe meno motivi di preoccuparsi. Dal maxi-accordo del 22
dicembre 1998, che traccia un percorso di concertazione legislativa modellato
su quello comunitario, è dato desumere che l’obbligo del potere pubblico ad
attivarsi a sostegno degli accordi raggiunti è giuridicamente inesigibile e
costituzionalmente irrilevante, ossia ha natura soltanto politica, ancorché le
intese vertano su “ materie che incidono direttamente sui rapporti tra
imprese, loro dipendenti e le rispettive organizzazioni di rappresentanza e non
comportino un impegno di spesa a carico del bilancio dello Stato”.
Concertazione, dunque, è una parola che non parla, gareggiando
da questo punto di vista con parole come flessibilità, come globalizzazione,
come gobba dei conti INPS. Non parla; in compenso, sconcerta.
“ Non amata, ma inevitabile ” ; ecco cosa sarebbe la
concertazione, secondo un apprezzato sociologo inglese: inevitabile, perché
permette ai governi e ai partner sociali di attuare uno scambio politico le cui
poste sono, da un lato, il rafforzamento della legittimazione politico-sociale
dei governi e, dall’altro, l’attivazione di un canale istituzionale che
permetta ai sindacati di influenzare le politiche pubbliche per arginare la
deriva neo-liberista, controllare la deregulation e contrastare la demolizione
indiscriminata del welfare state.
“ Destinato ad essere sempre con noi ” – prosegue Colin
Crouch – il fenomeno ha la ciclicità delle maree e, come le maree,
indietreggia e avanza. Ma è prevedibile l ’ intensificarsi dei suoi ritmi
contestualmente al processo d’integrazione europea, perché – come e più
della Commissione Delors, come e più della Commissione Santer – la
Commissione Prodi cercherà di rimediare al congenito deficit democratico
dell ’ Unione Europea stabilizzando rapporti diretti con le istituzioni
rappresentative della società e queste ultime potranno aiutare un’Europa
senza Stato ad acquisire quelle prerogative degli Stati-nazione dell’età
post-liberale che ne fanno un’autorità intesa come supremazia legittimata
dal consenso piuttosto che come forza dominante.
Per questo, scavando nel sottosuolo degli ordinamenti costituzionali, si
scoprirebbe che, proprio perché la concertazione dei nostri giorni è “un
modo informale di determinazione della volontà politica con funzione
complementare rispetto ai procedimenti formali” (L. Mengoni), nasconde lì
le sue radici. Come dire che è il più sonoro e visibile segnale, percepibile
anche dal più distratto dei giuristi e politologi contemporanei, di una
drammatica crisi epocale tuttora irrisolta: quella che sgretolò le basi degli
Stati mono-classe dell’Ottocento minacciati dalle istanze di protagonismo
delle masse popolari che la rivoluzione d’industriale, sovvertendo i delicati
equilibri dell’ecologia politica del tempo, scaraventava sulla ribalta della
scena nazionale col risultato di spaventare a morte le tradizionali élite del
potere e le classi medie. Di questa prolungata stagione formativa – si potrebbe
definirla la sua età di mezzo – il diritto del lavoro vigente nello scorcio finale
del Novecento conserva assai più di qualche segno superficiale; un po’
perché nessuna epoca storica inizia dall’ora zero e un po’ perché i molti
corporativismi dell’Europa della prima metà del Novecento si sono insediati
proprio per affrontare tutti i processi sociali, economici e politici con la
maturazione dei quali oggi stanno facendo i conti le democrazie dei paesi
industrialmente più progrediti ed è in quei contesti che si sono manifestati per
la prima volta i processi di giuridificazione dei rapporti tra i corpi intermedi e
lo Stato che taglieranno trasversalmente le società avanzate del secondo
dopoguerra.
Insomma, la concertazione non è altro che un neologismo per
riverniciare il lascito del corporatismo liberale, come Charles S. Maier
definisce – “non senza esitazione“ – la pratica di governo che si diffuse
intorno agli anni ’20 in alcuni paesi dell’Europa centro-meridionale e la
cui degenerazione provocò l’avvento di forme di Stato totalitario. Quella
pratica sviluppava una strategia di diseguale spessore e respiro aperta all’
integrazione nella legalità istituzionale del movimento operaio, nei confronti
della quale non potevano essere pregiudizialmente ostili le maggioranze
socialdemocratiche del sindacalismo euro-continentale che, da Weimar in poi,
ha considerato una sua vitale anomalia lo stare dentro la sfera dello Stato
senza compromettere il suo essere una forma primaria di auto-organizzazione
sociale.
Dopotutto, il fondatore delle Annales era del parere che ogni società è
sempre piena di ombre antiche che vi tornano o vi stazionano come i fantasmi
di certi morti insepolti e un grande intellettuale italiano ha scritto che “la
storia non ammette soluzioni di continuità e si serve dei miti, delle fedi, delle
illusioni per rinnovare la sua eternità” (P. Gobetti).
Per questo, dovremmo tutti riconoscere – con umiltà e non senza un filo
di gratitudine – che i padri costituenti, pur non sapendo rinunciare “agli
schemi che avevano caratterizzato l’esperienza sindacale fascista se non per
spogliarli del loro carattere autoritario ” (F. Mancini), al tempo stesso
cercarono di “frequentare il futuro”, per usare la “bella espressione”
che – sostiene Antonio Tabucchi – piacque tanto ad un abituale
frequentatore del passato come Pereira. E ciò perché seppero realisticamente
valutare come un dato irreversibile la centralità dell’apporto della legge alla
configurazione del contratto collettivo che nel corso del Novecento si era
venuto disegnando in ragione più dell’intreccio tra pubblico e privato che
non dell’intreccio tra interesse individuale e interesse di gruppo sul quale si
polarizzavano gli studi pionieristici di Lotmar in Germania, di Planiol in
Francia, di Messina o di Galizia in Italia.
Quindi, mettersi ad ironizzare sulla ingenuità di chi credeva nel “
miracolo della mediazione tra esigenze pluralistiche ed esigenze
pubblico-istituzionali” (F. Lunardon), come è tornato di moda non appena
ha ripreso ad espandersi la persuasione di quanto sia distorsivo attribuire all’
art. 39 nient’altro che la valenza di un veto costituzionale (per di più) “di
cartapesta” a legiferare in materia di contratto collettivo con efficacia
generale (M. D’ Antona), non è né impietoso né dissacrante. “ Taci,
Mercuzio, tu parli di nulla”, è la replica più cortese. “Miracoloso”,
casomai, è che il contratto collettivo del Novecento italiano si faccia ancora
prendere sul serio da un ceto di professionisti che non può sapere con
precisione di cosa sta parlando.
Perché, allora, non riconoscere che soltanto in seguito al prevalere della
tendenza – peraltro, viziata da strumentalismi – a sovrastimare l’anelito
libertario delle società intermedie e ad ingigantirne la paura d ’ uno
Stato-babau che si è potuto credere di avere sepolto il contratto collettivo
prefigurato dai padri costituenti?
Non lieve, infatti, è stata la sorpresa di “ ritrovare fuori della
costituzione quanto era già scritto in buona parte in quest’ultima” (G.
Vardaro); e non minore è stato l’imbarazzo con cui si è dovuto sostenerne,
con una singolare inversione metodologica, le “pretese di razionalizzazione
e di legittimazione” nei confronti dello stesso art. 39 di cui ogni tanto si
invocava la soppressione o una sapiente revisione (M. D’Antona).
La verità è che i più anziani avevano dimenticato ciò che, invece,
dovevano insegnare ai più giovani. Mario Nigro scrisse che “il ‘terzo’
non appartenente ai corpi intermedi è una realtà indistruttibile della struttura
sociale. E’ la sua sola esistenza che porta a negare la completa coincidenza
– presupposta, anche se non affermata esplicitamente dalle dottrine del
pluralismo sociale – fra insieme delle formazioni sociali e corpo più grande
(lo Stato)”.
9. – Le ragioni del neo-costituzionalismo.
“Quello che intercorre tra il giorno dell’approvazione della
costituzione ed il giorno della sua attuazione con leggi costituzionali o
ordinarie”, esorta a considerare Stefano Rodotà, “non è un periodo che
possa essere ignorato, quasi fosse una lunga parentesi chiusa la quale si torna
finalmente alla purezza delle origini”; come dire: niente può cambiare ciò
che, dovendo essere, è stato.
Sono convinto che l’esortazione non sia stata finora raccolta
con maggiore esprit de finesse di quanto non sia riuscito a Massimo D’
Antona allorché ha rivisitato l’art. 39.
“Rileggere oggi” il disposto costituzionale, assevera Massimo
nel suo saggio che reca la data del 18 maggio 1999, “significa innanzitutto
prendere atto del processo storico che ha spinto la legislazione sindacale a
coonestare, al di fuori degli schemi vincolati della seconda parte, le forme
volontarie e autolegittimate dell ’ organizzazione dei sindacati e della
contrattazione collettiva”.
Potrà anche destare una certa sensazione o un moto di vibrante
emozione che, nell’imminenza della tragedia di cui sarebbe rimasto vittima,
Massimo riprendesse il discorso là dove Gaetano Vardaro lo aveva interrotto
senza che potessimo sapere, né lui né noi, che un suo irreparabile gesto gli
avrebbe impedito di proseguirlo. Ma è normale che le sentinelle degli
avamposti si diano la voce nel cuore della notte; e non tanto per farsi coraggio
quanto piuttosto per darne agli altri, trasmettendo il messaggio che la frontiera
è presidiata. Anche se è pure normale che, se le retrovie sono troppo distanti,
il messaggio si percepisca debolmente, soltanto gli insonni possano udirlo e in
pochi siano disposti a decifrarlo compiutamente.
La frontiera è quella della rifondazione della teoria giuridica
del contratto collettivo sulla quale, quindici anni or sono, Gaetano si era
attestato con la tenacia che tutti ammiravamo allorché ci propose genialmente
di reinterpretare l’art. 39, immaginando che il disposto costituzionale “non
esauri(sse) le valenze normative assegnabili ai contratti collettivi all’interno
dell’ordinamento statale e non preclude(sse), neppure, il ricorso a forme
diverse di estensione erga omnes della loro efficacia. Né le une né le altre”,
sosteneva Gaetano, “godranno della tutela riservata al particolare sistema
espressamente menzionato dall’art. 39, comma 4°; ma saranno sempre
ammissibili, purché coerenti col principio di libertà sindacale formulato dall
’art. 39, comma 1°”.
La frontiera, quindi, coincide con quella che Armando Tursi ci
ha descritto di recente con una sintesi semantica così brillante da piacermi al
limite dell’invidia, riformulando “l’ipotesi che l’autonomia collettiva
riconosciuta e garantita dal primo comma dell’art. 39 costituisca una sorta di
‘cerchio maggiore’ al cui interno possono inscriversi ‘cerchi minori’
che realizzino diversi, possibili ed anche alternativi modelli di legificazione
dell’autonomia collettiva: il legislatore è libero di perseguire i propri
obiettivi di razionalizzazione del sistema contrattuale collettivo, purché non
valichi i limiti del cerchio maggiore”.
Senza poter prevedere come sarebbe andata a finire, nel 1997 l
’Aidlass ordinerà alle sue truppe di lasciare le retrovie e ammassarsi sulla
medesima frontiera per celebrare il suo XII Congresso nazionale, dominato
per l’appunto dal tema delle vicissitudini del contratto collettivo.
Il piccolo, ma agguerrito esercito vi affluì alla spicciolata e
dunque in maniera disordinata. Non per colpa dell ’ occasionale Stato
Maggiore, che anzi era di buona qualità ed era animato da buone intenzioni;
né per colpa dei capi storici, che ruppero il loro pensieroso silenzio soltanto
per auspicare “che i giovani si dedicassero, un po’ più intensamente e con
un po’ più di immaginazione, alla ricerca sui modi di espressione del
consenso in ambito sindacale, perché questa probabilmente costituisce la
chiave di volta attraverso la quale si riesce a risolvere tutta una serie di
problemi collaterali” (G. Giugni).
L’auspicio ha tutta l’aria d’un ripiego. Il suo autore infatti
era stato il presentatore di uno sfortunato disegno di legge in materia di
procedure per l’approvazione di accordi sindacali col dichiarato intento di
introdurre “correttivi al declino di un modello di democrazia sindacale
eutrofizzato in eguale misura da dosi eccessive di partecipazione
plebiscitario-informale alla base e di rigidità burocratico-istituzionali al
vertice” (B. Caruso). Ma, proprio perché era formulato da chi non poteva
rimproverarsi di non aver portato la questione nelle competenti sedi
legislative, l’auspicio va preso sul serio.
Il fatto è che, nell’arco dei trent’anni che separano il XII dal
III Congresso Aidlass, il legislatore non avrà agito a casaccio, ma –
secondo un’opinione che sa di antico – è stato “poco prudente” (M.
Grandi), perché avrebbe finalizzato l’autonomia collettiva alla composizione
di assetti di interessi legislativamente individuati, negandole “libertà di
contenuto, di procedimento, di scopo” (M. Grandi).
Chi la pensa così mostra di avere la proterva risolutezza
occorrente per candidarsi alla leadership degli assedianti di Montecitorio e
Palazzo Madama. Costoro, viceversa, farebbero meglio a sperare in Dio
piuttosto che ad impugnare le armi, seguitando così a prescindere dal solo
dato di fatto che merita di essere valutato con la necessaria pacatezza: è del
tutto irrilevante che l’autonomia collettiva si svolga in un regime di assoluta
informalità, quando “ il legislatore ha bisogno di lei come medium
indispensabile tra lo Stato e la società” (R. Del Punta). Pertanto, è inutile
mettersi ad agitare vessilli da crociata ogniqualvolta si assiste a tentativi di
spezzare un assedio durato assai più di quello narrato da Omero con iniziative
che testimoniano come gli assediati non siano affatto rassegnati a fare la fine
del pesce che nuota in una vasca a cui hanno tolto il tappo.
Senonché, è proprio a questo riguardo che la platea degli
spettatori si suddivide in opposte tifoserie.
I più duri, come Antonio Vallebona, non accettano
compromessi: “se non si attua o non si modifica l’art. 39, nel nostro
sistema non c’è spazio per l’efficacia generale del contratto collettivo”;
mentre i più buoni, come Franco Liso, sono indulgenti: “non deve dare
scandalo che il contratto collettivo venga caricato di funzioni regolative ultra
partes. Le parti sociali continuano ad operare liberamente”. Di rincalzo a
quest’ultimo, poi, Mario Napoli butta sul tavolo un carico da undici: dicono
che “la contrattazione collettiva, se funzionalizzata, perda la purezza dell’
originaria configurazione normativa, che risulterebbe bistrattata da un
legislatore deciso ad orientarla su obiettivi specifici. Capovolgerei totalmente
questo giudizio. (…) La contrattazione collettiva non cambia natura solo
perché il legislatore le attribuisce un oggetto d’intervento in funzione di
interessi generali. (…) Cambia forse natura la legge regionale che attua norme
di principio d’una legge dello Stato? La legge regionale rimane tale e quale,
come espressione della comunità locale, anche se si muove sui binari tracciati
da una apposita legge-cornice”.
Contrariamente alle intenzioni, è questo stesso accostamento – la
cui intonazione percussiva si addice all’estemporaneità – a scoperchiare
la fragilità dell’argomentazione. E’ dato infatti obiettare che legislazione
regionale e legislazione statale hanno basi fondative e profili istituzionali
qualitativamente identici. Per questo, la loro matrice ordinamentale non può
cambiare neanche quando si collocano in un rapporto gerarchico. Il fatto è che
l’argomentazione usata è un sintomo della vischiosità della medesima
ideologia giuridico-sindacale che, in passato, produsse dogmatismi sui quali
– come succede sempre –
è facile schierarsi e coi quali è difficile
dialogare.
Peraltro, nemmeno il giustificazionismo per partito preso può
essere più persuasivo. Anche l’accomodante Franco Liso lo sa. E non lo
nasconde: “è opportuno”, suggerisce, “che l’efficacia generalizzata del
contratto collettivo poggi su basi più solide”, affrontando “apertamente il
problema della seconda parte dell’art. 39”.
In realtà, sono perlomeno cinque anni che da un settore dello
star system accademico – non trascurabile più per qualità che per quantità: tra
i più solerti spiccano studiosi preparati e sensibili come Giampiero Proia e
Lorenzo Zoppoli – provengono insistiti segnali di un risveglio propositivo di
tipo neo-costituzionale. E’ come se i nodi non sciolti dell’ordinamento
sindacale di fatto fossero arrivati al pettine, e tutti in una volta.
Tenuto conto, come si deve, che la manipolazione anche delle
più care memorie di vicende o fatti del secolo XX anteriormente all’arrivo
del XXI è l’impudicizia intellettuale che chiamano revisionismo, vale la
pena di avvertire subito che la menzionata sollecitazione non ha questo vizio
d’origine. Ribadisco quindi che le dottrine giuridiche e politiche vincenti nel
dopo-costituzione hanno fatto bene a non risparmiarsi per dissuadere dall’
imboccare la strada dell’attuazione della seconda parte dell’art. 39.
Detto questo, però, non si è per ciò solo dimostrato che la strada
alternativa sia percorribile all’infinito divaricando la forbice tra i principi di
organizzazione del pluralismo sindacale ricavabili dalla costituzione formale e
il processo di formazione dell’ordinamento sindacale di fatto.
Non può certo essere questa la sede per rifare la storia della coalizione di governo
delle relazioni industriali che lo ha gestito. Una coalizione avente le caratteristiche di un
club l’appartenenza al quale conferisce una legittimazione paritaria e selettiva: paritaria,
nel senso che rende uguali i diversi, prevenendo così la rissosità per il primato tra gli
appartenenti al club, e selettiva in quanto chiude verso l'esterno, rifiutando così agli
estranei la legittimazione ad occuparsi delle materie che, per statuto, il club ha confiscato
per sé.
Ci tengo soltanto a dire che, nella persistente irrealizzabilità del progetto
costituzionale, è stato provvidenziale che tra i principali attori sociali si raggiungesse un
accordo di lungo periodo sull'assetto della costituzione materiale delle relazioni industriali.
Nondimeno, i guai sono arrivati quando, cooptato negli attici del potere pubblico ed
ammesso nei circuiti normativi dello Stato, il club ha rivelato la natura di “un’
organizzazione libera di diritto privato ed insieme altro-da-sé: un’istituzione in qualche
modo pubblica, braccio o segmento dello Stato” (V. Foa), nell’apparato e nell’
ordinamento del quale è venuta conficcandosi con la tenuta d’un chiodo ad espansione
piantato con perizia nella roccia, anche se in sistemi poco trasparenti come sono di solito
quelli autoreferenziali conta soltanto che i loro membri siano disposti a rilasciarsi
reciprocamente certificati di garanzia sulla genuinità del rispettivo pedigree e “più
esplicito è il monopolio contrattuale più forte diventa la posizione del vertice sindacale”
(S. Simitis). “E’ chiaro”, infatti, “ che né ai fini della contrattazione collettiva con
efficacia erga omnes né ai fini della concertazione neo-corporativa la legittimazione dei
rappresentanti di una delle parti sociali può dipendere esclusivamente dal riconoscimento
dell’altra” (L. Mengoni).
“La governabilità delle relazioni industriali – come di ogni altro sottosistema
sociale – si può garantire”, avrebbe detto Massimo D’Antona, “concentrando il potere
o incrementando il consenso ” . Si dà il caso che il club non fosse soltanto una
concentrazione di potere esercitato sulla società; incrementava anche il consenso della
società. Gli stati di grazia però non durano in eterno. E, quando spariscono, si determina un
’alternativa. Si può tentare di prolungarli artificialmente: “va in questo senso una
legislazione di ‘ premio ’ ai soggetti sindacali inseriti nel circuito politico degli
interlocutori dello Stato ” . Oppure, si può tentare di rianimare il pluralismo
rappresentativo, rivitalizzandone nei limiti del possibile il dinamismo che gli è proprio: “
va in questo senso una legislazione sulle procedure democratiche destinate a misurare la
rappresentatività concreta dell’agente contrattuale (…) che leghi l’efficacia generale del
contratto collettivo al consenso maggioritario” (M. D’Antona),
Se era probabilmente fuori posto l’elegante sarcasmo con
cui Luigi Mengoni commentò l’exploit del legislatore statutario – "ai suoi
occhi il sindacato (cioè, le tre maggiori organizzazioni sindacali) deve essere
apparso come agli occhi di Dio apparve l'Inghilterra nel glorioso 1689: 'la
guardò e vide che tutto era bene'" –
a distanza di trent’anni me ne
impadronisco volentieri per commentare l’impassibilità del legislatore di
fronte allo smisurato divario, privo di riscontri a livello comparato, “fra le
funzioni di rilevanza generale, direttamente o indirettamente attribuite ai
sindacati e alla contrattazione, e la totale assenza di regolazione legislativa
degli stessi soggetti e oggetti” (T. Treu).
Questo, ormai, è un luogo comune. Pochi, invece, dicono che il
legislatore non può addebitare la sua inerzia alla diabolica pervicacia delle
resistenze sindacali. Se fosse capace di compiere un severo esame di
coscienza, senza per ciò solo doversi sdraiare sul lettino dello psicanalista,
dovrebbe ammettere che lui stesso si è allevato in casa un sindacato il quale
col pluralismo si trova a suo agio soltanto se può amministrarlo come gli pare
e dunque che lui stesso, come suggeriva l’inascoltato Mario Nigro un quarto
di secolo fa, si è comportato da “protettore di privilegi e legittimatore
esplicito od occulto di poteri privati”, finendo così per “impattare contro il
principio costituzionale di libertà sindacale” (A. Tursi).
Infatti, proprio con lo statuto gli ha appaltato la gestione del
pluralismo sindacale esistente, giudicando il club della maggiore
rappresentatività “in condizioni di assicurare spontaneamente – una volta
rimosse le difficoltà di radicamento nei luoghi di lavoro – la necessaria
legittimazione alle proprie istituzioni”. Il pluralismo, insomma, lo statuto “
lo presuppone, ma non lo organizza”.
Per questo, tra tutti i “temi di un diritto sindacale possibile”
Massimo D’Antona attribuiva la priorità a quello attinente al “modo di
essere rappresentati, da chi e come ” : un modo da ridefinire in
corrispondenza al “bisogno più generale di ridisegnare nel sistema giuridico
l’immagine dell’individuo, con le sue istanze di autodeterminazione di
fronte ad ogni potere, anche se protettivo e benefico”.
Regole sulla legittimazione della rappresentanza, regole sulle garanzie
dei rappresentati, regole sul pluralismo associativo: ecco le regole che lo
statuto ha ritenuto di non dover scrivere, “dato che il sistema sindacale
assicurava autonomamente il necessario ordine”. Non a caso, Massimo
lo chiamava “’il non detto’ dello statuto dei lavoratori”.
“Contrariamente ad un diffuso luogo comune”, ha scritto, “nello
statuto i diritti di democrazia sindacale non sono riconosciuti ai
lavoratori come rappresentati”; infatti, “al diritto di assemblea e di
referendum corrispondono doveri a carico del datore di lavoro di
consentirne l’esercizio, non doveri a carico dei rappresentanti sindacali
di farne uso per ottenere il mandato o per rispondere ai rappresentati”..
Insomma, lo statuto “si preoccupa delle garanzie dei rappresentanti di
fronte al potere dell ’ impresa, ma non definisce la posizione dei
rappresentanti di fronte al lavoratori, né come iscritti né come
rappresentati”.
Non so cosa ne penserebbe, di questa denuncia, il ministro socialista al
quale la sorte negò la soddisfazione di concludere il dibattito
parlamentare che precedette l’emanazione dello statuto. “Il disegno
di legge che il mio ministero sta elaborando”, aveva preannunciato, “
si propone di fare del luogo di lavoro la sede della partecipazione
democratica alla vita associativa sindacale e alla formazione di tramiti
democratici di comunicazione tra il sindacato e la base dei lavoratori”.
Con ogni probabilità, Giacomo Brodolini che amava guardare in faccia
la realtà, perché sapeva che altrimenti non c’è nemmeno la speranza di
correggerla, penserebbe che allo statuto il miracolo non è riuscito; tutto
qui. Ma penserebbe anche che lo statuto non era attrezzato allo scopo. Le
sue coordinate storico-politiche non gli permettevano di affermare le
regole della democrazia sindacale se non “come rivendicazione nei
confronti di chi non solo doveva riconoscerle, ma anche subirle
sopportandone oneri e costi: le imprese” (B. Caruso).
Col passare del tempo, però, anche la Corte costituzionale ad un
certo punto ha dovuto ammettere che la maggiore rappresentatività
valorizzata dall’art. 19 dello statuto per premiare i sindacati confederali
era diventata per i medesimi quel che Giuliano Amato diceva spesso del
suo governo che, per quanto sventurato, sembra essersi procurata l’
imperitura stima degli italiani: un aliscafo sospeso su un cuscino d’aria
che può sgonfiarsi là per là.
La Corte però non se la prende col legislatore per ciò che aveva fatto
nel 1970 – “la Corte è ben consapevole che (…) l’idoneità del
modello disegnato nell ’ art. 19 a rispecchiare l ’ effettività della
rappresentatività sindacale è andata progressivamente attenuandosi” –
bensì per ciò che si ostina a non fare: fissare le regole del gioco che
permettano di sapere “chi rappresenta chi”, come e perché.
L’ostinazione è motivata non tanto da intrinseche difficoltà di ordine
logico-giuridico – perché in materia si può ormai scoprire soltanto l’
ombrello – quanto piuttosto dagli insuperati ostacoli che hanno finora
impedito di smantellare il bunker delle rendite di posizione nel frattempo
acquisite.
Ad ogni modo, un dato è fuori discussione: in un’epoca in cui è
legittimo “ chiedersi quale valore, anche giuridico, possa ancora
riconoscersi all’iscrizione ad un sindacato” (M. Rusciano) – un po
’ perché gli iscritti “ hanno scarso peso ” nelle decisioni del
sindacato e un po’ perché quest’ultimo, non trovando ragioni di
distinguere tra iscritti e non-iscritti, “tratta gli uni come tratta gli altri
” (A. Accornero) – non basta rivitalizzare l’etica del consenso;
occorre coniugarla con l’etica della responsabilità. Il che postula il
minimo legale necessario e sufficiente per rilegittimare una fonte di
produzione di norme imputabili ad un ordinamento che per i terzi
estranei è particolaristico e, ciononostante, adocchiate da rinvii
legificanti i quali, dilatandone l’efficacia, convertono l’autonomia
sociale – di cui sono espressione, nella migliore delle ipotesi, per gli
insider – in “indubbia eteronomia” per gli outsider (M. Nigro),
ossia per le moltitudini di cittadini che non hanno conferito alcun
mandato rappresentativo agli agenti effettivi del processo sociale.
E’ l’incessante circolarità di questo input-output tra sistema politico
(o giuridico-statale) e sistema di relazioni industriali (o sistema
giuridico-sindacale) che rende indifferibile l’accertamento dei requisiti
che i soggetti agenti devono possedere per acquistare una partnership
qualificata; un accertamento da effettuarsi in base a criteri, pensa e dice
la Corte, “ispirati alla valorizzazione dell’effettivo consenso come
metro di democrazia anche nell’ambito dei rapporti tra lavoratori e
sindacati” e dunque basati su di una combinazione virtuosa tra dato
associativo e dato elettorale risultante dall ’ istituzione legalmente
esigibile di rappresentanze unitarie del personale. E ciò non solo perché
“l’autorità della legge non può surrogare la forza sociale del contratto,
(ma anche perché) la forza sociale del contratto è commisurata al grado
di consenso che ottiene il rappresentante che negozia ” (M. D’
Antona).
Massimo Troisi direbbe: “scusate il ritardo”. Sarebbe carino che
facesse altrettanto anche la nostra corporazione. Oltretutto, non può
essere smemorata al punto di dimenticarsi che è stata formalmente
costituita in mora durante il suo XII Congresso.
Nel suo conciso intervento, infatti, Gino Giugni affermò che
toccava ai giuristi-scrittori dello star system accademico “ricostruire quello
che il legislatore ha voluto”. Vero è che qualcuno raccolse l’invito seduta
stante: il legislatore ha voluto “utilizzare la contrattazione collettiva per
quella che è in base al primo comma dell’art. 39, cioè come regolazione
sociale” (M. Napoli). Come dire: sono da escludere cedimenti alla “
tentazione panstatualista”, la cui pericolosa rinascita Gaetano Vardaro fu tra
i primi a percepire, “di utilizzare l’intensificazione dei rapporti tra Stato e
sindacati che il neo-corporativismo presuppone come punto di partenza per un
inglobamento vetero-corporativo dei secondi nel primo”.
Per quanto condivisibile, si tratta però dell’incipit di un discorso
bruscamente interrotto.
Che il legislatore consideri la contrattazione collettiva meritevole
di fiducia, sta bene: “è pacifico che il primo comma dell’art. 39 garantisce
tutela di rango costituzionale non solo ai sindacati in quanto gruppi
organizzati, ma anche alla loro attività negoziale e ai prodotti di tale attività”
(F. Bano). Anzi, il riconoscimento che l’ordinamento statale concede all’
ordinamento intersindacale, “ lasciandolo originario, è quello che si
consuma interamente nel primo comma dell’art. 39” (M. Pedrazzoli).
Tuttavia, ciò che ora interessa è interrogarsi sul punto se la condivisione dell
’incipit autorizzi il legislatore a sottostimare i principi costitutivi racchiusi
nei commi successivi della medesima disposizione costituzionale quando
ricollega ai prodotti dell’autonomia collettiva effetti ulteriori e/o diversi
rispetto a quelli che potrebbero ex se dispiegare. Infatti, “dire che non
estende l’efficacia del contratto collettivo, ma se ne avvale (…), non cambia
la sostanza delle cose” (P. Bellocchi).
“Al di là della loro inerenza al modello costituzionale di
dettaglio”, scrive Massimo D’Antona, “quei principi” esprimono scelte
di valore della costituzione dalle quali il legislatore non si può discostare
quando opera sul terreno della seconda parte dell’art. 39 e, sia pure allo
scopo di realizzare meccanismi alternativi al disposto costituzionale,
influenza il funzionamento del pluralismo sindacale”.. Piuttosto, alleggerito
e ripulito dei suoi (ormai) innocui e insignificanti detriti vetero-corporativi, è
tenuto ad attualizzarne il significato, adottando l ’ ottica di un ’
interpretazione adeguatrice od evolutiva e, cionondimeno, più recuperante che
correttiva.
Oggi, possiamo dire che ci ha provato; e senza dover esibire i
muscoli. Segno, questo, che si va mitigando il rifiuto di interferenze legali sui
“profili endo-organizzativi della formazione della decisione collettiva” (G.
Vardaro) e – amenoché non si sia trattato d’un isolato episodio, per ora
irripetibile, come sembra – la pretesa di rimandare sine die l’avvento di
“una seconda generazione di disposizioni a tutela del lavoro” (S. Simitis)
ha perduto l ’ intransigenza e l ’ arroganza che l ’ hanno sempre
caratterizzata.
A ragione, quindi, Massimo ha potuto concludere il suo saggio
del ’ 99 ravvisando una convincente “ concretizzazione ” del nucleo
essenziale dei principi dell’organizzazione del pluralismo sindacale secondo
la costituzione nel provvedimento legislativo che, nel medesimo arco
temporale, stava faticosamente producendo l’effetto di sbloccare l’acceso
alle uniche vie conosciute per restituire credibilità, trasparenza ed efficienza
ad un sistema sindacale maturo.
La prima, esplorata palmo a palmo da squadre di investigatori, è
quella che permette il transito da un regime di rappresentatività presunta dei
sindacati, nei confronti del quale una democrazia politica non può non essere
allergica, ad un regime di rappresentatività verificata sia agli effetti della
legittimazione a negoziare che agli effetti della misurazione secondo il criterio
proporzionalistico del consenso effettivo di cui ogni sindacato è portatore al
tavolo negoziale, rendendo così computabile il consenso maggioritario che
autorizza la stipulazione di contratti collettivi con la ragionevole certezza
della sua corrispondenza all’interesse comune dei rappresentati.
La seconda permette di passare da un pluralismo aselettivo e
non regolato ad un pluralismo governabile.
Vero è che il telaio normativo è stato allestito per essere
montato su di un veicolo per adesso parcheggiabile unicamente nell’area del
pubblico impiego.
Tuttavia, poiché le regole del suo funzionamento, se non
attuative dell’art. 39, appaiono compatibili col medesimo – specialmente
se valutate attraverso il filtro d’una pronuncia della Corte costituzionale di
poco posteriore al referendum abrogativo sull’art. 19 st. lav. – a quanti
sono interessati ad eliminare il dualismo normativo che è venuto a
determinarsi è scappato subito di dire che la soluzione del problema dell’
efficacia legale erga omnes del contratto collettivo del Novecento italiano
appariva più vicina alle soglie del Duemila di quanto non lo fosse nel
momento in cui essa venne proposta, profilandosi finalmente la possibilità di
una occupazione del sistema delle fonti regolative in materia sindacale e del
lavoro accompagnata dai preparativi per instaurarvi un regime di reggenza
condivisa da carissimi nemici.
Certo, se lo storico assedio della cittadella a cui ho più d’una
volta accennato fosse, come può sembrare, in procinto di concludersi senza la
sconfitta degli assedianti, ma anche senza la capitolazione degli assediati e
dunque senza vinti né vincitori, l’avvenimento segnerebbe un passaggio d’
epoca paragonabile a quello compiuto con lo statuto. Anche lo statuto,
secondo un attento osservatore francese di cose italiane, “segnò la fine di
una lunga pazienza”.