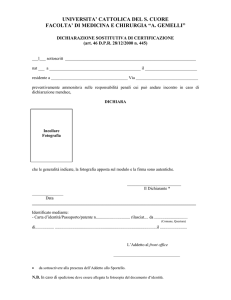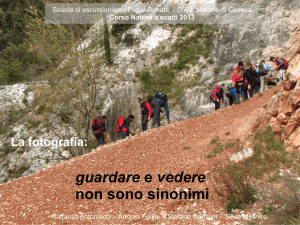Samuel Fosso, fotografo di studio a Bangui
di Maria Francesca Bonetti
Nonostante l’invito di Jean Lamorei a non classificare e a non considerare l’opera
fotografica di Samuel Fosso insieme a quella di altri fotografi africani, impegnati
professionalmente nel ritratto in studio, ci sembra invece utile tentare di esaminare
in questa occasione, accanto alle serie di autoritratti, che costituiscono il nodo
centrale dell’attività creativa di questa originale figura d’artista, anche il suo
lavoro con la clientela di Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, nella
quale Samuel Fosso vive dal 1972 e pratica l’attività di fotografo fin dal 1975.
Se in questi ultimi anni – a partire almeno dal 1994, quando il suo lavoro è
stato portato alla luce da Bernard Descamps alla prima edizione dei «Rencontres
de la Photographie Africaine» di Bamako (Mali) – l’enfasi è stata sempre posta, e
non a caso, sugli inediti, insoliti e accattivanti autoritratti, che l’autore continua a
realizzare in declinazioni sempre nuove e aggiornate, scandagliando ormai e
mettendo in scena traumi e personaggi legati alla propria vicenda biografica,
può essere interessante, d’altra parte, anche un’analisi dell’altro aspetto del suo
lavoro; e non soltanto alla luce e in rapporto a quanto Fosso ha espresso
contemporaneamente con le sue diverse autorappresentazioni, ma anche in
relazione a quello che è stato, fino agli inizi degli anni ’80, il principale genere
fotografico praticato in Africa nell’ambito del professionismo.
In questo ambito, infatti, Fosso può facilmente costituire un esempio e
rappresentare un ulteriore riferimento per una rilettura del ritratto fotografico in
studio – il genere che Simon Njami, direttore artistico del Festival di fotografia di
Bamako, individua come “the real one, in Africa”ii – e del percorso che questo ha
seguito negli anni critici del passaggio dall’age d’or del bianco e nero (dagli anni
’50 agli anni ’70) al suo declino e alla completa trasformazione negli anni ’80.
Lecito, a questo punto, domandarsi se sia giusto ancora considerare Fosso in
quanto fotografo ‘africano’, non soltanto ricadendo così in quel pregiudizio da
cui rifugge Jean Lamore – che lo considera tutt’altro rispetto ai diversi ritrattisti
attivi in Africa – ma anche correndo il rischio di una lettura ancora una volta
eurocentrica e di un’interpretazione che, anche se non intenzionalmente,
supponga una superiorità della fotografia occidentale, dalla quale, oltre tutto, ha
avuto storicamente origine la pratica fotografica in Africa. Senza poi considerare
che, anche assumere la fotografia ‘africana’ come un insieme di autori e di
episodi descrivibili unitariamente, facilmente riconoscibili per una presunta
omogeneità culturale e una specifica omologa identità, è ormai un approccio del
tutto superato dalla maturata consapevolezza, anche da parte del mondo
occidentale, delle molteplici diversità e peculiarità, non solo etniche, presenti nel
caleidoscopico mondo africano moderno e contemporaneoiii.
Nonostante il rifiuto di considerare l’Africa globalmente, proprio nell’ambito
di alcune manifestazioni che più recentemente hanno dato spazio alla fotografia
africana, o più in generale alle diverse arti e forme espressive del continente iv, si è
cercato tuttavia di individuare le caratteristiche che più propriamente
evidenziano lo sviluppo e l’autonomia della fotografia africana, provando a
delineare , anche al di là delle differenze e delle varietà locali, o dei generi
praticati e dei referenti scelti per le immagini, una sua possibile identità: riferibile,
cioè, ad una specifica e comune cultura dello sguardo; rilevabile, eventualmente,
grazie alla combinazione di particolari ‘fotemi’ più o meno ricorrenti, ossia
attraverso l’individuazione di precise tipologie formali; in grado, infine, di
promuovere anche una più profonda conoscenza e comprensione dei caratteri di
modernità impliciti, non soltanto nelle culture africane del XX secolo, ma anche
nelle loro strategie di autoaffermazione e nei loro sistemi di rappresentazione
nell’epoca post-colonialev.
In tal senso, particolarmente illuminante è il contributo di Pol Corvez offerto
in occasione del primo seminario dedicato alla semiologia della fotografia
africana, tenutosi durante la seconda biennale di Bamako (1996)vi, nel quale si è
tentato – proprio alla luce di un’analisi dei diversi autori e delle diverse immagini
presentate nella mostra – d’individuare l’insieme delle motivazioni, dei tabù e delle
norme linguistiche che potrebbero definire e qualificare appunto una specificità
della fotografia africana, intesa comunque come un complesso sistema di tensioni
generalmente “convergenti”, rispetto al quale però è sempre possibile constatare
“divergenze” e “periferie”vii.
Il lavoro di Samuel Fosso incarna esemplarmente queste tensioni,
visualizzando la modernità e l’individualità africana, sia quando, privatamente e
più liberamente, si spinge verso una ricerca del tutto indipendente e
autoreferenziale, trasgressiva e alternativa rispetto ai canoni generalmente diffusi
nella pratica dei fotografi di studio, sia quando, per esigenze strettamente
professionali e commerciali, si rivolge alla rappresentazione della comunità di cui si
sente intimamente parte e alla quale, anche a dispetto dello status di artista ormai
acquisito a livello internazionale, continua tuttora a offrire il proprio servizio di
fotografo.
E se i suoi autoritratti definiscono con più evidenza una personalità creativa
di spicco, incredibilmente precoce nel mostrare alcuni degli aspetti emergenti
nelle tendenze artistiche contemporanee, i ritratti realizzati in studio dal 1975 ben
sintetizzano invece la tradizione iconografica, gli usi e le modalità produttive del
genere fotografico certamente più rappresentativo e più diffuso nelle società
africane, mostrando pienamente anche i segni della sua obsolescenza e della sua
difficile sopravvivenza, in seguito all’introduzione nei primi anni ’80 della fotografia
a colori, di fronte all’invadenza delle nuove e più economiche pratiche dei
fotografi di strada.
Nell’attività professionale, e soprattutto a livello formale, Fosso è addirittura
più facilmente assimilabile ai ritrattisti classici delle precedenti generazioni (quali
Mama Casset, Seydou Keïta, Abderramane Sakaly o Malick Sidibéviii) che non ad
altri fotografi, suoi coetanei, maggiormente rappresentativi dell’attuale fotografia
africana (il ghanese Philip Kwame Apagya o il sudafricano Zwelethu Mthethwa),
con i quali invece condivide essenzialmente, a un livello più concettuale, una
vivace e critica opposizione all’immagine tradizionale dell’Africa, etnografica ed
esotica, costruita dall’Occidente, e le istanze di liberazione della fantasia
individuale al gioco delle multiformi e complesse identità che più propriamente
evocano la realtà transculturale e cosmopolita dell’Africa moderna.
È infatti nel solco della ritrattistica in studio, inaugurata dai fotografi africani
nei primi decenni del XX secolo e divenuta popolare negli anni ’50-60, che l’attività
professionale di Samuel Fosso prende avvio, dopo un’infanzia particolarmente
drammatica, e dopo un brevissimo apprendistato presso un fotografo nigeriano,
alla giovanissima età di 13 anni, quando viene inaugurato a Bangui, il 14 febbraio
1975, il suo primo locale, lo Studio Photo National
Sono gli anni in cui nella Repubblica Centrafricana, dichiarata indipendente
dal 1960 ma rimasta sotto l’influenza dell’amministrazione francese, si assiste
all’ascesa al potere di Jean-Bedel Bokassa il quale, dopo essersi proclamato
presidente a vita nel 1972, con il sostegno di Francia, Israele e Sudafrica si
autoincorana imperatore nel dicembre del 1977. Il paese, estremamente povero e
già depredato nel passato da un cruento e sanguinoso processo di
colonizzazione, durante il quale aveva subito lo sfruttamento della manodopera e
delle proprie risorse oltre che pesanti occupazioni e persecuzioni militari, non
aveva ancora visto la diffusione – né a livello professionale, né tanto meno a livello
privato e amatoriale –, della pratica fotografica che, in Africa, ha generalmente
seguito la stessa via di penetrazione delle compagnie commerciali e della
colonizzazione europea, manifestandosi quindi più tardivamente nelle zone
lontane dalle città portuali e dai maggiori centri situati lungo le coste. In questa
particolare condizione di arretratezza economica e culturale, anche nella
capitale della Repubblica Centrafricana, non si era perciò ancora
sufficientemente diffusa l’esigenza della piccola borghesia locale di farsi
rappresentare secondo gli schemi considerati alla moda, in una proiezione, non
tanto della propria realtà, quanto delle proprie aspirazioni sociali.
Seppure con un notevole scarto temporale, le fotografie realizzate da
Samuel Fosso nei primi anni della sua attività, mostrano pertanto, da parte della
clientela, lo stesso entusiasmo e la stessa gratificazione sociale che il ritratto
fotografico ha sempre suscitato, alle sue origini, in tutto il mondo, in quanto atto
eminentemente simbolico, di affermazione dell’individuo, che “corrisponde a uno
stadio particolare dell’evoluzione sociale: l’ascesa di larghi strati della società
verso un più alto significato politico e sociale” ix. Come sempre accade nel
ritratto ad uso delle classi piccolo-borghesi e più popolari, dove la fotografia, in
quanto arte “media” x , esprime massimamente la sua funzione di indicatore
sociale, così anche nelle immagini di Fosso, costumi, accessori, fondali, pose e
atteggiamenti non corrispondono tanto ad esigenze estetiche e di stile, quanto
piuttosto mirano alla costruzione di un messaggio emblematico, a una messa in
scena consapevole dei ritrattati, i quali – anche mediante e proprio grazie all’uso
di stereotipi – intendono rendere visibile a se stessi e alla collettività la prova della
loro affermazione e della loro appartenenza alla modernità.
La fotografia corrisponde in questo senso al bisogno di una comunità di
confermare l’“evidenza” e di rassicurare sulla “verità” di una realtà, non assoluta,
ma soggettiva (ciò che vuole essere e mostrare di sé), offrendo “nient’altro che la
riproduzione dell’immagine che il gruppo dà della propria integrazione”xi.
È in questo bisogno iconico collettivo che risiede molto probabilmente una
delle caratteristiche essenziali dei ritratti di Samuel Fosso, nei quali non interessano
tanto l’espressione, il carattere individuale, la personalità del soggetto fotografato,
quanto la sua rappresentazione secondo atteggiamenti, gesti, costumi che
possano essere riconosciuti e condivisi, dagli ‘altri’ cui l’immagine è generalmente
destinata, in quanto manifestazione di valori comuni.
E se, per rimanere nell’ambito dell’analisi fotologica proposta da Corvez,
possiamo facilmente individuare anche nelle immagini di Fosso (e non soltanto nei
ritratti della popolazione di Bangui, ma anche nei suoi stessi autoritratti), alcuni dei
‘fotemi’ che più frequentemente sono utilizzati dai fotografi di studio in Africa,
ancora più importante, per la comprensione e una corretta valutazione
sociologica di queste immagini, è l’individuazione di alcuni particolari elementi
della scena in cui si costruiscono i vari ritratti, particolarmente illuminanti e
significativi dei contenuti simbolici che tali immagini hanno la funzione di veicolare.
Come le immagini di Keïta o di Sidibé, i ritratti di Fosso presentano una
chiara strutturazione, in cui il soggetto principale è generalmente posto al centro
del campo visivo, è chiaramente e uniformemente illuminato, posto in relazione
con una serie di motivi e di forme che ne definiscono il contesto, semplificato e
standardizzato nella ripetizione di una serie di patterns scelti volta per volta in
favore della leggibilità della posa, del gesto o dell’accessorio-attributo su cui si
vuole porre l’accento. Tale strutturazione delle immagini, che tende alla massima
definizione del soggetto e a una evidente identificazione della fotografia con lo
stesso oggetto/soggetto fotografato, riconduce anche le opere di Fosso a quella
tipologia, caratteristica dei fotografi di studio africani che, secondo il modello
fotologico utilizzato da Corvez, può essere definita di carattere “clinico”xii.
Tale classificazione, tuttavia, non ci interessa qui per un’omologazione delle
immagini di Fosso a uno stile e a un modello formale dato, già fissato dagli
eleganti lavori dei più eminenti fotografi delle precedenti generazioni che, come
Mama Casset o Seydou Keïta, hanno non soltanto contribuito a ridisegnare e
reinventare il ritratto dell’Africa post-coloniale, neutralizzando completamente la
precedente rappresentazione coloniale dell’individualità africana, ma hanno
anche operato a favore della costruzione e della diffusione di un’estetica del
ritratto di altissima qualità, caratterizzata da composizioni austere e rigorose, in cui
all’equilibrio e alla sapiente modulazione degli elementi grafici si accompagna
una padronanza e una consapevolezza della regia artistica che traspare
nell’agio, nella naturalezza e nel dominio di sé che i personaggi ritratti mostrano di
fronte alla macchina.
Si tratta piuttosto di capire, semmai, se i caratteri formali delle immagini di
Fosso, come quelli degli altri fotografi africani, rimandino più semplicemente a una
loro comune cultura visiva, determinata da una struttura percettiva e da una
concezione prospettica dello spazio diverse da quelle occidentali, ravvisabile del
resto, in Africa, anche in altre forme e in altri sistemi di rappresentazione pittorica e
grafica.
In quanto regista delle immagini, magicien davanti al quale sfilano
ritualmente tutti gli abitanti del quartiere Moustapha – in cui Fosso ha il suo studioxiii
– per fissare nella propria e nella memoria dei propri cari i momenti più significativi
dell’ esistenza, il fotografo presta ai suoi attori tutto l’apparato necessario per la
fabbricazione dell’icona che essi desiderano, come esplicitamente egli promette,
all’ingresso del suo primo studio aperto a Bangui, nel programmatico slogan
pubblicitario: “Avec Studio photo Nationale vous serez beau, chic, delicat et facile
à reconnaitre”xiv
Negli anni ’70, la moda del ritratto fotografico in bianco e nero, realizzato in
studio e in un certo senso ‘codificato’ nei decenni precedenti secondo norme e
gusti propri alla nascente borghesia locale, si è particolarmente diffusa e radicata
in tutta la società, coinvolgendo ormai anche i gruppi sociali più poveri. Anche
l’accresciuta esigenza pubblica di disporre di foto d’identità per motivi burocratici
e amministrativi, insieme all’affermazione del genere del reportage di carattere
privato e familiare, contribuiscono in questi anni ad accreditare la figura del
fotografo agli occhi della comunità, a riconoscergli l’importante ruolo di testimone
di tutti gli avvenimenti rilevanti relativi alla vita familiare e pubblica.
In questa nuova situazione, di fronte a una più ampia ‘democratizzazione’
della fotografia, che presupponeva comunque l’uso di pratiche e di materiali
meno raffinati e più economici, diminuiscono anche le pretese estetiche di rigore
formale che avevano particolarmente qualificato il lavoro dei ritrattisti negli anni
’50-60. Anche gli accessori messi a disposizione dei clienti si riducono all’essenziale
e, pur mantenendo il loro importante carattere allusivo e simbolico, spesso si
presentano in oggetti e in forme meno nobili: non prevedono più, ad esempio, il
ricco e variegato corredo di costumi e gioielli tradizionali che Seydou Keïta
metteva a disposizione dei propri personaggi, provenienti in genere dall’élite
culturale, commerciale e professionale di Bamako. Ma sono soltanto, forse, alcuni
elementi più semplici dell’abbigliamento (T-shirts, camicie, occhiali, cravatte,
borse), aggiornati però secondo la moda del momento, per esprimere meglio la
propria disponibilità al cambiamento e la propria capacità di occupare un ruolo
nella società moderna.
Si tratta poi soprattutto di oggetti stereotipati: sedie, griglie di ferro, fiori
artificiali, strumenti vari che rimandano a gesti ed azioni della vita quotidiana e,
più in particolare, telefoni, biciclette, motociclette, radio, registratori, dischi, ossia
gli oggetti che più significativamente alludono alle novità e alle comodità di una
condizione sociale più avanzata, al successo che si è conquistato o che, più
plausibilmente, si desidera.
La radio, che già fa bella mostra di sé in un’immagine di Keïta della
seconda metà degli anni ’50, appare sempre più frequentemente, dagli anni ’60
in poi, nelle rappresentazioni figurative, e non soltanto fotografiche, dei paesi
africani. Come ben sottolinea Olu Oguibexv, la radio sintetizza una molteplicità di
valori positivi che rappresentano la nuova e urbanizzata società africana:
metafora di innovazione, scambio, libertà e circolazione di idee, strumento e
status symbol della comunicazione globale, è l’emblema di una cultura aperta
all’ascolto, sempre curiosa e disponibile a recepire i richiami del mondo esterno.
Come, e forse più di altri oggetti alla moda (sostituita però ormai dal computer
nella più recente immagine di Philip Kwame Apagya, Hello World), si impone
quale simbolo della cultura africana contemporanea, che come “ogni cultura è
un amalgama di fonti e riferimenti disparati e apparentemente incongrui, nessuno
dei quali è caratterizzato da un’autenticità intrinseca”xvi.
Anche nelle fotografie di Fosso, l’inserimento di elementi disparati, la
presenza dei quali sembrerebbe incongrua rispetto al contesto raffigurato –
soprattutto in relazione al ristretto e claustrofobico spazio della scena ricostruita nel
suo piccolo studio délabré –, rimanda invece intenzionalmente alla loro effettiva
ed importante presenza nella realtà africana contemporanea, all’attualità della
società che si afferma e si racconta attraverso le proprie immagini.
Tali oggetti, caratteristici della società dei consumi del mondo moderno
(orologi, biciclette, veicoli a motore, ventilatori, telefoni, macchine da cucire, ferri
da stiro, computer, etc.), assumono nelle fotografie lo stesso ruolo metaforico e
allusivo che, con particolare eloquenza, è stato loro affidato nei tessuti stampati
(wax prints), generalmente di produzione occidentale, che costituiscono da
tempo in Africa la base dell’abbigliamento femminile alla modaxvii.
Il linguaggio allegorico, tipico e convenzionale della cultura retorica
dell’Africa occidentale, è presente d’altra parte nelle fotografie di Fosso, come in
tutta la pratica fotografica della stessa area, anche sotto altre forme xviii. A volte gli
stessi abiti dei personaggi possono essere costituiti da tessuti del genere allegorico,
che rimandano a detti, a proverbi o fatti popolari o anche, più esplicitamente,
possono rappresentare un riferimento, un commento agli avvenimenti politici o ai
protagonisti dei nuovi sistemi di potere nell’epoca neocoloniale: ne sono esempio
l’autoritratto di Fosso con la maglia su cui sono stampati i ritratti di Boganda e
Bokassa o l’immagine con una coppia affrontata di donne che sembrano
celebrare fieramente l’avvento dell’Impero centrafricano (secondo la scritta sul
bordo dei loro vestiti “Empire Centrafricaine” xix ). Ma nello stesso senso,
certamente, giocano anche le scritte che in alcuni casi compaiono in rari vintages
dei primi autoritratti dell’autore (“Belles sont les caresses / Douces les tendresses”,
1978; “C’est là où j’ai passé une belle vie / en Empire Centrafricaine…”, 1977;
“Lisons dans le futur car le passé est là pour nous transformer”, 1977).
Anche gli atteggiamenti, i gesti, alcune pose dei personaggi, non sempre
per noi del tutto decifrabili, si riferiscono spesso ad un repertorio convenzionale,
comprensibile soltanto all’interno della cerchia familiare e culturale cui la
fotografia è destinata, in ricordo di un evento o in segno di un particolare
sentimento. E, a questo proposito, non bisogna dimenticare che anche gli
autoritratti di Fosso, almeno all’inizio, o comunque secondo quello che l’autore
dichiara essere stato il primo pretesto per la loro realizzazione, dovevano essere
inviati alla nonna in Nigeria, per rassicurarla, grazie all’effetto di evidenza e di
presenza della fotografia, sul proprio stato, sulla propria personalità e sulla fierezza
della propria esistenza.
Infine, a completamento di questo soltanto apparentemente ingenuo
sistema di significati e di rimandi a una realtà che, proprio grazie alla complicità e
alla stretta familiarità del fotografo e del ritrattato, può essere messa in atto nel
rituale che si svolge all’interno dello studio fotografico, si situano i fondali dipinti
che, mutuati all’origine dalla pratica dei fotografi occidentali, svolgono, come in
altri momenti della storia della fotografia, una funzione di particolare importanza
emblematica. Tuttavia, il senso del riferimento topico che questi attualmente
rappresentano è, ancora una volta, mutato rispetto a quello della tradizione
occidentale, nella quale il topos era ricollegabile precisamente e specificamente
al contesto ambientale, storico e geografico, in cui il ritratto veniva eseguito.
Nell’‘africanizzazione’ di questo elemento decorativo, ad opera soprattutto di
artisti nigeriani e ghanesi, che hanno tra l’altro contribuito a creare una sorta di
unità iconografica dei fondali più comunemente diffusi nei paesi dell’Africa
occidentalexx, il rimando è invece, più genericamente, alla civiltà e al mondo del
progresso, incarnato da tutte le anonime città post-moderne, rappresentate
icasticamente da un paesaggio urbano di enormi edifici, strade, incroci, ponti,
piloni, lampioni e fili della corrente elettrica. Nelle fotografie di Fosso appaiono,
alternativamente ad altri scenari composti da tendaggi di vario genere, sempre
senza riferimenti realistici particolari, ma con una forte connotazione simbolica del
mondo al quale il ritrattato vuol dimostrare di appartenere.
Soltanto più recentemente, con l’uso tra l’altro della fotografia a colori,
questi fondali si moltiplicano, nelle messe in scena del fotografo, alludendo anche
ad altri luoghi nel mondo, in un’accezione più esotica, legata all’idea del viaggio
e al desiderio del ritrattato di essere altrove, o di essere qualcun altro, in una
simulazione che – analogamente a quanto Fosso fa nei propri autoritratti – sfrutta il
travestimento e la dislocazione fittizia per riprodurre il proprio sguardo moderno sul
mondo e dar vita alle molteplici aspirazioni della propria personalità.
Jean Lamore, Samuel Fosso, «NKA. Journal of Contemporary African Art», n. 13/14, Spring/Summer 2001, pp. 34-39.
Simon Njami, A certain view of Mankind, in Magnus Af Petersens (a cura di), Samuel Fosso. Seydou Keïta. Malick Sidibé.
Portraits of Pride. West African Portrait Photography, catalogo della mostra (Stockholm, Moderna Museet; Sundsvall, Bildens
Hus; Oslo, Norskt Fotomuseum), Stockholm, Raster Förlag, 2002, pp. 70-77: 76.
iii Si veda in particolare Teresa Macrì, ibridAAfricA, tra memoria e modernità, in Egidio Cossa, Guido Schlinkert, ibridAAfricA /
hybrid,, catalogo della mostra (Cagliari- Lazzaretto Sant’Elia), Roma, Gangemi editore, 2002, pp. 86-91.
iv Oltre ai «Rencontres de la Photographie Africane», che dal 1994 si tengono ogni due anni a Bamako, si ricordano qui in
particolare l’esposizione «L’Afrique par elle-même» (Parigi, Maison Européenne de la Photographie, 1998), cui ha fatto
seguito il volume Anthologie de la Photographie africaine et de l’Océan Indien, Paris, Editions Revue Noire, 1998, e la mostra
a cura di Okwui Enwezor, The Short Century. Independence and Liberation Movements in Africa 1945-1994 (Monaco,
Museum Villa Stuck; Berlino, House of World Cultures; Chicago, Museum of Contemporary Art; New York, P.S.1 Contemporary
Art Center and The Museum of Modern Art), Munich-London-New York, Prestel, 2001. Si veda anche Simon Njami in Antonia
Carver (a cura di), Blink.100 Photographers 010 Curators 010 Writers, London-New York, Phaidon Press, 2002, pp. 415 e 426.
v Si vedano soprattutto Jean Loup Pivin, L’îcone et le totem, in Anthologie… cit., pp. 25-31 (ora anche in Blink… cit., pp. 426428) e Lauri Firstenberg, Postcoloniality, Performance, and Photographic Portraiture, in The Short Century…, cit., pp. 175-179.
vi Pol
Corvez, Réflexions sémiologiques sur la photographie africaine [1996] (disponibile in http://buweb.univngers.fr/PRESSES/publicationsnumeriques/Kachina/travauxling8/7corve~1.htm)
vii Sono i termini proposti da Anne-Marie Houdebine (citata da Corvez), secondo il suo modello di analisi linguistica.
viii Per un più ampio confronto con l’opera, in particolare, di Seydou Keïta e Malick Sidibé, si rimanda a Samuel Fosso.
Seydou Keïta… cit., 2002. Si vedano inoltre le due monografie dedicate da André Magnin ai due ormai ben noti fotografi di
Bamako (Mali): Seydou Keïta, testi di André Magnin e Youssouf Tata Cissé, Zurich-Berlin-New York, Scalo, 1997 e Malick
Sidibé, Zurich-Berlin-New York, Scalo, 1998, oltre al recente volume a cura di Cristiana Perrella, Valentina Bruschi, I Ka Nyì
Tan. Seydou Keïta e Malick Sidibé fotografi a Bamako, catalogo della mostra (Roma, Museo Hendrik Christian Andersen),
Roma, Castelvecchi Arte, 2001.
ix Gisèle Freund, Fotografia e società. Riflessione teorica ed esperienza pratica di una allieva di Adorno, prefazione di Carlo
Bertelli, Torino, Einaudi, 1976, p. 7.
x Pierre Bourdieu, Un Art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Les Editions de minuit, 1965 (tr. it. La
fotografia. Usi e funzioni di un’arte media, Rimini, Guaraldi, 1972).
xi Bourdieu, Un Art moyen… cit., p. 48 (ripreso anche da Rosalind Krauss, Nota sulla fotografia e il simulacro [Photography
and the Simulacrum,1983], ora in R. Krauss, Teoria e storia della fotografia, ed. it. a cura di Elio Grazioli, Milano, Bruno
Mondadori, 1996, pp. 218-232).
xii In base a tale modello, quattro sono le tipologie fotologiche entro le quali, in base alla ricorrenza degli elementi
linguistico-strutturali più frequentemente utilizzati, possono essere classificati i fotografi africani: oltre al tipo “clinico”, che
privilegia la riconoscibilità dei referenti, si hanno le fotografie “mitiche” (che utilizzano elementi destrutturanti, come il flou o
il filé, per una dissociazione estrema dell’oggetto/soggetto dalla fotografia) e le fotografie “morfiche” (che, pur
privilegiando l’aspetto formale, strutturato e controllato delle fotografie “cliniche”, non rispettano i caratteri di referenzialità
della fotografia), maggiormente influenzate dalle ricerche della fotografia occidentale contemporanea e che ricorrono
soprattutto nelle ricerche espressive dei più giovani fotografi africani; e infine le fotografie “deittiche” (che favoriscono il
riconoscimento del referente pur utilizzando elementi destrutturanti, tipici del “mitico”), più generalmente riconducibili al
fotogiornalismo (si veda Corvez, Réflexions… cit. , pp. 4-6).
xiii Già nel marzo del 1976, pochi mesi dopo aver inaugurato la propria attività, Fosso si trasferisce nello studio in cui ancora
lavora, chiamandolo “Studio Confiance”. Successivamente, lo studio prende il nome di “Studio Gentil” (1977), “Studio
Hobereau” (1979) ed infine, nel 1982, assume definitivamente l’attuale denominazione “Studio Convenance”.
xiv Cfr. la fotografia a p.97
xv Olu Oguibe, La radio a transistor degli dei, in Cossa, Schlinkert, ibridAAfricA… cit., pp. 100-114.
xvi Ivi, p. 106.
xvii Si veda in particolare Egidio Cossa, Sguardi incrociati (intervista di Teresa Macrì), in Cossa, Schlinkert, ibridAAfricA… cit.,
pp. 92-99.
xviii Si confronti, in particolare, Tobias Wendl, Ghana. Portraits et décors, in Anthologie… cit., pp. 143-155.
xix Una piccola stampa (vintage) di questa immagine, conservata ancora presso lo studio del fotografo, riporta sul verso
oltre al timbro “Studio Photo Gentil / Bangui – C. A.”, anche la significativa data “18 Dec. 1977”.
xx Già allo “Studio Photo National” di Samuel Fosso che, ricordiamo, ha svolto il suo apprendistato presso un fotografo
nigeriano, risale il primo di questi fondali, cui più tardi si aggiunge quello firmato e datato da “Bel Senghor / oiseau rare/
1979”.
i
ii