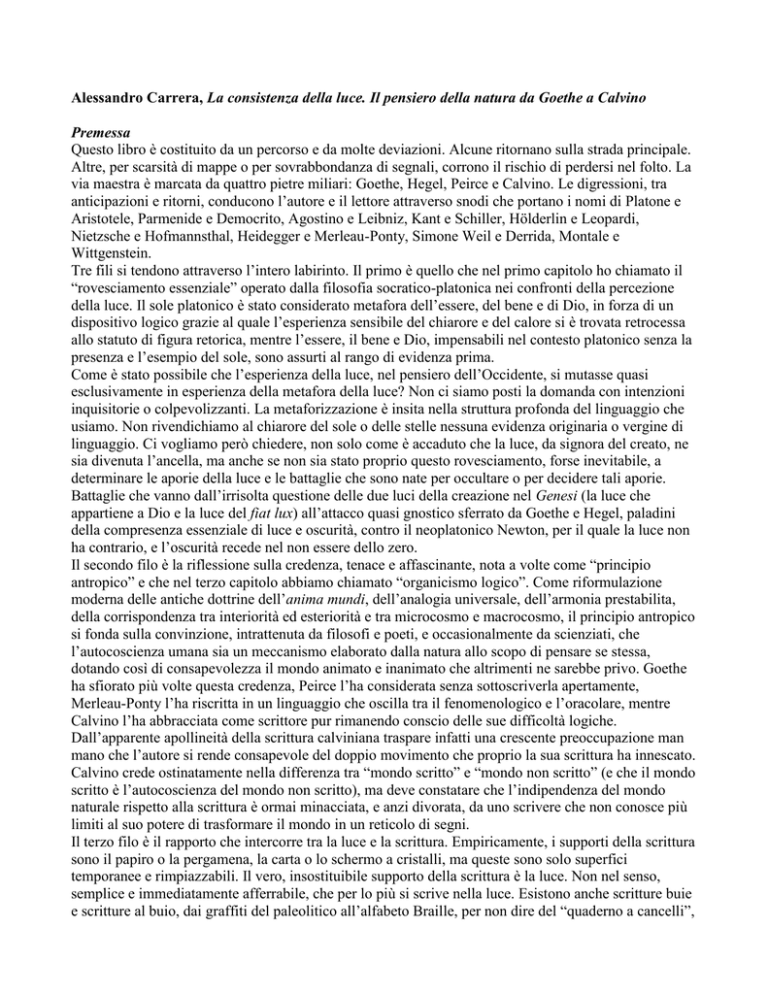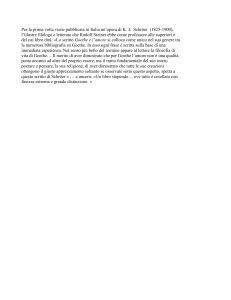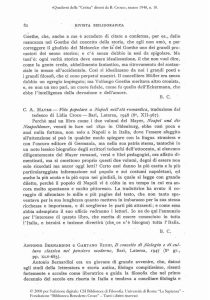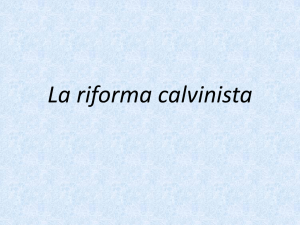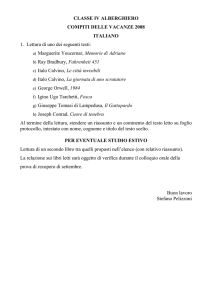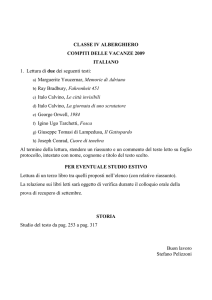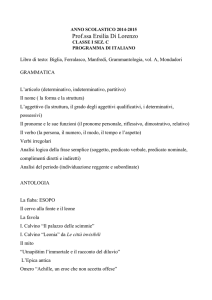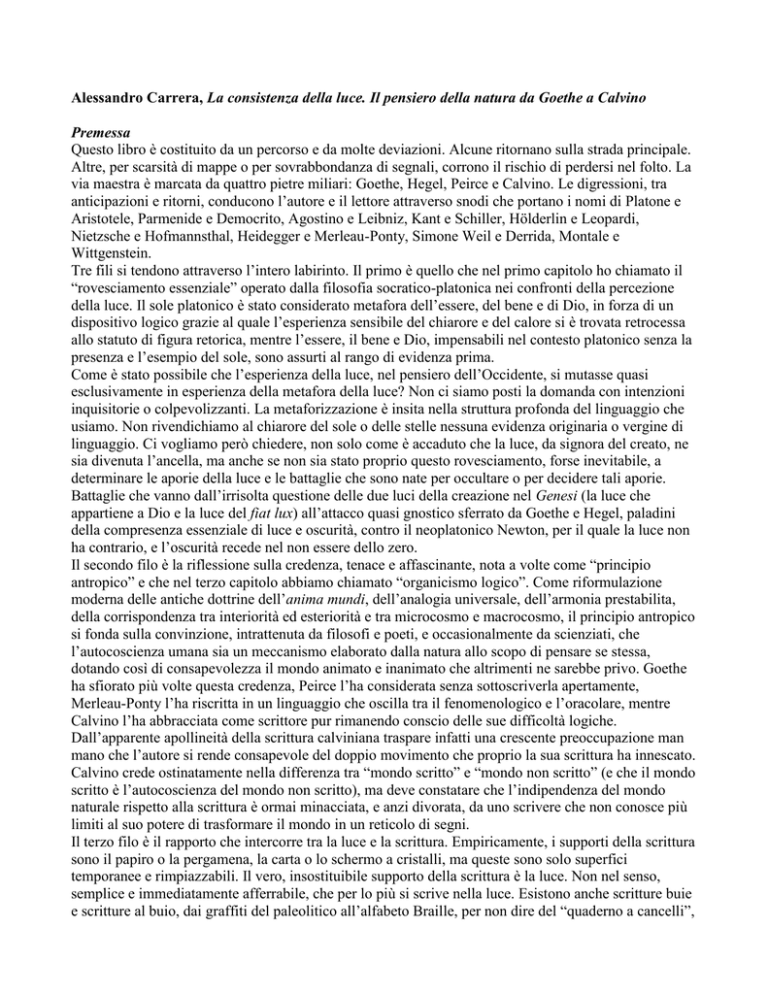
Alessandro Carrera, La consistenza della luce. Il pensiero della natura da Goethe a Calvino
Premessa
Questo libro è costituito da un percorso e da molte deviazioni. Alcune ritornano sulla strada principale.
Altre, per scarsità di mappe o per sovrabbondanza di segnali, corrono il rischio di perdersi nel folto. La
via maestra è marcata da quattro pietre miliari: Goethe, Hegel, Peirce e Calvino. Le digressioni, tra
anticipazioni e ritorni, conducono l’autore e il lettore attraverso snodi che portano i nomi di Platone e
Aristotele, Parmenide e Democrito, Agostino e Leibniz, Kant e Schiller, Hölderlin e Leopardi,
Nietzsche e Hofmannsthal, Heidegger e Merleau-Ponty, Simone Weil e Derrida, Montale e
Wittgenstein.
Tre fili si tendono attraverso l’intero labirinto. Il primo è quello che nel primo capitolo ho chiamato il
“rovesciamento essenziale” operato dalla filosofia socratico-platonica nei confronti della percezione
della luce. Il sole platonico è stato considerato metafora dell’essere, del bene e di Dio, in forza di un
dispositivo logico grazie al quale l’esperienza sensibile del chiarore e del calore si è trovata retrocessa
allo statuto di figura retorica, mentre l’essere, il bene e Dio, impensabili nel contesto platonico senza la
presenza e l’esempio del sole, sono assurti al rango di evidenza prima.
Come è stato possibile che l’esperienza della luce, nel pensiero dell’Occidente, si mutasse quasi
esclusivamente in esperienza della metafora della luce? Non ci siamo posti la domanda con intenzioni
inquisitorie o colpevolizzanti. La metaforizzazione è insita nella struttura profonda del linguaggio che
usiamo. Non rivendichiamo al chiarore del sole o delle stelle nessuna evidenza originaria o vergine di
linguaggio. Ci vogliamo però chiedere, non solo come è accaduto che la luce, da signora del creato, ne
sia divenuta l’ancella, ma anche se non sia stato proprio questo rovesciamento, forse inevitabile, a
determinare le aporie della luce e le battaglie che sono nate per occultare o per decidere tali aporie.
Battaglie che vanno dall’irrisolta questione delle due luci della creazione nel Genesi (la luce che
appartiene a Dio e la luce del fiat lux) all’attacco quasi gnostico sferrato da Goethe e Hegel, paladini
della compresenza essenziale di luce e oscurità, contro il neoplatonico Newton, per il quale la luce non
ha contrario, e l’oscurità recede nel non essere dello zero.
Il secondo filo è la riflessione sulla credenza, tenace e affascinante, nota a volte come “principio
antropico” e che nel terzo capitolo abbiamo chiamato “organicismo logico”. Come riformulazione
moderna delle antiche dottrine dell’anima mundi, dell’analogia universale, dell’armonia prestabilita,
della corrispondenza tra interiorità ed esteriorità e tra microcosmo e macrocosmo, il principio antropico
si fonda sulla convinzione, intrattenuta da filosofi e poeti, e occasionalmente da scienziati, che
l’autocoscienza umana sia un meccanismo elaborato dalla natura allo scopo di pensare se stessa,
dotando così di consapevolezza il mondo animato e inanimato che altrimenti ne sarebbe privo. Goethe
ha sfiorato più volte questa credenza, Peirce l’ha considerata senza sottoscriverla apertamente,
Merleau-Ponty l’ha riscritta in un linguaggio che oscilla tra il fenomenologico e l’oracolare, mentre
Calvino l’ha abbracciata come scrittore pur rimanendo conscio delle sue difficoltà logiche.
Dall’apparente apollineità della scrittura calviniana traspare infatti una crescente preoccupazione man
mano che l’autore si rende consapevole del doppio movimento che proprio la sua scrittura ha innescato.
Calvino crede ostinatamente nella differenza tra “mondo scritto” e “mondo non scritto” (e che il mondo
scritto è l’autocoscienza del mondo non scritto), ma deve constatare che l’indipendenza del mondo
naturale rispetto alla scrittura è ormai minacciata, e anzi divorata, da uno scrivere che non conosce più
limiti al suo potere di trasformare il mondo in un reticolo di segni.
Il terzo filo è il rapporto che intercorre tra la luce e la scrittura. Empiricamente, i supporti della scrittura
sono il papiro o la pergamena, la carta o lo schermo a cristalli, ma queste sono solo superfici
temporanee e rimpiazzabili. Il vero, insostituibile supporto della scrittura è la luce. Non nel senso,
semplice e immediatamente afferrabile, che per lo più si scrive nella luce. Esistono anche scritture buie
e scritture al buio, dai graffiti del paleolitico all’alfabeto Braille, per non dire del “quaderno a cancelli”,
composto da un telaio di fili montati su un foglio, che Carlo Levi si costruì per poter scrivere dopo
un’operazione agli occhi, e che Calvino ricorda in un suo scritto. Nessuna di queste scritture nega la
qualità di supporto della luce. Come esempi a contrario, esse ribadiscono piuttosto la doppia valenza
del rapporto. La luce è supporto della scrittura così come la scrittura, facendo apparire lo scuro del
segno su una superficie illuminata, cattura la luce nel punto di buio che così si manifesta, nella piega
che contrae lo spazio uniforme della diffusione luminosa. La scrittura accampata su tale supporto è
come quel “chiodo nel muro”, per usare un’espressione di Goethe, che permette all’occhio di
contribuire a creare, insieme alla natura, la rifrazione del bianco nei colori dell’iride.
Così, se la luce è supporto della scrittura, anche la scrittura è supporto della luce. Incidendo la luce, la
scrittura la cattura, la addomestica, la trasforma da esperienza singolare, questa luce qui ed ora, a
evidenza diffusa e universale. La idealizza, la rende “la” luce. Possiamo anche dire che la rende
invisibile, disposta al lavoro della metafora e del concetto, così come il papiro, la pergamena e gli altri
supporti si fanno immateriali e trasparenti per noi che non badiamo più alla loro materialità e alla loro
spazialità, ma a che cosa ci scriviamo, e a che cosa ci sta scritto.
Tra le modalità con le quali si può affrontare questo dramma della luce, ripetuto ogni volta che apriamo
un quaderno per scrivervi un appunto, o che accendiamo il computer e ci disponiamo a scriverci sopra
– ben sapendo che non è un sopra, ma un dentro, un fuori e un attraverso allo stesso tempo – questo
libro ne sceglie due. La prima è quella della filosofia, per la quale l’esistenza di un mondo non scritto e
resistente alla scrittura è un’aporia dalla quale la corretta applicazione della logica ci dovrebbe liberare
affinché il discorso filosofico possa dispiegare il suo potere argomentativo senza fastidiosi residui
esterni. La seconda è quella della letteratura, o per meglio dire del costante apporto d’ignoto che
l’esperienza scarica sulla scrittura, intasandola di problemi non risolti o che si credevano già liquidati, e
che invece si ripresentano come se ignorassero beatamente di non avere più una ragion d’essere. La
precipitazione letteraria, e dunque impura, di questo pensiero che altrimenti si riterrebbe puro, prende
le forme della parabola, della fantasticheria o dell’arguzia, sotto le quali spesso si nasconde il trauma.
Ma questo ricorso alla narrazione non è una debolezza del pensiero. In realtà lo fa ripartire, così come
ricomincia una storia già raccontata e che si ha voglia di risentire, perché qualcosa di importante
potrebbe esserci sfuggito e perché abbiamo il sospetto che la storia in questione potrebbe trasformarsi,
con il concorso del tempo e la partecipazione di narratori successivi, in una vicenda tutta diversa e dal
senso per ora imprevedibile.
Da qui, anche, l’accostamento di Goethe e Calvino. Due scrittori visivi, ma ben consapevoli che
guardare è già teorizzare; due non-filosofi che sapevano come affrontare la filosofia e soprattutto come
evitarla, in particolare quando la sentivano appressarsi come una minaccia, un’operazione di polizia,
una tassa doganale da pagare ogni volta che attraversavano il confine tra il mondo scritto e il mondo
non scritto o tra l’umano e il naturale, qualunque cosa questi termini volessero o vogliano ancora dire.
E che tale confine fosse poi interno alla loro pagina, inscritto nella loro peculiare impaginazione, e che
dovessero solo scendere più a fondo nella loro scrittura per poterlo vedere dall’altra parte, dalla zona
del buio, dove tutto è piega, dove tutto c’è ma nulla si espone, non muta le ragioni della loro
ostinazione, e anzi le rafforza.
Il mondo concettuale che questo libro vuole esplorare è forse ossessivo ma non è chiuso; anzi è stata
mia ambizione, non posso sapere quanto riuscita, di renderlo arioso a chi ne vorrà cogliere gli spifferi.
Il rovesciamento in forza del quale la scrittura viene prima della luce, e anzi contribuisce a crearla, può
apparire bizzarro al senso comune ma, per invocare un alto esempio, è apertamente biblico. Intende il
fiat lux come scritto oltre che pronunciato, e anzi solo scritto, perché così ci è giunto e nessuno di noi
era presente il primo giorno della creazione a udire Dio pronunciare la Parola. Non è Dio a creare il
mondo con questo Verbum, quanto è il Verbum a creare ciò che chiamiamo e scriviamo con il nome di
Dio, lasciando ovviamente intatto ciò che può essere il Dio che non chiamiamo e non scriviamo. Le
teorie che qui ho voluto esplorare, e che intendono abbracciare natura e cultura, luce e scrittura,
esperienza e conoscenza, rendono forse la realtà quotidiana un po’ più difficile a percepirsi, un po’ più
complicata da attraversare, come accade a chi passa per un labirinto di specchi e deve sempre tenere a
mente che la scena dispiegata davanti a lui può rivelarsi un inganno. Propongono uno sguardo parallelo
sulla realtà, una geometria non euclidea che, anche se non sarà mai sperimentata al di fuori dei suoi
assiomi, non sarà per questo meno rigorosa e, a suo modo, meno vera.
A questo avvertimento introduttivo aggiungerò soltanto che questo libro è l’elaborazione, e forse la
giustificazione, della sensazione, individuale e teoretica insieme, di una radicale separazione dalla
natura che ha accompagnato molti miei anni di formazione. Intendo la separazione da una natura intesa
comunemente come serbatoio di tropi sempre disponibili per l’intelligenza o lo spirito, ovvio sostrato
di ciò che poi si scriverà, indiscussa esteriorità contrapposta a un’altrettanto indiscussa interiorità. Non
avrei potuto sviluppare l’occhio a questa fallacia se non avessi vissuto l’esperienza della periferia.
Nella periferia dove io sono cresciuto, la natura era un materiale da costruzione rapidamente soppesato,
raramente utilizzato, e infine abbandonato in uno stato di perpetua provvisorietà. Ci si viveva come se i
prati fossero sempre stati parcheggi, come se le collinette fossero sempre state discariche, e come se i
cespi di cicoria selvatica fossero sempre stati lattine arrugginite. Da tempo immemorabile i rari giardini
pubblici fiorivano di rottami complicati come foreste. Muri di mattoni forati erano stati alzati a
recintare campi sui quali niente sarebbe mai stato costruito, ma che si sarebbero riempiti di mucchi di
sabbia nemmeno buona per farci un formicaio, o di vasche da bagno arrugginite dove sarebbero morti i
porcospini che
vi cadevano senza poter più risalire. Da questa antinatura si poteva solo fuggire. Un ordine doveva
essere cercato altrove, forse nello spazio della scrittura, che da fuori sembrava angusto e all’interno
appariva infinito.
Che io abbia trattato questo dato autobiografico secondo le modalità della scrittura saggistica non
cancella (ma il lettore potrà benissimo non tenerne conto) l’esigenza biografica dalla quale nasce la
presente esposizione. Nei capitoli che fanno seguito a questa introduzione, le categorie che vanno sotto
il nome di percezione del mondo, sensazione di appartenenza, comunanza o distanza dalla natura,
approdano alla scrittura come a un punto generativo di esperienza e certificativo dell’esperienza,
coincidenza di presenza e di assenza dall’esperienza stessa. Se ora affermassi che la scrittura di questo
libro non è altro che il mio fondo biologico giunto alla consapevolezza della sua genealogia
commetterei gli stessi errori degli “organicisti logici” che ho in parte difeso e in parte confutato. La vita
è più grande di ogni nome, e all’autobiografia togliamo pure l’auto e il bio; ciò che rimane è la grafia, il
segno che, per poco, resta inciso sulla corteccia del tempo e della luce.
Questo libro abita la periferia del pensiero come io ho abitato alla periferia della metropoli, iniziando il
viaggio verso la cinta murata solo per perdermi nell’interminabile intramondo dei caseggiati che uno
dopo l’altro finivano con il sostituire la metropoli stessa, facendo del centro cittadino un lontano caso
irrilevante, una periferia della periferia medesima. È della periferia del pensiero che si occupa questo
libro. Perché, anche se per una sorte fortunata ne raggiungesse infine il centro, si ostinerebbe a
decifrarlo come un caso particolare della periferia.