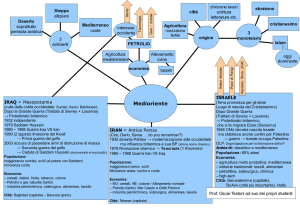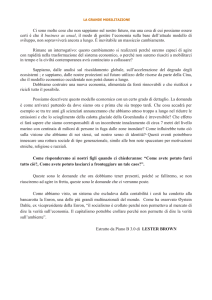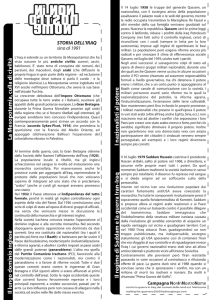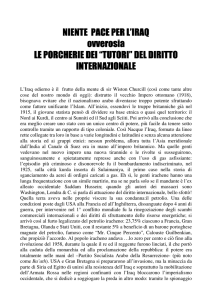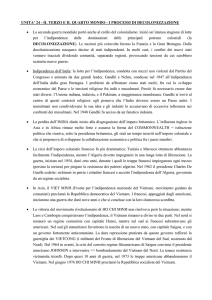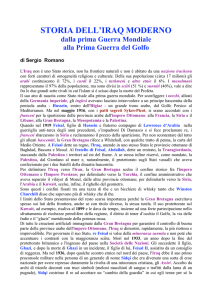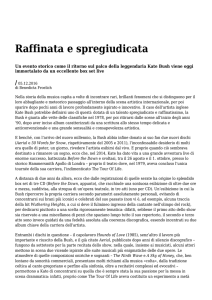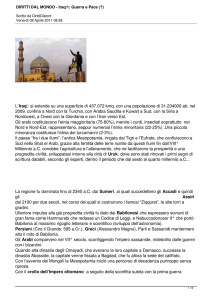Cap.I Perché la nuova guerra contro l’Iraq?
Premessa: la crisi
Il libro di Ricardo E. Rodríguez affronta molti dei misteriosi retroscena dell’11 settembre, alla
ricerca di tracce del coinvolgimento diretto di settori dell’apparato statale degli USA nella
distruzione delle Twin Towers e dell’attacco al Pentagono. Altri autori hanno esaminato molte altre
contraddizioni delle versioni ufficiali, le reticenze da un lato, gli eccessi di particolari “rivelati”
immediatamente dopo, la selezione di certe immagini e la scomparsa di altre nella documentazione
televisiva e perfino fotografica.
Anche se ci si avvicina sempre più a smontare le versioni ufficiali di quegli avvenimenti, non c’è
dubbio che alcuni elementi verranno occultati per sempre, come è accaduto per vicende
relativamente più semplici come l’uccisione del presidente Kennedy. I servizi, che non sono mai in
grado di prevenire i crimini, sono efficientissimi nel cancellare le tracce che porterebbero ai
responsabili. Ne sappiamo qualcosa anche in Italia, a proposito di Piazza Fontana, della stazione di
Bologna, perfino di quel modesto “infortunio” di qualche militare (italiano? francese? statunitense?)
che ha portato all’abbattimento dell’aereo sui cieli di Ustica, imprevisto e involontario, ma
ugualmente coperto con zelo degno di miglior causa.
Anche senza seguire le tracce dei molteplici collegamenti più recenti (a parte quelli del periodo
della lotta contro l’URSS in Afghanistan) tra fondamentalisti islamici e servizi segreti occidentali, e
quindi anche “senza prove” certe, possiamo avere alcune certezze.
Altri crolli: la Enron...
Questa fase di instabilità e di guerre permanenti è strettamente legata alla crisi economica del
capitalismo, negli Stati Uniti e mondiale. Si è detto che il crollo della Enron ha avuto effetti ben più
devastanti di quello delle Due Torri, ed è vero. Ebbene, l’esplosione della crisi della Enron era stata
differita per qualche tempo, ma era già innescata dalla primavera del 1991, e per gli addetti ai lavori
era anzi già venuta alla luce il 14 agosto con le improvvise dimissioni “per ragioni personali” di
Jeffrey Skilling da tutte le cariche, compresa quella di Amministratore delegato conquistata dopo
una lotta decennale appena sette mesi prima. Quindici giorni dopo, le azioni della Enron, già in
declino da mesi e di cui Skilling si era silenziosamente liberato in tempo, avevano perso il 50% del
loro valore, scivolando da 60 $ a 30 $. In dicembre sarebbero scese ancora, arrivando a 27 centesimi
di dollaro.1
Era inevitabile il fallimento di una società che dichiarava nei bilanci (truccati, è vero) un patrimonio
di oltre 50 miliardi di dollari, risultando così in assoluto la maggiore società statunitense ad aver
dichiarato bancarotta. Il 16 gennaio, l’ultimo giorno in cui la Enron era stata quotata a Wall Street,
era ritornata a 67 cents (invece di 60 $!), ma poco prima era scesa addirittura al livello incredibile di
0,6 cents.2
Un crollo simile ha determinato un vero e proprio disastro sociale, azzerando in primo luogo il
valore delle pensioni integrative a cui, come la maggior parte dei lavoratori statunitensi, erano stati
costretti a ricorrere i dipendenti, ma provocando effetti a cascata su altri fondi pensione che avevano
investito una parte significativa dei capitali in azioni Enron.3
1
Nicola Borzi, La parabola Enron e la crisi di fiducia del mercato mondiale, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 126.
Ibidem. Per capire l’ampiezza del disastro si pensi che nell’agosto 2000 la Enron aveva lanciato una ricapitalizzazione
usando i risparmi affidatile per acquistare le proprie azioni, facendo credere che si trattasse di un titolo solidissimo. Così
le azioni avevano raggiunto il livello altissimo di 90,56 $. Era più o meno la stessa tecnica usata da Giovanni Agnelli
nel 1906 per impossessarsi della FIAT estromettendo i veri soci fondatori. Cfr. Antonio Moscato (a cura di), Cento ... e
uno anni di FIAT, Massari, Bolsena, 2000.
3
N. Borzi, op. cit., pp. 153-156.
2
1
Milton Friedman, il famoso premio Nobel per l’economia, in un’intervista a Il Sole 24 Ore del 18
gennaio 2002, ha sostenuto candidamente che “il caso Enron rappresenta la bellezza del sistema
capitalistico” perché ci ricorda che “nell’economia di mercato ci sono i profitti ma anche le perdite”
che “sono funzionali al sistema tanto quanto i profitti”, e spiegava che la Enron “all’inizio
funzionava molto bene e ha reso un servizio al Paese”, poi ha sbagliato perché non ha capito che “la
concorrenza stava per entrare nel suo mercato” e quindi “si sono difesi male [...] e oggi pagano”.
All’intervistatore, non certo un pericoloso sovversivo, che osservava che a pagare erano stati anche
i “dipendenti che hanno perso le pensioni”, il guru del monetarismo non sapeva rispondere altro che
“quello delle pensioni è un problema”. Certo, non così grave secondo lui, dato che “come sappiamo
sono integrative”, e che la soluzione ci sarebbe: “impedire che gli investimenti si concentrino tutti
sui titoli dell’azienda in cui si lavora”.4 Per un Premio Nobel non c’è male come cinismo, ma anche
come concentrato di banalità: in primo luogo i lavoratori non hanno voce in capitolo nella scelta
degli investimenti dei fondi pensione, e comunque il crollo di una società le cui azioni apparivano
altamente remunerative colpisce anche altri fondi pensione e priva altri lavoratori di quella
sicurezza per la vecchiaia che lo Stato liberista non offre più da tempo.
Friedman negava perfino che ci fossero state collusioni tra la società di Houston e il mondo politico
di Washington, e che i finanziamenti della Enron alla campagna elettorale di Bush, Cheney e
praticamente di tutti i senatori e deputati dei due partiti fossero stati finalizzati a ottenere protezione,
visto il risultato finale: ancora una volta una banalità e una menzogna, dato che erano serviti in ogni
caso a rinviare il crollo, ingannando i piccoli azionisti e consentendo a quelli grossi di liquidare in
tempo i loro pacchetti azionari. Inoltre, grazie alla protezione politica, erano stati possibili scandali
come la crisi energetica californiana, provocata artificialmente dalla Enron tra il maggio 2000 e la
primavera 2001, facendo salire i prezzi dell’energia elettrica di tredici volte rispetto all’anno
precedente, smentendo la propaganda menzognera che nel 1998 aveva preparato la privatizzazione
del settore “per ridurre i prezzi”. Oltre a tutto le società pubbliche a cui era stato lasciato il solo
compito di distribuire l’energia prodotta dalla Enron, nell’impossibilità di applicare i prezzi imposti
dal monopolio Enron, avevano fatto fallimento, scaricando sui contribuenti perdite pari a 40
miliardi di dollari.
Tutto questo non era un episodio fortuito, ma era dovuto al “normale” funzionamento
dell’economia degli Stati Uniti, e in particolare al fatto che i controlli sulla veridicità dei bilanci
erano e sono affidati a società specializzate nel truccare i bilanci, e in caso di necessità nel
distruggere prove, come la Arthur Andersen.5
Su questa società il presidente George W. Bush ha cercato di scherzare con una battuta indecente,
raccontando durante una cena – nello stile caro anche a Silvio Berlusconi - la solita barzelletta sulle
“due notizie, una buona e una cattiva”. Secondo Bush “la buona notizia è che Saddam Hussein è
adesso pronto ad accogliere gli ispettori dell’ONU, [...] la cattiva notizia è che le ispezioni saranno
condotte dalla Andersen”6
In realtà c’era proprio poco da scherzare, in primo luogo perché sia il presidente sia il suo vice
Cheney hanno più volte beneficiato non solo dei finanziamenti elettorali della Enron, ma anche
delle ispezioni truccate della Andersen...7 Inoltre uno dei maggiori responsabili della Andersen,
Harvey Pitt, è stato chiamato da Bush alla testa della Sec (la Security and Exchange Commission,
creata nel 1934 proprio per garantire i risparmiatori ed evitare crolli come quelli del 1929).8 Un po’
come affidare a Totò Riina la commissione antimafia...
In ogni caso quella crisi, i cui retroscena sono venuti alla luce perché alcuni quadri intermedi delle
Enron, trascinati alla rovina dai propri dirigenti, hanno vuotato il sacco davanti a una corte federale,
ha avuto effetti a catena: nel giro di pochi mesi sono stati travolti giganti come la WorldCom, la
“Friedman: ‘l’America resta solida’”, in “Il Sole 24 Ore”, 18 gennaio 2002.
N. Borzi, op. cit., pp. 179-180.
6
Ivi, p. 108.
7
Ivi, pp. 177, 197 e passim.
8
Ivi, pp. 173-175.
4
5
2
seconda società americana di telefonia sulla lunga distanza. Le sue azioni, che avevano toccato un
massimo di 64 $ e che si erano assestate per qualche tempo sui 15 $, sono scese a 9 centesimi! E poi
è toccato a due colossi del settore farmaceutico come la Merck e la Bristol-Myers Squibb, alla
francese Vivendi, alla FIAT, ora alla Cirio.
I salvataggi pubblici hanno evitato finora il vero e proprio fallimento anche alla WorldCom (se ci
fosse toglierebbe alla Enron la palma della più grande società dichiarata fallita), ma la situazione
rimane appesa a un filo e ha già distrutto i risparmi di milioni di cittadini. Va detto che anche per la
WorldCom la società che ne attestava la buona salute e la correttezza dei bilanci era la solita
Andersen.
Ma che c’entrano queste crisi finanziarie con la guerra all’Iraq?
Non c’è dubbio che Milton Friedman o, per scendere più in basso, il nostro Renato Brunetta,
troverebbero inesistente il nesso tra questa prolungata e sempre più grave instabilità dell’economia
dei principali paesi capitalistici e la guerra. Non c’è nessun pericolo di un altro 1929, ripetono,
ammettendo così implicitamente che ad avviare la corsa al riarmo (e l’appoggio a Hitler da parte di
tutta la borghesia tedesca) era stata proprio quella crisi. Ci viene la curiosità di sapere se intanto,
una volta diffuso un ingiustificato ottimismo, stanno vendendo le azioni delle società in cui avevano
investito le loro laute prebende.9
Uno dei più grandi economisti del ventesimo secolo, non a caso non altrettanto esaltato dai “padroni
del vapore” e dai mass media, John Kenneth Galbraith, nel 1990 aveva domandato maliziosamente
all’amministrazione del presidente Bush (senior) come mai il bilancio militare non era stato ridotto
di un cent dopo il pesante ridimensionamento del tradizionale nemico, l’URSS, e lo sgretolamento
del Patto di Varsavia, nonostante gli Stati Uniti conoscessero ormai condizioni da “terzo mondo”
per il 30% degli abitanti della stessa New York, avessero distrutto l’educazione pubblica e il
sistema sanitario statale, e tagliato drasticamente le spese per l’assistenza ai vecchi e ai bisognosi...
Mentre Galbraith poneva queste domande imbarazzanti, di cui ovviamente sapeva bene la risposta,
Dick Cheney, allora capo del Pentagono (e oggi vicepresidente degli Stati Uniti, nonché leader
dell’ala oltranzista e bellicista) definiva le linee strategiche per il futuro: occorreva mettere in
sordina il “pericolo sovietico” e prepararsi ad affrontare eventuali conflitti con “potenze regionali
del terzo mondo come Siria o Iraq”.10
Il documento era del febbraio 1990. Non era ancora stato scelto il nemico, ma era stato deciso che
occorreva trovarne uno che prendesse il posto del declinante “impero del male”, per consentire di
non ridurre di un dollaro le spese militari che, se per gli Stati e i contribuenti figurano alla voce
“uscite”, per il complesso militare industriale rappresentano “entrate”.
La spiegazione suggerita dalla domanda retorica di Galbraith e confermata indirettamente dal
documento di Cheney è tuttavia solo una delle possibili chiavi di interpretazione di una guerra
decisa prima di aver deciso quale sarebbe stato il nemico. Lo stesso Galbraith nel 1991, a conflitto
iniziato, aveva scritto che la volontà del clan di Bush di arrivare alla guerra vera e propria
respingendo i tentativi di mediazione dell’URSS, di Arafat e dell’ONU si spiegava con l’illusione di
bloccare la recessione incipiente. Il grande economista aveva osservato che “a parte ogni altra
considerazione, la convinzione di arrestare la recessione con la guerra è profondamente errata e si
basa su una falsa analogia con la seconda guerra mondiale. Allora i sottomarini tedeschi e gli aerei
Non abbiamo le prove che lo abbiano fatto anche quei signori. Tuttavia l’esperienza insegna che questo è il
comportamento classico di ogni dirigente di un’azienda capitalistica minacciata dalla crisi, e di chiunque disponga di
informazioni riservate sui crolli prossimi venturi. Lo avevano fatto ad esempio non solo i dirigenti della Enron o della
WorldCom mentre occultavano i sintomi di una crisi inarrestabile, ma George W. Bush nel giugno 1990, quando
insieme ad altri dirigenti della Harken Energy Corporation aveva venduto le sue azioni (per complessivi 848 mila
dollari) appena due mesi prima che i titoli di quella società crollassero; lo aveva fatto Dick Cheney negli anni Novanta,
quando era il numero uno della Halliburton, i cui bilanci erano stati artificialmente gonfiati. E lo ha fatto la famiglia
Agnelli cominciando a liberarsi del settore auto della FIAT prima che ne venisse alla luce la crisi latente.
10
Citato in Michael Klare, “Le banc d’essai des guerre de demani”, in Le Monde Diplomatique, n. 442, gennaio 1991.
9
3
guidati dai kamikaze giapponesi, infliggendo dure perdite alla flotta navale e aerea degli Stati Uniti,
avevano avuto l’effetto indiretto e certo imprevisto di provocare un enorme sforzo dell’industria
bellica per colmare i vuoti e reggere alla sfida, con effetti di ricaduta a cascata su tutta l’industria
americana”, mentre nel 1991 “l’enorme sproporzione tra il potenziale bellico e la tecnologia delle
due parti” escludeva un analogo “effetto tonificante”.
Di fatto, nonostante la grottesca propaganda che presentava quello dell’Iraq come “il quarto esercito
del mondo”, era perfettamente prevedibile che per sconfiggere il “nuovo Hitler”, il “feroce
Saladino”, il “califfo di Baghdad” bastava scaricare su quello sventurato paese una parte delle
enormi giacenze di armi, soprattutto quelle relativamente obsolete, riducendo i costi di
immagazzinamento ed evitando le spese per la loro distruzione, ma senza la necessità di ricostituire
le scorte. Sintomatico il temporaneo rientro in servizio dei vecchi B52, che erano già in lista
d’attesa per la demolizione. Insomma, per vincere la guerra bastava liberarsi dei fondi di
magazzino.11 E infatti l’effetto salutare sull’economia non si è visto.
Ritorneremo successivamente sul perché la guerra del 1991 si è fermata prima di aver realizzato
l’obiettivo dichiarato, cioè l’abbattimento del regime di Saddam Hussein. Non possiamo intanto
fare a meno di constatare che Galbraith aveva visto bene. Non era stato l’unico commentatore ad
esprimere questi dubbi. Perfino Henry Kissinger – uomo notoriamente privo di preoccupazioni
etiche - si era domandato se non si corresse il rischio di creare situazioni incontrollabili in tutta
l’area, a beneficio di rivali ben più pericolosi, come l’Iran.12
Lo storico Paul Kennedy aveva scritto sul Wall Street Journal che il rifiuto di ogni proposta di
mediazione e di ogni segnale distensivo lanciato da Saddam Hussein faceva pensare a un “passo
imperiale più lungo della gamba”, e aveva garbatamente insinuato che la logica dei consiglieri di
Bush ricordava quella del conte Olivares, che aveva spinto Filippo IV all’intervento nella Guerra
dei Trent’anni nell’illusione di poter arginare il declino economico della Spagna con il ricorso alla
ancora preponderante forza militare.13
Un altro storico statunitense, Gabriel Kolko, aveva escluso che le motivazioni prevalenti fossero
economiche, dal momento che nel gruppo dirigente vicino a Bush riscontrava una forte componente
irrazionale: “È un errore cercare di trovare logica e coerenza nelle azioni che vengono decise dalla
casa Bianca. Dietro la retorica enunciata nel progetto di creare ‘un nuovo ordine mondiale, c’è un
vuoto, riempito di incoerenza e improvvisazione negli obiettivi prefissati”. Potrebbe sembrare un
giudizio troppo duro, ma non se si pensa all’incapacità di portare fino in fondo quella guerra, e alle
altre incoerenze manifestate durante la “spedizione umanitaria” in Somalia, conclusasi con una fuga
ignominiosa, ecc. Soprattutto se si pensa che tutte le imprese di questi anni non hanno risolto i
problemi di fondo degli Stati Uniti. Anzi! Chalmer Johnson sostiene che per garantire la sicurezza
dei propri approvvigionamenti petroliferi nel Golfo Persico gli Stati Uniti spendono ogni anno
cinque volte di più del loro valore.14
Viene da tremare pensando che la maggior parte dello staff del vecchio Bush appare oggi perplesso
di fronte a questa nuova guerra: di fatto quel gruppo era di gran lunga più preparato di molti dei più
Naturalmente, se per vincere bastavano i “fondi di magazzino”, nel corso delle guerra, come in ogni guerra
“parziale”, sono state sperimentate nuove armi, come i micidiali proiettili all’uranio impoverito, che tanto danno hanno
fatto anche agli ignari soldati statunitensi o britannici che venivano a contatto con le zone in cui erano caduti senza
avere mezzi di protezione o informazioni adeguate sui possibili rischi. Con la stessa leggerezza e indifferenza per la vita
dei propri militari, di tali armi micidiali si è fatto poi uso in Somalia e nelle guerre dei Balcani, coinvolgendo questa
volta anche soldati italiani, senza che fossero veramente necessarie ad altro che a una sperimentazione su cavie gratuite.
12
Interessante il fatto che Saddam, alla vigilia della guerra, aveva commissionato proprio alla società di consulenza di
Kissinger uno studio sulle possibili conseguenze dell’occupazione del Kuweit.
13
Paul Kennedy è autore di uno stimolante saggio su Ascesa e declino delle grandi potenze, Garzanti, Milano, 1989, in
cui già accennava a una possibile sovraesposizione militare degli Stati Uniti. Le sue tesi sono poi state brillantemente
riprese da uno specialista di Estremo Oriente, Chalmers Johnson, Gli ultimi giorni dell’impero americano, Garzanti,
Milano, 2001.
14
La tesi di fondo del libro di Chalmers Johnson è che per mantenere il proprio impero gli Stati Uniti hanno gravemente
indebolito la propria economia, sicché, conclude, “non sono le contraddizioni del capitalismo che portano
all’imperialismo, è l’imperialismo che alimenta alcune delle maggiori contraddizioni del capitalismo”. Ivi, p. 313.
11
4
stretti collaboratori di George W. Bush, che si è lanciato in una guerra afghana appena un anno
dopo la sua campagna elettorale, in cui aveva confessato in una conferenza stampa di non aver mai
“ascoltato i talebani”, che credeva fossero un gruppo musicale!
La logica della corsa agli armamenti
Abbiamo già detto che anche la guerra del 1991 era legata alla necessità di giustificare spese
militari che dopo il crollo dell’Impero del male apparivano poco verosimili. Quella che si sta
preparando lo è ancora di più. Il massacro di quanto rimaneva dell’Afghanistan dopo oltre venti
anni di guerre combattute sul suo suolo dalle più diverse bande armate, da un lato ha dimostrato
l’assoluta inconsistenza militare del “nemico” prescelto, dall’altro che i bombardamenti massicci
non sono serviti, come ogni persona in grado di ragionare poteva capire preventivamente, a
catturare la sfuggente e mitizzata cupola di al Qaeda. Nonostante la selezione e manipolazione delle
immagini, è apparso chiaro che nelle gallerie di Tora Bora c’erano solo sassi e sacchetti di sabbia, e
non le favoleggiate attrezzature elettroniche con cui Bin Laden avrebbe dovuto guidare le sue
legioni contro l’impero del bene. Una guerra feroce e devastante per la popolazione, dunque, ma
inutile per i fini annunciati.
Ma la corsa agli armamenti sofisticati prosegue: Chalmers Johnson ha scritto (prima
dell’aggressione all’Afghanistan) che “nonostante tutto il denaro profusovi, lo sconfinato orgoglio
con cui i mass media ne parlano, e i problemi di iperespansione e di ritorno di fiamma che crea, i
militari chiedono sempre di più”. E per spiegare come nel decennio successivo alla fine della guerra
fredda i bilanci militari hanno dato costantemente priorità a una “corsa agli armamenti che non
contava altri partecipanti”, fornisce un esempio concreto:
Ad esempio, il bilancio del Pentagono per l’anno fiscale 2000 prevedeva la sostituzione dell’F-15;
“l’aereo più avanzato del mondo”, con l’F-22, anch’esso “l’aereo più avanzato del mondo”.
L’areonautica voleva 339 F-22 a 188 milioni di dollari l’uno, tre volte il costo dell’apparecchio che
andava a sostituire. Gli Stati Uniti dispongono già di 1094 F-15, un aereo che oggi non ha eguali al
mondo.
Chalmers Johnson osservava che analogamente “l’ultimo bilancio clintoniano per la difesa
comprendeva fondi per ulteriori sottomarini nucleari d’attacco, di cui non si vede alcun utilizzo o
necessità”, tranne “dare lavoro alla locale industria della difesa” e che si andranno ad aggiungere
alla flotta di “Cernobyl galleggianti”, insieme alle portaerei nucleari, “che solcano incessantemente
i mari in attesa che scoppi qualche incidente”.15
In realtà la frase “non si vede nessuna necessità” è solo in parte esatta: effettivamente non può
esserci nessun utilizzo odierno, contro quelli che vengono additati all’opinione pubblica come
nemici, facendo un inverosimile amalgama tra Saddam, Bin Laden, i ceceni o il Fronte Popolare per
la Liberazione della Palestina (d’altra parte l’Italia non aveva mandato per la missione in
Afghanistan la flotta, con la portaerei Garibaldi in testa, nonostante quello sfortunato paese disti
molte centinaia di chilometri dal mare?). Ma rivela che queste guerre locali servono a preparare le
guerre del futuro, contro ex alleati che potrebbero diventare infidi dopo essere stati riforniti di armi
moderne, come l’Arabia Saudita e come è stato ieri per l’Iran dello Scià, passato imprevedibilmente
da principale gendarme dell’area a “Stato canaglia” (contro di esso tuttavia non fu possibile un
intervento diretto nel 1979 perché c’erano ancora le ferite brucianti lasciate dalla sconfitta nel
Vietnam). Ma soprattutto servono a prepararsi a fronteggiare la Russia, qualora dalla sua crisi un
domani emergesse, dopo tante umiliazioni subite, un governo disposto a tutelare la dignità
nazionale e a reagire al saccheggio delle sue risorse, o a “contenere” e intimidire la Cina, se
riuscisse a consolidarsi come pericolosa concorrente economica.
15
Ivi, p. 310.
5
Inventare il nemico da fronteggiare domani
Non sarà facile a uno storico futuro distinguere le fasi di questa guerra: in realtà è cominciata nel
1991 e non si è mai spenta, spostandosi volta a volta – per ragioni “umanitarie” o per combattere un
insidioso nemico - da una zona all’altra di una vasta area, che si estende dal corno d’Africa ai
Balcani, dal Vicino Oriente all’Afghanistan, ma che potrebbe estendersi ancora di più in base
all’incredibile catalogo di “organizzazioni terroriste” da combattere.
Molte di queste imprese si sono rapidamente rivelate fallimentari, soprattutto per l’incapacità dei
servizi di intelligence. Una cosa è preparare un’operazione sul piano propagandistico per
un’opinione pubblica di bocca buona (e che in genere viene a sapere dell’esistenza di un paese solo
nel momento in cui i suoi governanti hanno deciso di invaderlo), altra cosa riuscire a portare a
termine il progetto stabilendo un saldo controllo sul territorio occupato. Il caso classico è quello
della Somalia, che si doveva andare a “salvare dall’anarchia e dalla fame”, e nelle cui vicende
interne si tentò invece di intervenire senza avere la minima conoscenza della realtà. In Somalia
hanno fatto pena non solo i tanto decantati servizi segreti statunitensi, ma anche quelli italiani, dato
che la lunga presenza coloniale non aveva formato quadri preparati, con buona conoscenza della
realtà del paese, della lingua, della cultura., e i pochi italiani rimasti nel paese più che imprenditori
o commercianti possono essere considerati più o meno dei “magliari”, fin troppo integrati nel
malaffare locale (non a caso uno di loro è stato sospettato di aver partecipato all’agguato in cui fu
uccisa la testimone scomoda Ilaria Alpi).
Una cosa è mandare in avanscoperta Sofia Loren ad accarezzare un bambino malato e denutrito
davanti alle telecamere per preparare gli italiani all’idea di un “obbligo morale” di intervenire, altra
destreggiarsi tra gruppi politici e clan locali ed evitare scontri inutili e pericolosi. Per questo, dopo
tanto dispiegamento di forze, e la messa in scena televisiva di uno sbarco trionfale degno di un
filmaccio di propaganda, le perdite subite hanno costretto a una fuga ignominiosa senza raggiungere
nessun obiettivo, neppure quello principale, che non era il controllo delle insignificanti risorse (la
produzione di banane, buone ma poco commerciabili perché di dimensioni ridottissime,
un’agricoltura di sussistenza e una pastorizia nomade che al massimo esporta qualche migliaio di
cammellini di latte per le tavole dei ricchi yemeniti o sauditi), ma l’installazione di basi permanenti
per il controllo a breve distanza della penisola arabica, i cui possibili sviluppi politici preoccupano
fortemente gli Stati Uniti.
Anche la guerra all’Afghanistan ha ottenuto risultati modesti, soprattutto se si tiene conto dei mezzi
impiegati: la caduta del regime dei Talebani non era così importante in sé, dato che avevano
manifestato la disponibilità a trattare e a sbarazzarsi della presenza ingombrante di Bin Laden, e che
sono stati sostituiti da una coalizione non meno retrograda, lacerata da conflitti interni acutissimi, e
il cui premier sopravvive solo grazie a una robusta guardia del corpo tutta occidentale; molti
aderenti alla rete di al Qaeda, compresi i massimi dirigenti, hanno potuto dileguarsi grazie
all’appoggio (spontaneo o acquistato a caro prezzo) delle truppe afgane mandate a ripulire Tora
Bora; il paese rimane caratterizzato da una forte instabilità, che si manifesta nei ripetuti regolamenti
di conti tra ministri e signori della guerra.
L’unico obiettivo raggiunto non è interno all’Afghanistan: in nome della “lotta al terrorismo” e
grazie alla inevitabile complicità di Putin, costretto ad accettare come buona questa motivazione
della guerra, pur di ottenere l’avallo alla sua personale campagna di sterminio di quanto resta del
popolo ceceno, è stata possibile l’installazione di basi militari nelle repubbliche dell’Asia centrale
ex sovietica, approfittando della presenza per realizzare anche accordi per lo sfruttamento di risorse
minerarie e petrolifere, per oleodotti, ecc. La consigliera militare di Bush, Condoleezza Rice, era in
realtà già di casa da queste parti, in qualità di rappresentante di industrie del settore, prima di essere
chiamata a così alta responsabilità.
Questa presenza, al di là dei possibili vantaggi diretti, soprattutto per il clan di petrolieri che
costituisce il nucleo duro dello staff di Bush, corrisponde in realtà a esigenze di controllo di un’area
molto instabile. Se i presidenti delle cinque repubbliche, tutti senza eccezione ex “segretari
generali” dei locali partiti “comunisti”, continuano per ora a vincere le elezioni con percentuali del
6
98 o 99%, devono però fare i conti con robuste tendenze islamiche radicali, e con le difficoltà di
economie erose da corruzione e clientelismi, sicché non si sa cosa possa riservare loro il futuro
prossimo, anche come ripercussione indiretta di un maldestro intervento degli Stati Uniti in Iraq.
Ma soprattutto la presenza di basi militari statunitensi in quei paesi asiatici dell’ex URSS ha
un’evidente funzione di controllo dell’Iran, un nemico che per ora si preferisce non nominare, e
soprattutto di preparazione a un confronto diretto con una Cina che continua la sua crescita
economica, e che già nei primi otto mesi del 2002 ha superato gli Stati Uniti come meta preferita
degli investitori stranieri (compresi quelli americani), per la sicurezza che offre loro, sia pure al
prezzo di ben 26 milioni di operai licenziati perché scarsamente produttivi.
Se è stato facile ottenere le basi militari da regimi corrotti e indecenti, sulla cui “democrazia” si
chiudono tutti e due gli occhi, assai meno facile è capire come muoversi in quei paesi in cui le
tecniche del potere burocratico staliniano si combinano con un richiamo strumentale all’Islam.16
L’esplosione dell’URSS infatti ha rappresentato un innegabile vantaggio per gli Stati Uniti, ma ha
creato nuovi problemi: prima si trattava di analizzare gli scontri dietro le quinte a Mosca, di stabilire
rapporti con una leadership bene o male centralizzata, ora si tratta di analizzare almeno quindici
gruppi dirigenti, di trovare i loro punti deboli, di stabilire accordi con ciascuno di essi senza
suscitare reazioni pericolose, negli altri. Un compito non facile. Ne ha parlato con franchezza già
nel 1992 il colonnello Dennis Long, che era a capo del reparto speciale di intervento rapido con
base a Fort Knox:
Per cinquant’anni abbiamo organizzato la nostra squadra di football, ci siamo allenati cinque giorni alla
settimana e non abbiamo giocato una sola partita. Avevamo un nemico riconoscibile, con caratteristiche
definite, e lo avevamo studiato a fondo. ora saremo costretti a giocare un giorno sì e uno no senza sapere
nulla della squadra avversaria. Non sapremo niente delle partite giocate in precedenza, né in che stadio si
giocherà e di quanti uomini sarà composta la formazione avversaria. Per l’apparato militare si tratta di una
circostanza molto stressante, specie se si deve cercare di giustificare l’esistenza della propria
organizzazione e del proprio sistema.17
Perché ancora una volta viene scelto come bersaglio Saddam?
Ma alla fine, dopo molte esitazioni (Iran? Corea del Nord? Libia? Siria?) il nemico è stato trovato,
ed è lo stesso che era stato trovato undici anni fa: Saddam Hussein. Perché proprio lui, perché un
Iraq ormai distrutto da undici anni di ferocissimo embargo e da bombardamenti quasi quotidiani,
fatti senza la minima autorizzazione dell’ONU?
La spiegazione è la stessa che era stata data nel 1990. Perché è “antipatico” e quindi poco
difendibile, anche da chi non vorrebbe la guerra, per i suoi molti crimini (compiuti, è vero, in
prevalenza quando era ancora amico dell’Occidente, ma poco importa), e soprattutto perché il suo
regime oggi è indubbiamente molto meno forte di quello dell’Iran, che pure rimane sgraditissimo a
Washington.
Che i veri motivi siano inconfessabili risulta dalla pretestuosità e inconsistenza delle accuse
formulate da Bush e Blair, che hanno ripetuto di “avere le prove” dei legami di Saddam Hussein e
Bin Laden, e inoltre di avere la certezza che entro sei mesi l’Iraq sarebbe in grado di avere armi
atomiche.
Le prove, naturalmente, “non possono essere rese pubbliche per ragioni di sicurezza”. Ma i governi
alleati o clienti, a cui ovviamente potevano essere benissimo fornite, ammettono che non ci sono.
Anche quasi tutti i consiglieri del padre di Bush hanno espresso forti dubbi (e certo, se hanno
affiancato quello che era il presidente degli Stati Uniti al momento delle guerra del Golfo del 1991,
non dovrebbero essere stati oggi tenuti all’oscuro per “motivi di sicurezza”).
Su uno di questi paesi, il Turkmenistan, si veda l’articolo di Andrew Jack, “Il paese del presidente”, apparso sul
Financial Times e poi in Internazionale, n. 462, 8/14 novembre 2002.
17
Citato in William Blum, Con la scusa della libertà. Si può parlare di impero americano?, Marco Tropea, Milano,
2002, pp. 27-28. Secondo Blum non si trattava solo di smarrimento di fronte alla complessità dei nuovi compiti, ma di
una richiesta di maggiori finanziamenti.
16
7
Le “prove” sui tentativi iracheni di dotarsi di armi atomiche sono assolutamente risibili: i satelliti
spia avrebbero rilevato attività edilizie in zone dove in precedenza c’erano impianti militari
smantellati. Anche il superfalco Cheney sostiene che Saddam “cerca attivamente e aggressivamente
armi atomiche”. Cerca: ma dove? Al supermercato?
Tutti gli esperti sanno bene che il reattore nucleare (sperimentale) di Tamuz, distrutto con un azione
di pirateria aerea israeliana nell’aprile 1981, era stato allestito da tecnici francesi, e aveva bisogno
di una costante assistenza esterna. Anche se Saddam Hussein volesse veramente predisporre le
strutture edilizie per accoglierne uno nuovo, la messa in opera di un simile impianto dipenderebbe
da fornitori occidentali da cui sarebbe semplice ottenere informazioni. Ammesso che qualche
impresa statale francese o russa o tedesca avesse stabilito accordi per fornire impianti di questo
genere (cosa inverosimile in questo contesto), intervenire per bloccare tutto sarebbe facilissimo,
senza infliggere nuove sofferenze allo sventurato popolo iracheno. E poi, ammesso che qualcuno
riesca a trasformare un reattore sperimentale in un impianto capace di produrre un’atomica, gli
iracheni – ridotti come sono - come la invierebbero negli Stati Uniti o in Europa? Per posta
prioritaria?
Nel 1990-1991, quando molti ingenui (compresi alcuni “padri nobili” della sinistra italiana come
Vittorio Foa) ripetevano che Saddam era il nuovo Hitler e l’Iraq la nuova Germania con il quarto
esercito mondiale, risultò presto evidente che si trattava di una frottola grottesca, data l’arretratezza
di partenza del paese, interamente dipendente dalle forniture militari di paesi più sviluppati, tra cui
gli stessi Stati Uniti, la Germania e anche l’Italia.
Pierre Salinger ha documentato che alla vigilia della Guerra del Golfo 207 ditte avevano fornito a
Saddam “materiale bellico non convenzionale”: di queste 86 erano tedesche, 18 statunitensi,
altrettante britanniche, 16 francesi, 12 italiane. Tra queste ultime spiccava la Snia Tecnint (Fiat),
che aveva fornito un “laboratorio di armi chimiche per Saad16”, la Saia Bpd, che ha offerto
carburante per razzi, la Technipetrole tecnologia per gas nervino, la Hp degli Stati Uniti calcolatori
per missili e il “Center for Disease Control”, sempre statunitense, “il virus della febbre del Nilo”.
Ovviamente ciò si spiega col fatto che fino a pochi giorni prima di diventare “il nuovo Hitler”
Saddam era un amico degli occidentali e soprattutto un buon cliente. E questo spiega come sia stato
facile smantellare quegli impianti, che erano stati allestiti proprio da ditte dei paesi che hanno
invaso l’Iraq nel 1991!
Al momento dell’occupazione del Kuweit sarebbe stato facilissimo intervenire su Saddam
sospendendo forniture e assistenza. Per giunta, l’Iraq era dipendente dagli Stati Uniti anche sul
piano alimentare (era il primo degli acquirenti di riso dagli Stati Uniti, e l’ottavo per il grano),
sicché i mezzi per una pressione non mancavano. Ma quello che serviva non era “fermare Saddam
Hussein”, bensì dare una dimostrazione al mondo di cosa poteva aspettarsi chi veniva prescelto
come bersaglio dall’imperialismo.
Saddam era stato scelto allora e viene nuovamente additato come supermostro e pericolo pubblico
mondiale numero uno, per le stesse ragioni per cui nel 1989, dopo aver pensato che il dissolvimento
del potere sovietico avrebbe permesso di abbattere l’odiato Fidel Castro, si preferì fare la prova
generale (propagandistica e militare) con il presidente del Panama, Manuel Noriega, non pericoloso
in sé ma scelto perché sarebbe stato rischioso o comunque troppo costoso attaccare direttamente
Castro, e perché non godeva di una buona fama. Il generale Noriega, vecchio collaboratore della
Cia, era stato infatti accusato di narcotraffico con qualche fondamento, perché aveva collaborato
con il colonnello Oliver North e l’allora vicepresidente Bush all’operazione triangolare che
procurava cocaina in Colombia, la spacciava negli Usa per finanziare poi l’armamento della
“contra” nicaraguese alle spalle del Congresso degli Stati Uniti che aveva deciso di bloccarlo.
Noriega era stato incriminato negli Stati Uniti e si era deciso di arrestarlo: era la prova generale di
un analogo intervento a Cuba, con lo stesso pretesto. L’intervento a Panama durò due settimane, e
8
prima della resa di Noriega (avvenuta il 4 gennaio 1990) vennero bombardati interi quartieri, con
migliaia di morti.18
La scelta di colpire (almeno per il momento) Noriega e non Castro (il cui abbattimento era stato nel
programma di tutti i presidenti degli Stati Uniti, da Eisenhower e Kennedy in poi) era dettata anche
dall’esperienza della combattività dei cubani: non tanto quella di Playa Girón, lontana nel tempo,
ma quella dell’invasione di Grenada, nell’ottobre 1983.19 Sbarcati con migliaia di marines nella
piccolissima isola (100.000 abitanti e una milizia di un centinaio di uomini), gli aggressori si
trovarono di fronte una piccola guarnigione dell’esercito cubano addestrato dai sovietici i cui
ufficiali si arresero subito, mentre i lavoratori cubani dell’aeroporto resisterono a lungo
eroicamente, infliggendo serie perdite agli invasori (135 militari Usa; le vittime locali furono 400 e i
cubani morti combattendo 84, una percentuale altissima tenuto conto del loro numero complessivo,
che era di poche centinaia).
Una resistenza così tenace, dovuta evidentemente alla coscienza politica dei lavoratori cubani, fece
capire che uno sbarco a Cuba si sarebbe concluso con perdite altissime tra gli invasori, tanto più che
ammaestrati da quella esperienza i dirigenti cubani ridimensionarono rapidamente il ruolo
dell’esercito tradizionale organizzato dai sovietici e ripristinarono le milizie popolari basate sulla
distribuzione di armi in tutti i luoghi di lavoro.20
Dunque, analogamente, anche se l’Iran dà più fastidio agli Stati Uniti e a Israele (anche per le
simpatie di cui gode in vasti ambienti sciiti e non solo nel Libano), e se tanti altri dittatori hanno una
fedina penale non meno sporca di quella di Saddam Hussein, per ora il fuoco è concentrato solo su
di lui, considerando che sarebbe più difficile creare un fronte in sua difesa (ma, naturalmente, la
sinistra può e deve difendere l’Iraq senza giustificare e avallare Saddam, come ha difeso la Serbia
nonostante Milosevic).
Tuttavia va detto che, se i pretesti addotti sono falsi come quelli che hanno motivato l’intervento in
Afghanistan, quella di impartire una lezione al mondo su chi ha il coltello dalla parte del manico,
con o senza l’avallo dell’Onu, non può essere considerata l’unica causa della guerra in
preparazione. Nel caso dell’Iraq una guerra di conquista ha motivazioni concretissime, perché il
controllo del suo petrolio può diventare più che mai importante per gli Stati Uniti, dati i crescenti
segni di instabilità e insubordinazione dell’Arabia Saudita. Un sondaggio effettuato da Zogby
International nello scorso ottobre e pubblicato dal New York Times del 22/10/2002 rivelava un 87%
di sauditi che dichiaravano di “non amare gli Stati Uniti”. Per un’amministrazione americana al cui
vertice politico e militare si trova una banda di petrolieri, è veramente un segnale di “allarme
rosso”.
(5 12 02)
Vari commentatori hanno ritenuto che la severità usata a Cuba verso Arnaldo Ochoa, l’eroe della guerra di Angola e
di tante battaglie precedenti, accusato di complicità nel narcotraffico e fucilato il 13 luglio 1988 insieme ad altri tre
dirigenti della rivoluzione, e che aveva avuto presumibilmente contatti con Noriega, sia servita a scongiurare una
montatura che potesse giustificare un intervento militare USA a Cuba, dato che da tempo una campagna di stampa negli
Stati Uniti accusava Panama, Cuba e le guerriglie colombiane di essere il centro del narcotraffico mondiale.
19
L’invasione di Grenada suggerisce un’altra analogia: gli Stati Uniti avevano fatto una lunga campagna di
denigrazione contro il piccolo gruppo rivoluzionario “New Jewel”, guidato dal “guevarista” Maurice Bishop che era al
potere dal 1979, accusandolo di preparare un’aggressione contro gli Stati Uniti, e di altre inverosimili colpe, ma si
decisero a intervenire solo nel momento in cui uno sciagurato colpo di Stato di una frazione stalinista e filosovietica del
New Jewel provocò la morte del popolarissimo Bishop, sostituito da uno squallido burocrate.
20
Le milizie popolari erano state la molla del successo di Playa Girón, e avevano caratterizzato tutto il primo decennio
dopo la vittoria della rivoluzione. Dopo la morte di Guevara i consiglieri sovietici, che non riuscivano neppure a capire
come si potessero lasciare delle armi in mano al popolo, le fecero smantellare, chiedendo ai cittadini di consegnarle per
“registrarle” e non restituendole più. L’esercito nato dalla guerriglia fu rimodellato dai consiglieri sovietici, anche con
aspetti ridicoli come l’introduzione del passo dell’oca per il cambio della guardia nel clima tropicale dell’Avana. Dopo
l’esperienza di Grenada (che ebbe una sanzione pubblica con la solenne degradazione degli ufficiali codardi), il governo
cubano chiese aiuto ai vietnamiti per riorganizzare le milizie.
18
9