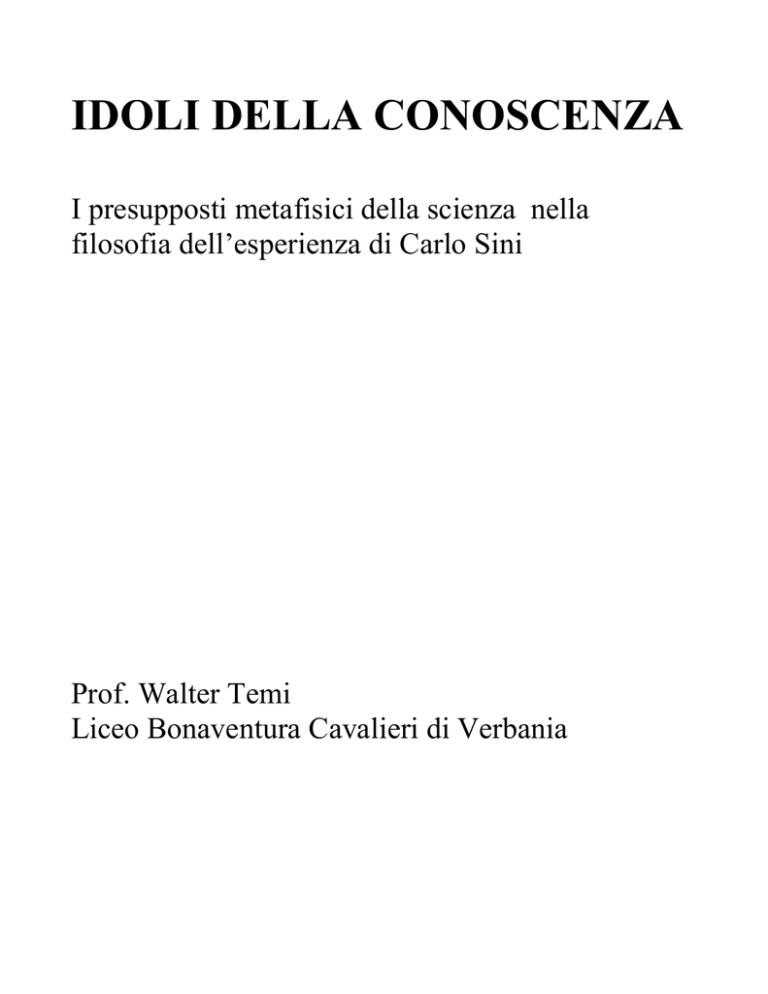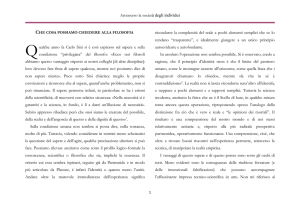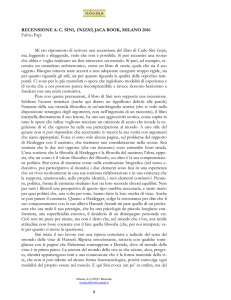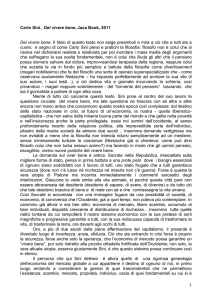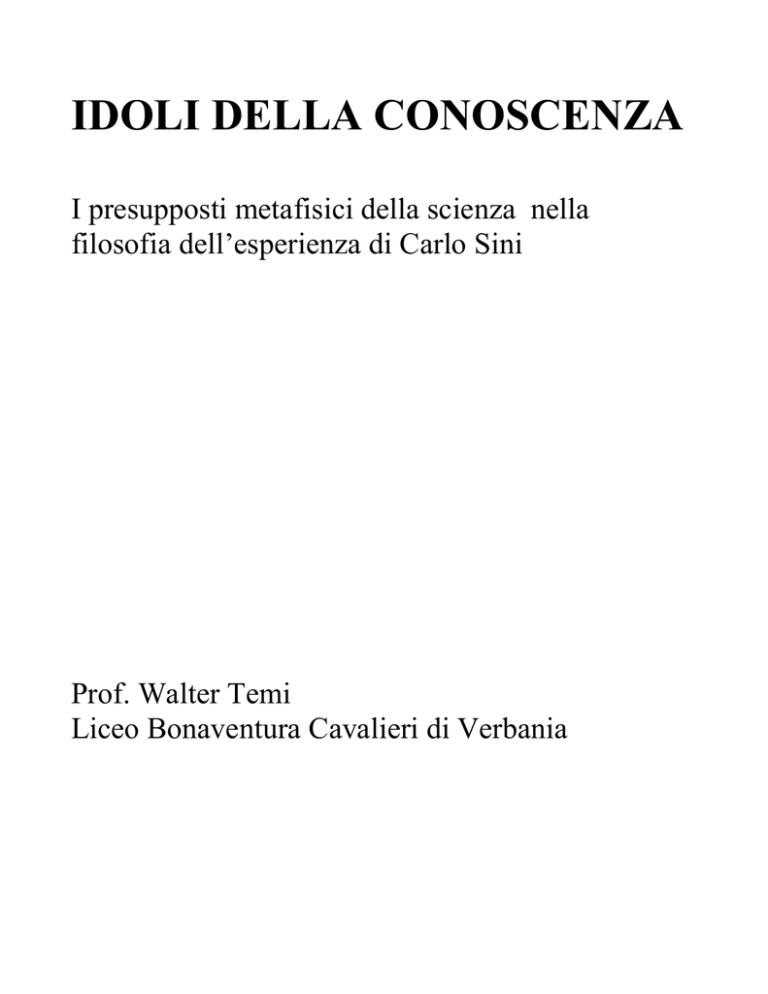
IDOLI DELLA CONOSCENZA
I presupposti metafisici della scienza nella
filosofia dell’esperienza di Carlo Sini
Prof. Walter Temi
Liceo Bonaventura Cavalieri di Verbania
La scienza non “pensa”, poiché non è suo compito pensare.
Si dovrebbe anzi aggiungere che la scienza può procedere
a condizione di non pensare
C. Sini
Precauzioni per l’uso
La presente dispensa non ha l’ambizione di delineare un quadro, non diciamo esaustivo,
ma anche soltanto condiviso della filosofia di Carlo Sini. Non esistono, per quanto ne
sappia, lavori critici sul pensiero di questo autore, il che conferisce al percorso qui
proposto, con relative glosse e postille, il carattere di un esperimento: non dubitiamo
che esso provocherebbe più di una benevola bacchettata da parte dell’interessato, che
comunque non ne verrà a conoscenza. Personalmente non nutro alcun dubbio sulla
superiorità di Sini rispetto a pensatori italiani contemporanei più celebrati, quali
Vattimo, Cacciari, Giorello, Severino ecc.. Questa scarsa notorietà si deve, oltre che
all’odierna “ineffettualità” della filosofia, anche, crediamo, alla natura schiva e riservata
del personaggio, che non ha mai rincorso la popolarità attraverso interviste a periodici
femminili o presenze in salotti televisivi. Scelte comprensibili, in un’epoca nella quale i
“maitres à penser” sdoganati dal circo massmediatico prendono i nomi di Barbara
Palombelli , Alba Parietti, Maurizio Costanzo e via profferendo.
Nella mia certo poco significativa esperienza personale ho conosciuto direttamente o
indirettamente esimi professori di filosofia, eruditi straordinari, perspicaci divulgatori.
Solo davanti a Carlo Sini, tuttavia, ho avuto la sicura percezione di trovarmi di fronte a
un filosofo, cioè ad un uomo capace di quella autentica radicalità e autonomia di
pensiero che la nostra disciplina richiede. Gentile ma non mellifluo, chiaro e
comunicativo benché mai “facile”, brillante conversatore ed accanito fumatore, amante
della buona musica e tifoso del Bologna, Sini ha rilasciato poche ma suggestive
interviste reperibili in Internet. Consigliamo a tutti di visionarle, se non altro per
comprendere che cosa significhi essere filosofi nell’epoca dell’inattualità della filosofia.
2
Parte prima:
I paradossi della scienza
Problemi di senso
Che è “scienza”? Quando un sapere è rigorosamente scientifico, cioè “razionale”? Lo
scienziato non lo sa; lui bada letteralmente ai “fatti suoi”, bada cioè a legittimarsi sulla
base delle verifiche e dei riscontri fattuali. I “fatti concreti”, come anche ama dire
ritenendo di opporsi alle “astrazioni metafisiche”, sono la guida della scientificità, il suo
carattere “positivo” (come dicevano appunto i positivisti). Ma le mere scienze di fatti,
come osserva Husserl, creano meri uomini di fatto. Cioè uomini poveri per una cultura
povera, del tutto inadeguata ad affrontare i problemi dell’esistenza. Questi ultimi sono
problemi di “senso”, non problemi fattuali. Lo scienziato si scontra qui con paradossi e
contraddizioni irresolubili. Innanzitutto egli confonde fattualità e senso. Io faccio
scienza, dice lo scienziato, perché non dico cose inverificabili. Queste le lascio ai
filosofi, ai poeti e all’uomo della strada. Io faccio scienza perché quello che dico trova
nei fatti il suo aver senso. Ma allora bisogna prima mostrare che un fatto ha senso.
Questa però è già di per sé una proposizione insensata. Il senso di un fatto non è un
fatto[…] In termini più semplici, e secondo un obbiezione non certo nuova ma che agli
scienziati non fa di solito piacere discutere, la proposizione “le verità scientifiche sono
tali perché sono verificabili”, non è una proposizione verificabile. Essa è piuttosto
un’assunzione di senso (e non di fatto): io do senso a tutte le proposizioni verificabili.
Resta dire perché e in base a che. Se non lo si dice tutto il progetto scientifico-positivo
resta infondato e perciò irrazionale; se lo si dice, non si possono evitare i problemi della
filosofia. In certo modo lo scienziato si fa vanto della sua stessa povertà, di essere cioè
un mero uomo di fatto che non ha nulla da dire circa i problemi più generali di senso. Di
questi non ne sa e, in quanto scienziato, non ne vuole sapere. Il suo “metodo” è
appunto fatto così.
C.Sini, La fenomenologia e la filosofia dell’esperienza
Il brano appena citato, tratto da una serie di lezioni di Carlo Sini concernenti la “Crisi delle scienze
europee” di Edmun Husserl, costituisce un appropriato incipit al percorso che vogliamo qui svolgere.
Non intendiamo infatti proporre un’esposizione analitica della filosofia di Sini, ma piuttosto una
provocazione ispirata ad alcune sue opere. Una provocazione a riflettere con occhio diverso, sgombro
da pregiudizi, sulla scienza, sul suo metodo, sui suoi presupposti e, come egli direbbe, le sue
superstizioni.
Il discorso non concerne la solita inflazionata discussione sui limiti della scienza (o meglio della
tecnica), sull’applicazione dei ritrovati scientifici alla sfera umana, sull’inquinamento, i cibi
transgenici, la fecondazione artificiale e via dicendo. Mi sembra evidente che la scienza non produca di
per sé un miglioramento della condizione umana e che ad ogni progresso faccia riscontro un qualche
regresso: mi fa piacere, ad esempio, poter telefonare agevolmente a chicchessia col cellulare, ma poi
mi è impossibile fare un viaggio in treno senza sviluppare pulsioni misantropiche. Questo tema, che
appassiona moltissimo quei funzionari della pubblica istruzione che, in occasione degli esami di Stato,
redigono la traccia cosiddetta (chissà perché) scientifico-tecnologica, non è quello che qui ci preme.
D’altronde conosciamo bene l’argomento “rassicurante” che gli scienziati hanno da sempre sulla bocca:
non la scienza ma certe sue applicazioni possono risultare nefaste, come dire che Oppenheimer non
c’entra con Hiroshima né Von Braun con il nazionalsocialismo.
Noi qui siamo invece interessati ad esaminare quella convinzione inconcussa e irriflessa dello
3
scienziato che, attraverso la mediazione di quell’agenzia di banalizzazione culturale che Nietzsche
chiamava il “vischioso tessuto connettivo” della nostra epoca, cioè il giornalismo, giunge all’uomo
della strada: la certezza della verità del sapere scientifico, garantito dalla neutralità ed oggettività del
suo sguardo. E’ notevole il fatto che, in un epoca nella quale si asserisce la soggettività di ogni tesi o
convinzione, e in cui le teste vuote o a corto di argomenti fanno appello, confortati dal gergo
giornalistico, alle loro “verità” , (io rispetto la tua opinione e tu rispetti la mia anche se dico
castronerie o mento spudoratamente), è notevole, dicevo, che si sia in genere così remissivi davanti
all’uomo di scienza o al venale “luminare”, tanto da accettare come rivelazione biblica tutto quanto
egli sentenzia. Le discipline umanistiche pensano di rendersi più presentabili qualificandosi come
“scienze” umane, e del resto non mancano le scienze dell’occulto e la scienza pranoterapeutica. Quelli
che la sanno più lunga sulla psicologia delle masse, e cioè gli esperti pubblicitari (cioè gli unici a
fregiarsi oggigiorno dell’appellativo di “creativi”), attingono all’aura seriosa e obiettiva del lessico
scientifico quando vogliono sbolognare un miracoloso detergente intimo o uno sturalavandini di nuova
generazione. La ragione di ciò non è difficile da comprendere. La scienza ha successo, e i successi della
scienza mutano la nostra vita. Ma ciò non vuol dire che la visione scientifica del mondo, per dirla alla
Reichembach, sia poi aproblematica. La credenza nello spazio assoluto, poi abbandonata, non ha
impedito a Newton di elaborare la teoria della gravitazione universale, né la postulazione dell’etere ha
precluso, nell’800, gli sviluppi dell’elettromagnetismo. In altre parole, il successo di una teoria non ne
assicura la “verità” oggettiva o “in sé”, se prima non si problematizza il concetto stesso di verità e
oggettività. Ma questo è appunto indagine che compete alla filosofia, poiché filosofare non significa,
come alcuni credono, “filosofeggiare”, ma vuol dire, tra le altre cose, interrogarsi su ciò che si dice e
sul perché lo si dice.
Proviamo allora a fare un tentativo diverso. Proviamo a rivolgerci a un filosofo per sottoporre ad
indagine ciò che nel pensiero e nella prassi dello scienziato rimane naturalmente presupposto.
Se anche la ricerca, lungi dall’approdare a certezze, avesse come unico effetto di suscitare dubbi e
perplessità , essa avrebbe conseguito il suo scopo: prima condizione del pensiero, infatti, è il dubbio,
come diceva Socrate, o lo stupore di cui parlava Aristotele: proprio per questa ragione, come ben
sapeva Hegel, ciò che è più vicino è anche sempre, per il pensiero, il più lontano.
Quello che sta nella testa degli scienziati
In un punto minuscolo, infinitesimale di questo Universo c’è una piccola girandola di
corpi celesti, orbitanti intorno a un piccolo Sole, insignificante e piuttosto eccentrico
rispetto alla sua stessa Galassia (tutto sommato un altro fenomeno poco più che
trascurabile nell’economia dell’insieme). Trai corpi orbitanti ce n’è uno, che è come un
granello di sabbia sperduto in una spiaggia sconfinata. Su questo corpo accade a un
certo punto, per cause tuttora sconosciute, l’insignificante, minuscolo evento della
nascita di organismi biologici, i quali, in breve tempo invero, rispetto alle età
complessive dell’universo, danno luogo a un’evoluzione differenziata, che culmina in
animali capaci di dotarsi di linguaggio, per gli evidenti scopi della loro sopravvivenza.
L’evoluzione di queste capacità linguistiche mette capo, in poche centinaia di migliaia
di anni a un tipo ci cultura che, nel giro di poco più di due millenni, dà luogo alla
conoscenza scientifica. La quale, infine, dice tutto quello che abbiamo appena detto e
ne disegna e approfondisce il quadro attraverso innumerevoli ricerche specialistiche.
Ecco, questo discorso, che grosso modo sta nella testa di tutti i nostri scienziati e, per il
loro tramite, nella testa del senso comune delle genti civilizzate, proprio questa
“narrazione” mi sembra in ogni senso “incomprensibile”
C. Sini, Idoli della conoscenza
4
Domande imbarazzanti
E’ incomprensibile che un infimo fenomeno di un infima parte dell’Universo possa
ritenersi idoneo a dirne la verità. E’ incomprensibile che un evento appartenente a una
storia sterminata possa parlarne come se ne fosse fuori e la osservasse dall’esterno, e
non come se fosse quello che diciamo appunto che è: un momento transeunte tra infiniti
momenti di quel cammino. E’ incomprensibile che quel linguaggio che sarebbe sorto ai
fini della sopravvivenza divenga improvvisamente idoneo a tutt’altro e cioè alla
registrazione o investigazione della verità da cui ha avuto origine e di cui è
conseguenza. E’ incomprensibile che uomini acuti, sottili e sagaci, abituati a fare i conti
con la logica, come gli scienziati, non si rendano conto o non si curino di rendersi conto
dell’illogicità e paradossalità della visione generale che hanno in testa.”
C. Sini, Idoli della conoscenza
Quel che non fa lo scienziato
Per quanto influenzato dalla pervasività della scienza, il senso comune nutre non poche ingenuità
circa l’effettiva pratica scientifica. Per il senso comune la scienza non fa che descrivere la “realtà
oggettiva” in modo diretto, osservativo e sperimentale, avanzando grazie alla tecnologia nella
comprensione e nel dominio tecnico del macrocosmo (l’esplorazione dello spazio) e
dell’infinitamente piccolo (DNA, atomo). Quest’ultimo è poi la frontiera che oggi più affascina.
Non ci entusiasmano più i voli spaziali, ma c’interessano computer, telefonini, nanomacchine e
manipolazioni genetiche.
I veri scienziati, però, la sanno un po’ più lunga, come Albert Einstein che, buon conoscitore di
Kant e Hume, ebbe a dire: “La cosa più incomprensibile nell’universo è la conoscenza”.
Sgombriamo dunque il campo dai luoghi comuni, proprio avvalendoci di chi, come Einstein, della
pratica scientifica un po’ s’intendeva.
Lo scienziato non desume le proprie teorie dai fatti osservati
“E’ un pregiudizio (che a tutt’oggi non è affatto sparito) che i fatti possano e debbano
tradursi in conoscenza scientifica di per sé, senza libera costruzione concettuale. Un
tale errore è possibile solo perché è difficile rendersi conto dell’arbitrarietà di tali
concetti che, attraverso la verifica e il lungo uso, sembrano invece direttamente
collegati col materiale empirico”
A. Einstein
Sini, in Idoli della conoscenza, così chiarisce il precedente passo:
Il fisico vuole configurare la realtà fisica, ma la realtà fisica non è ciò che si osserva. La
realtà fisica è ciò che si pensa, ciò che si pensa come stabile, come episteme…Ciò che
immagino non lo traggo da ciò che osservo. Caso mai è vero il contrario: è quel che
osservo che deve trovare in quel che immagino la sua ragion d’essere, la sua
spiegazione, il suo fondamento. E qui proprio metafisica e fisica sono vicinissime, anche
se diverso è il loro linguaggio moderno.
C. Sini, Idoli della conoscenza
Lo scienziato non può fare a meno di credere
“Enunciare un teorema prima della sua eventuale verifica significa che esso per ora può
basarsi soltanto sulla fede nella semplicità, cioè nella intelligibilità della natura”.
A.Einstein
5
Le ovvietà apparenti
Se la pratica scientifica si discosta nei modi che abbiamo visto da ciò che correntemente si crede, si
comprende l’affermazione di Einstein secondo cui “la cosa più incomprensibile nell’Universo è la
conoscenza” (per quali ragioni, infatti, gli assunti “fideistici” e le costruzioni concettuali dello
scienziato sarebbero in grado di descrivere la realtà oggettiva, rimane un mistero). Ma qui, appunto,
quando si tratta di cominciare a filosofare, lo scienziato, com’è giusto, si arresta. Egli infatti
condivide con il senso comune alcune apparenti certezze indeflettibili:
1. La scienza esamina oggettivamente i fatti esterni (il mondo) e i
fatti interni (la mente)
2. La scienza descrive il mondo com’è in se stesso, realmente
3. Gli asserti scientifici, anche se contengono termini denotanti
entità teoriche (non osservabili), sono riducibili ad enunciati
empirici, ostensivi, di evidenza intuitiva. Fatti, non interpretazioni
(lasciamo le interpretazioni ai filosofi)
4. Tutti gli elementi soggettivi che caratterizzano l’esperienza
(cause finali, qualità secondarie ecc.) sono meri residui
antropomorfici o apparenze: non esistono nella realtà
5. Le visioni della natura in disaccordo con la scienza sono mera
“superstizione” (non si può far piovere danzando)
6. Ciò che la scienza asserisce esistere è sempre esistito (il sole di
Giosuè era copernicano)
7. I fatti spiegati dalla scienza si iscrivono in un contenitore
temporale oggettivo. Il presente separa il passato dal futuro. Il
passato è immutabile (Le ere geologiche, ad es., sono “realtà”
oggettive; è possibile, in linea di principio, una macchina del
tempo)
Ebbene, proprio questi – ed altri – presupposti di fondo possono essere chiamati con un solo nome:
Metafisica: la volontà di trascendere l’esperienza. Proprio il sapere che ha ingaggiato la più aspra
battaglia contro la metafisica, e che poggia la superiorità del suo metodo sull’aderenza ai fatti,
risulta imbevuto, secondo Sini, di quella tradizione filosofica risalente a Parmenide e a Platone, che
chiamiamo metafisica. Anzi, si potrebbe aggiungere, la scienza, in questi suoi preconcetti, è
completamente teologica
6
1. Interno ed esterno
Poche distinzioni sembrano tanto ovvie quanto la dicotomia interno/esterno. La mente è concepita
da tutti come quell’interno (anima o secrezione cerebrale) che percepisce, riflettendo o deformando
il mondo esterno che la ospita. Le scienze esatte come la Fisica e la Chimica studiano l’esterno, con
risultati convincenti, mentre la Psicologia si occupa dell’interno, con esiti più opinabili perché, si
dice, viziati da un eccesso di interpretazioni filosofiche. Interno ed esterno Ma si tratta di
distinzioni cristalline? Leggiamo in proposito il seguente passo tratto da Immagine e conoscenza:
Non ci sono fatti in quanto esterni e fatti in quanto interni. Dove sono questi fatti?
Mostrami un fatto in quanto esterno e un fatto in quanto interno. Che cosa, per esempio
nell’esperienza di questo tavolo, o di questa sedia, è “fatto esterno” e che cosa è “fatto
interno”? Vi chiedo di rifletterci. Che cosa è esterno o interno di quel che possiamo dire,
esperire, toccare, vedere, ecc. ecc., di questo tavolo? La sua consistenza, il suo peso, la
sua massa, sono fatti in quanto esterni o in quanto interni? E’ evidente che non c’è nulla
né di esterno né d’interno nell’esperienza di questo tavolo. Perché per poterlo stabilire
bisognerebbe[…]assumere il punto di vista di uno spettatore esterno indipendente dai
fatti in quanto esterni e in quanto interni, il quale possa dire: questo appartiene
all’esterno, e quest’altro appartiene all’interno”. Il Sole è un fatto esterno? Chi lo può
dire? Non possiamo parlare del Sole indipendentemente dalla percezione che ne
abbiamo. Quando si osserva questo il senso comune fraintende subito: crede che stiamo
dicendo che il sole è una nostra idea, o che noi ci facciamo tutti i soli che vogliamo, e
che quindi ne pensiamo anche quindici e ne pensiamo uno anche di notte. Non è questo
che stiamo dicendo. Stiamo dicendo che il sole, sganciato da ogni esperienza del sole, è
evidentemente un’espressione priva di senso. Questo non significa che il sole dipenda
dalle esperienze che vogliamo noi, che è tutt’altra affermazione; semplicemente si dice
che il sole è un fenomeno complesso per cui non siamo in grado di dire che cosa
apparterrebbe a un ipotetico sole esterno o che cosa apparterrebbe a un’ipotetica
immagine interna del sole. Queste, appunto, sono costruzioni metafisiche arbitrarie; per
poter stabilire ciò dovremmo avere quell’osservatore indipendente che non abbiamo,
che non siamo.
Non ci sono fatti esterni, non solo perché l’espressione è contraddittoria, ma perché
dobbiamo sempre pensare i fatti come relativi a una pratica di mondo, a una pratica che
li mette in opera. I fatti, come direbbe Peirce, sono sempre relativi ad abiti di risposta.
E’ negli abiti di risposta che emergono i fatti. Se prendo nota che è sorto il sole, questo
abito di risposta è il luogo nel quale si manifesta il fatto “sorgere del sole”, e non fuori
di esso; non c’è un sorgere del sole indipendentemente da ogni abito di risposta. Il che
significa che non ci dobbiamo mai pensare di fronte al mondo; non siamo di fronte al
mondo; siamo all’interno del mondo, caso mai; siamo all’interno delle sue provocazioni
a rispondere.
7
“Fuori” non ci sono alberi
La scienza presume di descrivere la realtà com’è in se stessa, la cosa in sé, come sussiste a
prescindere da ogni atto conoscitivo o pratico del soggetto ad essa indirizzato. La faccenda
parrebbe pacifica, tanto che nemmeno il grande Kant ebbe l’audacia di liquidare la Ding, salvo
bollarla come inconoscibile (qualcuno ha perciò denominato la sua posizione gnoseologica
“realismo-foglia di fico”). Ma è davvero così? Secondo Sini, no. Un albero – dice – non è una cosa
esterna, fuori di noi. E questo per il semplice fatto che cose di questo genere – cose “esterne”, fuori
di noi”, non esistono: l’albero è un segno:
Cosa vuol dire l’albero preso in se stesso? O lo prendo con le mani o con le gambe o non
lo prendo; oppure vuol dire preso dalla definizione metafisica. Va benissimo. Basta che
lo si sappia. Preso a prescindere-da. Preso a partire dalla domanda di Socrate: non mi
interessa l’albero del pittore, dello scultore, del botanico, del biologo, ecc.; voglio
sapere che è questo albero che torna fuori in tutte queste varie esemplificazioni, cioè
che cos’è l’albero in sé. Questa è la domanda di Socrate. Lì compare questo oggetto.
Potremmo dire: Socrate porta a una estrema radicalità un’operazione di oggettivazione,
di universalizzazione, che è già implicita nel linguaggio. In effetti è il linguaggio che
sempre “prescinde”. Si potrebbe dire: la filosofia è quella potente pratica che prende
sul serio l’astrazione del linguaggio e la specializza, come nessun’altra cultura ha fatto
prima. Ma poi si dimentica di averlo fatto e crede che questa sia la verità del mondo. Si
dimentica la sua pratica particolare, che ha la particolarità della universalizzazione,
sicché anche l’universale è un particolare […] Questo albero preso in se stesso diviene
inconoscibile: preso in se stesso vuol dire che non si può conoscere, perché comunque lo
prendo non è più in se stesso. Dire però che una cosa è inconoscibile è dire una cosa
priva di senso, come ha mostrato Peirce. Già viene definita, già viene conosciuta,
attraverso questo non conoscibile.
C. Sini, Idoli della conoscenza
Sedie e tavoli
Ma naturalmente il senso comune recalcitra. Che vuol dire che fuori non ci sono gli alberi? Questi
filosofi…andrebbero tutti ricoverati. Con un linguaggio più elevato si potrebbe argomentare come
fa Hilary Putnam, nel libro La sfida del realismo. Qui il filosofo americano formula una
proposizione che pare persuasiva:
Questo relativismo culturale (Putnam pensa alla “filosofia continentale” dei Gadamer,
Foucault, Derrida ecc.) eccede quando dice che tutto è linguaggio. Noi possiamo e
dobbiamo insistere nel dire che ci sono alcuni fatti, non costituiti da noi, da scoprire,
ma lo possiamo dire solo dopo aver adottato un modo di parlare, un linguaggio, uno
schema concettuale. Lo schema concettuale restringe lo spazio della descrizione, ma
non predetermina le risposte ai nostri quesiti”. Putnam prosegue con un esempio:
“In questa stanza ci sono tavoli e sedie, che stanno là fuori, indipendentemente dalle
nostre menti”; e indipendenti anche dalle parole che usiamo per riferirci a essi. Infatti,
là fuori vi è anche qualcos’altro da ciò che indichiamo con le parole “tavoli” e “sedie”:
vi sono anche elettroni e campi gravitazionali; anche questi alludono in modo corretto a
qualcosa di comune che è là fuori. La differente scelta concettuale non toglie il dato di
realtà primario.
8
Sini, in Idoli della conoscenza, commenta questo brano con una certa dose di ironia:
Là fuori c’è il tavolo, là fuori c’è il campo gravitazionale, là fuori c’è un infinita
possibilità di altre cose, perché la cultura e la mente possono escogitare molti modi per
riferirsi a questo tavolo, ma non vi sembra che l’espressione ‘là fuori’ divenga allora
equivoca e ambigua? Essa non è per nulla un comune denominatore in grado di
esprimere il “dato di realtà primario”, quel qualcosa che ultimativamente starebbe
sotto questo tavolo (o campo gravitazionale, fate voi). Voglio dire che i campi
gravitazionali stanno anzitutto “dentro” le teorie della fisica, e per niente là fuori, se si
tratta del medesimo là fuori che mi consente di dire, con un’occhiata: guarda quanti
tavoli e quante sedie.
Ambiguità del “fuori” e anche dell’”essere”: come “ci sono” tutte queste cose? Che idea
ti fai allora dell’ “essere”, caro Putnam? In che senso dici che “sono” indipendenti dalla
cultura e dal linguaggio ? Ma forse Putnam disdegna tali questioni “ontologiche” (roba
vecchia, che ha di sicuro più di cinque anni).
“E allora almeno chiediamogli dell’ “anche”: che vuol dire “anche”, cioè che là fuori ci
sono tavoli e sedie “e anche” campi gravitazionali? Entrambi i modi di dire sono
legittimi, e così innumerevoli altri reali e possibili. Come sarà allora questo “fuori” per
sopportare e supportare una tal massa sconfinata di et, et…? Là fuori ci sono tavoli e
sedie e campi gravitazionali e elettroni e così via. Com’è strano questo “dato di realtà
primario”; forse più che strano è addirittura inconcepibile, puro non senso.
In conclusione, osserva Sini al termine della sua stroncatura, “è un’impresa impossibile, anzi
assurda voler discriminare che cosa è proprio della mente e che cosa del mondo.
Putnam per primo dovrebbe saperlo, ma poi non ne tiene conto, impegnato com’è a
salvare la vita dell’uomo, il che per lui significa salvare il senso comune, la verità della
cultura occidentale, la scienza moderna, l’aria condizionata e chissà che altro. Tutte
cose bellissime, che però chiedono non di essere ideologicamente salvate, ma di essere
filosoficamente comprese.
9
2. Nel luogo di Dio
Sia le scienze della natura che la “scienza” storica condividono il presupposto di esprimere la verità
oggettiva del mondo. Le entità scientifiche, i fatti dello storico esistono o sono esistiti, a prescindere
dalla soggettività che svolge la ricerca. Certo, si ammette che le teorie sono rivedibili, falsificabili,
approssimativamente vere, ma tali restrizioni costituiscono più una formula di circostanza che una
autentica cautela. Ciò avviene per il fatto che, secondo Sini, la scienza presuppone uno sguardo
pubblico, pan-oramico, derivato dalla metafisica greca, che implica la tacita pretesa di una visione
extramondana e assoluta: l’occhio di Dio. Lo sguardo della scienza è lo sguardo verace e
totalizzante di Dio, la cui visione è scevra da limitazioni soggettive.
Il movimento istitutivo del logos consiste in una sorta di collocazione extra-mondana
(l’occhio “pubblico”), cioè nell’assunzione di una posizione pan-oramica. Ma più
propriamente ciò equivale alla costituzione di una “mente pura”, disincarnata (nous);
per questa mente pura tutto il mondo è reso oggetto di visione). E’ questa propriamente
ciò che sono solito chiamare la “strategia dell’anima”[…]
C.Sini, Immagini di verità
Lo sguardo teoretico della metafisica (e la sua conseguente “verità” è appunto questo:
il guardare per ogni dove e da ogni dove, così da considerare il mondo sub specie
aeternitatis; non il mondo “mio”, “tuo”, “suo”, affetto dalle idiosincrasie delle nostre
parzialità in ultima analisi corporee, ma il mondo come esso è in quanto oggetto di
visione di Dio. La sapienza metafisica (e poi quella scientifica, che su ciò non fa alcuna
eccezione, ma si basa interamente su quella) è un collocarsi ideale nel posto di Dio.
{Questo dio è originariamente] Apollo, il Dio dall’occhiata che penetra e vede tutto in
un baleno. Già in Platone questo Dio comincerà ad attingere una più consapevole
universalità filosofica: occhio atemporale che sovrasta l’universo.
C. Sini, Metodo e filosofia
Questa parola (dello scienziato) designa e presuppone un’estraneità di sguardo, fuori del
tempo e del mondo (del tempo del mondo), che è il vecchio luogo di Dio. Lo scienziato
parla idealmente (o pretende di parlare) dal posto di Dio. La sua voce e la verità della
sua voce risuonano dal luogo pan-oramico dell’eterno che ha il mondo come oggetto di
contemplazione.
C. Sini, Il Tempo e l’esperienza
Ma tutto ciò è ovviamente falso. Questo sguardo pan-oramico non ci è dato. Non esiste uno sguardo
fuori dal mondo. Ogni visione umana è prospettica.
Non c’è una posizione privilegiata fuori del mondo; non esiste, come diceva MerlauPonty, un cosmotheoros, un essere umano che guardi il mondo là davanti. Non
possediamo, dico io, una “visione panoramica”; ci figuriamo solo di averla, di fatto
immaginandoci al posto di Dio[…] Quindi la conoscenza non è mai una adaequatio
intellectus ad rem. La conoscenza è un fatto interpretativo, ermeneutico, e perciò
“culturale”: fatti che stanno dentro il mondo e che ne sono parte, eventi del mondo.
Che è poi la mente di Dio? Forse che ne possediamo la teoria? Qui non si tratta di avere
fede o meno; si tratta semplicemente di sapere quel che si dice, ovvero di non dire
stupidaggini.
C. Sini, Idoli della conoscenza
10
Il corpo della parola
Qual è l’origine dell’occhio pubblico, dello sguardo panoramico? Rispondere a questa domande
equivale a svelare il senso e l’origine del logos, ovvero di quella tradizione cui appartiene la
filosofia occidentale e la pratica scientifica che ne deriva (la scienza è infatti un parto della
filosofia). A questo tema affascinante Sini ha dedicato molte opere, tra le quali Etica della scrittura.
Non essendo questa la sede per approfondire l’argomento, enunciamo subito la sorprendente
conclusione di Sini: alla base del logos – e quindi della stessa scienza - sta l’alfabeto.
Questa teoria potrà sembrare eccentrica, ma non piove dal cielo, specialmente per chi abbia
familiarità con il decostruzionismo di Jacques Derrida e in particolare con il suo scritto Della
Grammatologia, rispetto al quale, comunque, Sini si muove seguendo un percorso originale. Ma
che cosa mai c’entrerà l’alfabeto con la scienza?
Se davanti alla seguente scritta:
ABΓΔ
vi domandassi che cosa avete letto, non dubito che la risposta sarebbe: “le prime quattro lettere
dell’alfabeto greco”. Che altro? Ma se qualcuno sostenesse di aver visto buoi e capanne, non
sarebbe affatto da sottoporre a perizia psichiatrica. Chi di voi infatti conoscesse le opere del
linguista inglese Alfred Kallir, fondatore della semantica bisferica, saprebbe che quei segni, in un
remoto passato, esprimevano rispettivamente l’uomo (testa di bue rovesciata), la donna (il seno e il
ventre gravido, la generazione della prole (non è un caso che le lettere gutturali ricorrano
costantemente nelle parole che esprimono Generazione, ConCepimento, ConiuGazione, dove le
gutturali hanno una tipica concavità; quanto ai trattini della G, essi hanno un senso molto
pregnante), la casa (una capanna). L’originario iconismo della scrittura, evidente negli
ideogrammi, che ha preceduto e generato – sulla base del principio acrocratico - la scrittura
fonetica, è rintracciabile nello stesso alfabeto. Ma la scrittura alfabetica, proprio in virtù della
scomposizione letterale e della linearizzazione che le è peculiare, opera, a un certo livello di
stilizzazione, la separazione del significato astratto dal corpo sonoro e visivo del segno,
originariamente intrecciati. E’ così che si rende disponibile un significato astratto, pubblico e
indefinitamente iterabile, tanto che nella pratica della lettura noi letteralmente non vediamo le
lettere, a meno di importuni refusi o difficoltà visive (vediamo le lettere quando non riusciamo a
vederle). Questa svolta epocale, rileva Sini, trova il suo suggello nel Cratilo platonico, ove la
concezione della natura sostanzialmente convenzionale del linguaggio ha la meglio sull’arcaica
dottrina di Ermogene che asserisce una naturale rispondenza tra il corpo della parola e la cosa. E del
resto non è Platone ad aver istituito l’occhio dell’anima, la pura visione della mente che coglie la
forma ideale immateriale ed universale, istituendo l’episteme, cioè il sapere saldo, sottratto al
divenire e immune dalle idiosincrasie soggettive? Nel Sofista l’istituzione del logos consegue,
secondo Sini, il suo compimento. Le suddivisioni dialettiche ivi “delineate” (come il famoso
esempio della pesca alla lenza), sono consentite precisamente dalla sequenza lineare dell’alfabeto.
85. L’universalità epica. Devi osservare attentamente come via via si traduce il
carattere universalizzante che è implicito nella gestualità e nella pratica della voce.
Dapprima esso si espande in una comunità di pratiche orali. Gli uomini di questa
comunità cantano e raccontano i loro miti e le loro leggende, i loro Dei e i loro eroi,
raffigurandoli in imprese “poetiche” ed “epiche”. Questa parola fortemente patica
evoca e rievoca per tutti, cioè per tutti i partecipanti di quella comunità, l’ethos
comune del fare e del dire, dell’amare e del soffrire[…] E’ importantissimo che tu
comprenda e tenga fermo che la voce che parla nell’epos orale non è la stessa voce che
si dà a vedere nella scrittura alfabetica[…]
86. L’universalità logica. Quando la potenzialità universalizzante della voce si traduce
nella pratica della scrittura alfabetica, ciò che questa rende visibile non sono gli eventicose, i personaggi-luoghi della vicenda epica, si tratta invece della oggettività
“letterale” dei significati. La parola, sciolta dal contesto patico-espressivo della
evocazione “istoriale”, viene resa nei suoi elementi purificati e ideali, cioè nelle sue
lettere. Abbiamo così un’universalità astratta da ogni contesto. E’ così che si viene
formando il “lettore ideale”, per il quale leggere non è più guardare e contemplare il
corpo scritto, ma è dirigersi, tramite esso e la sua trasparenza convenzionale, al
significato logico.
11
88. Il ritmo e il tempo. […] La parola epica è un continuo interpretare provenendo e
inviando sulla base di blocchi di emozioni che procedono episodicamente in circolo,
indietro e avanti, e non in una serie unidirezionale. Questo tempo “etico” (o dell’ethos)
si potrebbe dire tempo plastico o symballico. La scrittura alfabetica iscrive invece i suoi
elementi ideali (apatici), depositari di significati oggettivi e universali (non di sensi), su
una linea omogenea. Ed è appunto questa trascrizione lineare che comporta una
specifica temporalizzazione.
89 La realtà costruita. L’ideale linea di scrittura è costituita di punti omogenei la cui
unica relazione è la successione astratta: relazione più spaziale che temporale, e in ogni
caso statica, cristallizzata, anziché ermeneutica. Nulla infatti accade al punto per il
fatto di trovarsi prima o dopo di un altro. Esso è solo uno snodo: il veicolo della
transizione che consente l’iscrizione. Il carattere puntuale della linea che è comune sia
alla scrittura alfabetica sia alla definizione potrebbe già indicarsi come il contenuto
della forma logica. La temporalità lineare spazializzata sarebbe allora il tratto
essenziale del logos logico. Voglio dire che, temporalizzandosi analiticamente (aritmogeometricamente) nella linea – nella linea scritturale e definitoria – il logos diviene
appunto “logico”; esso acquisisce in tal modo quella universalità oggettiva, “formale”,
che è propria dell’impersonale verità logica. La verità intesa come corrispondenza del
giudizio alla cosa avrebbe allora a suo fondamento il contenuto di una “costruzione”, la
costruzione di una realitas geometrica (aritmo-geometrica) fatta di punti astrattamente
omogenei linearmente disposti. Struttura di realtà che vale universalmente e
oggettivamente. La verità del giudizio è pertanto solo l’ultimo stadio di questa
costruzione. Il significato linearizzato del logos “si adegua” al carattere “logico” (“in
sé”) delle cose. Beninteso delle cose preliminarmente ridotte entro lo schema lineare
della definizione, cioè ridotte ai suoi elementi puntuali e geometrici[…]
La legge universale del logos logico – conclude Sini – è un principio formale il cui
contenuto è la linearità crono-logica della scrittura alfabetica.
C. Sini, Etica della scrittura
3. Dell’evidenza dei fatti
Appartiene alla tradizione positivistica, tutto sommato ancora molto viva tra scienziati e divulgatori
scientifici – Piero Angela docet -, la inconcussa certezza che la superiorità della pratica scientifica
rispetto alla filosofia e alla superstizione riposa sull’evidenza di fatti osservativi primari. Questi
fatti, imponendosi nella loro evidenza pura, non lasciano adito ad interpretazioni. Certo, si ammette
comunemente, anche nella scienza esistono congetture ed ipotesi, ma solo nella misura in cui non
se ne sa abbastanza. Cessano di essere tali e assumono piena dignità di verità scientifiche tramite la
prova dei fatti. E i fatti non sono interpretazioni.
Non s’inventa nulla, oggi, nel dimostrare la precarietà della demarcazione tra fatti ed
interpretazioni. A ciò è arrivata la stessa epistemologia, almeno a partire da Popper. Ma è un
grande merito di Carlo Sini l’aver imposto all’attenzione della cultura filosofica odierna un filosofo
– a lungo tempo ignorato - che per primo ha esplicitamente minato la credibilità di simili
concezioni impregnate di metafisica: Charles Sanders Peirce, la cui importanza per il percorso di
Sini emergerà più chiaramente in seguito. In un geniale saggio del 1868, rimasto pressoché ignorato
per un circa un secolo, l’eccentrico creatore del pragmatismo dimostra, con solidi argomenti, che
nessuna conoscenza può essere appresa intuitivamente, poiché ogni cognizione è determinata da
cognizioni precedenti. Nemmeno “x è rosso” è una tale immediata evidenza.
La stessa autocoscienza, supposta da Cartesio evidenza originaria indubitabile, appare un prodotto
di inferenze e interpretazioni. Conseguentemente non vi sono “fatti primari d’esperienza”,
“evidenze immediate” e simili.Forse soltanto Hegel era giunto, in precedenza, a una posizione
simile. Tuttavia nella Fenomenologia di Hegel vi è un cominciamento, che in Peirce manca. Questa
verità è stata espressa da svariati pensatori, ognuno col proprio gergo filosofico: Peirce parlò di
“semiosi infinita”, Heidegger di “circolo ermeneutico”. Derrida evocherebbe la différance. Sini
aggiungerebbe che non si dà l’uno ma la diade.
12
Occhio alle monetine
Peirce, filosofo indubbiamente originale, fornisce vari argomenti a favore della sua critica
dell’asserita facoltà intuitiva dell’uomo. Uno di essi suggerisce un curioso esperimento.
Prendete un foglio bianco piegato a metà e disponete ali lati due monetine. Ora chiudete con la
mano sinistra l’occhio sinistro e guardate le due monetine con l’occhio destro. Avete la percezione
di uno spazio ovale continuo. Sembra un’evidenza intuitiva immediata. Se però ora fissate la
monetina a sinistra e contemporaneamente spostate verso di essa la monetina di destra, risulterà,
nella piega del foglio, un punto cieco. Bisognerà girare l’occhio per vederla. Ne segue che la
continuità dello spazio non è immediatamente percepita, come sembrava, ma desunta da premesse
intellettuali. “Quale miglior esempio – conclude Peirce – si potrebbe desiderare dell’impossibilità
di distinguere i risultati intellettuali dai dati intuizionali attraverso la mera contemplazione?”
4. Rimuovere l’animale
La scienza si pone come sapere oggettivo. Di un qualsiasi fenomeno esso distingue l’aspetto in sé,
oggettivo, valido universalmente, dagli elementi soggettivi che lo accompagnano, vale a dire
emozioni, incanti o turbamenti, aspettative, credenze ecc. La luna potrà anche ispirare poeti e
musicisti quando si specchia nel lago, ma la luna oggettiva, la luna vera, è un satellite della Terra
butterato da crateri che ruota con velocità pari al tempo di rivoluzione, ecc. ecc. Questa è la
descrizione neutrale, oggettiva, verace e prosaica della Luna, valida universalmente, anche per il
Bororo dell’Amazzonia per i quali la sua apparizione è una ierofania che scandisce importanti
momenti della vita sociale. Questo pensiero si è imposto nella scienza fin dai tempi di Galileo, che
con la sua distinzione tra qualità oggettive e qualità soggettive dei corpi, sosteneva che, una volta
“rimosso l’animale” – il nostro apparato sensoriale – , possiamo conoscere il libro della natura.
Ma sorge ora un dubbio. L‘ontologia della scienza è “oggettiva” e “verace”, o piuttosto è
un’ontologia astratta, che cioè fa astrazione di tutti gli aspetti che non consentono misurazione e
manipolazione tecnica? La luna prosaica esiste in sé o all’interno dello sguardo scientificoobbiettivante che ha deciso, per il suo metodo e le sue finalità, e conseguendone grande efficacia
operativa, di prescindere da ciò che non rientra nel proprio metodo?
Nel brano che segue, Sini dimostra la fondatezza del dubbio. Gli oggetti scientifici, secondo il
filosofo, non esistono che nella visione e nella pratica scientifica, che comporta una estraneazione
del soggetto dalle sue concrete esperienze. Il sapere della scienza è dunque un sapere astratto.
Questa astrazione, che certo ha la sua grande efficacia, non è altro che il trionfo di ciò che il nostro
filosofo è solito chiamare la “strategia dell’anima”, ovvero la svolta di Platone, che concepì la
filosofia come contemplazione dell’universale in sé, della forma oggettiva, di quel triangolo che
non muta e che non è affetto dallo stato d’animo del geometra:
13
Lo scienziato, in un modo o in un altro, tirerà in ballo la celebre distinzione tra qualità
primarie e secondarie: le seconde, dirà, non appartengono alle cose reali, ma solo al
corpo senziente di colui che le percepisce; sicché, “rimosso l’animale” (cioè il corpo
animale), come diceva il grande Galileo, bisogna riconoscere che colori, odrori, sapori,
suoni, ecc. non sono veramente ciò che c’è “là fuori”[…] Movimenti, vibrazioni, “danze
di elettroni”; e così pure è fatto il corpo e, infine, il cervello: eventi che vanno colti in
termini fisici, chimici, fisiologici, neurologici; fenomeni quantitativi che ci vuole la
matematica per raffigurarli. Ma niente di rosso, di salato, di ruvido, ecc. Queste cose (lo
dicevano già, tra gli antichi, Democrito ed Epicuro) sono solo immaginazioni soggettive,
effetti degli scontri tra gli atomi della cosa e gli atomi del corpo senziente
(naturalmente, la scienza moderna usa linguaggi molto più raffinati e specialistici). Il
senso comune, non a torto, è affascinato, ma vorrebbe anche sapere, e capire, come
accada che questi fenomeni meccanici, quantitativi, queste vibrazioni, queste reazioni,
queste sinapsi cerebrali, gli si trasformano, dentro la coscienza, in colori, odori, sapori,
ecc.; per esempio, il rosso del’aurora o la Nona di Beethoven. Ma proprio a questo punto
il realista puro e semplice lo abbandona, cioè lo lascia completamente deluso, perché in
sostanza non lo sa. Putnam dice che ogni spiegazione scientifica della conoscenza finisce
per lasciar coesistere al suo interno “una parte magica”: per incanto, o per magia,
eventi puramente neurologici, fisici e chimici si trasformano in sensazioni qualitative. Il
senso comune comincia a sospettare che quei cani dei filosofi una qualche ragione
dovessero averla. Il realista puro e semplice tenta, allora, una spiegazione plausibile e
dice che è la mente che “proietta” sulle cose le qualità. Le vibrazioni delle molecole
d’aria (l’ “onda sonora”) colpiscono l’orecchio, mettendo in moto fenomeni fisiologiconervosi, sino a determinare aree cerebrali, ecc. ecc.; ma la mente “proietta” su tali
eventi dinamici la percezione qualitativa del suono, li “traveste” qualitativamente. Che
significa “proietta”? Che significa “traveste”? E come fa a farlo? Siamo di nuovo di
fronte a espressioni magiche, che comportano, come dice Putnam, la loro parte di
mistero. Situazione imbarazzante (anche noi dovremo pur rifletterci, una volta o l’altra,
amico lettore), perché nessuno dubita che lo scienziato, con i suoi calcoli ed
esperimenti, e indipendentemente dalle sue espressioni “magiche”, ridia la vista ai
ciechi e l’udito ai sordi, o almeno ci provi con non trascurabili successi. Però, un conto è
elaborare, o diremmo meglio (lo sosteneva già Galileo) trascrivere, le qualità percettive
in un linguaggio matematico, il quale consente esperimenti e poi applicazioni tecnicopratiche; un altro è decidere che cos’è un suono. Il fatto di poter “trascrivere” con
successo la qualità del suono in quantità misurabile e manipolabile non mostra per nulla
che la percezione del suono sia un fenomeno “soggettivo” e che la dinamica delle onde
sia un fenomeno “oggettivo”; insomma non chiarisce che cosa è il suono. Cosa c’è “là
fuori”? Suoni o vibrazioni, o nessuno dei due ? Parlare di proiezioni e di travestimenti
significa introdurre pseudospiegazioni, parole che rivestono la stessa pretesa di una
spiegazione magica. Un po’ come accade quando l’uomo cosiddetto primitivo asserisce
che una pianta ha certe virtù perché ha un mana. Che cos’è mana? Appunto, una virtù
soprannaturale. E che sarebbe questa virtù? Appunto, mana. Grazie, arrivederci.
C. Sini, Idoli della conoscenza
14
5. La nave del sole
Appartiene alla concezione scientifica del mondo una naturale attitudine a relegare nell’ambito
dell’ignoranza e della superstizione ogni concezione o visione del mondo non collimante con la
propria o non conforme alle esigenze del metodo sperimentale. Questo logocentrismo aspira
pertanto, come il capitalismo nel campo economico, a imporre globalmente la propria visuale, con
tutta la sua efficacia tecnica e il “disincantamento” nichilistico del mondo insito in essa. Si tratta di
capire se tutto ciò certifichi la “verità” della scienza e la “superiorità” dell’umanità scientifica. Le
seguenti pagine di Sini, di evidente matrice heideggeriana, ci propongono una lettura diversa:
L’essere-nel-mondo dell’uomo protostorico
Per le civiltà protostoriche vivere nella vicinanza dell’aperto che collega terra e cielo
voleva dire: sapere chi è l’uomo, donde proviene, qual è il suo exitus: il senso della sua
vita e della sua morte. Un sapere che non è di tipo concettuale, ma equivale a un
“essere orientati” tra terra e cielo, a un essere-nel-mondo emotivamente atteggiati,
interpretando e usando (avendo cura). Noi ci stupiamo di fronte alle innumerevoli e
bizzarre cosmologie protostoriche. L’idea che l’antica corte cinese, la sua reggia, gli
ordini e i titoli dei dignitari, le vesti dell’imperatore, persino i suoi gesti dovessero
rispecchiare, come in un’immensa coreografia, l’ordinamento cosmico e celeste,
colpisce la nostra curiosità: ammirazione, fastidio, senso dell’ “esotico” e del
totalmente estraneo. Bellissimo, certamente, ma nell’insieme, diciamolo con
franchezza, cose da pazzi. E questi uomini incredibili sarebbero i nostri antenati. Ma
invece di riconoscere modestamente la nostra impossibilità di capire, noi per lo più
sentenziamo sulla loro “ingenuità” e sulla loro superstiziosa assurdità. UI mito
cosmologico dell’antico Egitto diceva che il mondo è un solido rettangolare: al centro la
regione del Nilo, poiché il Nilo divide in due la terra; all’orizzonte una barca accoglie il
sole e lo trasborda nottetempo dalla parte opposta del mondo, e via di seguito. Ma
come, noi pensiamo, gli Egizi erano forse scemi che non vedevano che l’orizzonte è
circolare? Il fatto è che quell’ ”allegoria” (per usare un termine nostro e non loro)
dell’Egitto non chiedeva di essere “vera” nel senso della nostra nozione di verità. Né le
figure geometriche, il cerchio, il quadrato, significavano allora le stesse cose che
significano (o che non significano, poiché hanno perso, a partire da Euclide, ogni senso
ermeneutico) oggi per noi[…] Gli uomini protostorici “sentivano” la dipendenza della
terra dal cielo. Ne vedevano ovviamente anche la dipendenza reale, materiale: stagioni,
piogge, venti, siccità. E il cielo era il volto enigmatico degli Dei e de destino. Per questo
tanto ansiosamente lo scrutavano. Il cielo velava e insieme ri-velava l’evento del divino,
del divino che era nello stesso tempo l’incomprensibile. Il cielo era il grande Segno. In
particolare gli astri erano i segni, le costellazioni che svelavano i contorni del cielo. Di
qui l’opposizione fondamentale e sovrana di tutte le cosmologie: luce-tenebre. Caos
profondo della notte – quando le notti erano notti: buio immenso e impenetrabile che la
luce delle torce poteva solo scalfire; e la luce del giorno rivelatrice delle forme (dei
significati). Noi non ci accorgiamo più di tutto ciò. Non sentiamo più, come presenza
costante e onnipervasiva, la dipendenza della terra dal cielo. Dobbiamo fare uno sforzo
di riflessione per ricordarci che la luce dell’universo viene dagli astri. L’elementare
15
pensiero che, senza miriadi di soli, dappertutto sarebbe tenebra e notte è capace di
stupirci. Per noi la luce vien meno perché c’è stato uno sciopero dell’azienda elettrica.
Sappiamo che non è così, ma non viviamo tale sapere. Il nostro vissuto quotidiano è
quello delle previsioni meteorologiche del giornale, o dell’annuncio dello sciopero, del
guasto, dell’attentato[…] Coerentemente con ciò, ai nostri bambini diamo informazioni
sul sole, informazioni esatte. In questo modo pensiamo di rispondere ai loro perché. E
chissà per quale mai ragione riteniamo di esere, in questo modo, più “civili” dell’antico
padre babilonese che 4000 anni fa poneva il figlio in ginocchio, con le mani giunte sul
petto, di fronte al sole che sorgeva; senza dargli spiegazioni – che non erano infatti
necessarie[…]Ma i nostri bambini, non poi tanto diversi da quelli di 4000 anni fa, non
appena imparano a scarabocchiare, disegnano con ostinazione la casa, l’albero, il cielo
e il sole che brilla; cioè la terra e il cielo nella loro essenziale relazione, l’aperto che li
contiene. La casa come la terra: ora forse comprendiamo meglio gli egizi e il buffo
parallelepipedo che doveva raffigurare l’universo. Solo per noi la terra è una nozione
astratta: è la sfera del mappamondo; che è tutto fuorché ciò che noi di fatto vediamo
ed esperiamo. I nostri bambini hanno il senso del problema cosmologico. Poi, grazie a
noi, ai nostri mappamondi e alle nostre risposte scrupolosamente “esatte”, perdono ogni
senso cosmologico della loro vita.
C. Sini, Passare il segno
A caccia con i Bororo
E ancora:
Lo stregone Bororo dice certe cose del mondo che a noi suonano strane e
incomprensibili, e anche ingenue, perché esse non fanno più parte di ciò che è diventato
per noi il senso comune (peraltro ignaro a sua volta, bisognerebbe aggiungere, delle sue
ingenuità). Tuttavia, il relativismo culturale ci insegna a comprendere che quelle cose
che lo stregone dice non sono né inutili, né sciocche, né insensate e nemmeno prive di
un loro pratico successo. Se andate a vivere tra i Bororo, come ha fatto Lévi Strauss, e
tornate con loro all’accampamento dopo una lunga giornata di estenuante caccia, le
teorie astronomiche di Copernico e le formule di Einstein non vi servono a nulla; è
invece la dolcezza dei canti della sera che vi consentono di sentirvi, non come una belva
disperata e solitaria, ma come membro e partecipe di una comunità umana, la quale,
ripetendo una tradizione orale che affonda nella notte dei tempi, rende percepibile il
senso delle cose: cosa sono il cibo, gli animali, l’uomo, la donna, l’amore, i figli, la Luna
e le stelle che stanno sorgendo all’orizzonte. Il mito (la parola, mythos) lo dice in una
maniera che è congrua con il vivere umano in quella condizione e proprio dicendolo e
ripetendolo “salva” la vita dell’uomo. Il mondo è, quindi, ben ritagliabile e
interpretabile in questo modo. S’intende che se poi vai a Harvard o a Pasadena e in un
laboratorio scientifico ti comporti come un Bororo, le cose non funzionano più. Lì è
conveniente, per il senso della tua vita, pensare come Einstein o come Bertrand Russell
e disporsi, per il riposo, ad ascoltare le interessanti notizie del telegiornale e le belle e
intelligenti scenette pubblicitarie che immancabilmente lo seguono; sino a che il sonno
sopra di noi si chiuda.
C. Sini, Idoli della conoscenza
16
6. L’ “errore” di Giosuè
E’ credenza inconcussa del senso comune, come degli scienziati, che le oggettualità della scienza,
una volta teorizzate, vadano ovviamente retrocesse ad epoche antecedenti la scoperta stessa. Ad
esempio nessuno dubita che, una volta scoperta la legge di Coriolis che spiega lo spirare dei venti
Alisei, i viaggi di Cristoforo Colombo risultino giustificati da quella legge; oppure che, comprovata
la teoria copernicana, essa valga anche per il celebre Giosuè, quello che ordinò al sole di fermarsi.
Ma fino a che punto sono legittime queste “retroflessioni” o “retrocessioni”? Secondo Sini si deve
valutare con una certa cautela queste presunte ovvietà. Egli propone di valutare una particolare
situazione cosmologica, articolata in quattro livelli di esperienza.
Il primo livello è quello nel quale un’eclisse è intesa come una ierogamia [in precedenza
Sini ha ricordato come, secondo antiche tradizioni mitiche, una eclisse va intesa come una
ierogamia: “il signor Sole e la signora Luna “fanno l’amore”.]. Milioni di uomini hanno
pensato in questo modo e probabilmente ce n’è ancora sulla Terra che così pensano.
Appena si verifica l’eclisse, si gettano in ginocchio e fanno sacrifici. Un secondo livello
fa riferimento alla frase famosa di Giosuè “Fermati, o Sole!” Pare che il Sole abbia
obbedito e Giosuè, che era un guerriero, ebbe tempo di vincere la sua battaglia.
Posto come terzo livello il geocentrismo di Tolomeo e come quarto livello l’eliocentrismo
copernicano, Sini procede come segue:
Nei primi due casi non c’è alcun cammino verso la verità scientifica. Nell’esperienza di
quel mondo non esistono oggettualità scientifiche: non ci sono eclissi, Soli, moti celesti
nel senso di Talete, di Tolomeo, di Newton. Un lettore scienziato già si allarma: cosa
vuol dire “non ci sono”? Ci sono sì, solo che loro, quelli che vivono in quel mondo,
semplicemente lo ignorano. Già, questa maniera di ragionare è appunto quella che si
afferma nei due livelli successivi. Anche qui c’è differenza tra come ragiona un
tolemaico, con le sue sfere cristalline che paiono a Bruno solo superstizioni di morbose
menti, e un copernicano; però le sfere cristalline possono essere “falsificate”, direbbe
Popper, e quindi a loro modo sono già ipotesi dotate di dignità scientifica. Infatti,
derivano da pratiche che resteranno costanti nella scienza: il ragionamento,
l’osservazione sensibile, l’uso di calcoli e di diagrammi geometrici, ecc. […]Tolomeo non
è Newton, ma il suo modo di porre la questione del vero è manifestamente più vicina a
Newton che non a Giosuè. Più in generale, si potrebbe dire che la teoria tolemaica,
come ogni teoria scientifica, ha a che fare con dei “significati”, mentre la ierogamia ha
a che fare con un “senso”, un senso del mondo. La ipotesi geocentrica ed eliocentrica
sono significati astronomici, sicché se è vera l’una è falsa l’altra, e viceversa. Appunto
qui comincia la possibilità della “falsificazione” e, quindi, del dibattito razionale sul
progresso delle conoscenze. Sulla ierogamia non c’è niente da discutere. In pratica ci
troviamo di fronte a due universi di senso difficilmente confrontabili, perché gli oggetti
dell’uno non stanno e non possono stare nell’altro.”
Le paradossali, eppure sensate, considerazioni di Sini imporrebbero, per una più intima
comprensione, di affrontare nella sua completezza la fenomenologia siniana dell’evento, illustrata
soprattutto in Kinesis, e la teoria genealogica delle pratiche, esposta nelle opere più recenti.
Tuttavia, in Idoli della conoscenza, opera non rivolta a un pubblico specialistico, Sini fa
efficacemente intendere il suo pensiero:
17
Il punto, allora, dov’è? Il punto è in quell’insistenza che dice: le cose sono sempre state
come dice la teoria copernicana. Checché pensassero Giosuè o Tolomeo, anche allora si
viveva in una situazione eliocentrica, e non geocentrica, proprio come oggi sappiamo e
vediamo. E’ questo il nocciolo duro con il quale ci dobbiamo misurare[…] La
testimonianza che il copernicano fornisce certamente non è congrua con i sistemi di
pratiche di Giosuè[…]Diceva Michel Foucault: non si può dire qualunque cosa in qualsiasi
tempo. L’uomo dei geroglifici non poteva parlare come Demostene e Pindaro non poteva
pensare come Kant. Non è quindi possibile avere una concezione copernicana vivendo
nel mondo pastorale di Giosuè. Che significa, allora, “vivere in una situazione
eliocentrica”, fuori delle pratiche di vita e di sapere che definiamo, per fare in fretta
copernicane? L’asserzione scientifica copernicana ha la pretesa di riferirisi a un Universo
vero, indipendente da ogni sistema di pratiche definito (addirittura, checché gli uomini
ne pensino). Questa è appunto la sua pretesa ed è qui che dobbiamo chiedere: su che
cosa si fonda questa pretesa? In che consiste e che senso ha la pretesa di esprimere un
universo vero fuori da ogni pratica? Osserviamo, anzitutto, una prima difficoltà: le
asserzioni scientifiche pretendono di riferirsi a un universo vero indipendentemente da
tutte le pratiche – tranne la loro, beninteso. Della contingenza della loro pratica gli
scienziati non fanno questione, ammettono la contingenza delle teorie, ma non del
modo della loro costituzione[…]Non siamo però al cospetto, in questo modo, di un
“circolo” tutt’altro che virtuoso? Riconosciamo il carattere contingente dell’attuale
pratica scientifica (come si potrebbe, infatti, negarlo?), ma correggiamo questa
contingenza con il fare appello al suo successo pratico: poiché ha successo non è
contingente (o almeno è nella direzione canonica per non esserlo); ma ha successo
perché è contingente (perché è questa attuale pratica, non quella di un secolo o di
qualche secolo fa che ha successo. Il successo affrancherebbe dalla contingenza, ma è la
coontingenza che ha successo e che ha un successo contingente (come ogni
successo).[…] Ogni pratica è piena di senso entro il che del suo mondo, nella modalità
che la caratterizza. Fuori da questa modalità non ha universalità possibile; essa non si
trasferisce, non si “espande” debitamente. Ritenere che questa universalità sia
universalmente estensibile, questo è ciò che io chiamerei mera superstizione.
C.Sini, Idoli della conoscenza
7. Il “luogo” del passato
Uno dei presupposti più irriflessi che la scienza normale, salvo qualche complicazione
filosoficamente non sostanziale legata alla teoria della relatività, condivide con il senso comune, è
la concezione spaziale del tempo, e specialmente del passato. Anche le cosiddette scienze umane,
che pensano così di adornarsi del titolo che si attribuiscono, scontano qui la loro scarsa filosoficità,
compresa la storiografia. Tale superficiale comprensione del tempo comporta paradossi e assurdità
insostenibili, che Sini ha evidenziato in un memorabile corso universitario, da cui è tratta la
dispensa dal titolo “Il tempo e l’esperienza”, che qui utilizzeremo. Non è ovviamente possibile
seguire nella sua ricca e affascinante complessità il percorso di Sini. Ci limiteremo ad esporre
alcuni passi estremamente stimolanti per provare a discostarsi dalle opinioni comuni sul tempo, che
appaiono, se sottoposte allo sterramento filosofico, poco più che rozze superstizioni.
18
Il senso comune pensa come se ci fosse un’ideale linea di demarcazione: sin qui il
passato; da qui in avanti il futuro. La linea di demarcazione è quella ideale puntualità
del presente che discrimina, appunto, tiene separati e discosti passato e futuro. L’uno
infatti è già accaduto, l’altro non ancora. E quel che è accaduto è accaduto, sia che il
futuro poi accada oppure no[…]Il senso comune immagina il passato come un acccumulo
di eventi, di fatti e di cose, che se ne stanno là, chissà dove, intatti e inattingibili; cioè
immodificabili. Il tempo non è che un’immensa clessidra, dalla quale si staccano, uno
dopo l’altro, un istante dopo l’altro, i granellini di sabbia. Essi cadono e fanno mucchio
e questo mucchio è appunto il passato. Ogni granellino che cade ha sotto di sé lo stesso
mucchio; e il mucchio resta quello che è anche se nessun granellino dovesse più
cadere[…]Ma questo passato che il senso comune, e anche la scienza, considera come
una realtà in sé, avvenuta una volta per tutte, è un concetto “pubblico” e una verità
“pubblica”. In quanto tale, esso è figlio della ratio dell’Occidente, cioè della filosofia.
E’ la filosofia ad aver costituito una realtà pubblica, fatta di enti e di eventi pubblici,
esprimibili in un logos pubblico, in una ragione impersonale e universale. Ed è anzi
questo logos l’evento capitale che ha reso possibile uno sguardo volto a istituire
l’oggettività in sé, naturale e storica. E’ in questo modo che l’occhio del sapere ha
preso il posto dell’occhio degli Dei. Ora però che “morti son tutti gli Dei” è però rimasta
questa loro ombra nichilistica che disegna l’ideale figura di una grande coscienza, o di
un Interpretante finale e complessivo, al cospetto del quale da sempre si
totalizzerebbero tutti gli eventi del mondo, conservandovi la loro realtà e verità “in
sé”.
C. Sini, Il tempo e l’esperienza
Di antichi dei e nuovi
“Lo sguardo storico al quale siamo stati educati considera le cose del passato
“panoramicamente” e “pubblicamente”. Noi ci poniamo, rispetto al passato, come “spettatori
disinteressati”[…] Ciò che accade è che noi immaginiamo che i fatti accadano al cospetto di uno
sguardo universale e pubblico che era lì presente a registrarli. Gli antichi non lo sapevano, ma
mentre facevano ciò che facevano erano osservati dall’occhio pubblico della storia universale:
occhio impassibile e imparziale che registra e segna, in certo senso occhio divino che contempla
il mondo stando fuori dal mondo. Le nostre narrazioni del passato fanno di questo sguardo
(ovviamente impossibile da incarnare per noi) il loro ideale regolativo. E allora si può ben capire
che per questo occhio (immaginario) ciò che è stato è stato ed è accaduto così come è
accaduto, checché poi ne pensino e ne dicano i “mortali”, cioè coloro che furono parte di quei
fatti e che ancora per molto tempo continuarono a interpretarli come eventi immanenti della
loro perdurante passione. In qualche punto del cielo, su di una nuvoletta, Cesare e Pompeo
ancora discutono e si rimproverano a vicenda. Se tu non mi toglievi il comando militare…Se tu
non passavi il Rubicone..-.Ma le loro sono interpretazioni “di parte”. La guerra civile accadde
per la comodità dello storico contemporaneo, in modo che egli possa mostrare che cosa accadde
“in realtà” e “in verità”. Checché ne pensino Cesare, Pompeo e tutti i loro partigiani e nemici.
In questa ottica, infatti, la guerra civile diviene un fatto pubblico, impersonale e “oggettivo”,
totalmente “astratto” “deciso”, dalle continue interpretazioni che lo intramarono e lo fecero
accadere e vivere. In questo modo però il nostro comune senso storico opera con le sue
inerpretazioni, che spaccia per verità oggettive e assolute. In primo luogo scambia per concreto
ciò che è astratto: la narrazione immaginaria degli eventi in quanto oggetti dello sguardo
pubblico cui viene dato il nome di “guerra civile” viene sovrapposta alla concreta esperienza
ermeneutica che allora accadde, secondo una miriade praticamente infinita di prospettive per di
più in continuo movimento. In secondo luogo tale sguardo assume come “fatti” solo quelli che
per la sua attuale cultura, per il suo modo di interpretare il mondo, sono i fatti, i fatti reali
[…]Questi presupposti contravvengono però a ciò che l’esperienza continuamente ci mostra, cioè
che niente accade che non sia interpretato e che non sia un’interpretazione. E non nel senso di
una mera ed estrinseca somma[…]Non c’è la rappresentazione e poi il pensiero che
l’accompagna e la interpreta. C’è l’interpretare avendo già interpretato e avendo da
interpretare; cioè c’è l’ermeneutica profonda della temporalità. E questa ermeneutica mostra
appunto che il passato è un modo del provenire ora, cioè di aprirsi all’interpretazione futura del
mondo che ora ci incalza.
C.Sini, Il tempo e l’esperienza
19
Viaggi nel tempo
L’ingenua obiettivazione del passato come contenitore di fatti immutabili e “in sé” ha sempre
suscitato il desiderio di una macchina del tempo che consentisse di retrocedervi a piacere, per
scoprire come erano andate davvero le cose. Tutto ciò non solo non è possibile di fatto, ma è di
principio impossibile. Il solo concepirlo è insensato.
“A quale luogo tornerebbe infatti il “mondo”, tornando nel passato? Se tutto tornasse
nel 1942…Ma il 1942 è il luogo di un’interpretazione pubblica. Esso in sé non è mai
esistito (non è mai esistita la supposta totalità degli eventi che noi riassumiamo nel
numero 1942), come non esiste questo [aprile 2007] e l’immaginaria totalità degli eventi
obiettivi che starebbero in esso. Questi luoghi pubblici non sono “ciò che esiste” o “ciò
che accade”. Se tutto tornasse come allora: ma quale “tutto”, e a partire da che o da
chi? Solo per il “Dio”, al cospetto del quale e per il quale tutto accade ed è, questa
frase può avere senso. Ma è proprio il Dio, questo Interpretante complessivo immaginato
dall’onto-teo-logia, che non ci-è. […]Anche il tempo pubblico, con la sua finzione di
“scorrere”, non ci-è. Il passato, allora, cui si vorrebbe ritornare, non solo non c’è più,
ma, più esattamente, non è mai stato né sta”.
Il passato futuro
Bisogna, dice Sini, avere la capacità di pensare queste proposizioni, di cui la seconda appare molto
ardua:
Il passato accade nel presente
Il passato accade nel futuro
Queste asserzioni ci fanno sobbalzare, impregnati come siamo dei presupposti metafisici dello
sguardo pubblico e panoramico, del passato-deposito, ecc. Proviamo a rendere più familiari le
precedenti asserzioni con un banale esempio:
Il professore entra in classe…per l’ennesima volta; un’estenuante lezione sta per cominciare. In
passato ha sentenziato con evidente compiacimento che l’essere è e il non essere non è. Chissà che
cosa riserva il futuro. Già, ora però domandiamoci: che ne è di quelle passate lezioni e di quelle che
seguiranno? Qual è il loro “luogo”? Se passato e futuro hanno luogo, essi non possono averlo che
nel presente, come già argomentò inoppugnabilmente Sant’Agostino. Riflettiamo. In questa
esperienza scolastica il passato – direbbe Sini - mi si fa incontro esclusivamente nell’ “aver già”;
vedo il professore perché l’ho già visto. Mi accingo a scrivere perché ho già scritto. In altre parole il
passato non è che un presente provenire. Le lezioni del passato non trovano altro luogo che
nell’abito della presente interpretazione. Ma al tempo stesso l’atto del professore è riconosciuto
come tale in quanto provoca una risposta interpretante, un agire o astenersi: una “aver da”. Questo,
e non altro, è il futuro: il rinvio di ciò che, provenendo, destina. Passato e futuro sono compenetrati
nel presente, ma ciò che è veramente arduo comprendere è come il futuro condizioni il passato. La
relazione inversa è infatti abbastanza evidente, ma in quale modo mai il futuro potrebbe affettare il
passato? Non è possibile a questo punto comprendere adeguatamente il discorso di Sini senza avere
esaminato uno snodo fondamentale della sua intera filosofia: la questione del segno.
20
Parte seconda Semiotica e Filosofia
Un po’ di semiotica
Che cos’è un segno? Potremmo dire, preliminarmente, che esso è ciò che supponit pro, che cioè sta per
qualcosa d’altro, rinvia, rimanda. Si pensa allora, solitamente, a un’espressione linguistica, un segnale
stradale, un indicatore di pressione ecc. Ma in effetti, se la natura del segno consiste nel rimando,
potremmo annoverare tra i segni, che so io, l’improvviso rossore di un fanciullo, il portamento
esteriore di un ubriaco, il tono di voce con cui mi si è oggi rivolto Caio, il sogno per gli psicanalisti ecc.
Certo corre una bella differenza, poniamo, tra i segni linguistici che uso coscientemente parlando e un
lapsus o l’espressione esteriore con cui li profferisco. Edmund Husserl, nelle Ricerche logiche, ha
proposto di distinguere tra espressione e indice. Se, per fare esempi non husserliani, io vi dico “Fate
attenzione!”, questi segni linguistici sono espressioni: manifestano cioè un significato ben presente alla
coscienza di chi le profferisce (si spera anche di chi le ode); ma se, prima di pronunciarle, avevo
aggrottato le ciglia, respirato profondamente diventando contestualmente paonazzo, questi segni
(Zeichen) sono indici (anzeichen) che necessitano di un ricevente che ne vivifichi il significato. In
questo senso, per fare il noto esempio di Husserl, dei canali presenti su Marte sarebbero indici, poiché
sprovvisti, di per sé, di un’intenzionalità cosciente e che pertanto richiedono un soggetto pensante che
ne colga il significato. In tutti questi esempi, comunque, il segno è ciò che rimanda a un oggetto o a un
significato. Starà poi alla scienza semiotica fare le dovute tassonomie (distinguendo tra segni naturali,
artificiali, icone, simboli, ecc). Ora, tutto questo sembra lampante e ovvio. Ma appunto perché tale non
ci dobbiamo stupire che Sini lo ponga in discussione. Per il nostro filosofo questa spiegazione è
inadeguata. Perché? Perché essa dà ad intendere che un segno sia intrinsecamente tale, che la
distinzione tra significante e significato sia originaria, ponendo il caro davanti ai buoi:
Tutte queste distinzioni e descrizioni non ci hanno fatto fare, invero, alcun progresso.
Anche se le rendessimo molto più sottili e sistematiche, appellandoci alla semiotica, alla
linguistica, alla semantica e alla grande varietà di indirizzi che tali scienze contengono,
neanche allora avremmo compiuto alcun significativo passo in avanti: il problema del
significato, in un senso filosofico che sia ultimativamente fondativo e chiarificatore,
resterebbe inattinto e incompreso. Ciò accade essenzialmente per un fatto: che tutte le
analisi e le teorie scientifiche della relazione tra segno e significato non pongono in modo
filosoficamente adeguato, il problema dell’ “interpretante”[…] Ciò che viene trascurato, o
talora demandato a qualche supposta “psicologia” (che in realtà ne capisce ancora meno),
è che la relazione tra segno e significato, sia essa naturale o arbitraria, è messa in opera in
una interpretazione, cioè in un abito di risposta, ovvero e in questo preciso senso da un
interpretante. Segni e significati non sono “cose” o “fatti” che si esibiscono da sé[…] Presi
così, cioè come tali o in sé, essi invero non esistono, non accadono[…]Le uniche relazioni
segniche che concretamente esistono e che realmente “funzionano” sono relazioni
triadiche o ternarie.
C. Sini, L’origine del significato
21
Ciò che Sini sta dicendo è che, per comprendere la natura del segno, occorre elevarsi alla comprensione
della “relazione segnica”. L’autore che l’ha per primo l’ha introdotta è, ancora una volta, Peirce. Non
si esagera dicendo che la teoria semiotica del fondatore del pragmatismo o, meglio, del pragmaticismo,
costituisce il vero punto archimedeo dell’intera filosofia siniana.
La relazione segnica in Peirce
•
•
•
INTERPRETANTE
SEGNO
Representamen
OGGETTO
DINAMICO
Oggetto immediato
In questo diagramma è visualizzata la teoria della semiosi come Peirce l’ha esposta in articoli e
manoscritti inediti composti tra il 1895 e il 1902.
Il Representamen indica il dato, la qualità materiale che costituisce una pura possibilità segnica,.
L’Oggetto dinamico indica il puro rinvio del Representamen a un qualcosa, senza che questo qualcosa
sia ancora determinato e significato come questo o quello. Esso va altresì inteso come ciò che dà segni
di sé e provoca una risposta nell’Interpretante. Ciò spiega le due frecce che nel diagramma da esso si
dipartono. L’Interpretante è un “abito di risposta”. Cioè – spiega Sini in Passare il segno –“ non solo la
mente o il pensiero, ma più in generale un definito abito d’azione o una serie connessa di abiti di
azioni, ovvero una complessa regola di condotta. Potremmo al limite intendere l’Interpretante
come un intero mondo culturale[…] Solo per quell’Interpretante definito che è il mondo culturale
del medio evo le macchie della luna possono venir colte come qualità segniche che rinviano ad
Oggetti tanto differenti dagli Oggetti dell’astronomia post-galileiana. Si vede bene, allora, in che
senso la realtà è un segno: essa vale sempre infatti come significato per un Interpretante”.
C. Sini, L’origine del significato,
22
L’oggetto che, un po’ infelicemente, Peirce chiama immediato, è, per il filosofo pragmatista, “l’oggetto
come il Segno stesso lo rappresenta”, il riflesso dell’oggetto dinamico in sé “che, per la natura delle
cose, il Segno non può esprimere”. Cercherò di chiarire queste distinzioni con un esempio tratto dalle
mie disavventure domestiche. Uno strana macchia d’acqua vicino al lavandino è il segno,
“Representamen” che per un Interpretante, qui il sottoscritto con la sua modesta cultura idraulica, invia
a un Oggetto – una crepa in un tubo o altrettali (questa inferenza Peirce la chiama abduzione). Ma
questo Oggetto non è l’oggetto dinamico, l’oggetto in sé, ma una rappresentazione mentale che non
può certo esaurire la complessità dell’Oggetto. E’ chiaro che la rappresentazione che dell’Oggetto ha il
venale idraulico che lo ripara, e che qualifica il medesimo come un interpretante ben più esperto del
sottoscritto, è molto più articolata e promuove risposte più efficaci. Ma nemmeno l’idraulico conosce
perfettamente la natura di tubi e crepe. Forse bisognerebbe chiedere lumi a qualche ingegnere o fisico
dotato di conoscenze più approfondite sui materiali. Ma anche il fisico parlerebbe a partire da una
teoria provvisoria, indefinitamente perfettibile che non esaurirebbe la complessa natura dell’oggetto. Le
considerazioni di Peirce vanno comprese alla luce della sua famosa massima pragmatica, enunciata nel
saggio del 1878 Come rendere chiare le nostre idee. Qui l’iniziatore del pragmatismo sostiene, in
modo convincente, che “per sviluppare il significato di qualsiasi cosa, dobbiamo semplicemente
determinare quali abiti produce, perché ciò che una cosa significa è semplicemente l’abito che
comporta”. In altre parole, la comprensione di un oggetto non consiste in una improbabile intuizione
cartesiana chiara e distinta, ma nel complesso di pratiche che siamo in grado di svolgere in relazione ad
esso. Poiché tuttavia la totalità delle pratiche conoscitive e operative attuabili sono infinite, ne segue
che l’oggetto “in sé” non sarà mai pienamente conosciuto e stimolerà un continuo processo di
interpretazioni, una “semiosi infinita”. La conoscenza assoluta dell’oggetto e il conseguente accordo
conoscitivo su di esso di tutti gli esseri razionali costituiscono pertanto un ideale regolativo e non
costitutivo, per dirla kantianamente.
Ora, l’analisi peirceana ha certamente grandi meriti, ma appare per Sini affetta da un residuo
dogmatico. Se infatti l’ “Oggetto dinamico” è inattingibile ala luce del principio della semiosi infinita,
esso si avvicina pericolosamente alla cosa in sé kantiana, ovvero all’inconoscibile, che pure lo stesso
Peirce aveva dimostrato essere concetto insostenibile. Vediamo ora il perché.
23
Il noumeno, questo sconosciuto
In diversi geniali saggi Peirce ha dimostrato l’insostenibilità del concetto di inconoscibile (proprio uno
di quelli su cui in quegli stessi anni Herbert Spencer mieteva successi soprattutto in America, dove si
avvertiva l’esigenza di mitigare le componenti antireligiose dell’evoluzionismo). Nel già citato
Questioni concernenti certe pretese facoltà umane, del 1868, analizza la questione “se un segno possa
avere un significato, quando, per definizione, esso sia segno di qualcosa di assolutamente
inconoscibile”. La risposta è negativa. Infatti, la nozione di “conoscibile” indica il concetto più alto che
si possa formare per astrazione dall’esperienza; se pretendessimo di includere il conoscibile in una
realtà inconoscibile, noi avremmo affermato un non concetto, ovvero un concetto che implica di non
essere un concetto, insomma una nozione contraddittoria, quindi insensata. “Di fronte a ogni
cognizione c’è una realtà sconosciuta eppur conoscibile; ma di fronte a ogni possibile cognizione c’è
solo l’autocontraddittorio”.
In altri scritti Peirce si esprime così: “dal momento che il significato di una parola è il concetto che essa
veicola, l’assolutamente inconoscibile non ha alcun significato, perché non veicola alcun concetto;
perciò “inconoscibile” è parola senza significato; e per conseguenza qualsiasi cosa sia designata da
qualsiasi termine come “reale” è conoscibile in qualche grado”. Queste considerazioni stringenti
)ricordano da vicino le teorie di Ardigò nonché la scelta di Wittgenstein nel Tractatus logicophilosophicus di non voler demarcare il pensiero ma il linguaggio; d’altra parte scaturiscono in modo
lineare dalla “massima pragmatica”: infatti quali abiti di risposta potrebbe implicare tale
pseudoconcetto?
Alla luce di queste considerazioni appare chiara la permanenza di un presupposto dogmatico nella
semiotica di Peirce, certamente dovuto alla componente empiristica della sua formazione culturale, che
pure la geniale tesi della semiosi infinita avrebbe consentito di epurare. Contro tale residuo metafisico
Sini, ne L’origine del significato, è esplicito:
l’oggetto – scrive – non è altro che il significato del segno[…] Infatti dobbiamo dire in
generale (mettendo a dura prova il senso comune): non ci sono da nessuna parte realtà
esterne al triangolo semiotico.
L’Oggetto rappresentato dal segno è dunque a sua volta un segno che produce un ulteriore rinvio, e così
all’infinito: non solo nel senso dell’apertura ad infinite interpretazioni, ma anche nel senso dell’aver già
sempre interpretato. Tale concezione può apparire sconcertante, per varie ragioni tra le quali
l’apparente circolo vizioso nel quale sembrerebbe cadere. “Ci dovrà essere stata – obietta il senso
comune – una prima interpretazione! (il mitico dato immediato, il fatto scevro da interpretazioni)”
Eppure in questo circolo – il famoso “circolo ermeneutico” - noi ci muoviamo di continuo. C’è mai
qualcuno che abbia tradotto una versione mediante analisi e giustapposizione del significato dei singoli
termini? C’è qualcuno tra i classicisti presenti in grado di tradurre un δέ senza rifarsi al contesto? E
d’altra parte come fa ad afferrare il contesto se non conosce il significato delle singole parole? Eppure
traduciamo. Allo stesso modo la infinità della semiosi non contraddice il fatto che di continuo facciamo
esperienza interpretando.
24
La relazione segnica in Sini
(Semiosi infinita)
Interpretante
Interpretante
(Ripetizione e dif/ferenza)
•
Oggetto= Segno
Oggetto=Segno
Oggetto=Segno
Il triangolo, rispetto al modello precedentemente visualizzato, va dunque semplificato in una
relazione triadica di segno, oggetto, interpretante, dove l’oggetto non è “fuori” o in sé. Non vi sono
oggetti a prescindere da Interpretanti (abiti di risposta).
Ora, se quanto si è finora detto è vero, allora la relazione segnica non ha una limitata valenza semiotica,
buona per interessi specialistici: al contrario essa costituisce la “struttura” della nostra stessa
esperienza. Ovvero non si dà esperienza al di fuori dell’accadere della relazione segnica. Da qui
l’autentico rilievo di Peirce per la filosofia dell’esperienza:
“Anche noi vediamo e sappiamo benissimo che ci sono cose che sono segni in un senso più
ristretto o magari specifico, a cominciare dai segni del linguaggio e della scrittura. Ma il
fatto è che noi possiamo deputare certe cose a significarne altre, e quindi assumerle come
segni in senso specifico, solo perché la struttura generale della nostra esperienza è fondata
sul rimando, e cioè sulla relazione segnica in senso lato e originario.”
C. Sini, L’origine del significato
25
La relazione simbolica
La relazione segnica, correttamente intesa, e quindi concepita secondo i principi della semiosi infinita e
del circolo ermeneutico, si rivela essere una relazione simbolica, in un senso ben preciso che Sini ha
sviluppato in alcune ricerche di notevole originalità. Simbolo va qui inteso nel suo significato letterale
originario, dal greco symbàllo che significa metto insieme, unisco, accosto.
Presso i Greci – scrive Sini in I luoghi dell’immagine e la teoria dell’immaginazione – il symbolon
era un segno di riconoscimento costituito dalle due metà accostate di un oggetto spezzato.
Unendo le due metà di una tessera o di un coccio, i possessori si scoprivano adepti della
medesima filìa o consorteria, e come tali si riconoscevano; oppure, gli amici si scambiavano
questo pegno in vista di un incontro futuro.
Ora, ciò che per Sini è filosoficamente significativo, è che il simbolo è un segno che rinvia a se stesso
(l’intero spezzato rinvia all’intero non spezzato, così come ognuna delle due parti). Ma che cos’è che,
nel simbolo, produce il rinvio? Manifestamente la fessura: essa distanzia unificando. Ma non è
precisamente questa la natura di ogni relazione segnica, un essere distanziati che invia ad una
unificazione? Il bambino o forse già il feto che percepisce una presenza di madre può farlo solo nel
venir meno di una simbiosi con essa, della quale però non può avere alcuna esperienza. Non vi è infatti
una distanza, un orlo che la renda possibile. Da qui la tesi di Sini secondo la quale il simbolo, la
distanza simbolica, costituisce il carattere originario di ogni segno, ciò che fa di un segno
un segno.
Ma se è la fenditura dell’intero che consente l’esperienza, bisogna allora comprendere che il
fondamento dell’esperienza è nulla.
Il fondamento della relazione è nulla, nulla di fondamento, Ab-grund. Che cosa infatti
produce la differenza (e perciò la relazione)? Manifestamente la fessura. Ma la fessura è
appunto nulla, mero orlo, evento. Nulla – dobbiamo dire – divide a da a”.
Nulla non è niente. Bisogna comprendere questa differenza. “La fessura – continua Sini -,
che è nulla, non si annulla”. E’ proprio la comprensione di ciò che smaschera l’errore della
metafisica che sta anche a fondamento dei preconcetti scientifici. Il punto è che nel nostro
esperire non si dà, ne può darsi, la totalità unificata cui il simbolo allude. La nostra
condizione è, strutturalmente, analoga alla parte spezzata, con il suo orlo di nulla:
La relazione simbolica
A
• a
• a
26
La fessura comporta l’inesistenza dell’originario. La dimensione originaria è inesistente.
Non c’è una totalità (diciamo una “A” grande) che con-tiene le sue due parti (diciamo le
sue due ‘a’ piccole), poiché, appunto, è la fessura che lo fa, è lei che con-tiene. La
totalità, la “A” grande, è un’ipostasi metafisica e non necessaria della fessura[…] Il nostro
discorso (il nostro esperire) non è mai al livello della “A” grande: in questo luogo non sta
nessuno; questo posto (l’occhio dell’interpretante totalizzante o divino) è vuoto: la sua
voce è silenzio; la sua mano che spezza l’intero e lo riavvicina nelle sue parti è una figura
cancellata nella sabbia. Noi siamo, il nostro luogo è, sempre, in una delle due parti. Così
noi siamo con-tenuti e insieme separati, aperti al (nel) nulla. L’originario per noi non è che
questo essere rinviati nel nulla, l’evento.
C. Sini, I luoghi dell’immagine e la teoria dell’immaginazione
L’evento
Al tema dell’evento Sini ha dedicato molte indagini originali, indipendenti dalle note riflessioni
heideggeriane. La riflessione sull’evento è la maggiore lacuna riscontrabile nell’ermeneutica. Questa ha
avuto il merito di sottolineare il fatto che non si dà verità fuori dall’interpretazione, ma tende talvolta
a ridurre tutto a interpretazione. Con ciò essa non comprende il suo dire, cioè il suo accadere.
Certamente il come dell’accadere è sempre espresso da un interpretazione, ma il che dell’accadere
circoscrive l’interpretazione: ne è l’evento. Proviamo a comprenderlo con un esempio dello stesso Sini.
Supponiamo che io stia cercando di spiegare la natura della scrittura cuneiforme, raffigurando
contestualmente uno scriba sumero intento a imprimere cunei sulla sua tavoletta. Questa raffigurazione
descrive ciò che sto facendo? Certamente no, giacché dovrei raffigurare me stesso nell’atto di
raffigurare lo scriba. Ma allora non avrei raffigurato me stesso nell’atto di raffigurare me stesso che
raffigura…ecc.ecc. Lo stesso vale per il nostro dire: la parola non può mai dire il suo dire, in essa è
inscritta una dif/ferenza, direbbe Derrida. E’ in questo senso che, come scrive Sini in L’analogia della
parola, noi “stiamo sempre parlando d’altro”. Ciò – sia detto per inciso – mi ricorda la distinzione
wittgensteiniana tra dire e mostrare, nonché il teorema d’incompletezza di Gödel,.
Sebbene la parola non possa propriamente dire l’evento ma solo evocarlo, è però chiaro che l’evento
circoscrive il significato in quanto evento del suo accadere. L’evento è appunto l’accadere del
significato, ovvero dell’interpretazione con la sua prospettiva. Ma poiché ciò che qualifica
l’interpretazione nella sua determinatezza è proprio il suo orlo, che è orlo di nulla, allora si può dire che
l’evento è precisamente l’accadere di nulla. Nulla accade, non significa che non accada niente.
Significa che l’accadere è sempre in prospettiva, e non può mai pervenire a uno sguardo totalizzante.
Queste prospettive sono inoltre in continuo divenire, sicché il loro accadere è contestualmente un
cadere nel nulla. L’esperienza è un errare determinato da un costitutivo essere in errore.
“Dal punto di vista del significato il significato non è uguale a nulla; ma dal punto di vista
dell’evento, in quanto unità di nulla e significato, che accade qualcosa (il significato) è
assolutamente lo “stesso” di “accade nulla”. Questa è l’ardua verità sulla quale bisogna
compiere un’esperienza di pensiero”
C.Sini, Kinesis- Il movimento della differenza tra evento e significato
27
La soglia, lo stacco, il transito
Cercheremo di integrare i complessi passi precedenti, avvalendoci si alcune indagini più recenti di Sini
(la fase “genealogica” ed “enciclopedica” della sua filosofia).
Quando si afferma che l’evento è l’accadere di nulla non si vuole usare un linguaggio misticheggiante.
Si sta invece dicendo che l’accadere è un orlo, soltanto a partire dal quale noi svolgiamo tutte le nostre
pratiche di vita, compresa la pratica filosofica; esse, proprio perché delimitate da quell’orlo, sono in
prospettiva. Ma questo orlo determina uno stacco, a partire dal quale le pratiche, pur nella continuità
della ripetizione, si differenziano, retroflettendo e anteflettendo i loro oggetti. Conseguentemente l’orlo
dello stacco (l’evento) è altresì una soglia attraverso la quale transitano le interpretazioni, che nella
differenza della loro ripetizione, producono nuovi stacchi, ecc. Questa è ciò che Sini chiama anche la
kinesis della differenza tra evento e significato, o anche la “impermanente permanenza”.
Quando nominiamo l’impermanenza ci riferiamo alla deriva continua delle pratiche. Il
nostro “esserci” è collocato (dislocato) nell’essere sempre in atto, cioè in azione. Detto
alla buona, di continuo facciamo qualcosa (o, che è il medesimo, di continuo accade e ci
accade qualcosa). Siamo costantemente “in atto”, anche quando non facciamo nulla, che è
a sua volta un modo (difettivo) di fare. Gettati nell’intreccio semovente delle pratiche,
pratichiamo lo slittamento continuo dei suoi contesti di senso. Nel mutamento del contesto
qualcosa assume una determinata centralità prospettica, qualcosa prende rilievo e il
“fuoco” della visione “si stacca”: staglio di una figura di senso che ricontestualizza, a
partire da sé, il significato, fornendolo di nuovi sensi o di nuove formazioni di senso.[…]Col
mutare del contesto, costituito dall’intreccio delle pratiche, anche l’abito interpretante
muta e in questa relazione compare un nuovo oggetto: esso si iscrive sul transitante
supporto predisposto dall’intreccio delle pratiche e, così facendo, fa segno. Il che dà luogo
alla risposta la quale, per il solo fatto di accadere, traduce la sua soglia un po’ più in là.
L’accadere, così, cade nell’accaduto e predispone a un intreccio modificato per un nuovo
supporto accadente. Questa descrizione, sommaria e per certi versi imperfetta, intende
nondimeno mostrare quella inarrestabile mobilità del varco, del varco della soglia, che
costituisce la permanente impermanenza della verticalità dell’evento: kinesis inarrestabile
che si oppone a ogni pretesa “solidificazione” del significato. La soglia infatti, si potrebbe
anche dire, è la stanza di una distanza: luogo “metafisico” che congiunge in sé origine e
destinazione nello stacco della sua figura retroflessa e anteflessa.
C. Sini, L’origine del significato
Sarebbe necessario un discorso ampio e particolareggiato per comprendere a fondo queste ardue
proposizioni. I veri filosofi sono difficili, poiché esprimono con pregnante densità gli esiti di una
riflessione complessa e articolata, che li accompagna quotidianamente per anni come loro “perdurante
passione”. Il lettore frettoloso, o abituato a digerire un intero romanzo di Faletti prima di
addormentarsi, si lamenta dell’oscurità dei filosofi, che dovrebbero rendersi subito comprensibili a
tutti, secondo triti luoghi comuni. Nessuno però potrebbe pretendere da un matematico che gli
insegnasse in un ora le equazioni differenziali, né Einstein avrebbe potuto spiegare a chiunque le
curvature gaussiano-riemanniane dello spazio relativistico. Sini però ha sempre presente il problema
della comunicazione, dato anche il suo trentennale insegnamento universitario, e applica molto spesso
le sue complesse teorie all’analisi di casi esemplari tratti dalla quotidianità. Sicché, ferma restando la
necessità, per chi volesse approfondire, di ricorrere alla bibliografia segnalata alla fine di queste
dispense, voglio proporre qui per esteso una di queste analisi, che potrà certamente rendere più
accessibili le riflessioni siniane sull’evento. Il bellissimo brano che segue è tratto da L’origine del
significato
28
I quattro ultimi Lieder
Quello che ora segue non è un semplice esempio. E’ piuttosto una descrizione esemplare
che ha lo scopo di mettere alla prova la nozione di stacco[…] L’avvenimento in questione si
riferisce alla data del 22 maggio 1950. Il luogo di esso alla Royal Albert Hall di Londra. In
questa prestigiosa sala, la sera di quel giorno di maggio di mezzo secolo fa si tenne la prima
esecuzione mondiale dei Vier letze Lieder di Richard Strauss. Del concerto esiste una
registrazione dal vivo della RAI, che riproduce anche il grande e prolungato applauso del
pubblico alla fine dell’esecuzione[…]In vita Strauss aveva goduto di una grandissima fama,
sia come autore di celeberrimi poemi sinfonici (Don Giovanni, Così parlò Zarathustra ecc.),
sia di fortunate opere liriche composte in collaborazione col poeta Hugo von
Hoffmannstahl, collaborazione divenuta a sua volta leggendaria (Il cavaliere della rosa
ecc.).
Questo però non era tutto. Come decano dei compositori tedeschi e musicista di fama
mondiale, Strauss aveva collaborato con Hitler e col regime nazista, impegnandovi il suo
prestigio e il suo nome, il che ne aveva compromesso in qualche modo l’immagine[…] Lo
stesso era da dirsi di uno dei due protagonisti di quella esecuzione, il celebre direttore
d’orchestra Wilhelm Furtwängler. Anche Furtwängler aveva intrattenuto rapporti
professionali e personali con Hitler e col regime nazista. Indimenticabili e impressionanti
sono, in proposito, le registrazioni dei concerti diretti da Furtwängler con l’orchestra dei
Berliner (esentati dal fronte) ancora pochi mesi o addirittura settimane prima della fine del
conflitto mondiale, a pochi passi, si potrebbe dire, dal Bunker in cui Hitler si era rinchiuso
sotto i continui bombardamenti degli Alleati e dove, di lì a poco, si sarebbe suicidato. Ora,
è importante tener presente il clima generale entro il quale l’esecuzione dei “Quattro
ultimi Lieder” si collocava. La guerra era finita da appena cinque anni. Molte città della
Germania erano ancora un cumulo di macerie, compresa quella Norimberga in cui si era
tenuto il famoso processo contro i crimini nazisti: città d’arte meravigliosa, patria dei
“Maestri Cantori”, che Churchill fece radere al suolo dai bombardieri inglesi nelle ultime
settimane di guerra per puro spirito vendicativo. Curioso modo di punire la barbarie con un
atto di barbarie che sottrae per sempre, in modo criminale, un patrimonio di storia e
bellezza non ai Tedeschi soltanto, ma a tutti gli uomini presenti e futuri, Inglesi inclusi[…] Il
concerto dunque non era solo un grande avvenimento musicale e mondano, ma era anche
un evento politico e psicologico. I vincitori, per dir così, tendevano la mano ai vinti e, in
nome delle superiori ragioni dell’arte, avviavano un processo di distensione, animato da
reciproca buona volontà.
Questi, succintamente, i fatti. Ma cosa sono propriamente questi fatti, dove hanno luogo e
significato?[…]Osserviamo anzitutto l’evento del concerto e proviamo a immaginare alcune
plausibili serie di fatti che si mettono in cammino verso l’evento stesso. Per esempio c’è
Furtwängler in viaggio per Londra. Ha con sé la partitura di Strauss, che ha lungamente
studiato ecc. C’è la Flastadt anche lei in viaggio, reduce da molte prove al pianoforte e di
sicuro preoccupata ed emozionata per il ruolo di solista a lei affidato in un così significativo
evento. Nel contempo c’è tutto il lavorio delle autorità e delle maestranze politiche,
diplomatiche, artistiche, amministrative che hanno deciso di promuovere e ospitare
l’avvenimento, di sicuro non senza dubbi, esitazioni, opposizioni, sospetti, gelosie e
consimili beghe[…] Nel contempo c’è il darsi da fare di tutta la macchina organizzativa che
coinvolge alberghi, tecnici di sala e della rado, personale amministrativo della Royal Albert
Hall, sino ai copisti che preparano le parti per gli strumentisti dell’orchestra, ai tipografi
che stampano i manifesti, gli “attacchini” che li incollano sui muri di Londra, agli impiegati
del botteghino che prendono le prenotazioni, vendono i biglietti, spediscono gli inviti
omaggio alle autorità e via dicendo. Il tutto innesca la reazione del pubblico: da coloro che,
come si dice, amano la buona musica, ai patiti di Strauss, alle personalità della “buona
società” che si contendono l’onore mondano di festeggiare gli illustri ospiti, ai
frequentatori abituali dei concerti. Ma non bisogna dimenticare la “non reazione” di coloro
che non si interessano di queste cose, per loro “non significative”, e che gettano solo uno
sguardo distratto ai vari annunci sui giornali: per finire con coloro che ignorano del tutto ciò
che sta per accadere: anche costoro contribuiscono a creare il clima d’insieme dell’evento.
A questo punto potrebbe venirci in mente di approfondire seriamente la ricerca e di
costruire realmente una sorta di archivio o protocollo dell’intero avvenimento. Per esempio
potremmo proporci di comporre un libro documentario, zeppo di lettere, fotografie,
fotocopie di articoli, di manifesti, di interviste, di saggi, di recensioni di libri e di altre
innumerevoli testimonianze[…] L’ipotetico “dossier” vorrebbe narrare e spiegare che cosa
accadde in verità quella sera di maggio. Ma che cosa accadde in verità?
29
Come accadono i “fatti”
Cominciamo intanto a vedere cosa sta accadendo nella composizione di questo immaginario
“dossier”. Accade anzitutto che una sterminata congerie di avvenimenti, connesso ognuno a
pratiche di vita peculiari, viene fatta confluire, come se fosse un’unica serie convergente,
alla sera del 22 maggio e al concerto della Royal Albert Hall. Per esempio: i macchinisti
guidano i treni, i camerieri preparano le stanze d’albergo, i copisti approntano le parti
d’orchestra, i giornalisti battono a macchina gli articoli, gli orchestrali mettono a punto gli
strumenti (l’oboista si costruisce addirittura un’ancia speciale) e così via. Com’è chiaro,
ognuno è immerso nella sua pratica e pensa agli affari suoi. Alcuni sono consapevoli della
finalità del concerto, altri per nulla, poiché le loro pratiche hanno altre finalità che le
caratterizzano, anche se casualmente si intrecciano con l’evento di cui parliamo. Altri
ancora legano in modo singolare la finalità del concerto con finalità molto private: come il
giovanotto che ne fa l’occasione per invitare a uscire con lui una fanciulla che dice di
amare la musica sinfonica (il giovanotto è in realtà molto interessato al dopo concerto); o
come la moglie di un violino di fila, in crisi matrimoniale, che vi scorge l’occasione per
incontrarsi col suo amante.
Ma ora si consideri: tutto quello che così descriviamo e che potremmo indefinitamente
descrivere viene tradotto nel nostro progetto di “libro-verità” o nelle riprese televisive del
nostro immaginato “servizio” che vorremmo fare (come si dice, sebbene in televisione non
sia mai del tutto chiaro a chi). Una massa sterminata di fatti e cose viene trasferita sul
supporto cartaceo del libro o sullo schermo. Proprio questo, allora, è ciò che accade
anzitutto in verità: che noi ci inseriamo con la nostra pratica di trascrizione, sicché la serie
degli avvenimenti si traduce in frasi di scrittura e in documenti depositati sulla carta,
oppure in immagini e inquadrature del teleschermo. Pratica di trascrizione “animata” dalla
“volontà di sapere”; ovvero dalla intenzione di “conoscere” cosa oggettivamente accadde
in verità, come andarono davvero le cose; finalità che ovviamente non preoccupava
minimamente coloro che vivevano l’avvenimento in prima persona. Di ben altro dovevano
infatti preoccuparsi. L’impiegato del botteghino, per esempio, di calcolare esattamente il
resto, Furtwängler di dare l’attacco agli ottoni; la Flagstadt di respirare al momento giusto;
l’addetto alle luci di segnalare la fine dell’intervallo; lo spettatore di trattenere la tosse e
così via[…] Questo è ciò che accade in verità, ma a questa verità non prestiamo
solitamente attenzione, come cosa al tempo stesso irrilevante e ovvia. Il supposto autore
del “dossier” o del “servizio” è tutto teso a fornire la sua documentazione e a sviluppare il
suo racconto. Soggetto alle operazioni della sua pratica, è volto unicamente all’oggetto che
si disegna e si staglia in essa. Questo oggetto potremmo designarlo così: “Prima esecuzione
mondiale a Londra dei Quattro ultimi Lieder di Richard Strauss”. Ecco la figura di stacco in
cui si compendia tutta quella serie di avvenimenti ai quali si è variamente alluso. Già, ma è
davvero accaduta questa “cosa” cui si allude nominandola come sopra è detta?
“Prima esecuzione mondiale”: in verità, tanto per cominciare, il “mondo” non se ne è
accorto. Stando ai miliardi di uomini che popolano la terra, solo pochi intimi si trovarono
direttamente o indirettamente coinvolti in quell’avvenimento[...]Nessuno può negare che
molte cose siano allora accadute, ma ciò che dice e significa l’espressione “Prima
esecuzione mondiale ecc.” è ancora un’altra cosa: essa si sovrimpone col suo stacco alla
congerie di avvenimenti effettivamente accaduti e, retroflettendosi su di essi, fa accadere
la sua pretesa di riassumere il significato “oggettivo” costruito in base alla concreta quanto
aproblematica pratica della sua figura, come ciò che accadde in verità; laddove è questa
pretesa inavvertita ciò che accade in verità. Con questo non si vuole dire sostenere che ciò
che si dice e che si mostra nel supposto libro-dossier sia falso. Documenti, interviste,
testimonianze e infine tutta la storia ricostruita e narrata passo passo alludono a un “esser
venuti a sapere” che frequenta a suo modo la verità; e in quanto frequenta la verità, corre
un rischio peculiare di errore specifico, passibile di venire scoperto. Furtwängler non prese
il treno ma andò direttamente da Berlino a Londra in aereo. Si dice che la Flagstadt che è
un’artista tedesca invece è svedese, e così via. La dialettica vero/falso si esercita qui sullo
sfondo di contesti oggettivabili, vero-falsificabili, che ne incorniciano e ne delimitano il
senso.
Ma ciò che invece muta nella trascrizione che accade in verità è proprio quel contesto che
definisce la trascrizione stessa, cioè l’esercizio della sua pratica. Si tratta insomma di una
differenza di soglia, di supporto, imparagonabile con i supporti e i contesti che presiedono
agli avvenimenti e alle vicende, in quanto essi entrano ora nel luogo della loro trascrizione
narrata ed esibita. Differenza sottile ma decisiva[…]
30
Slittamenti di contesto
Stiamo dunque dicendo che sulla soglia dell’evento accade quello che accade, ma quello che accade
non è in sé né “unitario”, né “oggettivo”. Piuttosto è fatto oggetto della pratica in cui e in
riferimento alla quale accade. Questa pratica, allora, disegna un’unità di mondo a partire da sé –
compresa quella pratica che ha la finalità, o l’ossessione “storica”della “oggettività in sé”:
anch’essa disegna una unità di mondo a partire da sé, e la disegna come tutte le altre, cioè nel suo
modo parziale.
La pratica (ogni pratica) configura l’evento venendo da molto lontano e replicandosi per l’occasione
con una sua piccola (o grande) differenza. Alla luce di essa, retroflette indietro i suoi oggetti e
designa a suo modo la continuità dell’accadere nella sua differenza[…]
Se ora riconsideriamo l’espressione “Prima esecuzione mondiale ecc.”, è evidente che stiamo
parlando di un oggetto che ha la sua verità e realtà nelle pratiche degli storici della musica e dei
critici musicali, donde si travasa, si rispecchia e si introflette nell’immaginario soggettivo di tutti
coloro che, in un modo o nell’altro, si occupano di queste cose.[…] Ecco allora che l’espressione
“Prima esecuzione mondiale ecc.” non è più che un astratto riferimento alla “memoria pubblica”,
sostituibile, ai fini dell’esempio e dello “stacco”, con qualsiasi altro fatto “pubblico”[…]I contesti
mutano di continuo nel continuo accadere delle pratiche. Già ascoltare la registrazione alla radio è
qualcosa di infinitamente diverso e lontano dal partecipare all’evento vivente dell’esecuzione, dove
l’evento può solo registrarsi sul fragile supporto della memoria personale. La registrazione
radiofonica, come in generale la scrittura, tiene l’oggetto (vale a dire il suo oggetto) in
sospensione. In certo modo lo surgela, così che possa venire scongelato a piacere. Il che espone
l’oggetto stesso alla inserzione nei più imprevedibili contesti e alle metamorfosi nei più lontani e
inimmaginabili sensi.”
Il passato che non sta
L’ “analisi esemplare” sopra esposta ci può aiutare a comprendere il senso della sorprendente tesi
siniana, citata a pag. 20, secondo la quale “Il passato accade nel futuro”. Questa asserzione, di primo
acchito incomprensibile, comporta la conseguenza sconcertante che il passato è mobile, ovvero può
mutare, anzi muta in continuazione. Ora dovremmo comprenderne la ragione: essa consiste
nell’impossibilità dell’esperienza umana di trascendere il triangolo semiotico. Il passato, come
qualsiasi dato d’esperienza, ha natura segnica, cioè coincide con i segni, o con i “corpi signati”, come
anche li chiama Sini, che attivano le future interpretazioni. Ma le interpretazioni, come capiremo
meglio tra poco, mutano, operando nuovi stacchi e correlative retroflessioni che rimodellano il senso
di quei segni, precludendo interpretazioni definitive. Si consideri, ad esempio, quali infinite
modificazioni di senso ha assunto la figura di Cristo nel corso dei secoli. Pescatore di anime e
taumaturgo per i primi seguaci, figura irrilevante per Tacito e Svetonio, figlio di Dio e Redentore in
San Paolo, pura anima sotto apparenti spoglie corporee per gnostici e monofisiti, consustanziale a Dio
secondo il Credo niceno, profeta la cui discesa sul minareto della grande moschea di Damasco
annuncerà il Giudizio secondo una credenza islamica; puro uomo, per quanto divinamente concepito,
tra i Sociniani,, falso mago per Bruno, pericoloso sovversivo per Reimarus, figlio di giudea
scostumata per Sade, “ebreo crocifisso” per Nietzsche, marito della Maddalena per gli amanti dei
thriller logico-teologici e personaggio meno popolare di Berlusconi tra i bambini, secondo un recente
sondaggio. E non serve postulare l’ipotesi di un vero Gesù, che avremmo potuto conoscere “in sé
stesso” vivendo in Galilea ai tempi di Tiberio. Quale Gesù? Quello di Ponzio Pilato o degli ebrei? Di
San Pietro o di Caifa? Di quale occhio “oggettivo”? Per quale sguardo veritativo? In tutti questi casi la
“verità” del passato è inviata ad un futuro mai concluso che, retroflettendo il suo sguardo a partire dalla
sua prospettiva e dalle sue pratiche di vita, ridisegna il passato, cioè il suo provenire, che infatti non è
accaduto, ma accade.
31
Il precipitare delle interpretazioni
Ogni evento accade a partire dalla continuità di una pratica, anzi di un intreccio di pratiche, ma altresì
dalla differenza del suo stacco che nella soglia retroflette i suoi oggetti delineando il suo mondo. Ciò
però significa che l’accadere di quel nulla che è la soglia dell’evento implica il costitutivo errare delle
interpretazioni. Le interpretazioni fanno catena nelle pratiche, ma la differenza della ripetizione
produce il loro continuo, spesso impercettibile, decentrarsi con il correlativo mutare degli abiti di
risposta. E’ certo, ad es., che quando studiamo le credenze religiose politeistiche delle civiltà
protostoriche noi, retroflettendo la nostra attitudine logico-scientifico-storiografica, ci troviamo
nell’impossibilità di ripristinare il senso del sacro e il timor panico di quella esperienza del divino ( è
vero altresì che permane una flebile continuità che ci consente di dire almeno questo). E’ in tal senso
allora che, come spiega Sini, i significati si decentrano e precipitano. Ma che succede quando antichi
abiti e orizzonti di esperienza non fanno più catena, ovvero non danno più segni per interpretanti
futuri? La risposta, date le premesse, non può che essere la “catastrofe” del significato e il suo cadere
nel nulla.
Le interpretazioni, si è anche detto, fanno catena. Questa catena è come un intreccio
multiverso di innumerevoli fili. Ogni filo incarna il perdurare di un’attesa e di una risposta.
Se supponiamo che questi fili si distinguano per il diverso colore, accade allora, nella
continuità della catena interpretante, che le proporzioni cromatiche mutino nei loro
rapporti quantitativi. Il colore della Dea Levana [la dea che assisteva le partorienti], che un
tempo infiammava di sé tutta la catena, ora è ridotto a qualche filo impercettibile
nell’insieme. O forse, certi fili scompaiono del tutto; le risposte che essi incarnano non
torneranno più: la loro attesa cade nel nulla. Dopo essersi sempre più decentrata dal luogo
della presenza verso lo sfondo, alla fine la stessa attesa è caduta oltre l’orlo, nell’oblio[…]
Dice Whitehead: ciò che è accaduto, è accaduto per sempre. Ebbene, non è vero. Gli
interpretanti finiscono (muoiono). Un evento può mantenere la sua “efficacia”, ovvero la
sua “presenza” (sia pure relativa), sino a che si dirige a un Interpretante futuro (come
direbbe Peirce); cioè sino a che esso è preso nella kìnesis “retrograda” dell’interpretazione
che, raccogliendolo e interpretandolo, apre l’orlo del futuro dell’interpretazione. In altri
termini: l’evento permane sino a che esso giace entro la catena degli Interpretanti cui
appartiene, e questa si dilata prolungandosi[…] Sorge allora un’inquietante domanda: qual
è la “realtà” di ciò che non ha più Interpretanti avanti a sé? A questo punto non basta dire
che “non ha più realtà”. Ciò che si deve dire è altro. Questo altro suona così: esso
propriamente non è mai accaduto. Non è accaduto nulla. Questa conclusione ripugna al
senso comune. Tuttavia essa è inevitabile, salvo ammettere un tempo cosmico lineare
come luogo di tutti gli eventi e un Interpretante finale assoluto come meta prefissata del
cammino di tutte le catene di Interpretanti. In questo Interpretante assoluto si
raccoglierebbe la totalizzazione cosmica universale. Tutti gli eventi troverebbero in questo
Interpretante finale la loro ultima interpretazione e il loro senso definitivo, cioè la loro
conservazione sempiterna. In forza di queste considerazioni si rivela allora il senso profondo
dell’annuncio di Nietzsche relativo alla “morte di Dio”, come evento che inavvertitamente
(ma sempre meno inavvertitamente) si viene dispiegando. Esso apre l’età del nichilismo
nella quale viviamo[…] Dicono gli scienziati che tra qualche miliardo di anni l’equilibrio
gravitazionale che regge il sistema solare collasserà. Anche la terra allora, insieme
all’intero sistema, scomparirà. Di quel punto infinitesimale dell’universo che noi chiamiamo
la terra non ne sarà più nulla; la terra non ci srà mai (più) stata. Rispetto a chi o a che,
infatti, “ci sarà stata” la terra, la sua vita, la sua “belle d’erbe famiglia e d’animali”, e i
suoi “animali intelligenti”, come disse ancora Nietzsche? In quale serie del tempo cosmico,
calcolato da dove e da chi, in quale catena di Interpretanti essa potrebbe conservare il suo
“esserci stata”? Ma “di fatto” ci sarà stata, si potrebbe obiettare. Di fatto? Che fatto è mai
un fatto che non ha luogo? Questo fatto, che noi diciamo, sarà letteralmente un nulla
“affatto”: la terra non c’è stata affatto: essa non è mai accaduta.
C.Sini, Kìnesis
32
Nulla accade
Le frasi precedenti potrebbero suggerire l’impressione che l’ultimo approdo della filosofia siniana
dell’esperienza non sia che un nichilismo esasperato, per il quale “nulla vale la pena”. Ma per Sini non
è affatto così. Nichilistico non è l’atteggiamento di chi riconosce la costitutiva finitezza dell’esperienza
umana, il suo “errare”, e la conseguente infondatezza del progetto di ridurre le multiformi possibilità
dell’umano al modello unificato dell’umanità occidentale, ma proprio e precisamente quel pensiero
tecnico-scientifico, che nel mirare alla dominazione planetaria, perde il senso del suo stesso fare
riproducendosi senza un perché. Riconoscere che la nostra esperienza è orlata di nulla, può semmai
aiutarci a comprendere il limite delle nostre possibilità senza inseguire l’antico sogno platonico della
verità assoluta e dell’immortalità:
Quando qui si afferma che “accadere qualcosa” è lo stesso di “accadere nulla” non si
intende sostenere che tutti ciò che accade è “nulla”, “polvere e cenere”, che “nulla vale la
pena” poiché tutto, prima o poi, finirà e anzi non avrà mai avuto luogo. Si intende proprio
dire che il qualcosa che accade è in se stesso, proprio nella sua raltà “attuale”, accadere di
nulla[…]
Come rampollo della ratio, anche il senso comune aborre dal nulla, e noi ora sappiamo
perché esso aborre anche dagli enigmi del linguaggio e dalla crudele vivisezione filosofica
delle parole. Il senso comune non vuole vedere il nulla che si cela nel fondo del parlare
comune, e di ogni evento: del fiorire come del fulminare, dell’amare come dell’odiare. Non
lo vuol vedere perché pensa il nulla come l’assolutamente altro del qualcosa (lo pensa cioè
“metafisicamente”); in termini psicologici lo pensa come l’insensato, il misterioso, il
terrificante: emblema di morte, teschio e tibie incrociate (“Fratello ricordati che dobbiamo
morire”). Nella sua immaginazione, il comparire del nulla dietro il qualcosa rende ogni cosa
equivalente: il bello come il brutto, il bene come il male. In questo suo errore, il senso
comune non può accorgersi che il nulla e la ricchezza multiversa della vita sono “lo stesso”.
Come un “fanciullino”, il senso comune ha paura del nulla. Raccontandogli la favola
dell’aldilà, Socrate non lo liberò dalla paura; anzi, lo ribadì nell’errore. E del resto,
istituendo l’anima nel cuore della ratio occidentale, Socrate favorì la nascita di un’umanità
impegnata a combattere con tutti i mezzi la morte. Quale sia il destino veritativo di questa
umanità, che sta diventando planetaria”, non è possibile dire. Ma il suo rischio estremo e
connaturato è certamente quello di perdere la vita. Questo rischio viene rimosso e non più
visto proprio dalla lotta contro la morte che si configura come eliminazione del nulla. Ma se
il nulla è respinto, la vita non ha “significato”.
C. Sini, Kìnesis
33
La deriva dell’anima
L’epoca nella quale viviamo è certamente l’età della tecnica. I progressi scientifici e tecnologici hanno
dello straordinario e vanno esplicitamente riconosciuti, senza indulgere a mode new age o esoterismi
superficiali. Non è questo infatti il senso del discorso siniano sulla scienza. Il problema consiste
piuttosto in quell’interrogativo, di matrice heideggeriana, tematizzato da Adorno e Horkheimer nella
Dialettica dell’Illuminismo, che potremmo così formulare: perché la dominazione tecnica
dell’esistente coincide con il nichilismo dispiegato? Per quali ragioni l’età più prossima all’ideale
baconiano del regnum hominis è accompagnato dal più basso rispetto dell’uomo, della natura, della
vita, che forse l’umanità ricordi? Sono certo temi vasti e complessi, che qui non si possono che sfiorare.
C’è tuttavia un’ispirata pagina di Sini, con la quale concludiamo e che ci riporta al senso delle
considerazioni di sapore husserliano riferite nel primo brano di questa presentazione. Esse esprimono
con grande efficacia il vuoto di senso della tecnica quando, non più sensibile alle interrogazioni
filosofiche o non disposta ad interrogarsi filosoficamente su se stessa, procede riproducendosi
all’infinito. Infatti, come direbbe Nietzsche, “manca una risposta al…perché?”
A che serve una stazione radiotelevisiva? Mira a riprodurre se stessa. Il suo scopo è di poter
funzionare ininterrottamente per 16 o 24 ore al giorno. Questa è la sua “logica” intrinseca
(in sé e per sé). A questo scopo essa organizza, pianifica e strumentalizza una quantità
imponente di attività: bisogna produrre telefilm, telequiz, teleromanzi, telegiornali,
teledibattiti, teleinterviste, ecc.; e, come radio, radiosceneggiati, radiorubriche,
radiogiornali, radiobollettini, ecc. Un piccolo esercito di persone è messo all’opera. La
produzione assume l’aspetto della “serie”, a sua volta sorretta dalla struttura dell’ ”e
poi…e poi”, cioè dalla successione insignificante delle semplici presenze (anche la
radiotelevisione ha un’anima temporale – il che è una tautologia – ) caratterizzata dalla
“rotazione dell’uso”. Non è pensabile che l’annunciatrice, essa pure programmata come
appendice tecnica del “mezzo” televisivo, corpo esterno – “gradevole” – della sua voce
impersonale, geroglifico “estetico”, possa annunciare: - Ora avremmo voluto trasmettervi
un teledibattito, ma poiché non abbiamo nulla di importante da dire, la nostra stazione
tacerà per due ore. Il “mezzo” non è al servizio di cose che mette conto dire o vedere,
quando e se esse vi siano; al contrario, si dice e si fa vedere in funzione del “mezzo”, il
quale esige una cosa sola: funzionare, essere in funzione.
Da ciò derivano conseguenze ben note. Tra esse l’invenzione di “interessi”: idiozie musicali
motivano “classifiche di gradimento”. Poi la creazione di “pseudovalori”: film imbecilli
occasionano sproloqui di “esperti” (a loro volta uomini di “pseudocultura”) che ne trattano
come di “opere d’arte”, “documenti sociali e di costume” e così via. Altra conseguenza è la
creazione di uno stuolo di “specialisti”, che vanno dal cretino che urla per annunciare il
titolo (inglese)di dischetti pseudopopolari, incisi da altri cretini pseudomusicisti,
sfumandone di continuo l’ascolto per aggiungere altre urla entusiastico-demenziali al
“critico”, al “regista”, al “professore universitario” ecc., impegnati in discorsi pseudoseri
(tre minuti per spiegare al pubblico che cos’è la psicanalisi). Queste attività producono
funzioni vacue: annunciare il programma, introdurre l’ascolto di una sinfonia di Mozart
premettendo poche parole informative (la mentalità storico-critica regna sovrana, ridotta
naturalmente a scopiazzatura minimale dei vari “dizionari”, e tutto è “storico”, anche il
quiz dell’altroieri); e poi: spiegare perché c’è il sole e invece domani pioverà, riassumere il
dibattito parlamentare (“E’ tutto da Montecitorio”), intervistare il “personaggio”ecc.
Queste funzioni non esigono in genere alcuna seria preparazione o specifici talenti: son
buoni tutti (sebbene chi le incarni possa aspettarsene una vasta “popolarità”: diviene egli
stesso un “personaggio”, chissà perché “autorevole”)[…]
34
Di qui la prassi inevitabile del “raccomandato”: non si può selezionare il nulla. Gli individui
che scelgono e programmano (i “dirigenti”) sono investiti del potere tecnologico del mezzo.
Essi stessi, però, sono interscambiabili e indifferenti, cioè scelti per raccomandazione.
Il mezzo programma e produce anche i suoi utenti, assimilandone le funzioni vitali e di
relazione: mangiare davanti il televisore; andare a dormire quando i programmi sono
terminati[…]Questi schiavi del mezzo, in quanto “assimilati”, svolgono con gioioso scrupolo
la loro funzione: palpitano ansiosi perché il concorrente sembra non conoscere la risposta
all’indovinello e incrementano l’ipercritica del vuoto, parteggiando per questo o per quello
e ritenendo di avere “gusti” e “gradimenti” personali, meritevoli di discussione. A essi il
mezzo fornisce la “realtà vera”, cioè analizzata e scomposta: l’uomo che cade dalla
finestra ripreso al rallentatore; il tempo come successione di “attimi” ,di “ora”. Il mezzo è
onnipotente, più onnipotente del buon Dio, poiché sa fare ciò che anche al buon Dio è
negato: far scorrere il tempo all’indietro: l’omino torna sul tetto e riprecipita giù a
piacere. L’omino e i presenti hanno vissuto una realtà illusoria; la realtà vera la vede il
telespettatore D’ora in avanti è meglio che non si muova di casa, se vuole davvero vivere e
conoscere i fatti. Reazione ormai abituale: la gente dice che è successo qualcosa di grosso:
apri subito il televisore! La rivoluzione vissuta in tinello. Una stazione radiotelevisiva è un
microcosmo tecnologico, uno spazio di rinvio che assegna i ruoli degli Interpretanti in
funzione di determinate Qualità materiali, le quali stanno al posto dell’Oggetto. Ma
l’Ogggetto non è, come si crede, o non ha, il fine di produrre svago, informazione, cultura
ecc. (questi sono “esiti collaterali”); l’Oggetto non è altro che la legge
dell’autoconservazione progressiva ed evolutiva del mezzo: programmare i programma;
produrre il prodotto; utilizzare gli utenti (e riprodurli in una circolazione infinita). Si ritiene
che tutto ciò obbedisca a “interessi” di natura economica (e infine ideologico-politica). Essi
certo non mancano, ma incarnano, a ben vedere, quel poco di “esterno” che ancora sfugge
alla logica intrinseca del mezzo. Del resto tali “interessi” sono poi tecnologicamente
programmati altrove, in altri micro e macrocosmi tecnologici. Assumere la prospettiva del
“potere” economico- politico e della sua “volontà” significa infatti ricadere nell’illusione
antropologico-strumentale circa l’essenza della tecnica.
“L’ideologia scientifico-tecnologica è fondamentalmente irrazionalistica, ma
opera in maniera terroristica[…] Tutti gli argomenti che non assumono
preventivamente i parametri e i criteri di verità tecnologici (cioè della ratio)
sono terroristicamente definiti irrazionalistici[…] La creazione della pubblica
opinione artefatta e programmata è la strategia dell’anima portata alle sue
ultime conseguenze. L’in-formazione delle anime (delle “volontà”) è l’essenza
della tecnica contemporanea[…]
La tecnica moderna è la versione moderna dell’unica vera religione. L’unica
vera religione, l’unica vera tecnica e l’unico vero metodo sono tre momenti di
un unico progetto di produzione e domesticazione delle anime. La tecnica
ripudia ogni altro modo di essere uomini e di operare nel mondo che non sia
“simile a sé”. Essa si attribuisce l’unica efficacia che metta conto perseguire e
la impone mediante il dominio terroristico dell’informazione. Il mondo della
tecnica moderna è il mondo del “terrore pedagogico”.
C.Sini, Passare il segno
35
Nota bio-bibliografica
Carlo Sini , nato a Bologna nel 1933, insegna Filosofia teoretica all’Università degli studi di Milano.
Direttore della rivista di filosofia e cultura “L’uomo, un segno” e di varie collane di filosofia, è
Accademico dei Licei e membro dell’ Institut international de Philosophie. Apprezzato conferenziere,
ha tenuto seminari negli Stati Uniti, in Canada, in America latina e in diversi paesi europei.
Tra le sue opere ricordiamo:
Il pragmatismo americano, Laterza 1972
Passare il segno. Semiotica, cosmologia e tecnica, Il Saggiatore 1981
Kinesis. Saggio di interpretazione, Spirali 1982
Il silenzio e la parola, Marietti 1989
I segni dell’anima, Laterza 1989
Immagini di verità, Spirali 1990
Semiotica e filosofia, Il Mulino 1990
Il simbolo e l’uomo, Egea 1991
Etica della scrittura, Il Saggiatore 1992
Scrivere il silenzio, Egea 1995
Gli abiti, le pratiche, i saperi, Jaca Book 1996
Teoria e pratica del foglio-mondo, Jaca Book 1998
Idoli della conoscenza, Cortina 2000
La scrittura e il debito, Jaca Book 2002
Il comico e la vita, Jaca Book 2003
L’analogia della parola. Filosofia e metafisica, Jaca Book 2004
La mente e il corpo. Filosofia e psicologia, Jaca Book 2004
L’origine del significato, Jaca Book 2004
La virtù politica. Filosofia e antropologia, Jaca Book 2005
Raccontare il mondo. Filosofia e cosmologia, Jaca Book 2005
Le arti dinamiche. Filosofia e pedagogia, Jaca Book 2005
Il segreto di Alice e altri saggi, Albo Versorio 2006
36
37