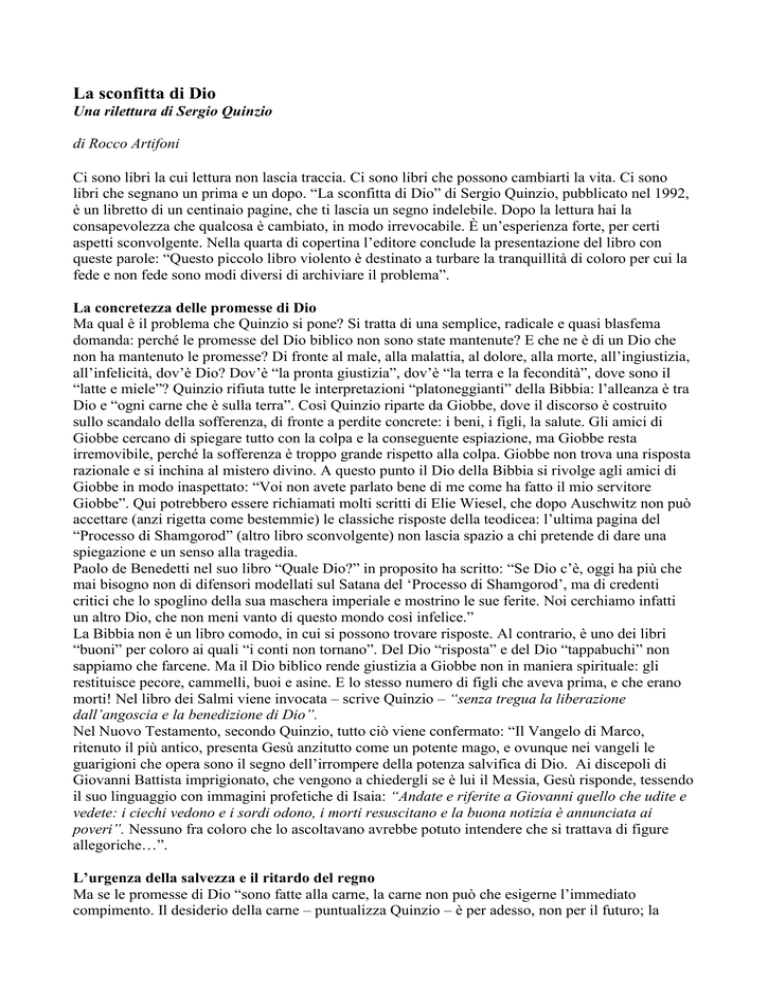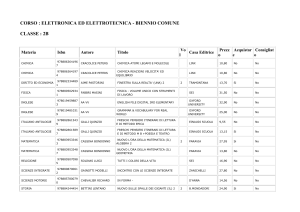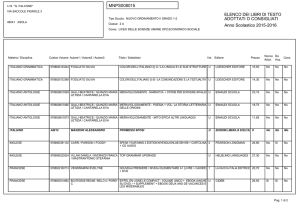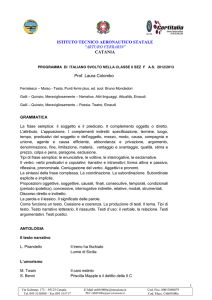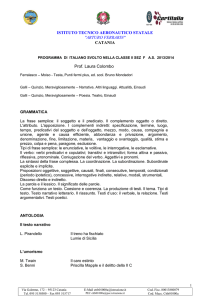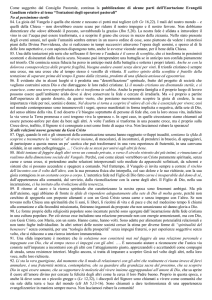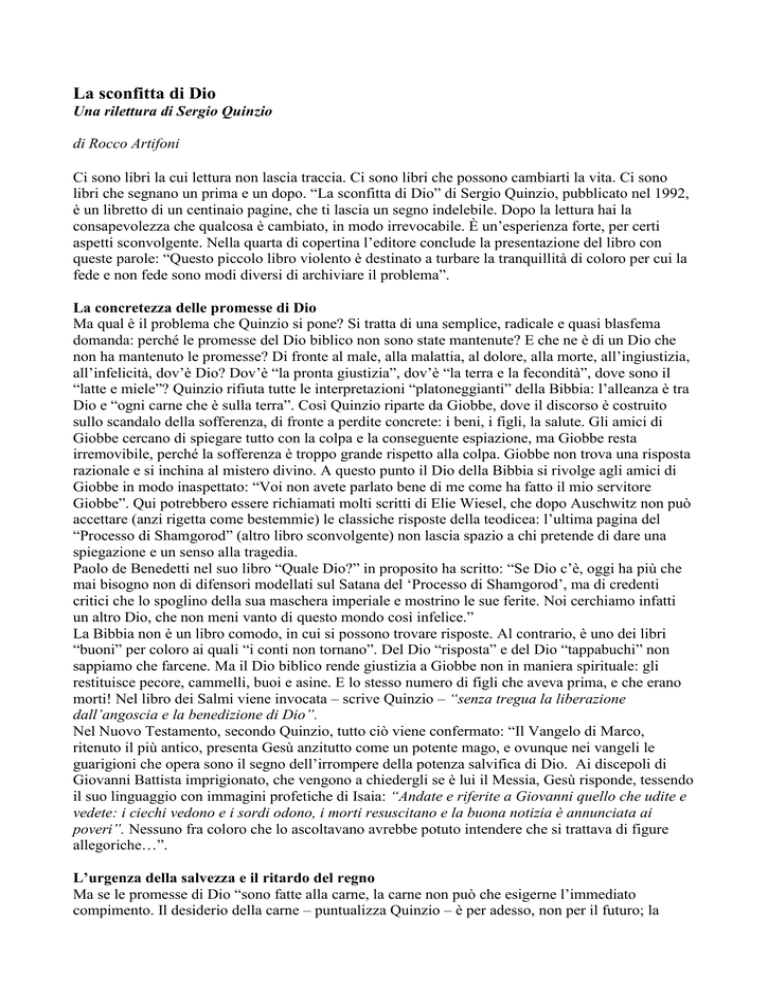
La sconfitta di Dio
Una rilettura di Sergio Quinzio
di Rocco Artifoni
Ci sono libri la cui lettura non lascia traccia. Ci sono libri che possono cambiarti la vita. Ci sono
libri che segnano un prima e un dopo. “La sconfitta di Dio” di Sergio Quinzio, pubblicato nel 1992,
è un libretto di un centinaio pagine, che ti lascia un segno indelebile. Dopo la lettura hai la
consapevolezza che qualcosa è cambiato, in modo irrevocabile. È un’esperienza forte, per certi
aspetti sconvolgente. Nella quarta di copertina l’editore conclude la presentazione del libro con
queste parole: “Questo piccolo libro violento è destinato a turbare la tranquillità di coloro per cui la
fede e non fede sono modi diversi di archiviare il problema”.
La concretezza delle promesse di Dio
Ma qual è il problema che Quinzio si pone? Si tratta di una semplice, radicale e quasi blasfema
domanda: perché le promesse del Dio biblico non sono state mantenute? E che ne è di un Dio che
non ha mantenuto le promesse? Di fronte al male, alla malattia, al dolore, alla morte, all’ingiustizia,
all’infelicità, dov’è Dio? Dov’è “la pronta giustizia”, dov’è “la terra e la fecondità”, dove sono il
“latte e miele”? Quinzio rifiuta tutte le interpretazioni “platoneggianti” della Bibbia: l’alleanza è tra
Dio e “ogni carne che è sulla terra”. Così Quinzio riparte da Giobbe, dove il discorso è costruito
sullo scandalo della sofferenza, di fronte a perdite concrete: i beni, i figli, la salute. Gli amici di
Giobbe cercano di spiegare tutto con la colpa e la conseguente espiazione, ma Giobbe resta
irremovibile, perché la sofferenza è troppo grande rispetto alla colpa. Giobbe non trova una risposta
razionale e si inchina al mistero divino. A questo punto il Dio della Bibbia si rivolge agli amici di
Giobbe in modo inaspettato: “Voi non avete parlato bene di me come ha fatto il mio servitore
Giobbe”. Qui potrebbero essere richiamati molti scritti di Elie Wiesel, che dopo Auschwitz non può
accettare (anzi rigetta come bestemmie) le classiche risposte della teodicea: l’ultima pagina del
“Processo di Shamgorod” (altro libro sconvolgente) non lascia spazio a chi pretende di dare una
spiegazione e un senso alla tragedia.
Paolo de Benedetti nel suo libro “Quale Dio?” in proposito ha scritto: “Se Dio c’è, oggi ha più che
mai bisogno non di difensori modellati sul Satana del ‘Processo di Shamgorod’, ma di credenti
critici che lo spoglino della sua maschera imperiale e mostrino le sue ferite. Noi cerchiamo infatti
un altro Dio, che non meni vanto di questo mondo così infelice.”
La Bibbia non è un libro comodo, in cui si possono trovare risposte. Al contrario, è uno dei libri
“buoni” per coloro ai quali “i conti non tornano”. Del Dio “risposta” e del Dio “tappabuchi” non
sappiamo che farcene. Ma il Dio biblico rende giustizia a Giobbe non in maniera spirituale: gli
restituisce pecore, cammelli, buoi e asine. E lo stesso numero di figli che aveva prima, e che erano
morti! Nel libro dei Salmi viene invocata – scrive Quinzio – “senza tregua la liberazione
dall’angoscia e la benedizione di Dio”.
Nel Nuovo Testamento, secondo Quinzio, tutto ciò viene confermato: “Il Vangelo di Marco,
ritenuto il più antico, presenta Gesù anzitutto come un potente mago, e ovunque nei vangeli le
guarigioni che opera sono il segno dell’irrompere della potenza salvifica di Dio. Ai discepoli di
Giovanni Battista imprigionato, che vengono a chiedergli se è lui il Messia, Gesù risponde, tessendo
il suo linguaggio con immagini profetiche di Isaia: “Andate e riferite a Giovanni quello che udite e
vedete: i ciechi vedono e i sordi odono, i morti resuscitano e la buona notizia è annunciata ai
poveri”. Nessuno fra coloro che lo ascoltavano avrebbe potuto intendere che si trattava di figure
allegoriche…”.
L’urgenza della salvezza e il ritardo del regno
Ma se le promesse di Dio “sono fatte alla carne, la carne non può che esigerne l’immediato
compimento. Il desiderio della carne – puntualizza Quinzio – è per adesso, non per il futuro; la
carne è mortale e non può attendere. La salvezza non può essere che per subito. L’urgenza della
salvezza è un motivo che ritorna spesso nella Bibbia ebraica, soprattutto nei Salmi. Ma nel nuovo
Testamento incalza ancora più violentemente, sebbene risulti invisibile ai teologi, non potendo
trovare posto nei loro trattati”.
Tra i tanti passi evangelici basti ricordare che, al momento della morte di Gesù sulla croce, “la
terra tremò, le rocce si spaccarono, le tombe si aprirono e numerosi corpi di santi trapassati
risuscitarono: uscirono dalle tombe dopo la resurrezione, entrarono nella città santa e furono visti
da parecchia gente”.
Quinzio sottolinea lo sconcerto in cui le prime comunità cristiane si sono trovate dopo la morte dei
primi credenti. Non essendoci più traccia evidente della resurrezione dei corpi, la chiesa delle
origini va in crisi proprio perché il regno tarda a venire.
Eppure, “ovunque nel nuovo testamento è ripetuto che siamo giunti all’ultima ora della storia del
mondo. Giacomo annuncia ai ricchi che sta per abbattersi su di loro il castigo: “Piangete, urlate
sulle sciagure che stanno per colpirvi. La vostra ricchezza è imputridita, le vostre vesti sono
divorate dalle trame. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, e la loro
ruggine testimonierà contro di voi e divorerà le vostre carni come il fuoco. Avete accumulato tesori
per l’ultimo giorno! Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre
terre grida; e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Avete
gozzovigliato sulla terra e vi siete saziati di piaceri, vi siete ingrassati per il giorno della strage.
Avete condannato e ucciso il giusto: egli non vi resiste. Siate dunque pazienti, fratelli, (…) la
venuta del Signore è prossima, il giudice è alle porte.”
Dopo duemila anni – secondo Quinzio – è evidente che “le promesse non sono state mantenute, che
i miti non hanno mai posseduto la terra, che Dio non ha reso ai suoi fedeli pronta giustizia, come
Gesù invece ci assicurava dopo aver raccontato la parabola del giudice iniquo”. Dinanzi a questo
fatto non è possibile “chiudere gli occhi e far finta di niente”, né usare la scappatoia per la quale il
regno tarda a venire a causa della scarsa fede degli uomini: “vogliamo continuare per altri millenni
a giocare al gioco di Dio che non ci aiuta perché non lo meritiamo? (…) Egli – conclude Quinzio –
dovrà venire, se verrà, malgrado la nostra mancanza di fede. E non sarà tutta colpa degli uomini se
la fede sarà andata perduta. Noi siamo qui soltanto perché siamo i figli di questo immane,
insostenibile ritardo”.
Il Dio che si contrae e che muore
Nella tradizione ebraica della Kabbalah “la creazione del mondo è resa possibile dal contrarsi di
Dio”. Dopo aver creato il mondo, Dio è cambiato, proprio perché ha lasciato spazio al mondo: “la
creazione, in quanto altro da Dio, comporta dunque almeno la possibilità di opporsi alla volontà di
Dio, la possibilità della colpa e della morte”. Di conseguenza “la giustizia di Dio è incompatibile, in
realtà, con l’esistenza degli uomini e del mondo. A rigore, Dio, essendo giusto, dovrebbe impedire
l’ingiustizia, annientare coloro che compiono il male”. Ma come è scritto nel libro dell’Esodo, di
fronte alle colpe degli ebrei usciti dall’Egitto, Dio dice: “Se vi accompagnassi, non fosse che per un
momento, vi sterminerei”. Soprattutto dopo Auschwitz, come ha razionalmente argomentato Hans
Jonas, non si può più credere ad un Dio onnipotente, pronto ad intervenire nella storia per salvare il
suo popolo o chi soffre.
Papa Benedetto XVI nella recente visita al lager di Auschwitz-Birkenau ha detto: “Quante domande
ci si impongono in questo luogo! Sempre di nuovo emerge la domanda: Dove era Dio in quei
giorni? Perché Egli ha taciuto? Come poté tollerare questo eccesso di distruzione, questo trionfo del
male? Ci vengono in mente le parole del Salmo 44, il lamento dell'Israele sofferente: “Tu ci hai
abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose… Per te siamo messi a morte,
stimati come pecore da macello. Svégliati, perché dormi, Signore? Déstati, non ci respingere per
sempre! Perché nascondi il tuo volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione? Poiché siamo
prostrati nella polvere, il nostro corpo è steso a terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto; salvaci per la tua
misericordia!”. (…) In definitiva, dobbiamo rimanere con l'umile ma insistente grido verso Dio:
Svégliati! Non dimenticare la tua creatura, l'uomo!”.
Nella teologia ebraica contemporanea sempre di più viene sottolineata la finitezza, l’impotenza, la
sofferenza di Dio. Nel racconto “La notte”, in cui Elie Wiesel testimonia la Shoah, di fronte al
bambino impiccato sulla forca di Auschwitz e che agonizzò a lungo prima di morire, sentì la
domanda umana “Dov’è il buon Dio?” e una voce che rispondeva: “Eccolo: è appeso lì, a quella
forca…”.
Il tema della “morte di Dio”, che ha avuto come “profeta” Friedrich Nietzsche, è stato talvolta
frainteso. Pochi hanno considerato la componente “religiosa” della prospettiva di Nietzsche, quando
afferma che “è nel cristianesimo che abbiamo le nostre radici, perché i nostri antenati furono
cristiani, di un’onesta assoluta”. Infatti, è l’ultimo papa (ultimo perché “Dio è morto”) che dice a
Zarathustra: “sei più devoto di quanto tu non creda, con questa tua miscredenza!”. Per Nietzsche la
religione viene rovesciata dall’interno, per “religiosità”, cioè portando alle estreme conseguenze le
sue premesse, scoprendone così l’auto-contradditorietà. “Anche noi, uomini della conoscenza di
oggi, continuiamo – scrive Nietzsche – a prendere anche il nostro fuoco dall’incendio che una fede
millenaria ha acceso”.
Questa “tensione” religiosa si può trovare, seppure espressa in altri termini, anche in Ernst Bloch.
Il fallimento del Dio crocifisso
Per Quinzio non è possibile leggere la storia dell’umanità e del mondo come il dispiegarsi di una
divina provvidenza. “La Bibbia, se la leggiamo senza lasciarci troppo ingannare dal nostro antico
postulato metafisico o dal nostro moderno postulato evoluzionista, colpisce anzitutto come la
registrazione di vicende fallimentari. Fallimentari per gli uomini, ma fallimentari anzitutto per Dio”.
Quinzio ripropone alcuni passi della Lettera ai Filippesi: “Essendo in forma di Dio, non tenne lo
stato d’uguaglianza con Dio come una preda, ma si svuotò di se stesso assumendo la forma di uno
schiavo, diventando simile agli uomini; ed essendo stato trovato come un uomo per il suo aspetto,
si umiliò obbediente fino alla morte, e a una morte sulla croce”.
Ma per Quinzio, evidentemente, questo non significa negare l’esistenza di Dio: sarebbe una risposta
troppo facile e comunque un’ipotesi “non più facilmente sostenibile di quella contraria”. D’altra
parte se “gli sconfitti sono dalla parte di Dio, la parte di Dio è la sconfitta. Dinanzi all’infelicità dei
poveri, dei cuori spezzati, viene meno, in Dio, la stessa giustizia, e avanza in suo luogo la
misericordia”. Di conseguenza “Dio si accontenta dell’uomo così com’è, che non può non
commettere il male, e promette di dargli per pietà quello che non potrebbe conseguire secondo
giustizia”.
Questa interpretazione della misericordia divina si collega per Quinzio al mistero dell’incarnazione
che “significa certamente un ‘abbassamento’ di Dio. Incarnandosi, Dio perde in Gesù la stessa
coscienza di essere Dio. Un evento, questo, non pensato mai fino in fondo…”.
Come per la creazione anche nell’incarnazione Dio cambia. Hans Jonas parla di un Dio
“diveniente”.
“Non essendo venute – conclude Quinzio – la giustizia e la pace del regno di Dio, l’annuncio
cristiano è diventato, almeno a cominciare da Paolo, l’annuncio della ‘morte di Dio’. (…) La storia
del mondo ha finito con il sancire quella morte: il grido di Nietzsche è sembrato nuovo, ma non era
che un’eco del grido di Cristo”.
Nella lettera ai Corinti è scritto che “ciò che è follia di Dio è più sapiente degli uomini” e “ciò che
è debolezza di Dio è più forte degli uomini”.
Per Quinzio significa che “alla croce è stato appeso e sulla croce è morto Dio, e si può solo sperare
che la morte di Dio sia più sapiente e più forte della vita degli uomini”.
Di fronte al grido di Gesù morente: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”, non sono
più possibili “interpretazioni elusive”. Gesù ha conosciuto le angosce della morte e – aggiunge
Quinzio – “la ‘discesa agli inferi’, che è stata sempre rappresentata tradizionalmente come una
trionfale vittoria, prima di essere del tutto dimenticata, appare l’esito dello sprofondamento e
dell’annichilimento di Dio crocefisso”.
La speranza dopo la croce
Dio è morto, ma la fede crede nella resurrezione dei morti. Paolo nella Lettera ai Corinzi spiega:
“Se non c’è resurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato,
allora il nostro annuncio è vano, vana anche la nostra fede.”
Per Quinzio, però, “Gesù risorto è irriconoscibile, o almeno non è riconosciuto (…). Il cadavere
rianimato che esce dalla tomba – e questo, per quanto si cerchi di non leggere quello che c’è scritto,
dicono le Scritture – ha sentore di morte, come nell’episodio di Lazzaro. La gioia della resurrezione
conserva una macchia cadaverica. Il Cristo risorto è rappresentato vincitore, ma il suo trionfo non
ha mai cancellato, nel cuore dei fedeli, l’immagine del Crocifisso”.
L’uomo “folle” che annuncia – per Nietzsche - la “morte di Dio” grida e domanda: “Dello strepito
che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo nulla? Non fiutiamo ancora il lezzo
della divina putrefazione? Anche gli dei si decompongono! Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo
abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e
di più possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri coltelli; chi detergerà
da noi questo sangue? Con quale acqua potremo noi lavarci? Quali riti espiatori, quali giochi sacri
dovremo noi inventare? Non è troppo grande per noi, la grandezza di questa azione?”.
Secondo Quinzio il tragico percorso e la memoria dell’epilogo di Gesù, restano orribili. Come è
scritto in Isaia solo Dio stesso potrà asciugare “le lacrime degli strappati all’abisso della morte e
degli inferi”. “Ma – per Quinzio – da ogni parte gli occhi della fede devono ormai veder irrompere
la sconfitta di Dio”.
Già le prime comunità cristiane, di fronte alla mancata resurrezione dei martiri, furono costrette a
parlare di “ciò che manca ai patimenti di Cristo” perché il tempo fosse compiuto. Secondo Quinzio
“lo scacco del crocifisso Dio di tenerezza e di pietà è in ciò palese”, perché “a coloro che
conservano la fede a prezzo del martirio – perché la fede implica comunque, nella sequela di Cristo,
un non metaforico martirio – è promessa una salvezza solo al di là della morte”.
Nietzsche, d’altra parte, non si limita ad annunciare la “morte di Dio”, ma aggiunge che “stando alla
natura degli uomini, ci saranno forse ancora per millenni caverne nelle quali si additerà la sua
ombra”. Dio comunque non può morire in tre giorni.
Ma c’è un altro scacco che “patirà Dio se non tutti saranno salvati”. Perché “se ci fosse anche un
solo dannato, si dovrebbe negare l’intenzione salvifica di Dio, o si dovrebbe inevitabilmente
concludere che tale intenzione, fondamentale per la comprensione del Dio che si rivela agli uomini
come salvatore, non viene realizzata, fallisce. Qui il fallimento di Dio non si verificherebbe soltanto
nella storia, ma anche nell’eternità. Se c’è l’inferno, allora Dio non può salvare le sue creature: la
centesima pecora, per la quale il pastore è disposto ad abbandonare nel deserto le altre novantanove,
e a dare la propria vita, non si può salvare.”
Dinanzi a questa serie di sconfitte di Dio, Quinzio non ne deduce “il rimedio facile e a portata di
mano” che da secoli avanza nel mondo, cioè il “non pensare più a Dio”. Per Quinzio “il Dio delle
sconfitte può servirci, perché è il nostro modello, l’unico modello di cui possiamo ancora sperare di
disporre”.
L’abisso della vita e la fedeltà a Dio
In Quinzio si profila una visione tragica del vivere: “L’esperienza dell’incombere del rischio
supremo che Dio non salvi, e che sia quindi definitivamente sconfitto, era già contenuta
nell’esperienza dell’ebreo biblico, perché affidarsi ad una promessa di salvezza significa sospendere
la propria vita su un abisso.”
Qui, paradossalmente, è evidente la vicinanza a Nietzsche, che sempre si pone davanti alla tragicità
del vivere: “Nell’occhio tuo guardai, or non è molto, o vita! E mi parve di sprofondare nell’abisso”,
dice Zarathustra.
Ma per Quinzio: “Né Giobbe né Qoehlet negano o dubitano che Dio esista – una via comoda e
presuntuosa, e in definitiva insignificante –, ma sono molto vicini a disperare che Dio salvi.
Qualcosa di molto radicale. (…) Ma la fede, posta ormai in questa definitivamente terribile
condizione, non può durare nella storia. Anche la fede, come Cristo, alla fine muore crocifissa nella
storia del mondo. Eppure, morendo – e facendo in questa morte l’esperienza dell’incombente
sconfitta di Dio –, agonizzando nella consapevolezza del definitivo orrore che la sovrasta, essa fa la
sua invocazione più potente, la più vicina, la più simile a quella di Gesù Cristo”.
È il concetto stesso di Dio che viene rivisto. Paolo de Benedetti dice: “Noi abbiamo bisogno di
cambiere Dio per conservarlo (e perché lui conservi noi)”. Il Dio della Bibbia vive nel tempo. “Dio
è “l’Anziano” dei giorni, – ricorda Quinzio – il tempo che passa incide su di lui i suoi segni. Dio si
modifica, si trasforma, attraverso il suo rapporto con gli uomini, fino a diventare un crocifisso
resuscitato, fino a dover assumere un “nome nuovo”. (…) Prendendo la carne umana di Gesù
Nazareno, Dio non è più identico a ciò che era prima. I tre giorni nel sepolcro non sono una
parentesi che si richiude perché tutto in Dio ritorni com’era prima. Se si pensa questo, non si prende
sul serio la croce”.
Per Quinzio, in conclusione, “mentre Dio è sconfitto (…), noi con la nostra fede saliamo sulla
croce, combattiamo l’ultima lotta, l’agonia, gridiamo: Eli, Eli, lema sabactani? (…) Il nostro
sacrificio infonderà vita, risusciterà Dio. Dio che si è offerto a noi, che aspetta da noi la salvezza, è
un Dio che dovremmo perfettamente amare, ma ci ha reso troppo stanchi, delusi, infelici per poterlo
fare”.
“E allora? – si chiede Paolo de Benedetti – Allora non resta che riaccostarsi allo spirito di
consolazione con cui il secondo Isaia apre il suo cammino di speranza: “Consolate, consolate il mio
popolo”: recita il versetto 40,1 e i maestri dell’ebraismo ci hanno insegnato che esso può anche
essere tradotto: “Consolatemi, consolatemi, popolo mio”. Dio consola l’uomo per le sofferenze,
anche ingiuste, che lo feriscono ogni giorno, per il male, che contro ogni umano e divino volere, lo
tormenta; e l’uomo consola Dio della rovina della sua creazione, del ritardo, dell’impossibilità di
compiersi della sua redenzione”.
Elie Wiesel racconta di un devoto ebreo che ad Auschwitz per protesta contro Dio (che ha
abbandonato il suo popolo) promise di non rispettare il digiuno rituale nel giorno prescritto dalla
tradizione. Ma arrivato quel giorno lo trovarono che digiunava. Interrogato in proposito disse che in
passato aveva sempre digiunato per espiazione e come lode a Dio, ma questa volta stava digiunando
per protesta contro Dio. L’ebreo devoto poteva tollerare il tradimento di Dio, ma non il tradimento
dell’Alleanza. Perciò aveva deciso di rimanere fedele, nonostante Auschwitz, nonostante tutto,
nonostante Dio.