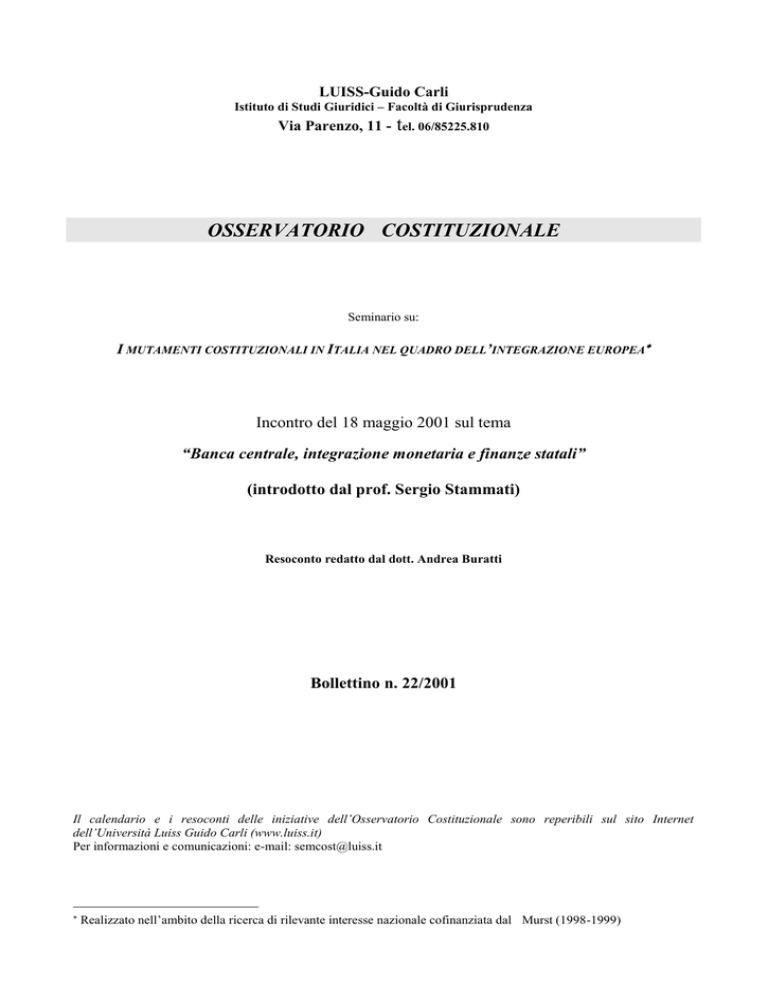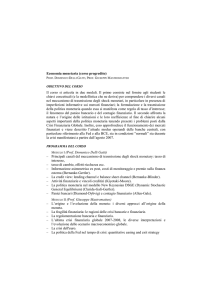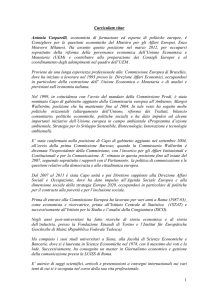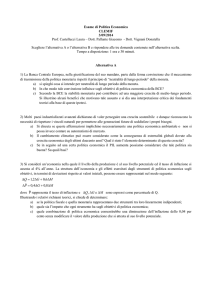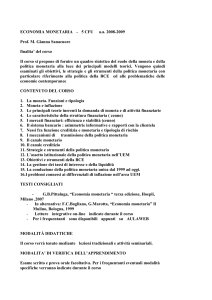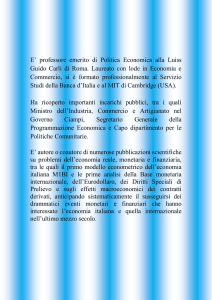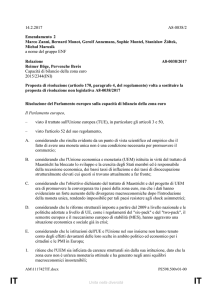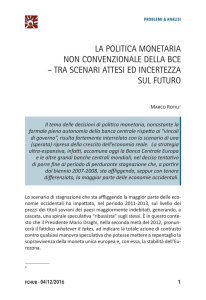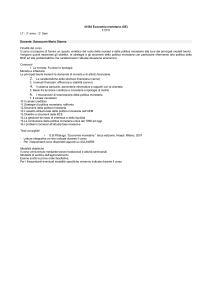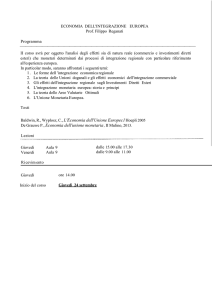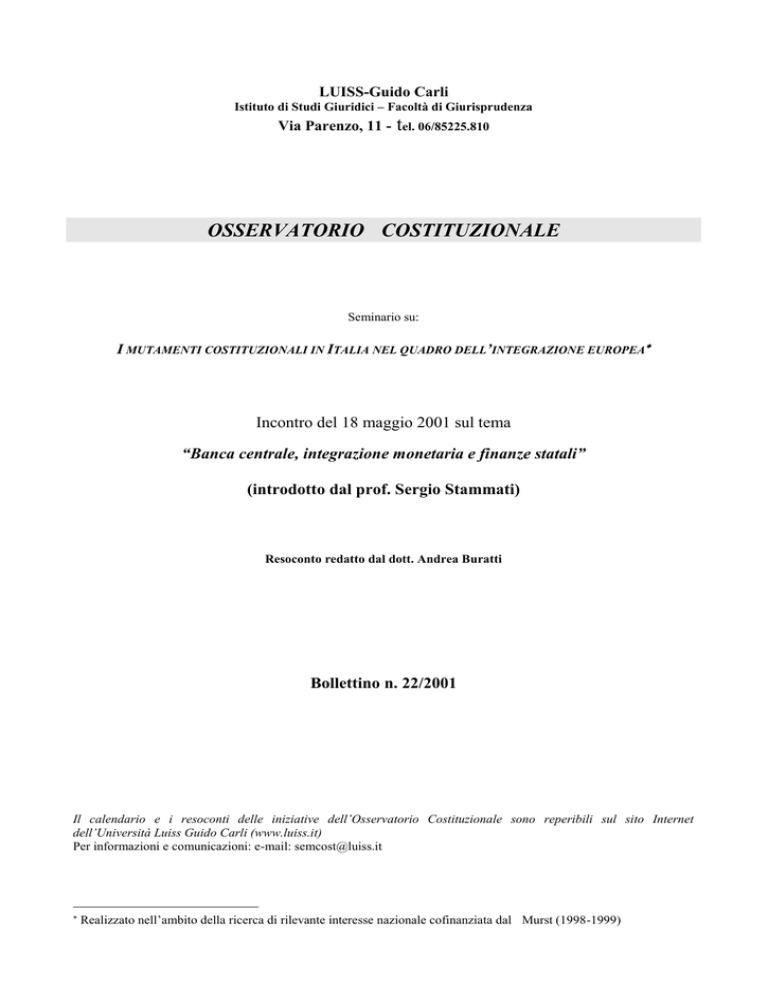
LUISS-Guido Carli
Istituto di Studi Giuridici – Facoltà di Giurisprudenza
Via Parenzo, 11 - tel. 06/85225.810
OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Seminario su:
I MUTAMENTI COSTITUZIONALI IN ITALIA NEL QUADRO DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA
Incontro del 18 maggio 2001 sul tema
“Banca centrale, integrazione monetaria e finanze statali”
(introdotto dal prof. Sergio Stammati)
Resoconto redatto dal dott. Andrea Buratti
Bollettino n. 22/2001
Il calendario e i resoconti delle iniziative dell’Osservatorio Costituzionale sono reperibili sul sito Internet
dell’Università Luiss Guido Carli (www.luiss.it)
Per informazioni e comunicazioni: e-mail: [email protected]
Realizzato nell’ambito della ricerca di rilevante interesse nazionale cofinanziata dal Murst (1998-1999)
Dopo un breve saluto di Sergio PANUNZIO, prende la parola Sergio STAMMATI, il quale tiene subito a far
notare come il tema da introdurre, lo si può constatare dal titolo che vorrebbe circoscriverlo, risulti visibilmente
sovradimensionato, tanto a considerarlo in se stesso, dacché le sue tre articolazioni ben si presterebbero a distinte, e per
niente anguste, esercitazioni analitiche, tanto a considerarlo secondo il metro con cui sono state per lo più ritagliate le
scansioni scientifiche dell’intero seminario. Tale situazione di base, se offre sicuramente splendide giustificazioni ai
presumibili vuoti dell’introduzione, oppone anche all’introduttore particolari difficoltà di accesso al tema, per la
molteplicità delle prospettive secondo le quali il suo compito può essere svolto, tutte alternativamente percorribili. La
scelta sottostante all’introduzione che sarà svolta è quella di considerare l’argomento secondo una prospettiva dinamica
che tenti di coinvolgere l’insieme dei suoi diversi segmenti, anziché dal punto di vista di uno qualsiasi di questi ultimi
(come forse adombrato dal titolo precostituito dell’introduzione), da un punto di vista più ampio donde cercare di
afferrare il farsi contestuale degli aspetti oggettivi e soggettivi dell’integrazione economica e monetaria e del successivo
stabilizzarsi, anch’esso dinamico, dei medesimi, una volta venuti ad esistenza effettiva gli elementi essenziali di quel
complesso farsi. E’ solo da questa prospettiva, per esempio, che si guarderà alla Banca centrale europea e non dalla
prospettiva opposta, la quale, tenuta a porla al suo centro, sarebbe con ciò costretta a misurarsi con i molteplici problemi
strutturali e funzionali che la vedono coinvolta, e riuscirebbe a superarli solo al termine di un troppo lungo tragitto
argomentativo.
Operata questa prima scelta, è proposito dell’introduzione tracciare, nella prima parte, un profilo genetico
dell’Unione economica e monetaria per illustrare l’ispirazione di fondo che sorregge le due dimensioni costitutive
(finanziaria e fiscale) sulle quali essa definisce la propria identità; di esaminare, nella seconda parte, le due disposizioni
del Trattato istitutivo della Comunità europea, ognuna centro di vere e proprie costellazioni normative di diritto
originario e (su varia scala) derivato, le quali rappresentano i perni positivi della costituzione economico–finanziaria
dell’UEM: l’articolo 99 TCE (ex 103) sul coordinamento, nell’ambito del Consiglio europeo, delle politiche
economiche degli Stati membri, vincolati questi ultimi a considerare quelle politiche, “questioni di interesse comune”
(art. 99, comma 1) e l’art. 104 (ex 104 C), la disposizione notissima che fa obbligo agli Stati membri di “evitare
disavanzi pubblici eccessivi” (art. 104, comma 1); infine, ulteriore proposito dell’introduzione è di individuare, in una
terza e conclusiva parte, alcuni degli effetti più significativi che, a causa della disciplina economico–finanziaria della
CE, rimbalzano nel perimetro del diritto pubblico nazionale, direttamente dirompendo il profilo di numerosi istituti
giuridici positivi di carattere finanziario, così come, parallelamente, la configurazione teorica di concettualizzazioni e di
istituti giuridici fra i più astratti e decisivi del diritto pubblico che a quegli istituti sono decisivamente collegati in modo
dipendente. Ma su questo terzo aspetto, per il suo frastagliarsi in una vera e propria rete di incidenze istituzionali,
l’introduzione dovrà limitarsi a svolgere considerazioni sintetiche, rimettendo ad altre sedi il compito di effettuare gli
approfondimenti analitici necessari.
1. Il parallelismo delle due integrazioni, economica e monetaria, ovvero la filosofia costitutiva dell’UEM.
Realtà e paradossi della terza integrazione.
La seconda e la terza lettera della sigla UEM, che si mostrano in questa come realtà simboliche reciprocamente
collegate e conciliate, riportano per contrasto il pensiero ai dibattiti che si erano svolti all’interno del comitato nel quale
si espresse per la prima volta l’intendimento della (allora) CEE, di affrontare la questione dell’equilibrio monetario fra i
Paesi aderenti al mercato comune, ignorate, in un periodo caratterizzato dalla stabilità dei rapporti fra le monete, dalla
disciplina del Trattato di Roma e portate prepotentemente sulla scena dall’ingresso della comunità internazionale in una
fase di turbolenza monetaria dovuta all’inadeguatezza del dollaro a svolgere la funzione guida attribuitagli dagli accordi
di Bretton Woods, non ostante che in quella sede J.M. Keynes, contrastando la proposta statunitense che finì per
prevalere, avesse proposto di non attribuire quella funzione a una moneta nazionale, ma a una moneta internazionale di
nuova creazione, della quale aveva financo suggerito il nome. In quel comitato, noto come comitato Werner dal nome
del componente lussemburghese che ebbe a presiederlo, si delineò subito, infatti, un forte contrasto fra la posizione
economicista o fondamentalista sostenuta dalla RFT, e condivisa dall’Italia, secondo la quale sarebbe stato necessario
prima armonizzare le politiche economiche degli Stati membri e poi varare politiche di armonizzazione monetaria, e la
posizione monetarista, che aveva per capofila la Francia, secondo la quale, poiché le due politiche potevano essere
considerate reciprocamente indipendenti, e dal momento che difettavano a quell’epoca le condizioni strutturali che
consentissero di allestire una politica economica e di bilancio comuni, sarebbe stato possibile varare fin dall’inizio una
politica comune di armonizzazione monetaria. Le proposte del comitato, le quali fin da allora auspicavano la creazione
di una moneta europea unica governata da un’autorità monetaria sovranazionale parimenti unica, per quanto fossero
antiveggenti nei fini, erano, per i contrasti insorti, costrette alla reticenza nell’indicazione dei percorsi destinati ad
attingerli; onde non potevano che essere percepite, in una situazione caratterizzata dalla forte chiusura reciproca delle
economie degli Stati nazionali aderenti al mercato comune, se non come una fuga in avanti. E poiché furono appunto
considerate alla stregua di proposte futuribili, non ebbero il seguito pratico che solo una convergenza politica
determinata a superare le barriere che si frapponevano all’istituzione di un mercato europeo effettivamente unificato e
conforme alle disattese previsioni del Trattato, avrebbe ad esse consentito di ottenere. In sostituzione di quelle proposte,
2
ambiziose, ma fragili, furono, invece, adottati accordi monetari di carattere parziale, consistenti nell’essenziale in
accordi di cambio variamente modulati, sbilanciati ancora, in un primo tempo, verso il dollaro, di nuovo assunto come
moneta di riferimento (tale fu l’impostazione fatta propria dal c.d. serpente monetario negli anni 1972 – 78), orientati,
invece, a partire dal 1978, verso parità reciproche definite in relazione all’ECU, una moneta europea di natura
composita, simile nella concezione ai diritti speciali di prelievo utilizzati come mezzo di pagamento dal FMI, non
sostitutiva delle monete nazionali; tale fu l’impostazione seguita per la costruzione del sistema monetario europeo
(SME). Quanto all’illustrazione più specifica delle caratteristiche tecniche dei due accordi, essa può essere considerata,
in questa sede, non rilevante per l’intelligenza della genesi dell’UEM.
Decisiva in vista di quest’ultimo scopo, deve considerarsi, invece, a parere di Stammati, la svolta del Trattato
comunitario in direzione del superamento della stasi nella quale per anni era restata impigliata la liberalizzazione del
mercato interno della CEE, registratasi con l’approvazione dell’Atto Unico europeo, nel cui testo l’art. 13 (che si
inseriva come art. 8A nel TCE) stabiliva, (I comma), che la Comunità avrebbe dovuto adottare “le misure destinate
all’instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo” che sarebbe scaduto il 31 dicembre 1992 e
precisava, (II comma), che quel mercato “comporta(va) uno spazio senza frontiere interne, nel quale (doveva essere)
assicurata la circolazione libera delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni del …
Trattato.” Una volta affermatasi nel diritto originario della CEE con valore giuridico prescrittivo l’intento di realizzare
quello spazio, esso ebbe un seguito, assai anticipato rispetto alla scadenza temporale fissata dall’art. 13AUE, nel diritto
derivato della comunità, quando, nel 1988, per impulso determinante del Presidente della Commissione europea,
J.Delors, fu approvata la direttiva 361/CEE, che, in attuazione dell’articolo 67 del Trattato, disponeva che gli Stati
comunitari sopprimessero le restrizioni ai movimenti di capitale effettuati tra le persone residenti nei medesimi,
effettuassero i trasferimenti relativi a tali movimenti “a condizioni di cambio uguali a quelle praticate per i pagamenti
relativi alle transazioni correnti” (art. 1), e si adoperassero per raggiungere, nel regime da essi applicato ai trasferimenti
relativi ai movimenti di capitale con i Paesi terzi, “lo stesso grado di liberalizzazione” realizzato nelle operazioni
omologhe fra residenti degli Stati membri (art. 7). Dal suo canto, la Conferenza intergovernativa di Hannover di quel
medesimo anno, deliberava di istituire quel Comitato Delors, composto dai governatori delle Banche centrali degli Stati
membri, il quale riuscì, poi, a trovare al proprio interno, nel giro di un anno, quell’accordo effettivo e integrale, sui fini,
ma anche sui mezzi, intorno al progetto di Unione monetaria europea che venti anni prima il Comitato Werner era
riuscito a raggiungere solo con uno slancio impolitico di ottimismo. E’ evidente, al riguardo, che la vicenda
consumatasi nel biennio ‘86 – ‘88, che va dall’AUE alla direttiva 361/88/CEE, fu decisiva ai fini del raggiungimento di
quell’accordo; una volta maturato il presupposto strutturale costituito dalla piena apertura reciproca dei mercati
particolari degli Stati aderenti alla CEE, il dilemma che aveva visto formarsi due opposti schieramenti entro il primo
comitato monetario, perdeva la sua ragion d’essere, infatti. Era l’integrazione dei mercati, la creazione di un mercato
unico nella Comunità, a reclamare, in nome di ragioni pratiche e logiche non oppugnabili, e prive di riscontri similari
nel passato, la creazione di un mezzo di scambio adeguato a rappresentare lo spirito e le esigenze reali di quella
unificazione; e d’altra parte, la creazione della moneta unica, l’equilibrio della quale si trova necessariamente sospeso
fra l’andamento delle contrattazioni del mercato e gli orientamenti perseguiti dalle decisioni politico–economiche degli
Stati, postulava, con altrettanta imperiosità, l’esigenza, internamente più articolata, di associare all’unificazione dal
basso realizzata con la liberalizzazione dei movimenti finanziari, anche un’unificazione dall’alto delle politiche
monetarie e di bilancio degli Stati membri. Quest’ultima, infatti, si imponeva certamente, per adeguare quella politica al
mutamento strutturale già realizzato (l’unificazione del mercato), ma si mostrava altrettanto necessaria allo scopo di
creare le condizioni istituzionali necessarie a realizzare il mutamento progettato come ineludibile seguito del primo (la
creazione della moneta unica), e, infine, con forza non meno imperiosa, allo scopo di conservare alla politica
economico–finanziaria degli Stati membri la disponibilità degli spazi necessari ad attivare le decisioni allocative
indispensabili al raggiungimento degli obiettivi ultimi esplicitamente enunciati dal TCE in chiusura del suo articolo 2,
che la CE è tenuta, per conseguenza, a perseguire. Il Comitato Delors, in definitiva, una volta trovata la strada sgombra
dagli ostacoli fino ad allora frapposti dagli Stati alla realizzazione compiuta del mercato comunitario, che stavano alla
base della precedente controversia sul prima e sul dopo, e non gravato dalla responsabilità di dover pensare in quel
momento al come avrebbero potuto essere realizzati gli obiettivi ultimi della Comunità, ebbe la possibilità di
concentrarsi sulla questione intermedia della creazione della moneta unica europea e più in particolare sul modo
attraverso il quale pervenire a quella creazione; il percorso di avvicinamento all’obiettivo finale che, senza rilevanti
contrasti interni, venne proposto, prese corpo nella proposta che gli Stati, per entrare nel futuro sistema della moneta
unica, qualora fossero effettivamente determinati ad entrarvi, avrebbero dovuto, gradualmente e contestualmente,
conformare le proprie politiche economiche, parimenti a condizioni restrittive di carattere squisitamente monetario
(inflazione, tasso di cambio, tasso di interesse a lungo termine) e a condizioni limitative della propria politica di
bilancio (limitazione del disavanzo annuale e del debito complessivo). Nel progetto Delors, per effetto del mutamento
strutturale dal quale era stato immediatamente preceduto, giungeva, dunque, a maturazione la possibilità che le politiche
monetarie e le politiche di bilancio dei vari Stati nazionali, le quali, in molti di essi, si erano fino a quel punto
incamminate lungo sentieri fra loro malamente comunicanti, venissero vigorosamente (pure se non in forza di un
obbligo giuridico) rilanciate verso la convergenza reciproca, entro ogni Stato e, in parallelo, nelle relazioni fra gli Stati,
in vista dell’obiettivo di conseguire un nuovo e superiore livello di integrazione fra le economie e le politiche
economiche nazionali. Era la forza dell’integrazione, affermatasi a un primo, basilare, livello, a propagare
irresistibilmente la propria forma costitutiva ai livelli secondi; essa agiva, dunque, come causa del nuovo patto fra le
3
forme della politica economica avanti indicate e si proponeva come obiettivo capace di trascinare quel patto fra le due
politiche verso un consolidamento ulteriore. In tal modo quest’ultimo, pure se destinato a riversarsi nelle disposizioni
del Trattato istitutivo di una nuova Comunità europea, dopo che gli Stati, come avvenne, avessero approvato il progetto
di unificazione delle monete e quello di integrazione delle politiche economiche che lo sorreggeva, finiva per travalicare
i limiti di quel Trattato per assumere, senza dichiararlo apertamente, una chiara valenza politica. Per dimostrarlo non
v’è che da richiamarsi alla sostanza dei fenomeni che sono confluiti nel progetto di unificazione–integrazione,
schematicamente descritto. Ma se si voglia aggiungere a quel richiamo, qualche riscontro simbolico–positivo, si può
chiamare in causa ancora la sigla del nuovo costrutto economico–monetario, più volte evocata dalle disposizioni del
TCE (art. 116, ex 109, art. 121, ex 109 J, art. 124, ex 109 M), nella quale il termine “Unione” con il quale è stato
battezzato il patto fra economia e moneta, oltre a valorizzare più l’unificazione (monetaria) che la determinante
integrazione, interna e esterna, fra i vari aspetti della politica economica nazionale, non può non essere associato a
quello identico che denomina il Trattato nel quale è offerto il primo consistente sviluppo istituzionale al progetto di
unificazione politica degli Stati dell’Europa comunitaria. Sullo stesso piano deve essere attirata con forza ancor
maggiore l’attenzione, (oltre che sulla formulazione dei commi 2 e 3 dell’art. 99 sulla quale ci intratterremo più oltre),
su quella dei commi 2 e 3 dell’art. 121 (ex 109 J) del TCE, nei quali la decisione circa l’opportunità che la CE “passi
alla terza fase dell’Unione” (art. 121, comma 3, II trattino) è affidata a quell’organo singolare costituito dal Consiglio
dei Ministri “riunito nella composizione dei Capi di Stato e di Governo”, che rappresenta un’evidente ibridazione fra un
organo della CE, il Consiglio dei ministri appunto, (art. 7, comma 1, I trattino, TCE) e il Consiglio europeo (art. 4
TUE), inserito quest’ultimo, viceversa, nel “quadro istituzionale unico” (art. 3 TUE) dell’Unione europea, e che, in via
generale, è esplicitamente previsto dall’art. 7, comma 1, del TUE. Una formulazione cosiffatta offre, dunque, ampia
materia per argomentare che, non appena la CE, attraverso la moneta unica e la Banca centrale, sostenute
dall’integrazione delle politiche economiche nazionali, ma al di là di esse, è riuscita a darsi le prime istituzioni
economiche effettivamente unitarie, da queste ultime, già in se stesse rappresentative del primo, più elementare, nucleo
di integrazione politica fra gli Stati comunitari, abbia preso slancio un ulteriore processo di unificazione, volto a
conseguire superiori forme di espressione anche in questo terzo e decisivo campo di integrazione.
2. La disciplina positiva del TCE dalla convergenza delle politiche economiche degli Stati a quella della loro
stabilizzazione dinamica.
Nel passare alla seconda parte della sua introduzione, Stammati osserva come sia complicato sistemare in un
insieme ordinato le regole scritte che disciplinano l’UEM. Per la gran parte esse sono individuabili in quelle che il TCE
riserva alla “politica economica e monetaria” (T,VII ex T,VI, suddiviso in 4 capitoli che abbracciano la successione
degli articoli 98 – 124), le quali si caratterizzano, non solo per il numero elevato, ma per la sconnessione espositiva e
per la singolarità del compito al quale devono assolvere, che è quello di regolare, accanto a questioni di carattere
istituzionale e permanente (come quella, per esempio – art. 104 ex 104 C CE –, dell’obbligo degli Stati di “evitare
disavanzi eccessivi”), altre, che, viceversa, posseggono carattere esplicitamente transitorio (capo IV del titolo citato),
incentrate come sono sulla disciplina della II fase dell’UEM (che si sovrappone, fra l’altro, alla terza, conclusiva, fase
dello SME), nella quale era previsto il compiersi (entro il 1997) del processo di convergenza delle politiche
economiche, e destinate a consumare la propria efficacia, non appena raggiunta, con l’introduzione dell’euro scritturale,
la terza fase dell’UEM. A tali disposizioni del trattato devono essere, poi, affiancate, per ciò che riguarda la disciplina
dello svolgersi di quest’ultima fase, le regole direttive e imperative dettate da altri atti comunitari, di indirizzo e
regolamentari (li si citerà puntualmente più avanti), le quali, pur giuridicamente disuguali da quelle del Trattato, ne
condividono formalmente la funzione, quella di essere volte a regolare una fase particolare e ancora più avanzata del
processo di integrazione delle politiche economiche nazionali, caratterizzata, tuttavia, a differenza dell’altra, dal
predominarvi dell’obiettivo di stabilizzare (dinamicamente) tali politiche, anziché da quello di guidarle verso esiti
prestabiliti di convergenza da raggiungere a tappe forzate. A questo pronunciato orientamento funzionale si lega la
singolarissima scrittura dell’uno e dell’altro fascio di regole, che, non ostante esse siano prevalentemente iscritte sul più
alto piano giuridico–formale, si caratterizza, contrariamente a quanto avviene alle disposizioni tendenzialmente
atemporali collocate a quel livello, per la minuzia estrema delle previsioni, per il carattere frequentemente
autoregolativo delle stesse, per la natura della prescrittività irradiata che, in misura amplissima, è procedimentale, per la
concatenazione molto elaborata delle regole basilari con le regole e con gli atti ai quali le prime affidano la propria
applicazione e, in definitiva, per l’intonazione più amministrativa che normativa di tali catene prescrittive.
Stammati, richiamando osservazioni precedenti, osserva che sono le disposizioni degli articoli 99, ex 103, (sul
coordinamento delle politiche economiche degli Stati nazionali) e 104, ex 104 C (sul divieto dei disavanzi eccessivi),
quelle che il diritto positivo del Trattato pone alla base delle due principali fra tali concatenazioni normative, onde
ritiene conveniente procedere muovendo da ognuna di tali disposizioni stabili, per poi rintracciare e analizzare
schematicamente le regole ulteriori, dettate sul presupposto della loro esistenza e allacciate a ciascuna di esse, le quali
sono volte, in entrambe le serie prescrittive, naturalmente con intenti e incidenze differenti, a regolare il percorso
nervoso e l’approdo della seconda fase dell’UEM e il percorso più lento, attestato sulla difesa dei risultati raggiunti e
aperto ai balzi verso il finalismo ultimo della Comunità, che attraversa, caratterizzandola decisivamente, la terza fase di
questa stessa unione.
4
A) L’art. 99 TCE e le disposizioni ad esso collegate nella fase di convergenza delle politiche economiche degli
Stati e in quella della stabilizzazione dinamica di tali politiche.
A parere di Stammati, la più interessante, per la sua dinamicità, delle due concatenazioni è senz’altro quella
che, facendo capo all’art. 99 TCE, si prolunga, prima – relativamente alla seconda fase dell’UEM – nelle disposizioni
del capo IV, titolo VII (ex VI) del Trattato, quindi – con riguardo alla terza fase dell’Unione – nelle disposizioni dettate
da indirizzi, raccomandazioni e, infine, dal regolamento CE n. 1466, adottati tutti nel periodo giugno – luglio del 1997,
dopo che, nei mesi precedenti, era stata deliberato il passaggio della Comunità alla terza fase dell’Unione monetaria,
una volta verificato formalmente (dall’IME, dal Consiglio dei ministri e finalmente dal Consiglio europeo nella
composizione particolare sulla quale si è poco fa richiamata l’attenzione) che, con l’eccezione della Grecia (ammessa
successivamente anch’essa nel sistema della moneta unica), tutti gli Stati della Comunità avevano rispettato le
condizioni imposte dal Trattato per l’accesso alla fase conclusiva dell’UEM. Nel suo insieme la catena normativa
considerata riguarda il coordinamento delle politiche economiche degli Stati, cioè l’aspetto più recente e innovativo
della politica comunitaria. Essa si caratterizza: per il profilo strutturale, nel collegare una disposizione base di carattere
permanente con disposizioni da essa dipendenti, a prescrittività temporalmente circoscritta; per il profilo organizzativo,
nell’associare strettamente, in un procedimento di altissimo profilo politico, finalizzato all’elaborazione degli indirizzi
generali delle politiche economiche degli Stati, le deliberazioni dei più importanti organi della Comunità e quelle del
Consiglio europeo, istituzione la più alta dell’UE; per il profilo funzionale, infine, per essere mirata, nel complesso delle
disposizioni che la compongono, a instaurare negli Stati una nuova piattaforma di equilibrio economico generale,
articolata su assetti monetari e di bilancio meno espansivi, da realizzare utilizzando le leve di comando della politica
economica conformemente agli “indirizzi di massima” elaborati nei modi previsti dall’articolo, ciò che imprime su di
essa uno speciale, giuridicamente inconsueto, sigillo dinamico .
a) La disposizione di base, l’articolo 99 TCE, espone la prescrizione basilare per la quale gli Stati devono
considerare le loro politiche economiche “una questione di interesse comune” onde sono tenuti a coordinarle
“nell’ambito del Consiglio” (comma 1), ed è imperniata su tre procedimenti diretti a realizzarla e disposti secondo un
ordine logico e giuridico di presupposizione. Il primo è il più importante dei tre; in esso, infatti, la simbologia politico istituzionale raggiunge la sua più alta forma di espressione (comma 2) con il prevedersi l’elaborazione in sede europea
di “indirizzi di massima” per le politiche economiche degli Stati membri della CE, filtrandola attraverso una fitta e
concatenata sequenza di atti imputati ai massimi organi della Comunità e dell’Unione: una raccomandazione iniziale
della Commissione, l’elaborazione di un progetto di massima ad opera del Consiglio dei ministri e la presentazione di
una relazione sul progetto al Consiglio europeo, le conclusioni di quest’ultimo sulla relazione, la raccomandazione
finale del Consiglio dei ministri che definisce gli indirizzi di massima, informandone il Parlamento europeo. Il secondo,
meno altisonante, procedimento (comma 3) disciplina la sorveglianza che il Consiglio, “sulla base di relazioni
presentate dalla Commissione”, eserciterà sull’evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità,
paragonandone la coerenza agli indirizzi di massima in precedenza elaborati e formalizzando regolarmente in
“valutazioni globali”, i risultati dei riscontri effettuati. Il terzo procedimento (comma 4), prevede infine che il Consiglio
adotti misure sanzionatorie, (raccomandazioni, eventualmente pubblicate, rivolte agli Stati inadempienti), nelle quali la
cifra etico–politica sembra prevalere su quella strettamente giuridica, qualora l’incoerenza eventualmente riscontrata fra
le politiche economiche degli Stati e gli indirizzi di massima deliberati dalla Comunità–Unione, rischi “di
compromettere il corretto funzionamento dell’Unione economica e monetaria”. Ogni connessione particolare fra gli atti
di ciascun procedimento si presta ad analisi particolari variamente complesse, in quanto tali inadatte a tutte le
dimensioni caratteristiche di questi incontri. Ad esse può considerarsi, viceversa, appropriata, a mò di chiusura sintetica,
l’osservazione che metta in luce come l’esibizione di altissimo decoro istituzionale di cui la disposizione fa mostra
allorché disciplina l’elaborazione degli indirizzi di massima, solo formalmente discordi con il tenore assai più informale
e flessibile che connota la disciplina della sorveglianza e delle sanzioni, essendo l’uno e l’altro stile normativo
finalizzato a rendere omaggio, in forme opposte, alla strapazzata sovranità degli Stati; l’intera disposizione è percorsa,
infatti, dalla consapevolezza che limitazioni astratte alle prerogative sovrane di questi ultimi, tanto profonde quanto
quelle che la fattispecie normativa esaminata configura, possano essere disposte solo impegnando al massimo le risorse
dello stile costituzionale europeo e che l’attuazione concreta delle limitazioni di quelle stesse prerogative, possa essere
simmetricamente praticata solo facendo ricorso al massimo di leggerezza che le risorse di quello stesso stile abbiano la
capacità di mostrare.
b) All’articolo 99, con la sua signorile cautela prescrittiva, deve, tuttavia, essere accostato subito il secondo
anello della catena normativa che stiamo considerando, l’art. 121 (ex art. 109 J) TCE, collocato fra le disposizioni
transitorie iscritte nel capitolo IV del titolo VII (ex VI) qui esaminato, in ragione del fatto che anche questo articolo,
come il primo, si occupa del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, considerandole, però, sotto
il profilo dei risultati che esse in ciascuno degli Stati aderenti avrebbero dovuto (entro il 1997), conseguire, così da
rendere possibile ai medesimi Stati di superare positivamente la valutazione articolata, condotta alla luce dei criteri
distintamente enunciati nel I comma dell’articolo esaminato, alla quale le singole politiche economiche nazionali
5
avrebbero dovuto sottoporsi in funzione dell’ingresso dei rispettivi Paesi nell’Unione economica e monetaria europea.
Tale articolo si fa notare, anzitutto, per una diversa qualità del linguaggio normativo, che in esso esibisce un timbro
sempre marcatamente pragmatico, che a tratti anche si mostra persino brusco, per esempio quando, proprio nelle battute
iniziali della disposizione, richiama i controlli ai quali gli Stati dovevano sottostare onde mostrare i “progressi compiuti
… nell’adempimento dei loro obblighi”, volendo presumibilmente echeggiare il tenore della VII Dichiarazione
premessa al TUE e l’affermazione dell’articolo 2 dello stesso testo, ove è affermato che l’Unione si prefigge ....”
l’instaurazione di un’Unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle
disposizioni del presente Trattato”. Ma, certamente, più significativa ancora è la circostanza che esso esibisca, rispetto a
quella dell’art. 99, una struttura concettuale bensì omologa, essendo dominata anch’essa dall’idea che le politiche
economiche nazionali debbano tendere a conformarsi a parametri elaborati in sede comunitaria, ma espressa in forme
molto più rigide, essendo stati quei parametri, dettati direttamente dal Trattato, concepiti in guisa da prefigurare con
precisione il collegamento interno fra gli aspetti monetari e gli aspetti “fiscali” di quelle politiche. Queste ultime non
avrebbero dovuto essere più misurate, infatti, a mente dell’art. 121, sul rispetto degli elastici (tolleranti) indirizzi di
massima intorno ai quali abbiamo visto l’art. 99 limitarsi a dettare disposizioni circa il metodo della loro elaborazione
progressiva, sibbene, invece, e questo è l’aspetto forse più divulgato, sul rispetto di parametri di convergenza, i quali,
anche a chi mette in dubbio la rilevanza del loro significato economico, appaiono non di meno formulati dalle
disposizioni del Trattato (da associare nella lettura a quelle dei Protocolli 5 e 6 allegati al Trattato di Maastricht) in
termini contenutisticamente diversificati, rigidi, e tali da implicare inevitabilmente un irrigidirsi parallelo delle attività
susseguenti, di sorveglianza e di sanzione. In ogni caso, nel raccordo fra le due disposizioni, il profilo della diversità
della fonte e del contenuto dei parametri comunitari di valutazione delle politiche economiche nazionali risultava
esaltata dalla duplice circostanza che, per tutta la durata della seconda fase dell’UEM, dal 1993 al 1997, l’utilizzazione
dei parametri previsti dalle disposizioni transitorie dell’art. 121, comma 1, TCE, sarebbe stata necessariamente ostativa
all’utilizzazione dei più indeterminati parametri previsti, nel modo che si è detto, dal precedente art. 99 TCE ,e che, per
altro verso, quelle stesse disposizioni, mostravano, tanto intrinsecamente, per i contenuti, quanto estrinsecamente, per la
dislocazione testuale, quest’ultima consecutiva a quella dei capitoli destinati dal Trattato alla politica economica degli
Stati membri e alla politica monetaria della Comunità, di voler condensare in una medesima formulazione prescrittiva,
esigenze dedotte dai valori ancor più che dalle discipline positive di entrambe quelle politiche. Onde, in definitiva, l’art.
121 del Trattato, per il periodo limitato della propria vigenza, ha voluto stabilire fra la propria formulazione positiva e
quella dell’art. 99 che la precede, un rapporto istituzionalmente derogatorio, essendo la propria cifra prescrittiva
finalizzata a creare puntualmente e in tempi brevi quelle superiori condizioni di stabilità economica che, per altro verso,
sotto il profilo del ”mantenimento della stabilità dei prezzi”, rappresentavano e rappresentano tuttora, secondo l’art. 105
TCE, “l’obiettivo principale” del SEBC e, dunque, della BCE, della quale il primo rappresenta contraddittoriamente il
contenitore (essendo “composto dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali”) (art. 107 TCE, ex 106,
comma 1) e il contenuto (essendo il sistema europeo delle banche centrali “retto dagli organi della BCE”) (art. 107
TCE, comma 3).
Rispetto alle osservazioni che precedono, interesse minore presenta in questa sede l’esame dettagliato dei
singoli criteri di convergenza dettati dall’articolo 121 TCE (ai quali gli Stati avrebbero dovuto adeguarsi entro il 1997,
importando essenzialmente il trovare conferma, nell’elenco propostone da tale articolo, e nella bipartizione logica
secondo la quale quell’elenco deve essere decifrato, della volontà del Trattato di abbinare rigidamente, secondo
l’ideologia del parallelismo precedentemente esposta, i due profili, monetario e di bilancio, della politica economica
degli Stati. Basti qui limitarsi a ricordare che i parametri monetari, inflazione, tassi di interesse a lungo termine,
meccanismi di cambio venivano agganciati a valori diversi, rappresentati, per i primi due, dai risultati raggiunti dai tre
Paesi europei che avessero conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, e per il terzo, dai normali
margini di fluttuazione stabiliti dal Meccanismo del Sistema monetario europeo, quantificati, tanto i primi che
quest’ultimo, dalle disposizioni (articoli 1, 3 e 4) del Protocollo 6, allegato al Trattato di Maastricht, attuativo
dell’articolo esaminato; e che i parametri stabiliti in limitazione delle politiche nazionali di bilancio, in virtù del rinvio
operato dall’art. 121, comma 1, II trattino, all’art. 104, paragrafo 6, TCE (che così facendo istituisce un raccordo
orizzontale fra la concatenazione normativa che stiamo esaminando e quella facente capo a quest’ultimo articolo) erano
agganciati al prodotto interno lordo e quantificati dall’art. 1 del protocollo 5 allegato allo stesso Trattato (al quale faceva
rinvio l’art. 2 del protocollo 6), nel 3% (per il disavanzo) e nel 60 % (per il debito) di quel medesimo prodotto.
Resta da dire che l’edificio giuridico eretto sulla disposizione transitoria dell’art. 121 TCE, esaminato dal
punto di vista delle situazioni giuridiche sulle quali si sorregge, mostra un’evidente, forse inevitabile, discrasia fra
obblighi strumentali e obblighi finali imposti dal Trattato agli Stati e alla stessa Comunità. Alla rigidità dei primi,
illustrata dai vincoli imposti alle politiche economiche nazionali dalle prescrizioni puntuali dei parametri di
convergenza, fa riscontro l’elasticità dei secondi, esemplificata dalla previsione che un certo numero di Stati –
eventualmente la maggioranza – non si fosse adeguato a quegli obblighi strumentali al termine del periodo
programmato (art. 121, comma 3, I trattino), dalla previsione che un regime giuridico derogatorio si sarebbe dovuto
applicare alla minoranza di Stati (“Stati membri con deroga”) che non avesse rispettato quegli stessi obblighi entro
quello stesso periodo (art. 122 TCE, commi 1 e 3), dalla facoltà accordata a Stati che pure si fossero conformati agli
obblighi strumentali previsti dall’articolo esaminato di non partecipare all’Unione economica e monetaria (protocolli,
11 su Gran Bretagna e Irlanda del Nord e 12 su Danimarca – successivamente denominati “Stati non partecipanti” –
allegati entrambi al Trattato di Maastricht), infine dalla previsione dell’eventualità che il Consiglio dei ministri nella
6
speciale composizione integrata della quale si è detto, al termine del periodo programmato, potesse considerare
inopportuno il passaggio “alla terza fase dell’Unione” (art. 121,comma 3, II trattino). Considerata in astratto, la
discrasia segnalata avrebbe potuto essere considerata fonte di un drastico abbassamento della probabilità che gli Stati
comunitari prendessero sul serio gli obblighi strumentali ai quali erano richiesti di sottostare. Essendo noto, viceversa,
che, non ostante quella discrasia, non si è verificata alcuna caduta nell’impegno degli Stati a conseguire l’obiettivo
ultimo dell’ingresso nell’Unione economica e monetaria, e per logica e pratica necessità, anche nell’impegno a
rispettare gli obblighi strumentali e a conseguire gli obiettivi intermedi collegati a tale rispetto, si offre alla meditazione
dei giuristi una vicenda donde si evince che l’efficacia formale e materiale di formule normative dirette, come quelle
esaminate, a regolare fenomeni economici di amplissima portata, non dipende dalla forza della propria imperatività
formale e dalla dimensione altrettanto forte delle situazioni soggettive imposte ai soggetti ai quali esse si indirizzano,
ma piuttosto dai caratteri materiali della situazione ambientale nella quale quelle formule devono trovare applicazione.
Per un verso una constatazione come questa non fa che confermare tesi ampiamente elaborate in dottrina circa lo stile
prescrittivo che più conviene alle regole finalizzate a disciplinare i fenomeni economici, fondato assai più sulla
sollecitazione e la regolazione di azioni libere che non sulla limitazione imperativa delle medesime; per altro verso,
tuttavia, essa porta ben al di là di quelle tesi. Infatti, l’imponenza delle modificazioni finali richieste in forma non
imperativa dalle regole comunitarie che si stanno esaminando, quella delle limitazioni dalle medesime pretese in via
strumentale, tali da incidere profondamente sulla qualità di poteri che tradizionalmente caratterizzano la sovranità degli
Stati nazionali, e, infine, il forte impegno di obbedienza prestato a queste ultime dagli stessi, non può non rilanciare in
termini rinnovati la riflessione sulla natura, la potenza e la qualità della normatività costituzionale materiale più basilare
e profonda e sui canali attraverso i quali essa riesce a trasmettere la propria energia di comando a formule normative di
per sé dotate di scarso nerbo prescrittivo. Ma, va da se che una riflessione di tal portata potrà essere condotta in sedi e in
occasioni diverse da quella nella quale si tiene l’introduzione odierna.
c) L’anello conclusivo della concatenazione normativa che fa capo all’art. 99 TCE è, secondo Stammati, il
risultato dell’incastro unitario di una serie di anelli minori, intesi nel loro complesso a formulare le regole particolari
destinate a guidare le politiche economiche, e degli Stati nazionali ammessi a partecipare alla terza fase dell’UEM e di
quelli che, pure possedendo i requisiti per esservi ammessi, abbiano, tuttavia, esercitato il diritto di opting out loro
riconosciuto dai Protocolli ricordati. Quanto a quelli non ammessi a partecipare alla terza fase dell’Unione (nel 1997, la
sola Grecia, ammessa dopo un biennio), essi avrebbero dovuto sottostare ancora alle disposizioni regolatrici della
seconda fase dell’Unione. Poiché su queste regole particolari il Trattato tace, si sarebbe potuto ipotizzare che, una volta
esaurito il regime derogatorio previsto transitoriamente per quest’ultima, si sarebbe tornati, puramente e semplicemente,
all’applicazione, nella terza fase, delle regole generali enunciate dall’art. 99 del medesimo nei modi avanti ricordati, con
elaborazione di indirizzi di massima, sorveglianza delle politiche economiche nazionali ed eventuali raccomandazioni
sanzionatorie. E in effetti si ritrovano in essa alcuni degli attori menzionati nell’articolo 99 TCE, la Commissione, il
Consiglio europeo, e l’atto più caratteristico del suo dettato, la raccomandazione (nel caso specifico, quella del 7 luglio
1997 - 97/479/CE), su quegli “indirizzi di massima” per la politica economica della Comunità e degli Stati membri, dei
quali si è detto. Ma, a capo e a conclusione, della sequenza procedimentale che prevede l’approvazione di quella
raccomandazione, si trovano in funzione avvolgente, atti in quell’articolo non contemplati, e precisamente la
Risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997, relativa al patto di stabilità (97/C 236/01) e il Regolamento CE
1466/97 del medesimo Consiglio (7 luglio 1997) volto al “rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio,
nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche” degli Stati, atti entrambi materialmente non
previsti dal Trattato, pure se entrambi formalmente fondati su disposizioni, particolari (l’art. 99, comma2, ex art. 103
comma 2) o generali (l’art. 249,ex 189), del medesimo.
La risoluzione del Consiglio europeo appena richiamata ha carattere generale; il suo intento è, infatti, di
indirizzare tanto il regolamento citato, insieme al quale costituisce la prima articolazione del c.d. patto di stabilità,
quanto il regolamento CE 1467/97, insieme al quale costituisce la seconda articolazione di quel patto. Richiamandosi
alla propria natura di primo atto costitutivo del patto, la risoluzione si rivolge, in modo conciso, agli Stati membri, alla
Commissione europea e al Consiglio dell’Unione europea (dal quale ultimo essa stessa promanava), invitandoli
“solennemente”, “ad attuare – ciascuno secondo le proprie competenze – il trattato e il patto di stabilità e crescita
(qualificazione quest’ultima abbinata alla prima per esplicita richiesta della Francia ) in modo rigoroso e tempestivo.”
Le preoccupazioni più vive che vi risuonano sono, non ostante la sua natura di atto generale, collegato a valle con
ambedue i regolamenti citati e a monte con le disposizioni degli articoli 99 e 104 TCE, quelle relative al rispetto del
divieto per gli Stati membri di presentare bilanci che esponessero “disavanzi eccessivi.”
Fra la risoluzione e il regolamento CE 1466/97, si interpone, ampiamente irraggiata sulle questioni socio –
economiche più scottanti, con spirito di stabilità aperto verso le finalità sociali della crescita e dell’occupazione, la
raccomandazione 94/479/CE del Consiglio dell’Unione europea sugli “indirizzi di massima”, adottata sulla base di altra
raccomandazione della Commissione e delle “conclusioni” del Consiglio Europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno
1997. Gli indirizzi espongono, consecutivamente a quelle finalità sociali, “una strategia comune di politica
macroeconomica” segnata, metodologicamente, dalla filosofia del parallelismo, fondata sulla politica monetaria comune
guidata dalla Banca centrale e, insieme, sul coordinamento delle politiche di bilancio, destinate invece a rimanere “di
competenza dei governi nazionali”. Quanto al legame fra le due esigenze, invece, la raccomandazione è nutrita dalla
filosofia della consecuzione, cioè dalla persuasione che la cooperazione delle persone coinvolte a ogni livello
7
nell’attuazione del quadro macroeconomico in essa proposto (fondato sulla stabilità dei prezzi e dei cambi, oltre che
sull’equilibrio delle finanze pubbliche), rappresenti il passaggio necessario (il mezzo) per “la creazione delle condizioni
di una crescita forte, sostenuta e creatrice di posti di lavoro” (il fine).
Conclude la serie degli atti normativi che prolungano la normatività dell’art. 99 TCE nella terza fase
dell’UEM, il regolamento 1466/97 del Consiglio dell’Unione europea e si torna a sentirvi risuonare, come già nella
raccomandazione, la voce alta dello spirito europeo. L’atto enunciava ed enuncia gli obiettivi del Patto europeo di
stabilità e crescita (l’equilibrio delle finanze pubbliche, funzionale alla stabilizzazione dei prezzi e alla crescita di
produzione e occupazione, il miglioramento del mercato dei prodotti e dei servizi) e obbliga gli Stati nazionali a
presentare al Consiglio e alla Commissione un “programma di Stabilità”, evidente proiezione in ciascun Paese di quel
Patto, considerandone la formazione necessaria a mantenere e, anzi, a migliorare, nel medio termine, le condizioni
economico–finanziarie raggiunte nella seconda fase dell’UEM, per mezzo delle quali era stata ottenuta la prima seria
realizzazione di quegli obiettivi. Quelle condizioni rimangono dunque al centro della manovra di stabilizzazione
prevista dal regolamento, ma vengono sospinti innanzi secondo la medesima visione che abbina la politica di bilancio a
quella finanziaria, verso traguardi ulteriori da perseguirsi con un impegno continuo, ma non brusco come quello che
aveva caratterizzato la fase precedente, né definito temporalmente in forma rigida, con l’indicazione di un termine
finale di compimento. L’orizzonte della manovra richiesta dal Patto ai programmi nazionali di stabilità è di medio
termine; essa prevede che in quel periodo gli Stati nazionali presentino saldi di bilancio “prossimi al pareggio o in
attivo” e che quelli non ancora allineati all’indicazione del protocollo 5, (art. 1, III trattino), avvicinino a quella
indicazione il rapporto debito/PIL; presuppone, in parallelo, che gli indicatori monetari, inflazione, tassi di interesse a
medio termine, fra l’altro misurati ormai sul PIL o sull’indice dei prezzi medi dei prodotti consumati dalle famiglie, e
non più sul parametro dei tre paesi della comunità più virtuosi nella stabilità dei prezzi, debbano essere sospinti ad
assestarsi su equilibri caratterizzati da un abbassamento del rapporto che li lega a quei parametri; pretende, infine,
l’esposizione dei dati indicativi della “crescita reale del PIL, come quelli sulle “spese per investimenti pubblici” e
”sull’occupazione.” Quanto alla politica del cambio, il Patto ne tace. A partire dalla III fase dell’UEM, essa ha cessato,
infatti, di essere “un problema di interesse comune” (art. 124, comma 1 TCE) ed è diventata una questione unitaria,
essendo demandato alla BCE (art. 105, comma 2, II trattino - ex 105 TCE) di “svolgere le operazioni sui cambi”, salvo
le deliberazioni relative agli accordi di cambio fra la Comunità e gli Stati terzi, regolate da disposizioni speciali (art. 300
TCE e, in deroga a questo, art. 111). E’ un’impronta dinamica, dunque, quella che il Patto di stabilità e crescita imprime
ai “programmi di stabilità” degli “Stati membri partecipanti” e anche ai “programmi di convergenza” degli “Stati
membri non partecipanti” ed è tale impronta a spiegare, secondo Stammati, come, non ostante la previsione accurata
degli esami ai quali sono sottoposte la formulazione, l’aggiornamento e, infine, l’applicazione di quei programmi (art. 5
Regolamento), da parte dei loro occhiuti controllori (la commissione, il Consiglio, il Comitato economico–finanziario
dell’art. 114, comma 2 (ex 109 C, comma 2), essi si conchiudono con quelle stesse raccomandazioni, eventualmente
pubblicate, agli Stati nei quali si sia verificato “uno scostamento sensibile della posizione di bilancio dall’obiettivo a
medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo” (art. 6 Regolamento), che abbiamo a suo tempo
rinvenute nella disciplina flessibile dell’articolo–padre della concatenazione normativa descritta. In effetti il proposito
della disciplina regolamentare esaminata di sospingere le politiche economiche nazionali verso traguardi
programmaticamente individuati mediante indirizzi formulati nelle proprie regole sembrerebbe destinato al fallimento
se lo si paragonasse ai risultati che tentativi omologhi di guidare la politica con “indirizzi politici costituzionali” hanno
conseguito negli ordinamenti interni. Ma, nel caso esaminato, le cose stanno diversamente. Le regole non sono sole di
fronte alla politiche nazionali; se lo fossero perderebbero il confronto. Esse sono, invece, possentemente sostenute da
una spinta politica metanazionale, o se si vuole da una costituzione materiale europea, che esalta la loro efficacia
giuridica e le fa pari al compito loro assegnato.
B) L’art. 104 TCE e le disposizioni ad esso collegate nella fase della convergenza delle politiche economiche
degli Stati e in quella della loro successiva stabilizzazione dinamica.
Secondo Stammati il cammino attraverso i passaggi della concatenazione normativa fondata sull’art. 104 TCE
(ex 104 C), che, lo si è detto, obbliga gli Stati membri ad “evitare disavanzi eccessivi”, può essere assai più veloce di
quello appena concluso, per il giovamento che si trae dall’aver acquisito coscienza dello spirito dinamico, fatto di
avanzamenti progressivi, che segna complessivamente quel cammino e dall’aver riconosciuto gli elementi particolari
che si incontrano lungo il suo percorso.
a) Il primo passaggio di questo cammino (includente, come subito vedremo, il secondo) riguarda le
caratteristiche pregnanti della regola base, l’art. 104 TCE esaminate in contrappunto a quelle già esaminate, dell’art. 99.
Sotto questo profilo, l’art. 104 appare, anzitutto come fonte di regole incidenti su un oggetto più ristretto di quello
abbracciato dall’articolo precedente e che, nello stesso tempo, ricade, come suo aspetto parziale, nel campo di
applicazione di quest’ultimo. L’articolo si occupa, infatti, esclusivamente del disavanzo di bilancio e del debito
storicamente accumulatosi per effetto del prevalere di politiche pubbliche favorevoli all’indebitamento, e si preoccupa
che il rapporto dell’uno e dell’altro con il prodotto interno lordo non abbia a superare un “valore di riferimento”, da esso
stesso, peraltro non direttamente precisato. Da quest’ultima preoccupazione sembra, poi, potersi derivare la filosofia
8
complessiva dell’articolo che si sta esaminando, che è quella di evitare che le situazioni (in ipotesi negative) fatte
registrare dal disavanzo e dal debito pubblico rispetto al PIL, in un qualsiasi momento nel quale quel rapporto abbia ad
essere formalmente misurato, abbiano a superare il valore di riferimento stabilito. Una prima lettura del testo
indurrebbe, dunque, a ritenerlo ispirato a una filosofia, non solo diversa, ma opposta, rispetto a quella avanti illustrata,
apparendo esso dominato dall’esigenza statica di evitare il peggioramento delle due posizioni di bilancio esposte, cioè
l’assestamento di entrambe su rapporti con il PIL superiori a quelli di riferimento prestabiliti per ciascuna di esse dalle
Autorità comunitarie, anziché dall’esigenza di promuovere il miglioramento, il dinamismo positivo, di quelle posizioni,
ottenibile con la riduzione del valore attuale di ognuno di quei rapporti. Ma all’interpretazione conservativa
dell’articolo, quella cioè onde esso vieterebbe perentoriamente agli Stati comunitari di peggiorare le proprie attuali
posizioni di bilancio, si giustappone ,e anzi si sovrappone in guisa da comprometterne transitoriamente l’applicabilità,
una diversa, potenzialmente non statica, progressiva, interpretazione del medesimo, basata sull’osservazione che quelle
due posizioni non sono state prese in considerazione dalla disposizione considerata per come effettivamente si
presentavano in ciascuno Stato al momento dell’approvazione del Trattato di Maastricht, bensì per come avrebbero
dovuto essere, ed eventualmente trasformarsi nell’ipotesi che non corrispondessero ai parametri minimi fissati in
relazione ad ognuna dal Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi (art. 1, I e II trattino) al quale il comma 2,
lett. b), ultimo periodo, dell’articolo esaminato, rinvia. Sulla base di questa osservazione non v’è dubbio, secondo
Stammati, che l’ispirazione complessiva dell’articolo assuma carattere più complesso e diversificato, decifrabile a
seconda del periodo,anteriore o posteriore all’inizio della terza fase dell’UEM, rispetto al quale venga considerata
l’applicazione del medesimo, e, in relazione al primo di tali periodi, a seconda del rapporto nel quale si trovassero,
rispetto al PIL, le due tipiche posizioni di bilancio, quella attuale e quella storica, in ciascuno degli Stati comunitari.
Considerata all’interno delle due variabili prospettate, dunque, l’ispirazione dell’articolo sembra essere senz’altro quella
della conservazione (o del non peggioramento) delle posizioni di bilancio acquisite, se la sua applicazione venga
considerata in prospettiva ampia, riferita al periodo che inizia con la terza fase dell’UEM, allorché gli Stati, una volta
raggiunto l’allineamento assoluto e relativo, delle posizioni di bilancio, sarebbero stati obbligati a mantenerlo; nel
mentre che, considerando tale applicazione in una prospettiva più immediata, coincidente con la seconda fase
dell’UEM, quell’ispirazione può essere considerata ugualmente conservativa verso la politica fiscale degli Stati che fin
dall’entrata in vigore del Trattato avessero presentato disavanzi e debiti coerenti con le indicazioni prescrittive del
Protocollo citato; e deve essere considerata, viceversa, nell’insieme, dinamica e propulsiva verso la politica fiscale degli
Stati (in pratica la totalità dei medesimi) i quali avessero presentato posizioni di bilancio contrassegnate da livelli di
disavanzo e di debito più o meno negativamente distanti da quelli espressi in quelle indicazioni. La presenza di questo
sdoppiamento di ispirazione nell’art. 104 trova la sua spiegazione nel fatto che esso, facendo rinvio al V Protocollo
allegato al Trattato di Maastricht, ha incorporato immediatamente in sé, le esigenze di trasformazione delle politiche
nazionali di bilancio imposte agli Stati come condizione per ammetterli alla fase conclusiva dell’UEM, senza rinunciare
allo stesso tempo, in tal guisa sdoppiandosi, alla propria ambizione fondamentale di disciplinare le politiche pubbliche
trasformate. Una strategia normativa, questa ora esposta, del tutto diversa da quella che abbiamo visto percorsa dall’art.
99, nel quale i procedimenti di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, essendo enunciati senza
ancoraggio applicativo a particolari circostanze temporali, devono poi fare i conti con distinte discipline transitorie
speciali (quelle del ricordato art. 121 TCE) operanti con efficacia derogatoria nei confronti di quella principale. In
definitiva, dunque, nel mentre che la disciplina comunitaria sul divieto dei disavanzi eccessivi include nella stessa
disposizione due logiche diverse, quella sul coordinamento delle politiche economiche distribuisce tali logiche
all’interno di due disposizioni distinte.
Non c’è dubbio, tuttavia, una volta che è stato messo a punto il quadro teorico generale dell’articolo 104, che
quest’ultimo si mostri fonte di norme caratterizzate recisamente in senso imperativo, pienamente conformi all’intento
del trattato di imporre agli Stati un vero e proprio obbligo giuridico a evitare disavanzi eccessivi e che tale stile
normativo, che il successivo regolamento 1467/97/CE ha condotto a livelli esasperati, appare assai più conforme alla
filosofia normativa che divieta di peggioramento delle due tipiche posizioni del bilancio pubblico che non a quella
donde debbano irraggiarsi impulsi volti a far si che quelle posizioni, una volta che queste siano lievitate all’altezza dei
livelli voluti, evolvano verso tali livelli, allineandosi al doppio parametro stabilito dall’art. 1 del nominato protocollo
sulle procedure per i disavanzi eccessivi. Ad argomento di ciò, Stammati si appella, oltre che alla cultura degli
ascoltatori e dei lettori, anche a vari passaggi delle notazioni precedenti, in particolare a quelli relativi all’elasticità
dell’obbligo finale degli Stati comunitari di partecipare alla terza fase dell’UEM e agli effetti che siffatta configurazione
di quell’obbligo esercita sugli obblighi strumentali dei medesimi, formulati si rigidamente, ma risospinti, a causa
dell’elasticità del primo, entro i limiti concettuali della situazione giuridica soggettiva dell’onere. La staticità giuridica
sostanziale dell’obbligo sembra incompatibile con la dinamicità giuridica sostanziale dell’onere.
La difficoltà esposta non viene risolta esplicitamente dal testo dell’articolo commentato, che, tuttavia, offre
elementi testuali utilizzabili dall’interprete per scoprire entro l’apparato strumentale predisposto dall’articolo quella
stessa ambivalenza concettuale che caratterizza la parte sostanziale della medesima e per costruire proprio su di essa
una filosofia (statica) dell’obbligo compatibile con quella (dinamica) dell’onere.
Per Stammati, la questione predetta presenta un profilo concettuale che si rapporta in forma simmetrica a
quella presentata all’inizio della lettera a) del punto B. Lì, la filosofia del non peggioramento delle posizioni di bilancio
esistenti veniva sconvolta dalla considerazione che quella filosofia era riferita a posizioni di bilancio future, ancora
irraggiunte dalla più parte degli Stati. Qui l’impostazione filosofica è opposta; l’obbligo degli Stati a rispettare “i
9
requisiti – peraltro solo eventualmente posseduti dai medesimi all’interno della seconda fase dell’UEM – previsti da
uno o da entrambi i criteri menzionati” dal Protocollo sulle procedure per i disavanzi eccessivi, viene apertamente
enunciato all’inizio (comma 3, I periodo) delle disposizioni in serie, commi 3 - 9 e 11 - 12) che mettono a punto la
minuziosissima procedura di sorveglianza multilaterale sui bilanci nazionali, e predispongono, quando i controlli
effettuati siano pervenuti a conclusioni negative per qualcuno degli Stati, un sistema di sanzioni che si segnala per la
(talora altamente inopportuna e in definitiva inutile) rudezza. Trattandosi, tuttavia, con evidenza, di un obbligo
sostanziale ad attuazione impossibile, esso viene tacitamente sostituito con il più abbordabile obbligo alternativo che il
rapporto del disavanzo con il PIL, pure essendo superiore a quello prescritto dal Protocollo, sia, tuttavia “diminuito in
modo sostanziale e continuo” (comma 2, lett. a), I trattino) e che, a sua volta, il rapporto del debito con il medesimo
PIL, pur se superiore anch’esso a quello prescritto, “si stia riducendo in misura sufficiente” (comma 2, lett. b).
Per la verità anche il nuovo parametro espresso nelle due formule citate, a causa del dinamismo pur limitato
che vi si esprime, oppone difficoltà alla costruzione degli obblighi sostanziali intorno ai quali ruota l’intero costrutto
dell’articolo. E, tuttavia, la formula nella quale esso è esposto può essere letta come sineddoche di due formule
normative collegate, centrate rispettivamente sull’onere e sull’obbligo. La prima, agendo propulsivamente, metteva
ciascuno Stato di fronte all’onere di migliorare gli equilibri della propria finanza pubblica qualora intendesse
beneficiare dei vantaggi dell’Unione economica e monetaria ed evitare gli svantaggi che (specialmente se la sua
economia fosse stata debole) avrebbe sofferto restando fuori dell’Unione. La seconda, agendo da stabilizzatore
provvisorio, li obbligava a non peggiorare i più favorevoli equilibri finanziari transitoriamente conquistati,
minacciandoli di sanzioni nell’ipotesi che avessero fatto registrare arretramenti dalle posizioni appena conquistate; cioè
un disavanzo qualificabile come “eccessivo secondo il parametro transitorio. L’avvicinamento ascensionale delle
finanze pubbliche nazionali ai requisiti fissati dal Protocollo sulle procedure per i disavanzi eccessivi veniva in tal modo
costruito secondo il modello di un percorso giuridico segmentato in una successione di gradini, e più precisamente su
una serie di elementi verticali (oneri) collegati fra loro da una serie parallela di elementi orizzontali (obblighi).
Dopo queste considerazioni relative all’apparato finalistico dell’art. 104, Stammati, avverte di non potere
analizzare con la stessa cura l’apparato strumentale e sanzionatorio del medesimo, e di limitarsi, per quanto li riguarda,
a brevissime note di sintesi. Quanto al sistema di sorveglianza multilaterale previsto dall’articolo, esso si articola su un
procedimento necessario e su un procedimento eventuale. Il primo, muovendo dal presupposto che gli Stati membri
abbiano assolto agli obblighi di informazione e abbiano dato assicurazione circa le responsabilità ad essi assegnate
dall’art. 3 del Protocollo sui disavanzi, è basato su una relazione della Commissione sulla situazione del bilancio
pubblico nei singoli Stati e su un parere del comitato monetario (divenuto comitato economico e finanziario all’inizio
della terza fase UEM) su tale relazione, ed è funzionale tanto all’accertamento dei progressi fatti registrare
dall’equilibrio finanziario dei singoli Stati, quanto all’accertamento dei regressi e/o di situazioni che li facciano
presagire (commi 3 e 4). Il secondo, basato sulla trasmissione di un parere della Commissione al Consiglio sulla
situazione finanziariamente precaria di uno Stato membro, quando esista un disavanzo eccessivo o il rischio di tale
disavanzo (comma 5), su una successiva raccomandazione della Commissione al medesimo Consiglio che ne sollecita
una decisione, e, infine, su una deliberazione di quest’ultimo (comma 6), la quale può aprire la strada alla serie delle
sanzioni previste nei commi 7, 9 e 11 dell’articolo, quando, in punto di procedura, sia stata adottata a maggioranza
qualificata, e, in punto di sostanza, si concluda sfavorevolmente per lo Stato.
Quanto alle sanzioni, le disposizioni appena indicate ne affidano l’irrogazione a successive deliberazioni del
Consiglio adottate a maggioranza di 2/3 (comma 13) e le dispongono secondo un ordine di gravità crescente,
concatenandole lungo una sequenza procedimentale che può essere interrotta in qualsiasi momento, da deliberazioni
contrarie dello stesso organo, adottate con la medesima maggioranza, volte ad abrogare “alcune o tutte le decisioni”
sanzionatorie precedenti, se il Consiglio ritenga “che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato
corretto” (comma 12). Per Stammati la circostanza che il Trattato abbia elevato tale medesima maggioranza
“costituzionale” a porta di accesso di ciascuna delle sanzioni da esso previste deve considerarsi indice della profonda
perplessità teorica e politica del medesimo circa l’adeguatezza del sistema punitivo da esso architettato al migliore
svolgimento della II fase dell’UEM. La negativa prassi applicativa di quelle disposizioni, dal suo canto, ha pienamente
confermato tali perplessità, aggiungendo ad esse una recisa valutazione di inutilità dell’altisonante costrutto per la
realizzazione degli specifici scopi di quella fase.
b) Il terzo (e ultimo) passaggio del “nuovo sistema integrato di norme per l’applicazione dell’articolo 104
TCE” (I considerando dell’atto in appresso citato) conduce al Regolamento CE n.1467/97 “per l’accelerazione e il
chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi”, entrato in vigore il I gennaio del
1999 (art. 18 del medesimo), il quale, a confronto con quello individuato con il numero che immediatamente lo precede
(1466/97/CE), esibisce, insieme al Protocollo n. 5 del Trattato, la “faccia feroce” del “patto di stabilità e crescita”. In
effetti, non appena, prima ancora dell’inizio della terza fase dell’UEM, la Comunità e gli Stati componenti hanno potuto
considerare raggiunti i traguardi dell’unificazione monetaria e dell’allineamento delle politiche economiche nazionali,
in quello stesso momento si sono risolti a sbrogliare i problemi sollevati dalla sovrapposizione degli obiettivi dinamici
della convergenza economica con quelli statici della conservazione dei miglioramenti parziali ottenuti sulla via che
avrebbe condotto ad essa, approvando i due regolamenti or ora menzionati, deputati, l’uno (1466/97) a impegnare gli
Stati sulla strada del nuovo obiettivo a medio termine “consistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al
pareggio o positivo”, l’altro (1467/97) a obbligarli a “mantenere il disavanzo pubblico entro il valore del 3% del PIL”,
10
(vedi rispettivamente i considerando 3 e 7 premessi a quest’ultimo). Per assolvere a quest’ultimo compito il
regolamento che qui interessa, che obbliga allo stesso modo gli “Stati partecipanti” alla moneta unica e quelli “non
partecipanti”, concentra la propria disciplina sull’apparato strumentale dell’art. 104, da esso costantemente e
puntualmente richiamato, allo scopo duplice di regolare con precisione il funzionamento dei meccanismi di
sorveglianza e l’applicazione delle sanzioni eventualmente irrogate a conclusione dei medesimi. Nell’una e nell’altra
ipotesi, osserva Stammati, esso sembra voler assolvere al proprio compito nello stile normativo puntiglioso di un vero e
proprio regolamento (interno) secondario–esecutivo.
Nella prima, partendo dalla premessa (enunciata nel XV considerando, poi ribadita nell’art. 7 del testo
regolamentare) che il termine di 10 mesi “tra la data per la comunicazione dei dati che indicano l’esistenza di un
disavanzo eccessivo e la decisione, ove ritenuto necessario, di imporre sanzioni” si mostri “realistico ed appropriato al
fine di esercitare sullo Stato membro partecipante interessato” (che non abbia adottato nel corso di esso “provvedimenti
efficaci per correggere” quel disavanzo), “la pressione opportuna per indurlo ad adottare siffatti provvedimenti”, il
regolamento provvede a dettare, all’interno di quel periodo, (sezione 2, articoli 3 – 8) la cadenza temporale di ciascun
provvedimento tipico di sorveglianza, (raccomandazioni, pareri, intimazioni, decisioni di irrogare, intensificare,
sospendere, abrogare, sanzioni) rispetto a ciascun altro. In tale cadenza, che parte dalla data entro cui gli Stati membri
devono comunicare i dati relativi alle proprie posizioni di bilancio, la disciplina regolamentare coinvolge, in aggiunta
agli atti (eventuali) indirizzati dal Consiglio agli “Stati membri partecipanti interessati” e, nei limiti da essa stessa
precisati, agli “Stati membri interessati”(art. 3, commi 3 e 4; articoli 4, 5, 6, 7 e 8) anche quelli (normali) indirizzati da
ciascun organo comunitario a ciascun altro, collocati all’inizio del procedimento di sorveglianza e atti potenzialmente a
concluderlo (art. 3, commi 1 – 3).
Nella seconda ipotesi, (sezione 4, articoli 11 – 16), il regolamento, anzitutto interviene sulle fattispecie
sanzionatorie già individuate dall’art. 104 comma 11, III e IV trattino, TCE, talora per confermarne semplicemente
l’applicazione (ultimo periodo dell’art. 11), talaltra per articolarle ulteriormente (costituzione di un deposito infruttifero
presso la Comunità, versamento di un’ammenda), legittimando in un caso il Consiglio ad esigere un “deposito
infruttifero aggiuntivo” dallo Stato membro partecipante che, ricevuta l’intimazione a ridurre il proprio disavanzo, non
abbia adottato le misure necessarie, (art. 12, comma 2) e prevedendo nell’altro la conversione automatica del primo
deposito in ammenda se, trascorsi due anni dalla decisione che ne abbia imposto la costituzione, il disavanzo eccessivo,
a giudizio del Consiglio, non sia stato corretto (art. 13). Quindi esso interviene sulla quantificazione dei depositi: del
primo, la disciplina regolamentare quantifica direttamente l’elemento fisso (0,2% del PIL) e stabilisce indirettamente
l’elemento mobile (art. 12,comma 1); del secondo stabilisce il metodo per la determinazione dell’ammontare (art. 12,
comma 2); rispetto ad entrambi, stabilisce che debbano essere costituiti “presso la Commissione” (art. 16, I periodo),
che l’importo di ciascuno non possa superare il massimale dello 0,5% del PIL (art. 12, comma 3), e si spinge financo a
precisare con ragionieristica minuzia, che gli interessi maturati su di essi, da considerarsi entrate diverse dalle risorse
proprie della Comunità (art. 269, ex art. 201), debbano essere “redistribuiti tra gli Stati membri senza disavanzo”. (art.
16, II periodo). Con lo stesso spirito occhiuto che mal si confà alla dimensione dei fenomeni affrontati, alla dignità degli
Stati membri e al respiro costituzionale dello stesso “patto di stabilità e crescita”, l’articolo 15 del regolamento si
premura di puntualizzare che, pur dopo l’abrogazione della “decisione sui disavanzi eccessivi” e quella conseguente
delle sanzioni ancora in atto, non siano rimborsate allo Stato membro le ammende risultanti dalla conversione dei
depositi infruttiferi descritti, nel mentre quello successivo riserva agli interessi maturati su di esse lo stesso trattamento
previsto per gli interessi sui depositi.
La presentazione del sistema architettato dal regolamento non può evitare di sollevare conclusivamente un
problema. L’attivazione delle deliberazioni con le quali le sanzioni devono essere adottate dal Consiglio, sono o no
vincolate al quorum di 2/3 previsto dall’art. 104, comma 13, non facendovi il regolamento esaminato il minimo rinvio?
Il dubbio è lecito non sembrando la circostanza casuale, e mostrandosi anzi la risposta negativa quella più conforme agli
aggravamenti che la disciplina del regolamento, espressione di libertà politica, ha apportato a quella dettata dalla
disposizione del Trattato alla quale è collegata, ma non per questo puntualmente subordinata. Ma anche a respingere
quei dubbi, dando peso maggiore agli argomenti adducibili per oppugnare quelli adombrati, resta pur vero, secondo
Stammati, che l’ostacolo frapposto dal quorum anzidetto, potrebbe rivelarsi meno insuperabile nella terza fase
dell’UEM di quanto lo è stato nella seconda. Se, infatti, il Consiglio dovesse fare propria l’idea che lo spirito del
regolamento risieda nella volontà di stendere un cordone sanitario intorno al Paese affetto dal contagioso morbo
denominato “disavanzo eccessivo”, piuttosto che in quella di indagare più a fondo le ragioni specifiche di quel morbo
onde potervi contrapporre adeguate terapie comunitarie, allora la formazione di un fronte comune dei paesi “senza
disavanzo” contro il paese “con disavanzo”, potrebbe essere eventualità, non solo possibile, ma, rispetto a ogni altra,
quella maggiormente probabile. E, in tal caso, gli effetti pratici dell’una o dell’altra soluzione giuridica della questione
discussa, sarebbero assai meno distanti di quanto non siano, sul piano giuridico–formale, le impostazioni, decisionista e
punitiva l’una, garantista e cooperativa l’altra, dalla quale esse rispettivamente discendono.
3. La disciplina comunitaria sulla politica economica e monetaria. Riflessi sul potere di bilancio degli Stati.
Riflessioni minime e rinvii.
11
Si apre, o meglio dovrebbe aprirsi, a questo punto, il capitolo dei riflessi nel diritto interno degli Stati, delle
discipline avanti esaminate. Poiché, però, se lo si svolgesse, farebbe scoppiare i limiti dell’introduzione, Stammati
avverte che si limiterà a considerazioni minime, affidando all’articolazione bibliografica proposta, l’indicazione
schematica delle proprie intenzioni di svolgimento del tema.
Una distinzione possibile dei riflessi interni di tali discipline può essere quella che distingue quelli formali, di
natura generale e indiretta, quelli sostanziali di natura specifica e diretta, infine, quelli procedimentali, di natura
specifica, ma legati alle caratteristiche dell’equilibrio finanziario dei singoli Stati. I primi attengono ai grandi istituti o
concetti del diritto costituzionale (costituzione, Stato, sovranità); i secondi riguardano specificamente il potere di
bilancio degli Stati (potere di indirizzo politico economico, potere di spendere , di imporre tributi); i terzi riguardano
specificamente il sempre più complesso processo di bilancio e gli atti concatenati che ne sono parte costitutiva, il
numero dei quali si accresce (basti pensare al “programma di stabilità” imperativamente previsto dal regolamento
1467/97/CE) e la fisionomia dei quali evolve di continuo (basti pensare ai mutamenti di concezione che negli ultimi
venti anni hanno investito l’istituto della legge finanziaria e, negli ultimi dieci, l’istituto delle “leggi di spesa
collegate”), per effetto dei vincoli comunitari.
L’analisi di questi ultimi limiti, per l’accavallarsi contradittorio delle discipline che li definiscono, talora di
lungo, talora di brevissimo respiro, e per le distorsioni alle quali spesso una medesima disciplina è stata
applicativamente sottoposta, non può essere compiuta con il grado di specificità che essa impone, nel tempo, ormai
vicino all’esaurimento, di questa introduzione. Onde va rinviata senz’altro ad altra sede e/o agli studi, non rari quelli
pregevoli, condotti sul tema degli studiosi di contabilità di Stato citati in bibliografia.
Anche l’analisi delle trasformazioni dei grandi concetti del diritto costituzionale per effetto della
configurazione impressa ai poteri di bilancio degli Stati dalle discipline comunitarie esaminate, alle quali esse sono
effettivamente associate più frequentemente che a discipline di ogni altra specie, postula un impegno alla
chiarificazione teorica dei concetti usati, che, pure se per ragioni opposte a quelle appena denunciate, non può essere
parimenti condotta nell’introduzione. Per esempio le restrizioni a quei poteri (da nessuno studioso negata) si risolvono
nella cancellazione della sovranità degli Stati, o piuttosto in una trasformazione della stessa, o, finiscono per portare allo
scoperto un nucleo irriducibile di quest’ultima che si oppone insuperabilmente a limitazioni ulteriori ad opera di
ordinamenti giuridici sovranazionali pur quando il rapporto di integrazione di questi con quelli nazionali è ormai molto
sviluppato? Si tratta di tesi tutte sostenibili e tutte più o meno recentemente sostenute. La prima e più estrema, ad
esempio, da Guarino che alla negazione della sovranità dello Stato, associa quella dello stesso Stato, pur precisando,
poi, che entrambe le negazioni devono intendersi “nel senso in cui classicamente si intendeva la sovranità.” La seconda,
per esempio, nel Maastrichtsurteil nella quale è esposto il punto di vista democratico – nazionale, onde lo Stato rimane
sovrano finché resta espressione organizzata (attualmente quella di livello più alto) del principio di legittimazione
democratica dei poteri costituzionali e del principio garantistico che assicura tutela integrale ai diritti enunciati dalla
costituzione nazionale. La seconda, ancora ad esempio, è quella recente di E. Denninger, secondo il quale ad essersi
esaurita è la sovranità dello Stato nazionale, senza che ciò comporti il venire meno del concetto e della realtà dello
Stato, il quale, pur assumendo ormai la veste di ente intermediario, resta pur sempre irriducibile al modello degli altri
poteri pubblici territoriali. “Sovranità” ha cessato, dunque, da un pezzo, di essere un concetto categorico, con certezza
di contenuti e di confini, sul quale trovare un appoggio affidabile; al contrario è divenuto un concetto di approdo al
quale si arriva, per affermarla o negarla, a partire da una prospettiva o da un’altra. Ognuna ne offre, quindi, una
rappresentazione diversa, che non per questo è incompatibile con ciascun’altra. Stabilire se si tratti dell’una o dell’altra,
secondo Stammati, è compito di un paziente lavoro di analisi, non dell’introduzione. Questa può limitarsi a constatare
che le tesi dottrinali, pur quando divergono molto, concordano generalmente nel negare alla Comunità europea, anche
nella materia esaminata, la sovranità, in tutto o in parte, sfuggita agli Stati.
Qualche parola in più deve essere detta su quelle che, secondo la classificazione avanti prospettata, possono
denominarsi le incidenze sostanziali dirette delle discipline comunitarie in tema di politica economica e monetaria.
Stammati ricapitola, anzitutto, l’incidenza esercitata da queste ultime sul potere di indirizzo esercitabile dagli
Stati sulla politica economica complessivamente intesa e, più specificamente, su quel più circoscritto oggetto della
medesima costituito dalla politica di bilancio.
Al centro del primo indirizzo sta la politica di bilancio, considerata, però, non solo nella sua articolazione
interna, ma nelle interrelazioni che, a parità di equilibrio di bilancio, essa può intrattenere con altri aspetti della politica
economica nazionale, a quella politica collegati, ma non coincidenti con essa. Si pensi, per esempio alla politica
tariffaria, alla produzione e alla vendita di beni da parte di enti pubblici, le quali incidono (per via diretta) sul livello dei
prezzi e (per via indiretta) su quello dei tassi di interesse. A circoscrivere tale indirizzo stanno, come si è visto, gli
“indirizzi di massima” previsti dall’art. 99 TCE e ribaditi dal regolamento 1466/97/CE, prima articolazione del Patto di
stabilità, nei quali vengono periodicamente indicati obiettivi a medio termine alla politica economica degli Stati,
formalmente configurabili come limiti finalistici di natura politico – giuridica, ai quali gli stessi Stati sono “impegnati”
a conformare gli indirizzi di politica economica annualmente adottati, prima con gli aggiornamenti, anch’essi annuali,
del “Programma di stabilità”, quindi, in Italia, con il DPEF.
A circoscrivere il secondo indirizzo, che ha per oggetto esclusivo la politica di bilancio, stanno, invece, come si
è visto i limiti severi previsti dall’art. 104 CE, che la disciplina del regolamento 1466/97/CE, ha, come si è mostrato,
ulteriormente (oltre che inutilmente) irrigidito. I limiti di questa seconda categoria hanno carattere negativo,
relativamente al disavanzo, positivo rispetto al debito, e configurano, in entrambi i casi, un vero e proprio obbligo
12
giuridico che gli Stati, nell’adottare le proprie decisioni in materia di politica di bilancio, delle quali seguitano ad essere
i responsabili, sono tenuti a rispettare. Si apre, per ciò, a questo punto, la questione se, vista la rigidità dell’obbligo al
quale è sottoposta, la politica di bilancio degli Stati nazionali conservi quei margini di scelta che paiono necessari a
configurare le decisioni, sulla spesa e sull’entrata, che la caratterizzano, come decisioni di indirizzo.
Stammati ricorda in proposito che i limiti giuridici alle politiche nazionali di bilancio, previsti dall’art. 104
TCE e specificati dal Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, sono formulati in termini relativi, anzi
doppiamente relativi, non assoluti. L’oggetto immediato di essi, non è, infatti, l’ammontare annuale o storico delle spese
e/o delle entrate, ma, invece, il rapporto, annuale o storico, delle une rispetto alle altre e, quindi, la commisurazione del
dislivello delle prime rispetto alle seconde all’ammontare del PIL. Più precisamente il Trattato e gli atti collegati
obbligano gli Stati a conservare l’equilibrio annuale fra spese ed entrate raggiunto alla fine della seconda fase
dell’UEM, per quel che riguarda il disavanzo, e a progredire verso il raggiungimento dell’equilibrio storico da essi
stessi astrattamente predeterminato fra spese e entrate e di tale equilibrio rispetto al PIL, entro un termine non
prefissato, per quel che riguarda il debito. Ipoteticamente, dunque, in due Stati che si pareggino quanto ad ammontare
del PIL, potrebbe registrarsi, senza che venga con ciò infranto alcun obbligo comunitario, un livello di spesa pubblica
anche considerevolmente diverso, purché nello Stato ove esso è più alto lieviti parallelamente, anche se non nella stessa
misura, il flusso delle entrate, che dovrà innalzarsi almeno a quel livello, che, maggiorato del 3% del PIL, giunga
all’altezza di quello della spesa. Il potere nazionale di spesa viene, in definitiva, commisurato dalle discipline
comunitarie considerate, a due distinti parametri giuridici, uno mobile, rappresentato dal livello delle entrate pubbliche,
l’altro fisso, rappresentato dalla quota predefinita del PIL, entro la quale deve essere contenuto il dislivello delle spese
rispetto alle entrate. Giuridicamente quest’ultimo è il più severo perché sfugge alle scelte di politica di bilancio degli
Stati, al contrario dell’altro, che può essere determinato da tali scelte. Quantitativamente, però, esso incide solo in
misura modesta sull’ammontare della spesa.
In ogni caso, se ci si fermi a considerarlo in se stesso, l’obbligo di evitare disavanzi eccessivi imposto agli Stati
dall’art. 104 TCE, non è tale, per l’elasticità del primo dei parametri al quale è ancorato, pure attenuata dai limiti che le
regole comunitarie impongono al credito delle banche e a quello del pubblico, da cancellare il loro potere di allestire
una politica di bilancio conformata secondo propri indirizzi generali di politica economica. E’ vero certamente, invece,
che esso viene ridimensionato.
A considerazioni più restrittive induce, invece, la considerazione di quell’obbligo in un quadro normativo più
integrato e in una prospettiva più attenta alla sua applicazione concreta. Relativamente al primo aspetto, infatti, esso non
può essere dissociato dagli impegni alla convergenza ulteriore delle politiche di bilancio assunti dagli Stati comunitari
con l’approvazione del primo dei regolamenti (1466/97/CE) nei quali si articola il “patto di stabilità”, i quali agiranno in
senso contrario alla differenziazione di quelle politiche e delle loro componenti costitutive, di entrata e di spesa. Quanto
al secondo aspetto, esso fa emergere ragioni economiche generali e particolari che irrigidiscono i vincoli discendenti
dallo stesso. Infatti, la politica nazionale delle entrate subisce in tutti gli Stati forti restrizioni causate dalla
mondializzazione dei mercati con le sue implicazioni di mobilità delle attività finanziarie e produttive, la quale alimenta
la concorrenza dei sistemi tributari nazionali, fin qui riottosa, anche in sede comunitaria, all’accettazione di regole
condivise. D’altra parte, quella stessa politica è esposta a condizionamenti specialmente intensi in quegli Stati ove
l’obbligo di rientro da situazioni storiche di indebitamento vincola la politica tributaria dei medesimi ad attestarsi, nel
periodo medio – lungo, su livelli superiori a quelli raggiunti dalla spesa pubblica. Esso agisce, dunque, nello stesso
senso del primo, mostrando in definitiva come i due obblighi stabiliti dall’art. 104 TCE sono destinati ad esaltare, nel
periodo indicato, le differenze fra le politiche di bilancio nazionali legate in vario senso a circostanze negative, attuali o
pregresse, e ad appiattire, invece, quelle dirette ad affermare differenti scelte di indirizzo nella politica economica degli
Stati comunitari.
E’ sensato sperare che al di là di esso avverrà l’inverso?
Apre il dibattito Roberto Guizzi, soffermandosi sulle posizioni di Guarino, al quale obietta un errore di
confusione di fini e mezzi, poiché mitizza l’UEM come fine in sé, mentre il Trattato parla esplicitamente di questa
istituzione come di uno strumento. Riguardo ai poteri della BCE, se è vero che è in corso un trend nel senso di
un’autonomia delle banche centrali in generale, è anche vero che la BCE, salvo per il controllo dei suoi atti attribuito
alla Corte di giustizia, non ha un contrappeso politico che agisca collateralmente, con ciò rappresentando un esempio di
quel deficit democratico spesso citato.
Altra forzatura è quella operata dal Patto di stabilità. Infatti, mentre l’art. 104 del Trattato implicava una certa
elasticità, grazie alla quale l’Italia ed il Belgio sono riusciti ad entrare nell’UEM nonostante non avessero rispettato tutti
i parametri richiesti, il Patto di stabilità è molto più rigido, ad esempio laddove trasforma il mero deposito infruttifero,
disposto nel Trattato, nella sanzione dell’ammenda, determinandosi una sorta di incostituzionalità del regolamento
1467. Vi è stata dunque una debolezza di alcuni governi, tra cui quello italiano, nell’accettare questa camicia di forza
imposta dal ministro tedesco Weigel, mentre sarebbe stato molto più saggio attenersi alle norme del Trattato.
Infine, Guizzi apprezza la citazione di Stammati sul Consiglio europeo, che con i Trattati di Maastricht e di
Amsterdam assume la fisionomia di superistituzione.
Paolo Ridola ringrazia Sergio Stammati per la sua ricca introduzione e riprende la suggestione da lui indicata a
proposito delle ricadute sulla sovranità e sulla democrazia. Non si tratta di due problemi perfettamente coincidenti,
13
poiché l’approccio fondato sulle ricadute sulla sovranità è un approccio fondato sulla dialettica tra pretese di sovranità
concorrenti, mentre l’approccio fondato sulla democrazia può non essere costruito in termini di concorrenza e di
esclusività, a meno di non aderire alla tesi della sentenza Maastricht del Tribunale costituzionale sulla
Mittelbarkeitslehre della sovranità dell’Unione, quindi sulla legittimazione democratica mediata dell’Unione.
Se non si aderisce a questa prospettiva così unilateralizzante, l’approccio fondato sulla democrazia è un
approccio che considera un processo democratico integrato che pervade i diversi livelli, dall’Unione agli stati, alle entità
infrastatuali, come le regioni, i Lander.
Il punto veramente critico è quello del polo decisionale costituito dalla BCE e dalle banche centrali degli stati.
Secondo l’art. 105, l’obiettivo principale di questo polo è il mantenimento della stabilità dei prezzi. L’art. 105 fa poi
riferimento agli altri obiettivi del Trattato sulla Comunità, in particolare agli obiettivi fissati dall’art. 2: piena
occupazione, coesione economico-sociale, sviluppo equilibrato e sostenibile. Ma in sostanza si afferma che tali obiettivi
sono subordinati all’obiettivo primario della stabilità dei prezzi. Il problema è quello di ricondurre l’obiettivo della
stabilità dei prezzi all’interno di un principio democratico, di un processo democraticamente legittimato.
Si può rispondere che questo polo, pur non avendo una legittimazione democratica nel senso del principio
maggioritario (ma la dottrina costituzionale ormai da decenni insegna che il principio democratico non si esaurisce
soltanto nelle logiche del principio maggioritario), può considerarsi comunque soggetto ad un controllo diffuso da parte
dell’opinione pubblica europea. L’importante è che questo controllo diffuso non sia soltanto il controllo dei mercati.
L’importante è che il controllo diffuso dell’opinione pubblica europea sia rappresentata dalla vitalità del tessuto
pluralistico dei singoli stati, che può avere un rendimento diverso.
Ridola non è incline a dare una valutazione totalmente negativa del rendimento democratico di questo polo
decisionale. Chi legga le memorie di Guido Carli, che sono un testo fondamentale per capire molti aspetti della storia
costituzionale della Repubblica, si renderà conto che in realtà, nel lungo periodo durante il quale Carli fu Governatore
della Banca d’Italia, non fu soltanto la stabilità dei prezzi il faro che guidò l’operato della Banca centrale, ma anche
l’equilibrio economico, motivazioni di coesione economica, ecc. Quindi, in fondo, anche le banche centrali si sono
orientate in una direzione un po’ più ampia.
Natalino Ronzitti propone una considerazione sul problema del controllo democratico, già introdotto da
Guizzi e da Ridola. Bisogna pensare alle origini della BCE e al modello che si è voluto seguire, il modello tedesco,
della Bundesbank, svincolata da qualsiasi potere politico. Proprio in vista di questo modello le banche centrali nazionali
hanno dovuto cambiare il proprio statuto. E’ vero che i poteri della BCE sono oggi poco moderati dal Consiglio, anche
se ormai si è stabilita una certa dialettica tra Consiglio e BCE, secondo quello che hanno voluto alcuni stati membri, ma,
ad esempio, un dibattito, che non è vero e proprio controllo, può essere aperto nel Parlamento europeo: la BCE, infatti,
deve riferire almeno una volta l’anno la propria politica monetaria al Parlamento europeo.
La BCE oggi si sente svincolata da quello che è il sistema comunitario. Vi è attualmente un procedimento in
corso tra Commissione e BCE per quanto riguarda la repressione delle frodi e la BCE ha dichiarato che questo sistema
non si applica a lei, poiché la BCE non farebbe parte dell'ordinamento comunitario così come ne fanno parte altre
istituzioni comunitarie. Ciò, a prescindere da come andrà a finire il procedimento, è sintomatico degli indirizzi della
BCE.
Inoltre, sulla questione della sovranità, vi è da dire che la sovranità monetaria è uno dei simboli esterni
maggiormente incisivi dello stato, così come la sovranità nel campo della difesa. La conclusione che Ronzitti dà è che la
sovranità monetaria, per il momento, è stata ceduta.
Un quesito cui finora nessuno ha dato una risposta è se questo sistema è un sistema necessario: cosa
succederebbe se uno stato membro, parte dell’UEM, decidesse di uscire? Potrebbe farlo pur restando nell’ambito
dell’Unione europea e della Comunità europea? Cosa succederebbe poi se uno stato non fosse più virtuoso? Dopo la
sanzione della trasformazione del deposito infruttifero in ammenda, se questo stato continuasse a derogare ai parametri
stabiliti, vi sarebbe la possibilità di un’espulsione? Una risposta non è ancora stata data, e per questo Ronzitti conserva
dei dubbi sull’effettiva sovranità monetaria della BCE. Dei limiti, infatti, vengono posti anche da altre istituzioni
monetarie, come il Fondo monetario internazionale, ma nessuno ne deduce un trasferimento di sovranità. Infine,
bisogna ricordarsi che i Trattati mutano nel tempo: finora sono mutati nel senso di una maggiore integrazione, ma non è
detto che sarà sempre così.
Interviene Augusto Cerri, secondo cui la filosofia attuale è quella del non nuocersi, che si esplica in un potere
negativo. Cerri si domanda quanto l’iperpotere della BCE sia conseguenza di questa filosofia e quanto invece di modelli
nazionali. Tale filosofia del non nuocersi, si domanda ancora Cerri, è uno stato temporaneo determinato dal deficit di
democrazia oppure è un modo stabile per eliminare il circuito della democrazia?
Quindi, in questa fase, più che porsi problemi di etichettatura, forse sarebbe bene concentrarsi su di un
recupero di democraticità ad ogni livello in cui è possibile.
Salvatore Alberto Romano si domanda: se, come detto da Ronzitti, il modello prescelto per la BCE è stato
quello tedesco, della Bundesbank, a sua volta indipendente dalle strutture politiche e governative tedesche, allora in
Germania lo stato aveva già perso la propria sovranità monetaria a favore della Banca centrale? Inoltre, a proposito di
democrazia, la posizione d’indipendenza della Banca centrale tedesca non rispondeva proprio al fatto che la società
14
tedesca riteneva che i propri interessi fossero meglio tutelati da una Banca centrale indipendente, piuttosto che da un
meccanismo che garantisse il principio democratico?
Prende la parola Guido Sirianni, il quale esprime una considerazione circa l’ideologia economica che è
immanente al modello della BCE. E forse questo è ciò che distingue il modello della BCE rispetto al modello di Banca
centrale che abbiamo avuto in Italia fino alla riforma introdotta dietro sollecitazione dell’UE. Non è un caso che
abbiamo avuto una legge bancaria che è sopravvissuta a stagioni economiche completamente diverse: uno stesso istituto
ha continuato a svolgere la sua funzione regolatrice del mercato finanziario dal fascismo alla guerra, dalla ripresa
liberale einaudiana al momento del centrismo ed alla espansione dello stato sociale. L’interrogativo che Sirianni si pone
è se questa istituzione europea, così segnata da una cultura economica, abbia quelle caratteristiche di flessibilità e di
duttilità che le possono consentire di reggere la prova del tempo.
A proposito del rendimento democratico, Paolo Ridola parlava di un controllo che non deve essere solo quello
dei mercati. Nei documenti comunitari ed anche nel Trattato emerge l’enorme problema della coesione interna. Questa
coesione interna, coesione sociale, non è altro che il tentativo di arricchire i parametri di valutazione in ragione dei quali
devono essere orientate le politiche comunitarie e quindi anche la politica monetaria fatta attraverso le istituzioni
comunitarie. E’ cioè impensabile che soltanto in funzione di una pur rispettabilissima cultura economica si possa
realizzare un elemento di rigidità che è incompatibile con il dato dell’istituzione politica, che per forza di cose deve
avere degli enormi elementi di flessibilità e duttilità interna.
Inoltre, a proposito della sovranità, è vero che questa implica il controllo sulle politiche monetarie, e sappiamo
anche che l’esperienza dello stato sociale ha condotto ad un ingigantimento del ruolo dello stato come intermediario
finanziario. Quindi, dall’idea della sovranità concepita solamente come potere di imposizione fiscale, si è passati ad
un’idea molto più ampia di una sovranità democratica o sociale concepita come possibilità di ridistribuire chances di
vita nell’ambito del corpo sociale.
Sirianni ricorda come Stammati abbia spiegato che le nostre nozioni di PIL in realtà sono neutrali, perché il
PIL può essere variamente ridistribuito tra economia pubblica ed economia privata: cioè che possiamo allargare e
ridurre a piacimento questa potestà di riallocazione propria della sovranità statale. Questo è certamente vero, ma
bisogna considerare che si tratta di dati storici, che devono sempre essere confrontati con le dinamiche reali e con il
problema della coesione sociale. Si può anche immaginare che uno stato sovrano, membro della UE, decida di colpo di
cambiare radicalmente la propria missione nella ridistribuzione delle chances di vita, orientandosi per esempio in un
senso liberale piuttosto che ridistributivo e sociale, ma sembra una possibilità virtuale: gli spostamenti potranno essere
del 2 o 3%. E’ follia pensare che la barra del timone possa essere spostata a piacimento in una direzione piuttosto che in
un’altra.
Un altro interrogativo che Sirianni si pone riguarda le sorti del debito. Noi finora abbiamo vissuto in una
rassicurante convinzione che in fondo il problema dei 2.400 milioni di miliardi di debito fosse un problema relativo,
perché si tratta di un indebitamento interno. Oggi è come se sull’Italia ricadesse un omen tragico in ragione di scelte di
cultura economica, prima ancora che di responsabilità politica, che sono state fatte nel passato.
E’ veramente stravagante che i figli dei figli dovranno continuare a pagare per chi sa quanto tempo le
responsabilità che non sono solo responsabilità di dissipazione di risorse pubbliche, ma che dipendono anche da
politiche economiche svolte quando esisteva una cultura economica orientata sul deficit spending, che non era
considerato un crimine in termini economici, ma anzi era considerato un risvolto del tutto positivo.
Gaetano Azzariti si chiede se la BCE sia espressione di una nuova forma della sovranità e della democrazia, o
se le cose esposte possono essere interpretate come la conclusione di un percorso di impoverimento della pienezza del
concetto di democrazia così come siamo stati abituati a concepirla. Si potrebbe anche dire che non si tratta di un
impoverimento, bensì di una mera trasformazione, che si tratta di un processo che viene da lontano, già presente, in
nuce, alle origini dell’istituzione della Comunità, negli anni ‘50, quando si è affermata l’idea che alcuni valori e alcuni
fini, fino ad allora propri dei sistemi democratici, dovessero essere espunti dalla dialettica democratica.
Azzariti è d’accordo con Paolo Ridola quando afferma che la democrazia non è soltanto sistema maggioritario
e neppure soltanto legittimazione dei poteri, bensì contempera anche altri elementi quali il ruolo dell’opinione pubblica
ed il controllo come forma di espressione dei demoi, per cui non è escluso che alcuni elementi vengano estraniati dal
tradizionale circuito democratico. Tuttavia, questa estraniazione si è sempre più ampliata dagli anni ‘50, ed oggi ha
raggiunto un’estensione che fa un po’ impressione, perché questi valori–fini che vengono estraniati dal circuito
democratico sono la stabilità dei prezzi, la stabilità economica in generale, i parametri di Maastricht che tanto
condizionano non solo l’economia, ma anche la politica. Fino a far ritenere – è l’argomentazione di Guarino – che
ormai l’impossibilità di fare politica monetaria significa impossibilità per gli stati di fare politica tout court. Dunque,
fine della politica ed espansione dell’economia a-sovrana e a-democratica.
Si è veramente giunti a questo? Azzariti nota che, in fondo, non è così se rimane agli stati una capacità
ridistributiva, di fare politica non solo tout court, ma anche politica economica. Cosa riserva allora il futuro? Secondo la
prima ipotesi, solo la conclusione del processo, e dunque la fine della sovranità e della democrazia. Secondo un’altra
ipotesi questo ciclo non può trovare una sua così lineare soluzione: pensando alla tendenza verso l’integrazione europea
che ha fasi oscillanti, che sembra andare molto avanti, ma che ogni tanto torna indietro, e che in questa fase è in
15
arretramento sul piano del consolidamento dell’integrazione, come dimostratosi a Nizza, può darsi che l’integrazione
europea non abbia una prospettiva così negativa per le sorti della democrazia.
Gianclaudio De Cesare interviene a proposito di alcuni problemi presenti sin dall’origine dell’Unione
monetaria. Un primo problema riguarda il Consiglio dei ministri degli stati membri dell’UEM e la sua posizione
sostanziale rispetto alla costruzione comunitaria tradizionale. Quest’organo, separato dall’UE, potrebbe infatti
estromettere le altre istituzioni comunitarie dalla gestione della politica monetaria. De Cesare ritiene invece che il
coordinamento della politica finanziaria debba permanere nell’ambito dell’Unione europea.
In questo quadro si pone il problema del ruolo che occupano il nostro Esecutivo ed il nostro Parlamento
nell’ambito della gestione dell’Unione monetaria. L’Italia, che rappresenta il grande punto debole dell’UEM, ha
bisogno di recuperare un’influenza politica. In particolare, il Parlamento dovrebbe acquisire un ruolo di correzione e di
indirizzo nei confronti dell’Esecutivo quando si tratti, ad esempio, di assicurare il rispetto del Patto di stabilità.
De Cesare sostiene che quella attuale è una fase iniziale dello sviluppo dei problemi dell’Euro, per cui è
necessario farsi carico, da un punto di vista costituzionale, del riflesso che ciò determina, non tanto a livello teorico ed
astratto, quanto piuttosto a livello puntuale, analizzando i poteri degli organi costituzionali interni.
Prende la parola Francesco Cerrone, che ringrazia Sergio Stammati, la cui introduzione suscita una domanda
circa il rapporto tra i vincoli determinati dalla normativa comunitaria e che riguardano il Patto di stabilità interna, la
stabilità dei prezzi, ecc. ed i vincoli che derivano, per ciascuno stato membro, dalle politiche comunitarie, e persino da
settori non formalmente ricompresi in queste ultime. Ad esempio, la filosofia ispiratrice della riforma universitaria, il
c.d. 3+2, nasce anche dall’esigenza, almeno secondo le dichiarazioni, di seguire un’ispirazione comune quanto meno ad
alcuni paesi dell’Unione. D'altra parte, l’Università è stata fatta oggetto di cospicui tagli alla spesa a partire dal '97, per
cercare di venire incontro alle esigenze imposte dalle compatibilità finanziarie europee. Sarà ancora aperto, allora, uno
spiraglio di speranza, per il disastrato sistema universitario italiano, speranza che possa derivare dalla pressione dei
controlli comunitari su questo settore? Ad esempio, l'Università di Perugia ha una biblioteca che è aperta in orari
ristrettissimi, come in nessun'altra università europea. D'altra parte, c'è una situazione finanziaria che sembra imporre
questa situazione. Come possono trovare composizione le esigenze di contenimento della spesa e quelle di omogeneità
delle politiche? Se questa composizione non è destinata a trovare spazio nella dialettica fra stati ed istituzioni
comunitarie, come potranno rintracciarsi opportunità reali di innesto, in un tessuto democratico comune - caratterizzato
da opinioni pubbliche vitali e capaci di controllo - delle istituzioni bancarie europee? Infine, Cerrone fa presenti delle
perplessità circa la prospettiva indicata da Paolo Ridola sulla vitalità del tessuto pluralista della società italiana.
Sergio Stammati ringrazia tutti i presenti e particolarmente i colleghi intervenuti. Precisa di aver cercato di
conservare in queste sue osservazioni il carattere immediato e asistematico del dialogo.
Condivide nel loro complesso le osservazioni di Guizzi; ritiene anch’egli che il regolamento 1467/97/CE
aggravi la disciplina parametro dell’art. 104, ma che, non ostante ciò, la disciplina di quell’atto non faccia venire meno
l’elasticità delle valutazioni relative alla consistenza dei progressi fatti registrare dal debito.
La tesi di Ridola circa la concorrenzialità (e forse l’antagonismo) degli Stati con l’Unione a proposito della
sovranità e circa la non necessaria concorrenzialità dei medesimi soggetti riguardo agli indicatori di democraticità dei
rispettivi sistemi, gli sembra meritare ogni attenzione e, nella sua seconda parte, quella più problematica, sollecitare
approfondimenti adeguati alla cifra, così tipicamente costituzionale, dei problemi che solleva. Indubbiamente la
questione dell’individuazione di nuove forme di legittimazione delle istituzioni munite di ampia responsabilità di
governo, come la BCE, che va di pari passo con la constatazione del declino delle vecchie, è di grandissima portata. In
ogni caso gli sembra da evitare (e presume essere così anche per Ridola) che la distinzione delle une dalle altre sia
spinta fino a renderle non comunicanti; e quanto all’esperienza della politica Carli – Colombo, che non è tanto ingenuo
da giudicare per il valore che ebbe a suo tempo, non la ritiene fonte di suggerimenti utili all’oggi delle istituzioni
europee.
Le osservazioni di Ronzitti (e l’esempio concreto da lui addotto) sono appunto, dirette contro il tessuto
connettivo troppo esangue tra i due tipi di legittimazione delle principali istituzioni comunitarie, quello della BCE e
quello delle altre. Come dargli torto? Circa l’interrogativo da lui sollevato, Stammati esprime l’opinione che, allo stato
attuale (assai avanzato) dell’integrazione degli ordinamenti statali con quello comunitario, l’uscita, transitoria e
concordata, degli Stati comunitari dalla sola UEM possa essere concepita ipotizzando l’attivazione di regimi derogatori
assimilabili a quello previsto dall’art. 122 (ex 109 k) TCE, piuttosto che all’approvazione di nuovi protocolli che
prevedano nuove, temporalmente indeterminate, clausole di opting out. Quanto all’uscita dall’UEM, e insieme, dalla CE
e dall’Unione europea, egli ritiene che gli Stati membri, avendo ceduto alla CE e all’UE fino alla data futura e incerta in
cui una modificazione unanimemente condivisa dei Trattati istitutivi dei due ordinamenti sovranazionali preveda quella
eventualità, i poteri sulla base dei quali quegli ordinamenti sono stati fondati, essi potrebbero riappropriarsene, o
sostenendo che gli organi esponenziali dei medesimi si muovono contro i valori supremi della convivenza pacifica e
dello sviluppo socioeconomico delle nazioni, affermati dalle proprie costituzioni, oppure assumendosi in via di fatto la
responsabilità di riappropriarsene.
Cerri, se il suo pensiero non è stato frainteso, osserva come a una certa grandiosità della costruzione europea
non corrisponda una filosofia politico–istituzionale adeguata. Tale non può considerarsi, infatti, a suo avviso, quella
16
del “non nuocersi” degli Stati, nella quale essa si esprimerebbe. In effetti, un’osservazione come questa può servire a
spiegare perché sempre più di frequente, a partire dall’avvio della III fase dell’UEM, e in particolare dalla prima metà
del 2000 fino ad oggi, siano stati enunciati in sedi politiche comunitarie e nazionali favorevoli a dare ad essi alta
risonanza, progetti di riforma dell’organizzazione politica dell’UE, nei quali è percepibile la preoccupazione di larghi
strati della dirigenza politica degli Stati membri, che l’integrazione economica raggiunta dall’ordinamento
giuridico–economico comunitario, possa pretendere troppo da se stessa e, privata troppo a lungo del sostegno di
istituzioni politiche radicate nei valori del costituzionalismo delle origini, rischi di regredire verso forme integrative più
rudimentali di quelle attualmente raggiunte. Inoltre, se dalla stessa osservazione si ritorna al tema della Banca centrale
europea, ci si avvede facilmente come l’assimilazione della stessa alla Bundesbank (fondata principalmente
sull’obiettivo, comune ad entrambe, di garantire la stabilità dei prezzi) trascuri del tutto la relazione delle due banche
con l’ambiente istituzionale circostante. La banca federale tedesca nasce, infatti, contestualmente agli organi
costituzionali fondamentali, democraticamente caratterizzati, di quella Repubblica federale ed è rispetto alla
potenziale ingerenza di questi ultimi che la legge fondamentale si preoccupa di proclamarne l’indipendenza; la BCE,
nasce, invece, prima che gli organi costituzionali europei abbiano acquisito quella piena caratterizzazione democratica,
in un momento nel quale è ancora incerto se mai la acquisiranno, onde la sua posizione rispetto ad essi appare
caratterizzata più che dall’indipendenza, dal fatto di immedesimare una più forte rappresentazione di unità degli Stati
comunitari. Se le cose stanno così, è lecito affermare (rivolgendosi qui ad Azzariti) che l’istituzione della BCE
corrisponde al limite massimo di dilatazione della concezione funzionalistica della CE, oltre il quale non può esserci
(questo è almeno ciò che Stammati si augura) se non il cammino verso il recupero delle forme basilari della convivenza
civile e politica già realizzate nella forma liberal–democratica degli Stati. In questi ultimi la democrazia politica ha
generalmente preceduto le forme di democrazia (di autonomia) funzionale; nella RFT (in risposta a Romano), le due
forme (la sovranità politica dello Stato federale e quella funzionale della Bundesbank) sono emerse contestualmente,
onde non può parlarsi di una perdita della seconda da parte del soggetto titolare della prima; nell’organizzazione
sovranazionale europea (prima CEE, poi CE e UE), che poteva usufruire della rendita democratica ad essa garantita
dagli Stati dai quali è stata istituita, si è potuto percorrere il tragitto inverso, che va dalla caratterizzazione funzionale a
quella politica. Quelle due anime, però, sono destinate, anche se in forme probabilmente nuove, a riunificarsi. Se così
non dovesse essere, si potrebbe forse affermare che l’UE ci ha fatto scoprire una nuova forma di democrazia?
Stammati condivide le affermazioni di Sirianni circa la connessione fra modello istituzionale della BCE e
costituzione economica a struttura liberale della CE, circa le rigidità che ne conseguono per le politiche economiche
degli Stati, e circa le preoccupazioni che ciò desta. I margini per tali politiche che, fino alla fine degli anni ‘70, venivano
guadagnati a scapito degli equilibri monetari; da quel momento in poi, e tanto più ora dopo l’ingresso dell’Italia nella
terza fase dell’ UEM, possono essere riconquistati, invece, non attraverso la modifica dei meccanismi di controllo
della politica monetaria e del modello BCE, ma intensificando i processi di innovazione tecnologica e di crescita
economica. Per gli Stati più indebitati la riconquista di questa nuova libertà sociale sarà, dunque, durissima e forse potrà
essere possibile solo se l’UE saprà attivare meccanismi di effettiva solidarietà fra gli Stati. Stammati condivide pure
l’opinione di De Cesare se, come è stata intesa, afferma che i Governi dei singoli Stati potranno riconquistare effettiva
autonomia nell’esercizio della politica economica (che fra l’altro il Trattato affida formalmente alla loro responsabilità
particolare) solo se la perseguiranno all’interno delle possibilità offerte da un coordinamento comunitario più attivo
delle politiche economiche nazionali e in contesto di responsabilità condivise dai massimi organi costituzionali e dagli
enti dell’autonomia territoriale.
Quanto, infine, alla questione posta da Cerrone, essa offre l’occasione giusta a portare l’attenzione sulla relazione
particolare che la politica e le istituzioni intrattengono reciprocamente nel contesto della Comunità e dell’Unione
europea. Quella relazione sembra richiamare le forme costituzionali del primo Stato liberale di diritto, ove la politica,
strutturalmente, si esprimeva tutta all’interno del guscio delle istituzioni rappresentative, e, funzionalmente, si esauriva
nella creazione di regole giuridiche. Se si conviene che sia tale cifra tutta istituzionale e normativa della politica a
caratterizzare l’insediamento di quest’ultima nel contesto sovranazionale europeo, allora non v’è da stupirsi che anche
le non molte espressioni della medesima che si enunciano con modalità difformi da quelle proprie del modello
dominante, finiscano per assumere, per l’attrazione esercitata su di esse da quel modello, un’impropria valenza
istituzionale e normativa.
17