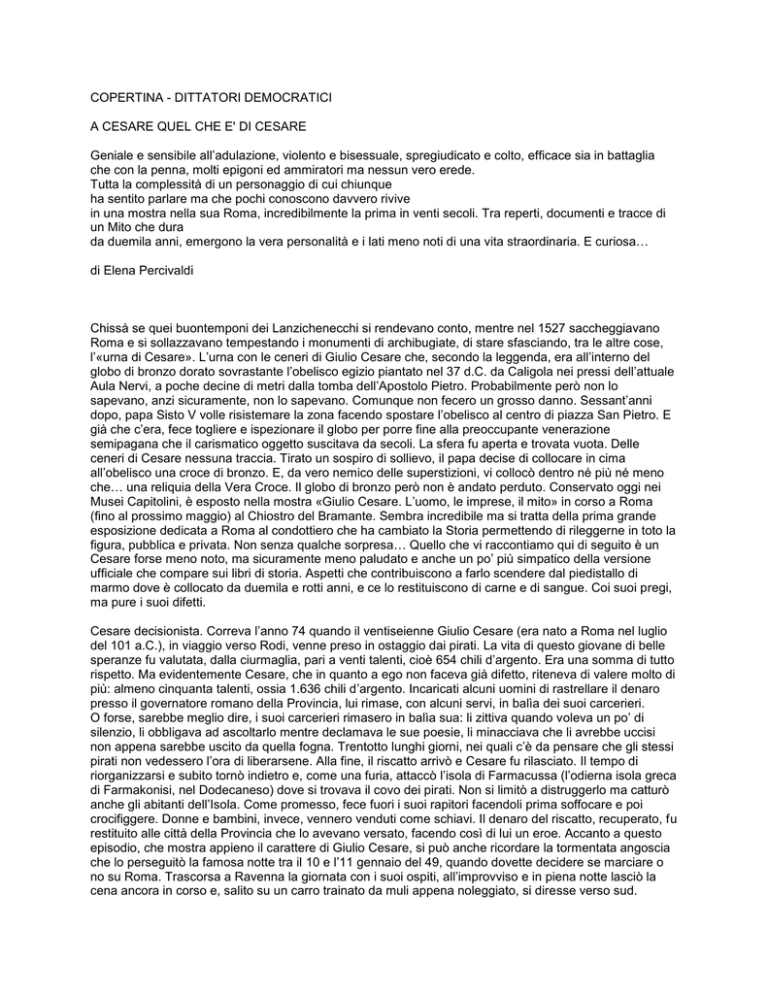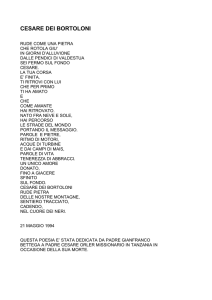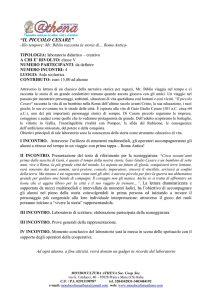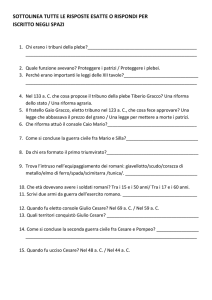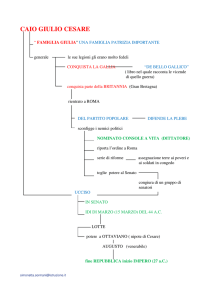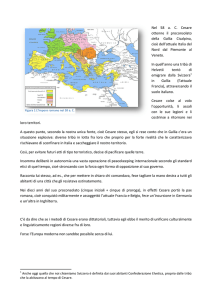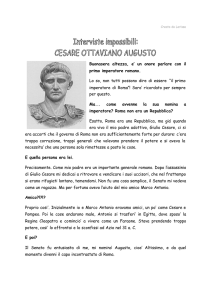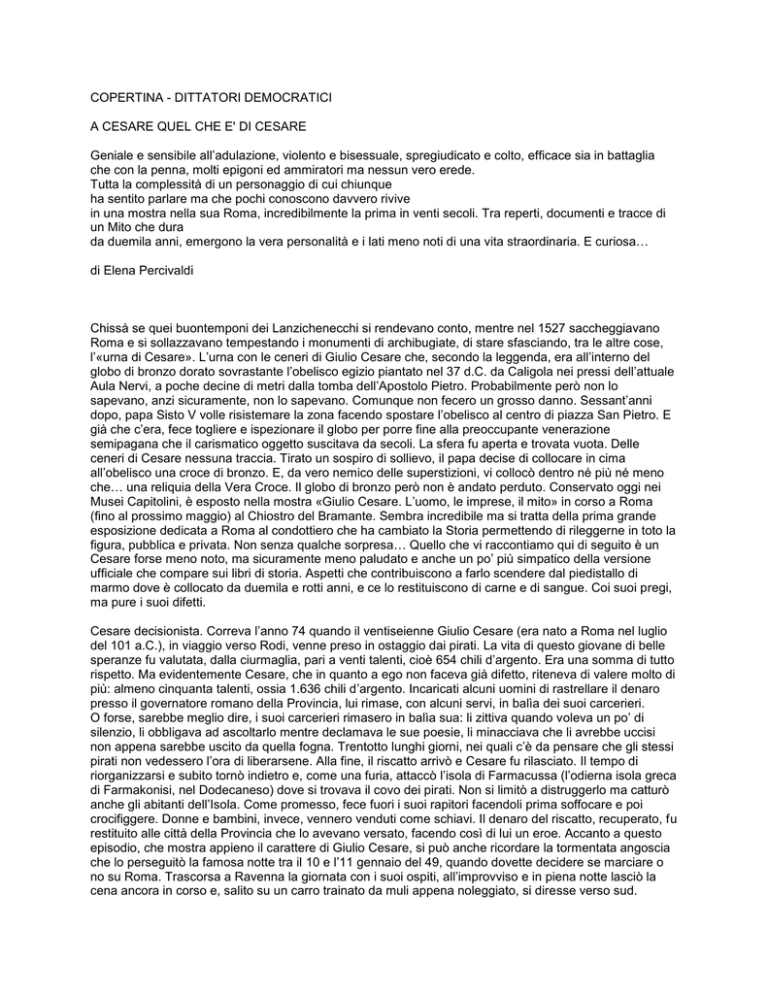
COPERTINA - DITTATORI DEMOCRATICI
A CESARE QUEL CHE E' DI CESARE
Geniale e sensibile all’adulazione, violento e bisessuale, spregiudicato e colto, efficace sia in battaglia
che con la penna, molti epigoni ed ammiratori ma nessun vero erede.
Tutta la complessità di un personaggio di cui chiunque
ha sentito parlare ma che pochi conoscono davvero rivive
in una mostra nella sua Roma, incredibilmente la prima in venti secoli. Tra reperti, documenti e tracce di
un Mito che dura
da duemila anni, emergono la vera personalità e i lati meno noti di una vita straordinaria. E curiosa…
di Elena Percivaldi
Chissà se quei buontemponi dei Lanzichenecchi si rendevano conto, mentre nel 1527 saccheggiavano
Roma e si sollazzavano tempestando i monumenti di archibugiate, di stare sfasciando, tra le altre cose,
l’«urna di Cesare». L’urna con le ceneri di Giulio Cesare che, secondo la leggenda, era all’interno del
globo di bronzo dorato sovrastante l’obelisco egizio piantato nel 37 d.C. da Caligola nei pressi dell’attuale
Aula Nervi, a poche decine di metri dalla tomba dell’Apostolo Pietro. Probabilmente però non lo
sapevano, anzi sicuramente, non lo sapevano. Comunque non fecero un grosso danno. Sessant’anni
dopo, papa Sisto V volle risistemare la zona facendo spostare l’obelisco al centro di piazza San Pietro. E
già che c’era, fece togliere e ispezionare il globo per porre fine alla preoccupante venerazione
semipagana che il carismatico oggetto suscitava da secoli. La sfera fu aperta e trovata vuota. Delle
ceneri di Cesare nessuna traccia. Tirato un sospiro di sollievo, il papa decise di collocare in cima
all’obelisco una croce di bronzo. E, da vero nemico delle superstizioni, vi collocò dentro né più né meno
che… una reliquia della Vera Croce. Il globo di bronzo però non è andato perduto. Conservato oggi nei
Musei Capitolini, è esposto nella mostra «Giulio Cesare. L’uomo, le imprese, il mito» in corso a Roma
(fino al prossimo maggio) al Chiostro del Bramante. Sembra incredibile ma si tratta della prima grande
esposizione dedicata a Roma al condottiero che ha cambiato la Storia permettendo di rileggerne in toto la
figura, pubblica e privata. Non senza qualche sorpresa… Quello che vi raccontiamo qui di seguito è un
Cesare forse meno noto, ma sicuramente meno paludato e anche un po’ più simpatico della versione
ufficiale che compare sui libri di storia. Aspetti che contribuiscono a farlo scendere dal piedistallo di
marmo dove è collocato da duemila e rotti anni, e ce lo restituiscono di carne e di sangue. Coi suoi pregi,
ma pure i suoi difetti.
Cesare decisionista. Correva l’anno 74 quando il ventiseienne Giulio Cesare (era nato a Roma nel luglio
del 101 a.C.), in viaggio verso Rodi, venne preso in ostaggio dai pirati. La vita di questo giovane di belle
speranze fu valutata, dalla ciurmaglia, pari a venti talenti, cioè 654 chili d’argento. Era una somma di tutto
rispetto. Ma evidentemente Cesare, che in quanto a ego non faceva già difetto, riteneva di valere molto di
più: almeno cinquanta talenti, ossia 1.636 chili d’argento. Incaricati alcuni uomini di rastrellare il denaro
presso il governatore romano della Provincia, lui rimase, con alcuni servi, in balìa dei suoi carcerieri.
O forse, sarebbe meglio dire, i suoi carcerieri rimasero in balìa sua: li zittiva quando voleva un po’ di
silenzio, li obbligava ad ascoltarlo mentre declamava le sue poesie, li minacciava che li avrebbe uccisi
non appena sarebbe uscito da quella fogna. Trentotto lunghi giorni, nei quali c’è da pensare che gli stessi
pirati non vedessero l’ora di liberarsene. Alla fine, il riscatto arrivò e Cesare fu rilasciato. Il tempo di
riorganizzarsi e subito tornò indietro e, come una furia, attaccò l’isola di Farmacussa (l’odierna isola greca
di Farmakonisi, nel Dodecaneso) dove si trovava il covo dei pirati. Non si limitò a distruggerlo ma catturò
anche gli abitanti dell’Isola. Come promesso, fece fuori i suoi rapitori facendoli prima soffocare e poi
crocifiggere. Donne e bambini, invece, vennero venduti come schiavi. Il denaro del riscatto, recuperato, fu
restituito alle città della Provincia che lo avevano versato, facendo così di lui un eroe. Accanto a questo
episodio, che mostra appieno il carattere di Giulio Cesare, si può anche ricordare la tormentata angoscia
che lo perseguitò la famosa notte tra il 10 e l’11 gennaio del 49, quando dovette decidere se marciare o
no su Roma. Trascorsa a Ravenna la giornata con i suoi ospiti, all’improvviso e in piena notte lasciò la
cena ancora in corso e, salito su un carro trainato da muli appena noleggiato, si diresse verso sud.
Contemporaneamente, per altre strade, le sue legioni si stavano dirigendo nella sua stessa direzione:
l’appuntamento, per generale e soldati, era Ariminium, l’odierna Rimini, prima città del pomerium, il limite
sacro di Roma, oltre il quale nessuno poteva portare armi. Il confine era fissato al fiume Rubicone, oggi
incluso nella provincia di Forlì-Cesena: Cesare giunse alle sue rive in ritardo, essendosi smarrito per il
buio con un manipolo dei suoi, e qui si fermò, meditando sul da farsi. Prima si confrontò coi pochi
presenti, in particolare con il fido Asinio Pollione, in merito alle conseguenze inevitabili legate
all’attraversamento del fiume – cioè, la dichiarazione della guerra civile -, ma anche sull’eventualità di una
ritirata; poi si ricordò dello strano incubo fatto la notte prima, quando aveva sognato un rapporto
incestuoso con la madre. La lettura psicanalitica dell’episodio è chiara: una metafora del rapporto
amore-odio, presente e futuro, verso la «madre» Roma. Meno chiara l’interpretazione della visione
seguente, che avvenne all’improvviso, lì, sul greto del torrente: un giovane bellissimo, perfetto come una
statua greca, suonando il flauto invitava il generale a compiere il fatidico gesto. Comunque sia, Cesare
decise di passare il fiume pronunciando la famosa frase: «Alea iacta est», il dado è tratto. Quella
decisione cambiò la storia di Roma. E quindi del mondo.
Cesare scrittore. Raffinato, essenziale, obiettivo. Si potrebbe dire «giornalistico», intendendo con ciò il
giornalismo buono, quello basato sui fatti e non sui facili e chiassosi sensazionalismi. Quello, insomma,
delle famose «cinque w»: who, when, where, what, why, ossia chi, quando, dove, cosa e perché. Questo
lo stile del Nostro alle prese con i resoconti in terza persona delle sue grandi campagne militari, guerra
gallica e guerra civile, pubblicate nei celeberrimi «Commentarii». Opere che sono diventate un classico, e
sulle quali ancora oggi sudano gli studenti dei licei. «Nudi, schietti e pieni di grazia, spogliati di ogni
abbellimento oratorio come un corpo senz’abito», li definì il suo antipode politico e stilistico Cicerone,
tradiscono lo spirito pratico e «militare» appunto del suo autore, non certo amante dei vezzi inutili. Ma
anche il suo spirito politico. Dietro l’apparente semplicità e l’impassibile obiettività della narrazione,
emerge l’intento di presentare le proprie imprese belliche non come una iniziativa personale (cosa che gli
rinfacciava il Senato), ma come un fatto necessario per proteggere l’incolumità della stessa Roma dalle
minacce esterne. Idem la guerra civile: anch’essa necessaria, e non certo perché lui prendesse il potere
ma per difendere Roma dal nemico. Cesare, ci tiene a sottolinearlo: a differenza di Pompeo e dei suoi
seguaci era uno che si muoveva nel solco della tradizione, e che meditava ogni mossa mantenendosi
ben dentro l’alveo delle leggi romane: guai ad accusarlo di essere un rivoluzionario, lui era solo un uomo
d’ordine. Intendiamoci. Non che Cesare abbia mai falsato la realtà «inventando» di sana pianta. Ma
scrivendo la storia, si possono anche scrivere mezze verità, omettendo fatti scomodi. Oppure decisioni
sbagliate, a giustificare un proprio eventuale insuccesso. Comunque, lo stile, l’abilità letteraria e la grande
autostima di Cesare si riassumono nell’iscrizione che dettò in occasione del trionfo contro il ribelle
Farnace II, re del Ponto, nel settembre del 46: «Veni, vidi, vici», ossia «Venni, vidi, vinsi». Tanto asciutta
ed efficace da diventare proverbiale.
Cesare ingegnere e stratega. Quale migliore dimostrazione delle sue capacità se non le gigantesche
macchine d’assedio approntate, ad esempio, durante la guerra gallica? Per prendere Alesia, l’odierna
Alise-Sainte-Reine, e sconfiggere il capo dei galli Vercingetorige, fece costruire una doppia fortificazione
del perimetro di dieci miglia (15 km) – quella interna (controvallazione) – e 14 miglia (21 km) quella
esterna (circonvallazione), lungo la quale pose a guardia ventitre fortini (castella) presidiati notte e giorno
da sentinelle. A quattrocento passi (600 m) circa di distanza, fu scavato un fossato di venti piedi (circa sei
metri), poi altri due fossati larghi altri cinque metri il più interno dei quali fu riempito di acqua deviata dal
fiume. Dietro ai fossati, un terrapieno fortificato alto quattro metri e dotato di rostri e plutei sporgenti per
ostacolare un’eventuale scalata dei nemici. Chi fosse riuscito a passare sarebbe finito infilzato sui tronchi
appuntiti posti a gruppi di cinque in fosse profonde un metro e mezzo, oppure sarebbe morto nelle
trappole che, accuratamente nascoste da fascine di rami, celavano buche ricolme di altri tronchi d’albero
appuntiti (bocche di lupo). Davanti a questi trabocchetti, Cesare fece piantare in terra una moltitudine di
pioli di ferro uncinati, e completò l’opera schierando intorno alla fortificazione un gran numero di
macchine da guerra. Tracce di tutto l’apparato sono riemerse durante parecchie compagne di scavo, e
tutte non hanno fatto che confermare la genialità di Cesare come stratega militare. E anche la sua
concezione «utilitaristica» delle imprese di costruzione, come il ponte sul Reno fatto costruire in soli dieci
giorni e poi distrutto una volta terminata la missione. Fatte per restare (e già che c’era, per glorificarlo)
dovevano invece essere le grandi costruzioni realizzate a Roma tra cui, appunto, il Foro che porta il suo
nome, la ricostruzione della Basilica Sempronia inaugurata nel 46, che da lui prenderà il nome di Giulia,
quella dei Rostri, il teatro Marcello, la nuova Curia Iulia, che sarà portata a termine solo da Augusto. Oltre
al grandioso progetto che prevedeva addirittura di deviare il corso del Tevere, configurando una vera e
propria rivoluzione urbanistica per una Roma che si stava espandendo tanto da diventare il nuovo punto
di riferimento del Mediterraneo.
Cesare divo. Una cosa è certa: a Cesare l’autostima non faceva difetto. Ma non ritenendo forse
sufficiente il proprio indubbio valore politico e militare a conferirgli il prestigio necessario a governare,
pensò con un colpo di genio di legittimare la propria persona legandola alla stirpe divina. Per farlo, si
proclamò discendente di Enea, mitico padre fondatore di Roma, che in quanto figlio di Venere aveva il
pedigree che occorreva. A Venere, dunque, Cesare dedicò un tempio a Farsalo (in Tessaglia, Grecia)
che iniziò a far costruire l’indomani della vittoria contro Pompeo. A Roma, nel Foro, un altro tempio
dedicato a Venere genitrice celebrava la genìa di Cesare, ormai dittatore, e della gens Iulia alla quale egli
apparteneva. Il suo essere divus fu esaltato non solo dai monumenti nell’Urbe, ma anche da un esercito
di statue come quella equestre eretta nel Foro, che si diceva rappresentasse in origine Alessandro
Magno: per farla somigliare a Cesare, le cambiarono semplicemente i connotati. Un po’ come oggi fanno
con le loro foto meno riuscite dive e divi del cinema per i calendari.
Cesare comunicatore. In questo campo, Giulio Cesare si dimostrò davvero geniale, al punto che se
vivesse oggi nell’era della comunicazione di massa, sicuramente non avrebbe nulla da imparare dagli
uomini politici che modificano la propria immagine in base ai sondaggi. Non a caso Luciano Canfora ha
dedicato a Cesare un saggio intitolato «Il dittatore democratico». Per prima cosa, infatti, Giulio Cesare
aveva capito che, in quanto personaggio pubblico, il popolo – volubile e incostante – era il vero
fondamento del suo potere, e che averlo in pugno significava comandare senza alcun intoppo. Ecco che
allora, sfoggiando la sua invidiabile capacità oratoria, diventò sin da giovane il beniamino del pubblico in
innumerevoli dibattiti. Nel 65, mentre ricopriva la carica di edile curule (cioè di magistrato incaricato di
sorvegliare i luoghi pubblici, di tenere sotto controllo i prezzi e di organizzare feste religiosi e giochi
pubblici) si autocelebrò con una serie di iniziative che al tempo stesso blandivano la popolazione: per i
raffinati aristocratici con la puzza sotto il naso realizzò sul Campidoglio la prima «mostra pubblica»,
esponendo la propria collezione d’arte; per la plebe, invece, con la scusa di omaggiare il padre morto
anni prima, ecco un’overdose di giochi, in parte a sue spese, con centinaia di belve impiegate in
spettacolari cacce circensi e ben 320 coppie di gladiatori pronti a scannarsi nell’arena. Considerato il
successo finale, i ludi diverranno una costante per mantenersi il favore del popolo. Insieme ai ben quattro
grandi trionfi celebrati tra il 46 e il 45, dedicati alle vittorie riportate sui «ribelli» galli, egizi, pontici e
africani. Parecchie le cadute, diremmo oggi, di gusto: si veda il corteo di elefanti che reggevano
giganteschi candelabri in oro, enormi alberi di cedro dalla Gallia o d’acanto dal Ponto e gusci di
tartarughe dall’Egitto, tra i quali svettavano (si fa per dire) i prigionieri più nobili, ovvero Vercingetorige,
capo dei Galli, la principessa Arsinoe, sorella e rivale sconfitta di Cleopatra, e Giuba II di Numidia, figlio
dell’omonimo re morto in guerra. Un vero e proprio serraglio che oggi fa, se non raccapricciare, almeno
sorridere. Fin qui i circenses. Ma Cesare non dimenticò neppure il pane. Una pioggia di grano e di olio e
ben 400 sesterzi a testa, insieme al blocco degli affitti per un anno esteso a tutta l’Italia e a un sontuoso
banchetto durato giorni erano cadeaux che non potevano lasciare indifferente nessuno. Molto più della
gigantesca battaglia navale combattuta in un’area apposita allestita presso il Campo Marzio. O della
stranezza di veder combattere in veste di gladiatori persino alcuni giovani membri del Senato. Populista
(il suo partito era quello dei «Populares», in antitesi con i conservatori) Cesare lo fu fino alla fine, almeno
stando a Plutarco, che fornì a Shakespeare lo spunto per il celeberrimo discorso di Marco Antonio: nel
suo testamento, pare, lasciò a ogni romano 75 dracme (pari a tre etti d’argento) e i giardini al di là del
Tevere. E, a modo suo, la plebe, gli rimase fedele: appena apprese le sue ultime volontà, il popolo si
scatenò costringendo alla fuga i congiurati. Quando si dice: un uomo che fiuta le masse.
Cesare uomo spietato. Inflessibile col nemico, ma anche talmente cinico da usare pure le mogli come
pedine per i suoi fini politici. Corteggiate (poco), sposate (ebbe quattro mogli), tradite (parecchie le
amanti), ripudiate, seppellite (la seconda moglie, Cornelia), le donne per lui erano poco più che oggetti. A
parte, forse, Servilia, sorella di Catone e madre di Bruto (e probabilmente il padre era proprio Cesare),
con cui ebbe l’unica relazione davvero sincera della sua vita. E il grande amore che lo consegnò alla
Storia, quello per Cleopatra? Beh, per prima cosa è da escludere che la regina d’Egitto potesse, in
qualsiasi maniera, assomigliare a Liz Taylor oppure a Monica Bellucci. Alta poco più di un metro e mezzo
e dotata di un gran nasone, «Cleopatras lussuriosa» (come la definisce Dante nell’Inferno) ebbe da lui un
figlio, Tolomeo XV Cesarione, ma nel testamento non fu neppure nominata. Serviva solo per esercitare la
longa manus di Roma sull’Egitto, con buona pace dei romantici di ogni tempo. Non meglio andavano i
rapporti con il resto della famiglia. La perduta orazione per la zia Giulia, morta nel 69 a.C., pare non fosse
nulla più che un semplice elogio di maniera: il vero proposito era quello di riabilitare – per motivi anche
qui, squisitamente politici - il marito Gaio Mario. Ma il top forse lo si raggiunse nel 62 a.C., quando Cesare
ripudiò la terza moglie Pompeia (nipote di Silla) in un modo tanto inquietante quanto pretestuoso. Certo,
lei se l’andò a cercare. A casa di Cesare si celebravano degli strani riti dedicati alla Bona Dea, ai quali
dovevano prendere parte solamente le donne. Ma quell’anno un tal Publio Clodio Pulcro, rampollo
molliccio e decadente di una famiglia dell’alta aristocrazia romana ma anche collaboratore di Cesare,
pensò bene di intrufolarsi nel gruppo travestito da suonatrice. Smascherato da un’ancella fu cacciato
mentre la festicciola veniva annullata tra gli strepiti di chi urlava al sacrilegio. Non solo della divinità, ma
pure del talamo: Publio Clodio infatti era l’amante di Pompeia. Dopo sei anni di matrimonio, Cesare
decise dunque di ripudiare la moglie. Ma nel processo non volle testimoniare contro l’amico: meglio tener
bassi i toni dello scandalo per salvare, oltre che l’onore, anche la carriera politica. E poi, con certa gente,
non si sa mai…
Cesare disinvolto e cinico. Tale dunque, il buon Cesare, lo era anche sotto le lenzuola. E non solo con le
donne. Una delle definizioni più famose è quella che coniò il suo grande nemico Cicerone: «il marito di
tutte le mogli e la moglie di tutti i mariti». In realtà, è cosa nota, l’omosessualità era un’abitudine piuttosto
diffusa sia in Grecia sia a Roma, e per le classi abbienti pare anzi fosse molto trendy giocare al dottore
con giovani sbarbatelli. Forse, però, nel caso di Cesare essa sottintende un dramma. Quando aveva
diciannove anni, il giovane fu costretto, per sfuggire alla persecuzione da parte del dittatore Silla, a
rifugiarsi prima in Sabina e poi in Asia, dove fu mandato come legato del pretore Marco Minucio Termo.
Quest’ultimo gli ordinò di recarsi dal re di Bitinia Nicomede IV, il quale pare lo abbia trattato come Apollo
fece con Giacinto, o Zeus con Ganimede. Insomma, il giovane romano fu iniziato ai piaceri dell’amore tra
uomini. Secoli più tardi, anche il terribile voivoda Vlad Tepes (1431-1476), la cui storia si sarebbe poi
confusa con la leggenda del vampiro conte Dracula, da giovanissimo fu «ospite» del sultano in Turchia e
lì costretto ad apprendere contro la sua volontà costumi non proprio virili che, probabilmente, gli
deviarono il carattere. E la futura predilezione per l’impalamento dei nemici potrebbe dunque essere
interpretabile come una nemesi dai chiari contorni freudiani. Tornando a Cesare, non ebbe mai granché
voglia di parlare delle sue amicizie maschili, e gli sbeffeggiamenti di cui fu oggetto ancora nel 46 da parte
dei legionari (riportati da Svetonio) per la sua presunta «sottomissione» al re di Bitinia non gli fecero né
caldo né freddo. Dicerie e malignità? Forse. Certo è che anche quella linguaccia di Marco Antonio, che
ben lo conosceva, girava dicendo che era merito della «docilità» del giovane Ottaviano, frequentatore
assiduo della tenda e della lettiga di Cesare in Spagna, se alla fine era stato adottato e nominato suo
erede.
Cesare mito e antimito. A partire dal nome, che da allora ha indicato sempre i regnanti di ogni epoca e di
ogni dove. Un nome, anzi, che è diventato un titolo. E di cui si fregiarono da allora un po’ tutti, e forse
pure a sproposito. Cesari erano gli Imperatori del tardo impero, i sovrani medievali, i re assolutisti. Che
poi divennero, a seconda dei Paesi, César, Kaiser, o ancora Zar, anzi, più precisamente Czar.
Richiamarsi a lui era considerato legittimante, bastava il nome a conferire l’autorevolezza necessaria a
regnare. Napoleone Bonaparte ad esempio, che fu suo grande ammiratore, ripeteva spesso che «Cesare
si nasce, non si diventa», tant’è che si riteneva «della migliore stirpe dei Cesari, di quelli che fondano». Il
Grande Còrso, del resto, lega proprio al divo Giulio la scoperta della sua «missione» e nel «Précis des
guerres de César», dettato in esilio al fedele Marchand: «Il giorno in cui, per un caso fortunato, mi
imbattei in Bossuet, e lessi quello che scrive di Cesare, il quale vittorioso a Farsalia fu visto in un attimo in
tutto il mondo, quel giorno mi parve che si lacerasse di cima in fondo il velo del tempio, e credetti di
vedere avanzare gli Dèi. Da allora questa visione mi ha seguito ovunque, in Italia, in Egitto, in Siria, in
Germania, in tutte le mie più grandi giornate!». Napoleone III, ultimo imperatore dei francesi invece, si
ispirò a Cesare in linea di principio – nel senso che ne ammirava profondamente le gesta e riconosceva il
debito della Francia nei confronti della Roma antica -, ma non poteva, nel clima nazionalista
ottocentesco, non ricordare che il divo Giulio era stato l’uomo che aveva sconfitto i celti, i veri antenati dei
francesi. Il patriottismo lo portò dunque a fare dei galli i propri eroi nazionali, mentre i luoghi delle storiche
battaglie combattute contro i romani invasori (Alesia, Gergovia e Bibracte in primis) diventarono
luoghi-simbolo, da individuare tramite scavi sistematici (Alesia a partire dal 1861) e da celebrare con la
creazione di appositi musei archeologici e l’erezione di monumenti come quello, enorme, dedicato a
Vercingetorige proprio davanti al luogo che fu teatro del tragico, ultimo assedio. Esaltazione celtica che
tuttavia non significava affatto denigrazione nei confronti dei romani: «Nell’onorare la memoria di
Vercingetorige – affermava proprio Napoleone III nel 1866 - non dobbiamo lamentare la sua sconfitta. È
giusto ammirare l’ardente e sincero amore di questo capo gallico per l’indipendenza del suo paese, ma
non dobbiamo dimenticare che è grazie a questo trionfo degli eserciti romani che noi abbiamo la nostra
civiltà, le nostre istituzioni, le nostre tradizioni, la nostra lingua, tutto ciò giunge a noi dalla conquista». Il
che, indirettamente, equivaleva pur se a modo suo a glorificare le gesta di Cesare. Un mito, dunque, che
sfida i secoli e non perde la sua potenza. Fino a diventare addirittura fenomeno di massa. Nel Novecento
è anche e forse soprattutto il cinema ad averlo glorificato, al punto che con una punta di ironia si potrebbe
dire che Cesare è stato un divo anche sullo schermo. Oltre cento le pellicole, dal muto ad oggi, che lo
hanno visto diretto o indiretto protagonista. Tra gli attori che gli hanno dato il volto, due hanno segnato
nell’immaginario cinematografico i suoi tratti e il suo carattere: Louis Calhern nel «Giulio Cesare» di
Joseph L. Mankiewicz, del 1953, e Rex Harrison, Cesare in «Cleopatra», dello stesso regista, girato nel
1963. Ma forse oggi, soprattutto per i giovani, il suo aspetto è legato al carattere che di lui tratteggiarono i
francesi René Goscinny e Albert Uderzo nella saga a fumetti «Asterix il Gallico»: alto di statura, naso
aquilino, occhi grigi, toga immacolata con paludamento porpora e corona d’alloro in precario equilibrio sui
capelli canuti. Fanatico del circo, deciso a comandare sull’intero orbe terraqueo, determinato nel
perseguitare i ribelli del tignosissimo villaggio dell’Armorica, parla romanesco e alla fine con i galli perde
sempre, riuscendo a risultare persino simpatico. Una delle poche cose che, in vita, non gli era riuscita
bene.
Elena Percivaldi