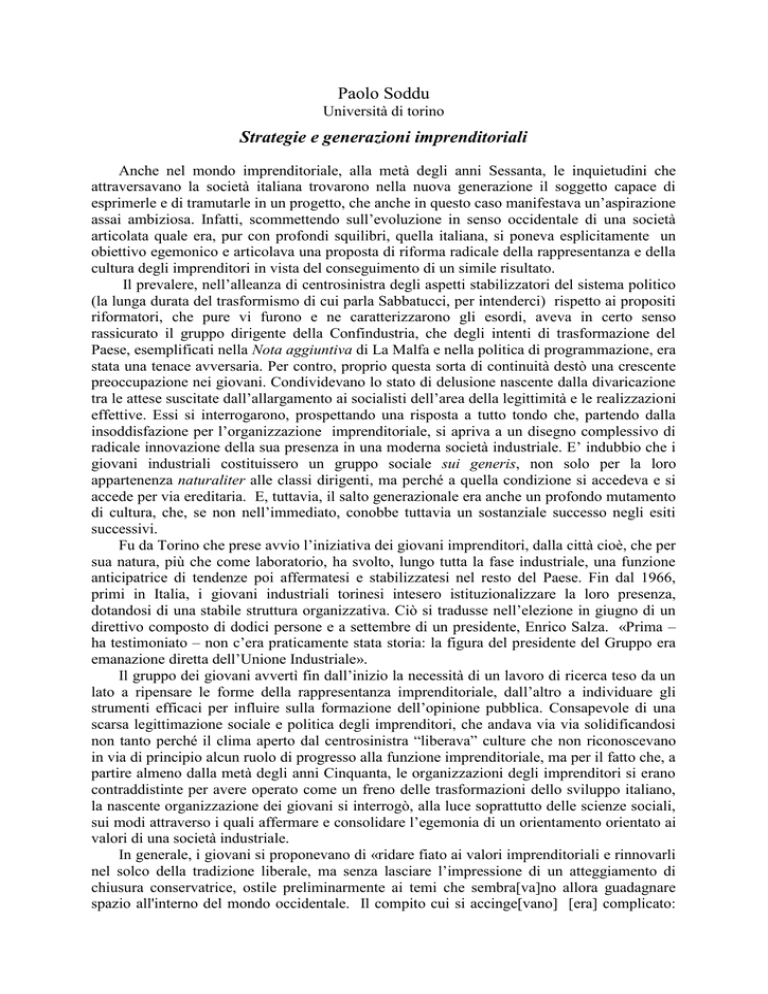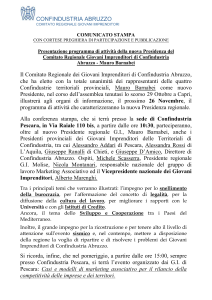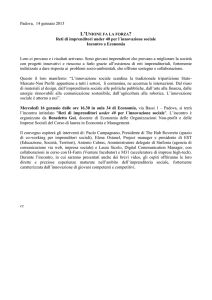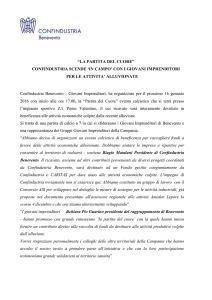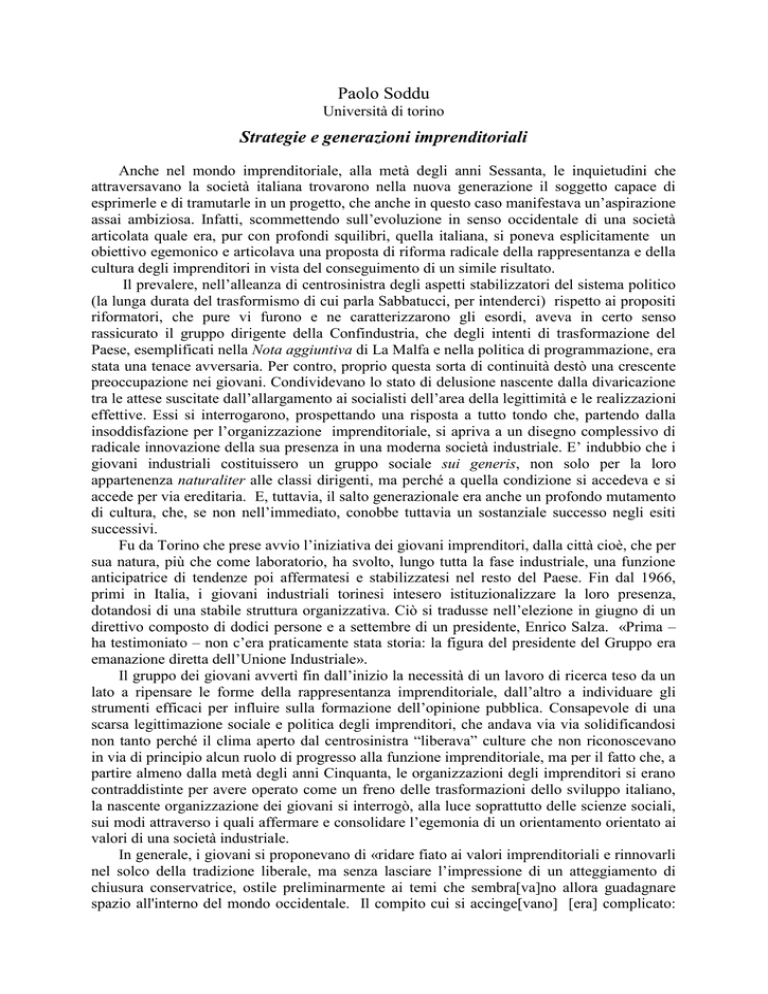
Paolo Soddu
Università di torino
Strategie e generazioni imprenditoriali
Anche nel mondo imprenditoriale, alla metà degli anni Sessanta, le inquietudini che
attraversavano la società italiana trovarono nella nuova generazione il soggetto capace di
esprimerle e di tramutarle in un progetto, che anche in questo caso manifestava un’aspirazione
assai ambiziosa. Infatti, scommettendo sull’evoluzione in senso occidentale di una società
articolata quale era, pur con profondi squilibri, quella italiana, si poneva esplicitamente un
obiettivo egemonico e articolava una proposta di riforma radicale della rappresentanza e della
cultura degli imprenditori in vista del conseguimento di un simile risultato.
Il prevalere, nell’alleanza di centrosinistra degli aspetti stabilizzatori del sistema politico
(la lunga durata del trasformismo di cui parla Sabbatucci, per intenderci) rispetto ai propositi
riformatori, che pure vi furono e ne caratterizzarono gli esordi, aveva in certo senso
rassicurato il gruppo dirigente della Confindustria, che degli intenti di trasformazione del
Paese, esemplificati nella Nota aggiuntiva di La Malfa e nella politica di programmazione, era
stata una tenace avversaria. Per contro, proprio questa sorta di continuità destò una crescente
preoccupazione nei giovani. Condividevano lo stato di delusione nascente dalla divaricazione
tra le attese suscitate dall’allargamento ai socialisti dell’area della legittimità e le realizzazioni
effettive. Essi si interrogarono, prospettando una risposta a tutto tondo che, partendo dalla
insoddisfazione per l’organizzazione imprenditoriale, si apriva a un disegno complessivo di
radicale innovazione della sua presenza in una moderna società industriale. E’ indubbio che i
giovani industriali costituissero un gruppo sociale sui generis, non solo per la loro
appartenenza naturaliter alle classi dirigenti, ma perché a quella condizione si accedeva e si
accede per via ereditaria. E, tuttavia, il salto generazionale era anche un profondo mutamento
di cultura, che, se non nell’immediato, conobbe tuttavia un sostanziale successo negli esiti
successivi.
Fu da Torino che prese avvio l’iniziativa dei giovani imprenditori, dalla città cioè, che per
sua natura, più che come laboratorio, ha svolto, lungo tutta la fase industriale, una funzione
anticipatrice di tendenze poi affermatesi e stabilizzatesi nel resto del Paese. Fin dal 1966,
primi in Italia, i giovani industriali torinesi intesero istituzionalizzare la loro presenza,
dotandosi di una stabile struttura organizzativa. Ciò si tradusse nell’elezione in giugno di un
direttivo composto di dodici persone e a settembre di un presidente, Enrico Salza. «Prima –
ha testimoniato – non c’era praticamente stata storia: la figura del presidente del Gruppo era
emanazione diretta dell’Unione Industriale».
Il gruppo dei giovani avvertì fin dall’inizio la necessità di un lavoro di ricerca teso da un
lato a ripensare le forme della rappresentanza imprenditoriale, dall’altro a individuare gli
strumenti efficaci per influire sulla formazione dell’opinione pubblica. Consapevole di una
scarsa legittimazione sociale e politica degli imprenditori, che andava via via solidificandosi
non tanto perché il clima aperto dal centrosinistra “liberava” culture che non riconoscevano
in via di principio alcun ruolo di progresso alla funzione imprenditoriale, ma per il fatto che, a
partire almeno dalla metà degli anni Cinquanta, le organizzazioni degli imprenditori si erano
contraddistinte per avere operato come un freno delle trasformazioni dello sviluppo italiano,
la nascente organizzazione dei giovani si interrogò, alla luce soprattutto delle scienze sociali,
sui modi attraverso i quali affermare e consolidare l’egemonia di un orientamento orientato ai
valori di una società industriale.
In generale, i giovani si proponevano di «ridare fiato ai valori imprenditoriali e rinnovarli
nel solco della tradizione liberale, ma senza lasciare l’impressione di un atteggiamento di
chiusura conservatrice, ostile preliminarmente ai temi che sembra[va]no allora guadagnare
spazio all'interno del mondo occidentale. Il compito cui si accinge[vano] [era] complicato:
d[ovevano] parlare con il linguaggio del liberalismo, ma di un liberalismo che v[oleva]
dialogare con le altre culture politiche e che si misura[va] sul terreno di confronto scelto dal
centro-sinistra». Organizzarono quindi convegni sulla programmazione economica, sebbene
ne affidassero lo svolgimento a un esponente del Pli, cioè di una forza politica risolutamente
contraria a essa. Non era tuttavia all’ammuffito pensiero liberale italiano quello cui essi
guardavano, ma all’opera di rinnovamento e di ripensamento di quella tradizione messa in
atto a Torino dal Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi”, le cui energie erano
rappresentante da giovani politologi ed economisti come Giuliano Urbani, Mario Deaglio,
Valerio Zanone, Piero Ostellino, tutti di area liberale, e segnatamente della “sinistra”, in
sostanza sofferente rispetto alla mummificazione del pensiero liberale dominante in
quell’area, contrassegnata da un accentuato misoneismo.
Il Centro Einaudi promosse tra il 1966 e il 1967 la pubblicazione di una raccolta di saggi
politici di Keynes e la traduzione de Il capitalismo e gli storici di von Hayek, il primo curato
da Sergio Ricossa, che allora lavorava all’ufficio studi dell’Unione industriale di Torino, e il
secondo da Deaglio, come a segnare, nella sostanziale fedeltà a una tradizione culturale, un
netto ampliamento dei suoi orizzonti.
La prima fase dell’attività dei giovani si prefisse quindi un incessante rinnovamento dei
paradigmi culturali. Era un operare, peraltro, fortemente caldeggiato dagli organi direttivi
dell’Unione industriale del capoluogo sabaudo, che vi intravedevano appunto una via preziosa
di rilegittimazione della figura dell’imprenditore. Ma l’attività culturale, negli intenti dei
giovani, era meramente propedeutica all’obiettivo prioritario: ridefinire la posizione
dell’imprenditore nella società contemporanea e, conseguentemente, ripensare e rinnovare la
rappresentanza imprenditoriale. E questo compito imponeva una riflessione anche autocritica,
importava la disponibilità della Confindustria a sacrificare mentalità e forme di presenza, che
ne avevano in una società complessa determinato, almeno sul breve periodo, il declino.
Non è un caso che i giovani stabilissero immediatamente un rapporto privilegiato con
l’astro nascente del capitalismo italiano, Gianni Agnelli, che proprio nel 1966 aveva assunto
la guida del maggiore gruppo industriale italiano. Del resto, per il gruppo dei “novatori” la
ricerca di un rapporto con la Fiat era essenziale. Già durante l’ultimissima fase di Valletta,
Salza aveva tentato un contatto, perché la Fiat «deve interessarsi della città». Era quindi la
polis il raggio d’azione degli imprenditori se volevano che il loro modo di concepire una
società democratica e pluralista la plasmasse, se in una parola volevano imprimere un segno
egemonico all’evoluzione della società italiana. L’impulso alla istituzionalizzazione formale
del gruppo dei giovani nasceva quindi dalla considerazione che in una società articolata la
rappresentanza degli imprenditori non si dovesse limitare a quella degli interessi, ma dovesse
pienamente coinvolgere le «responsabilità collettive». Insomma, nel quadro di una società
che aveva individuato, ancorché la sua realizzazione fosse rimasta sospesa a mezz’aria, la
programmazione come strumento della sua trasformazione, la rappresentanza della
Confindustria doveva, sotto ogni profilo, compiere un decisivo salto di qualità.
I contatti tra Salza e Agnelli, il quale nel primo colloquio impostò la discussione sul La
sfida americana di Jean Jacques Servan-Schreiber, che venne poi tradotto in italiano con la
prefazione di Ugo La Malfa, divennero frequenti e regolari.
I giovani industriali percepivano ed erano parte dell’irrequietezza che sempre più andava
diffondendosi nella società italiana. Condividevano con le nuove generazioni, che di fronte a
una modernizzazione dimezzata, i cui tratti caratteristici di un materialismo senza
secolarizzazione andavano profilandosi, un analogo disagio. Non a caso, essi ritennero
fondate le ragioni della contestazione, nella forma di protesta rispetto all’organizzazione degli
studi. Ritennero di dovere favorire una divisione delle sue anime, affinché prevalesse quella
indirizzata verso un’azione riformatrice, capace di solidificare quell’esile costruzione di
società aperta e pluralista che l’Italia del dopoguerra aveva assunto. Ma misurarono anche
all’interno dell’organizzazione confindustriale le straordinarie resistenze che ne ostacolavano
l’accoglimento.
Nel 1968 i giovani imprenditori torinesi assunsero l’iniziativa di generalizzare la loro
esperienza, promuovendo la costituzione di gruppi analoghi in altre città. Costituirono 45
gruppi giovani, alle origini di quello nazionale del quale nel 1969 fu primo presidente Renato
Altissimo, che aveva peraltro già intrapreso la carriera politica (era consigliere comunale del
Pli a Torino) e che venne costretto a dimettersi nel 1973, essendo stato eletto l’anno
precedente deputato. Era quindi una rete associativa estesa a tutto il territorio nazionale
l’obiettivo che si prefissero. Concretizzarono i loro intenti nella elaborazione dello studio Una
politica per l’industria, al quale lavorò un gruppo composto da esponenti dei giovani
industriali piemontesi e dagli intellettuali del Centro Einaudi – Zanone, Urbani, Ostellino e gli
economisti Giorgio Rota e Mario Deaglio. Nel contempo, in Confindustria si era data vita alla
commissione presieduta Leopoldo Pirelli, con l’obiettivo di definire una proposta di riforma
organizzativa dell’organizzazione. Anch’essa nasceva dalla constatazione che la sfera della
rappresentanza industriale, come ha osservato Berta, era «sottomessa all’esercizio del potere
di un ceto esiguo e di un corpo funzionariale consolidato, che fanno blocco l’uno con l’altro e
che si autoperpetuano, con un basso grado di tolleranza verso chi mostra di non rispettare alla
lettera i loro codici». Tra l’iniziativa dei giovani torinesi e quella di Confindustria - della
Commissione Pirelli fu segretario uno degli esponenti di punta dei giovani industriali torinesi,
Renzo Vallarino Gancia - si creò «uno stretto parallelismo». Si esprimeva in tal modo una
insofferenza per i vecchi riti di Confindustria: altro non era che consapevolezza del consenso
sempre più debole della figura dell’imprenditore e quindi della sua concezione della società.
Avvertirono il «rumore di fondo ostile», come lo ha definito Berta, e proposero un
ripensamento globale della figura e della funzione dell’imprenditore.
Una politica per l’industria venne presentato nel maggio 1969 in mille copie e venne
ristampato nell’estate in altre 3500 copie. Suddiviso in cinque parti, lo studio era suddiviso in
cinque parti:
- l’esame della figura dell’imprenditore così come era andata profilandosi negli economisti,
dai fisiocrati a Galbraith, e nel contesto della società italiana, come emergeva dall’analisi
dei questionari distribuiti a 98 imprenditori nazionali;
- la definizione del sistema politico italiano sulla base delle definizioni che negli anni
sessanta venivano proposte dalla nascente politologia (dal pluralismo polarizzato di
Sartori al bipartitismo imperfetto di Giorgio Galli);
- l’analisi del sistema confindustriale e del suo sistema comunicativo;
- la comparazione tra i sistemi di rappresentanza dell’industria italiano, francese, belga,
tedesco e inglese;
- una proposta tesa appunto a orientare l’evoluzione della società italiana secondo un
orientamento favorevole all’egemonia della cultura espressa dagli imprenditori.
E’ stato osservato che «Una politica per l’industria può forse essere letto come una sorta
di grande incunabolo e di canovaccio culturale del rapporto che la Commissione Pirelli
diffonderà al termine dei suoi lavori», i cui risultati furono presentati il 21 febbraio 1970, dato
che anche il rapporto Pirelli muoveva «da una ridefinizione sociale del ruolo imprenditoriale
che tende a rimarcare l’evoluzione della società italiana verso un modello di pluralismo
compiuto».
All’inizio, comunque, il progetto dei torinesi venne ostacolato dalla Confindustria, alla
cui guida era nuovamente Angelo Costa. A Vallarino Gancia che a nome dei giovani chiese
all’organizzazione imprenditoriale di finanziare la ricerca, Costa oppose un netto rifiuto, le
cui ragioni espose il 23 luglio 1968 in modo chiaro in una lettera a Gianni Agnelli, che
riteneva essere l’ispiratore dei giovani: «Se gli industriali italiani dovessero rivolgersi a
persone estranee, sia pure professori, per farsi indicare come deve essere fatta la loro
organizzazione darebbero a se stessi una qualifica di incapacità, che non meritano, ed una
qualifica di inettitudine a coloro, e sono molti, che hanno dichiarato all’organizzazione
decenni di lavoro. […] Ritengo che sarebbe un errore, come Confederazione, valorizzare
indirettamente giornalisti e professori che affermano che la figura dell’imprenditore deve
cambiare e lo affermano con un tono che vuol fare intendere che gli attuali imprenditori non
sono all’altezza dei loro compiti».
Agnelli replicò il 30 luglio confermando l’intento di effettuare un «personale parziale
appoggio finanziario». In realtà, le resistenze del gruppo dirigente di Confindustria furono
progressivamente superate, sicché Costa finì con il finanziare il progetto.
Al centro di Una politica per l’industria era la preoccupazione per la funzione “politica”,
«di integrazione cioè dell’impresa nella polis, nella società civile che la circonda». Ciò
richiedeva «una presenza aperta, pubblica, controllabile». Era finalizzata alla soddisfazione
del bisogno di rappresentatività, cioè della promozione di un ambiente socio-politico che
contenesse i prerequisiti indispensabili dello sviluppo economico.
Occorreva «”liberare” la domanda politica della società civile dai diaframmi che la
costringono a non essere politicamente rilevante ovvero a perdere mordente sotto il carico di
deformazioni ideologiche fuorvianti», attraverso la vivificazione della società civile
moltiplicando le forme associazionistiche e l’accesso ai media.
Il Paese, in tutte le sue ramificazioni, aveva «”sete” di dati, di idee operative nuove, di
valori» e sotto questo aspetto si apriva per Confindustria un campo di azione fondamentale
per realizzare un’effettiva egemonia, che importava il condurre a compimento la
secolarizzazione culturale della società italiana.
Bisogno di dati, di informazioni, di idee operative; ricerca di nuovi valori;
secolarizzazione politico-culturale; liberazione della “domanda politica” dai diaframmi
ideologici; formazione delle nuove élite; associazionismo autonomo; continui aggiustamenti
di potere nei precari equilibri inter- e intra-partitici, erano i principali punti deboli del sistema
politico sui quali la Confindustria doveva operare.
Ne discese una proposta di ricollocazione complessiva dell’organizzazione
confindustriale nel rapporto con l’ambiente e le istituzioni politiche (attrezzatura per
l’osservazione dell’ambiente, variamente articolata, che sapesse utilizzare compiutamente le
conoscenze delle scienze sociali; la promozione di una nuova domanda politica; l’influenza
esercitabile sul sistema partitico; il contributo alla soluzione dei problemi prioritari del paese);
e con la società, in particolare con il mondo dell’istruzione, dove la diffusione dei valori
dell’impresa era indispensabile se si voleva conseguire l’obiettivo di una loro condivisione, e
con la classe dirigente.
Sotto il primo aspetto, ciò che va sottolineato è che il pericolo rispetto all’affermazione di
una società aperta e pluralista, che si sosteneva di volere perseguire, era intravisto nel Pci,
nella sua irrisolta duplicità, nella sua incertezza cioè tra ipotesi leninista e prospettiva
riformatrice. Si rifletteva nell’analisi del Pci un atteggiamento che sarebbe stato, dopo il lungo
Sessantotto e, poi, dopo l’esaurimento dell’ipotesi di ricomposizione delle fratture della
società italiane, prefiguratasi negli anni Settanta e rapidamente sconfitta, politicamente
definito dalla sinistra liberale e dal nuovo corso socialista. L’analisi dei giovani imprenditori e
degli intellettuali a essi legati, si fondava sulla consapevolezza dell’inservibilità
dell’anticomunismo classico, ma manteneva un opposizione altrettanto rigida al Pci, e ne
ricercava gli elementi di contraddizione e di debolezza, destinati a emergere nei decenni
successivi (ideologia, collocazione internazionale, centralismo democratico). Infatti,
assumeva come fondamento l’assunto che «mai come oggi il comunismo ha rappresentato un
serio “pericolo” per il futuro della nostra democrazia, almeno nella misura in cui si presenta
come uno sbocco quasi inevitabile, senza credibili volontà d’imboccare strade alternative.
Così, in modo indolore, il Pci minaccia crescentemente di indebolire (se non di recidere) i
legami che vincolano l’Italia al mondo occidentale ed altrettanto ineluttabilmente sembra
spingere le altre forze politiche verso comportamenti legislativi sempre più inclini alla
demagogia». La soluzione alla sfida dell’ipoteca comunista del Pci consisteva nel “restituire
compattezza, stabilità e valore allo schieramento dei partiti autenticamente democratici», in
una parola si prefigurava quello che sarebbe stato il pentapartito, intravisto come uno
schieramento “i cui protagonisti impersonificassero tutte le parti della dialettica democratica”.
Comunque, il complesso di proposte aveva un obiettivo chiaro: «L’integrazione
dell’impresa nella polis, nella società civile che la circonda e compenetra, è la condizione
decisiva per la legittimità sociale dell’immagine imprenditoriale. Una società essenzialmente
basata sull’industria deve trovare in essa una giustificazione anche in termini di valori e
l’associazione degli imprenditori deve assumere il ruolo di “emittente” di questi valori».
Nel contempo, ai lavori della Commissione Pirelli prese parte, oltre a Vallarino Gancia,
anche Salza. Essa era stata composta secondo un attento dosaggio, ma la sua funzione
riformatrice fu accentuata dalla presenza della generazione dei quarantenni, cioè di
imprenditori ritenuti riformatori, per il fatto di attingere alle altre esperienze delle società
industriali, come Agnelli, Pirelli e Roberto Olivetti. Vennero elaborati due documenti, uno
sulle relazioni pubbliche, e l’altro sull’ufficio studi, che però non furono diramati. La sintesi
politica, pubblicata sul quotidiano della Confindustria, accoglieva con un ritardo ormai
irrecuperabile, la programmazione e conseguentemente la politica dei redditi come suo
strumento di realizzazione. Era in sintesi la trasposizione a livello nazionale della proposta
egemonica avanzata da Una politica per l’industria.
Non a caso Giuseppe Berta ne ha rintracciato un precedente nella proposta, avanzata nel
1919 da Dante Ferraris, sia nel tentativo di instaurare un’egemonia dell’industrialismo sia,
anche se per ragioni differenti, nel fallimento delle proposte. Ne deriva un parallelismo tra
Grande Guerra e Sessantotto, tra due momenti di svolta della società italiana, due momenti
simbolici di trasformazioni a lungo incubate e poi accelerate da un’intensa mobilitazione
collettiva.
Le citazioni sono tratte da:
Alla ricerca di una politica per l’industria. L’esperienza del Gruppo giovani
imprenditori di Torino dalla costituzione al 2000, Marsilio, Venezia 2000 (contiene anche
l’XI capitolo di Una politica per l’industria).
G. Berta, L’Italia delle fabbriche. Genealogia ed esperienze dell’industrialismo nel
Novecento, Il Mulino, Bologna 2001.