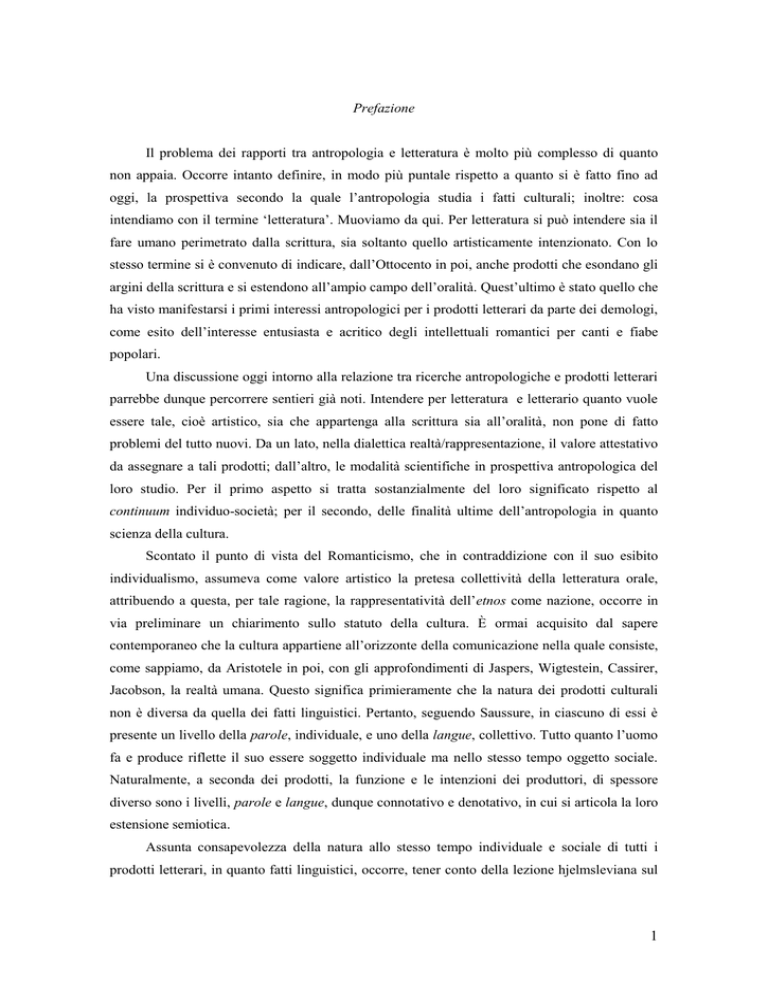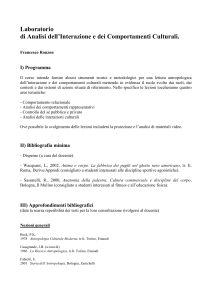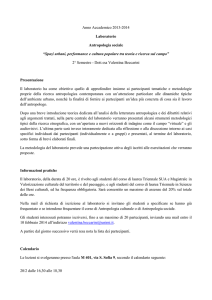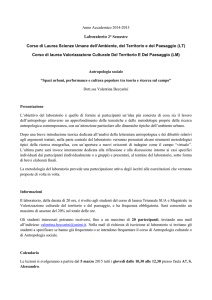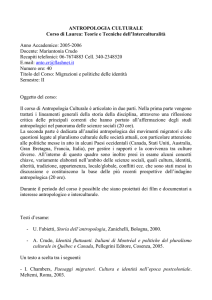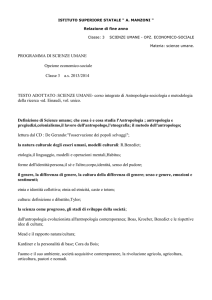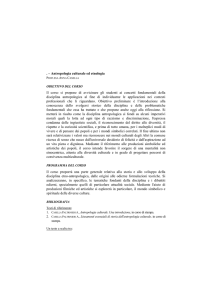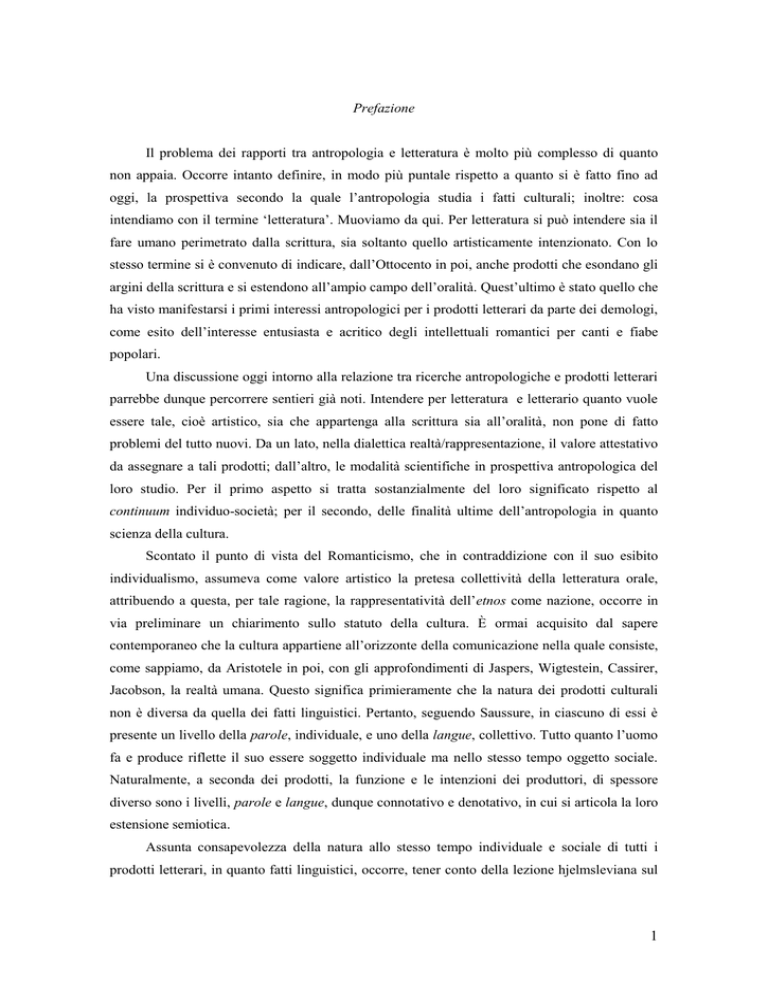
Prefazione
Il problema dei rapporti tra antropologia e letteratura è molto più complesso di quanto
non appaia. Occorre intanto definire, in modo più puntale rispetto a quanto si è fatto fino ad
oggi, la prospettiva secondo la quale l’antropologia studia i fatti culturali; inoltre: cosa
intendiamo con il termine ‘letteratura’. Muoviamo da qui. Per letteratura si può intendere sia il
fare umano perimetrato dalla scrittura, sia soltanto quello artisticamente intenzionato. Con lo
stesso termine si è convenuto di indicare, dall’Ottocento in poi, anche prodotti che esondano gli
argini della scrittura e si estendono all’ampio campo dell’oralità. Quest’ultimo è stato quello che
ha visto manifestarsi i primi interessi antropologici per i prodotti letterari da parte dei demologi,
come esito dell’interesse entusiasta e acritico degli intellettuali romantici per canti e fiabe
popolari.
Una discussione oggi intorno alla relazione tra ricerche antropologiche e prodotti letterari
parrebbe dunque percorrere sentieri già noti. Intendere per letteratura e letterario quanto vuole
essere tale, cioè artistico, sia che appartenga alla scrittura sia all’oralità, non pone di fatto
problemi del tutto nuovi. Da un lato, nella dialettica realtà/rappresentazione, il valore attestativo
da assegnare a tali prodotti; dall’altro, le modalità scientifiche in prospettiva antropologica del
loro studio. Per il primo aspetto si tratta sostanzialmente del loro significato rispetto al
continuum individuo-società; per il secondo, delle finalità ultime dell’antropologia in quanto
scienza della cultura.
Scontato il punto di vista del Romanticismo, che in contraddizione con il suo esibito
individualismo, assumeva come valore artistico la pretesa collettività della letteratura orale,
attribuendo a questa, per tale ragione, la rappresentatività dell’etnos come nazione, occorre in
via preliminare un chiarimento sullo statuto della cultura. È ormai acquisito dal sapere
contemporaneo che la cultura appartiene all’orizzonte della comunicazione nella quale consiste,
come sappiamo, da Aristotele in poi, con gli approfondimenti di Jaspers, Wigtestein, Cassirer,
Jacobson, la realtà umana. Questo significa primieramente che la natura dei prodotti culturali
non è diversa da quella dei fatti linguistici. Pertanto, seguendo Saussure, in ciascuno di essi è
presente un livello della parole, individuale, e uno della langue, collettivo. Tutto quanto l’uomo
fa e produce riflette il suo essere soggetto individuale ma nello stesso tempo oggetto sociale.
Naturalmente, a seconda dei prodotti, la funzione e le intenzioni dei produttori, di spessore
diverso sono i livelli, parole e langue, dunque connotativo e denotativo, in cui si articola la loro
estensione semiotica.
Assunta consapevolezza della natura allo stesso tempo individuale e sociale di tutti i
prodotti letterari, in quanto fatti linguistici, occorre, tener conto della lezione hjelmsleviana sul
1
loro assetto strutturale. Mentre il livello parole, individuale, di ciascuno di essi, sia pure non
disconnesso dagli altri, è facilmente individuabile, quello sociale non è immediatamente
percepibile. Il termine in effetti società è equivoco. Il nostro essere sociale rinvia a tre ambiti dal
perimetro diverso: la comunità cui apparteniamo (l’ambiente sociale e culturale in cui ci
riconosciamo); la società nazionale all’interno della quale è iscritta la nostra comunità; il grande
mosaico dell’umanità nella sua totalità di cui essa è una tessera. Con Hjelmslev dobbiamo
pertanto in ogni fatto letterario individuare , tenuto conto della estensione sociale dei suoi tratti
sostantivi, secondo l’ordine precedente, quattro livelli: parole, uso, norma e schema; con
l’ulteriore e utile precisazione della loro diversa temporalità, rispettivamente: rapida, scandita,
lenta, lentissima, ma anche del grado di consapevolezza: dal consapevole (la parole)
all’assolutamente inconsapevole (lo schema).
Determinato lo statuto dei fatti letterari rispetto al loro spazio sociale e al loro tempo
storico, si pone in termini più chiari il problema dei rapporti tra antropologia e letteratura, e si
definisce meglio anche quale debba o possa essere il punto di vista dal quale l’antropologo
studia i fatti letterari soprattutto quando pensati come tali. Occorre pertanto per chiarezza
definire cosa è da intendere per antropologia e qual è il suo compito. Il problema non è quello di
definirne l’oggetto né il metodo. Quantomeno da Lalande in poi sappiamo che oggetto e metodo
delle scienze sociali o umane sono sempre gli stessi: l’uomo e il metodo sperimentale. È solo
diverso in ciascuna il punto di vista dal quale studiano lo stesso oggetto con lo stesso metodo.
Eredi della lezione vichiana circa l’essenza della “scienza nuova” da lui inaugurata: “cercare
connessioni tra cose fra di loro lontanissime”; assumiamo assiomaticamente quanto dice C.
Lévi-Strauss a proposito della differenza tra storia e antropologia: la prima si occupa del livello
individuale e consapevole dei prodotti umani, la seconda di quello collettivo e inconsapevole. È
proprio questa prospettiva a fondare la legittimità del percorso delle scienze antropologiche,
intravista da Vico, inteso a cogliere le strutture comuni di fenomeni apparentemente diversi e
lontani.
Risulta ora in tutta chiarezza secondo quale prospettiva l’antropologo studia i prodotti
letterari. Suo campo di osservazione è quello dei livelli e di analisi dei loro rapporti, che, sia
pure con estensione e ritmi diversi, riflettono in ciascuna opera la dimensione della socialità:
dagli “universali fantastici” vichiani ai caratteri specifici dovuti alle appartenenze culturali e
sociali dei loro autori, dunque i denotata collettivi connessi alla rete espansiva che perimetra le
comunità e via via le società e l’umano.
La ricerca antropologica ha fatto un lungo cammino per arrivare a questo risultato per
altro ancora non del tutto esitato. A differenza del nostro Paese non mancano precedenti e
modelli in altri: dalle ricerche delle leggi dell’epica di Axel Olrik al censimento e ordinamento
2
dei temi i motivi della narrativa orale, dei Krohn, di Aarne e Thopson, dalla determinazione
della morfologia della fiaba di Propp allo studio della struttura dei miti di Lévi-Strauss,
Greimas, Meletinskij infine alle ricerche di ispirazione psicologica da Jung a Soriano. Né sono
da dimenticare gli studi degli antropologi inglesi in ordine alla più o meno persuasiva presenza
di credenze e riti dei popoli primitivi nella narrativa orale, strada seguita anche dal Propp delle
Radici storiche, sia pure in chiave marxista. Più prossimi comunque a uno studio antropologico
dei fatti letterari si mostrano le analisi di Lévi-Strauss, Jacobson, Greimas riguardo a testi di
Baudelaire, Maupassant, Calvino, e sopra tutte di Bachtin su Rabelais. Il percorso da
quest’ultimo seguito per la individuazione del significato profondo dell’opera dello Scrittore
francese, in riferimento all’assiologia dei rituali carnevaleschi, è infatti esemplare per tutti
coloro che si pongono di fronte ai fatti letterari in una prospettiva antropologica.
Seguendo la tradizione della Scuola storicofilologica, dunque non De Gubernatis ma
Comparetti e il primo Croce, gli studiosi italiani, quando mossi da interessi antropologici, hanno
studiato la letteratura alla ricerca di credenze e riti popolari come in una sorta di archivio di
pratiche e costumi. Si pensi a Giovanni Crocioni, le cui opere sono sicuramente utili ma di
scarso rilievo euristico. Il limite di questo tipo di ricerche, è evidente. Assumere notizie e
descrizioni di usanze popolari e non dai testi letterari come testimonianze validamente
documentarie, trascura un dato: la scrittura è un fatto non di rispecchiamento della realtà ma una
sua reinvenzione. Gli stessi antropologi oggi riconoscono che le loro strategie descrittive sono
riformulazione dei fatti osservati. Naturalmente il prodotto letterario in sé, a prescindere se
descrive o accenna a particolari usanze e credenze, è pur sempre un documento antropologico,
anche e soprattutto quando valutato rispetto ai rapporti con la società e le correnti letterarie del
suo tempo. È questa la strada seguita da Giuseppe Cocchiara in Popolo e letteratura in Italia.
Cocchiara non si è tanto preoccupato di misurare il valore documentario delle opere dei singoli
autori, scrittori o studiosi, rispetto al mondo popolare, quanto le modalità espressive e gli
orientamenti scientifici delle loro scelte stilistiche e tematiche, in relazione alle vicende
letterarie italiane e europee. In questo senso la sua opera si è venuta a configurare come una
storia della letteratura e della cultura italiane nei loro rapporti con il mondo contadino. D’altra
parte, considerata la forte prevalenza fino a pochi decenni fa dell’economia agraria nel nostro
Paese, letterati e studiosi, nel rappresentare il popolo, non potevano che privilegiare questa
realtà.
L’opera di Cocchiara pertanto costituisce un notevole passo avanti in direzione di una
corretta scelta metodologica relativamente allo studio antropologico della letteratura, anche se le
vicende sociali e politiche del nostro Paese, alle quali quelle letterarie non possono non essere
strettamente connesse, nelle sue pagine si indovinano spesso come sinopie sbiadite per di più
3
appannate da una lettura idealistica. Sono limiti dovuti da un lato a preoccupazioni di carattere
accademico: affermare lo statuto scientifico dello studio del folklore (basti ricordare che fu
negata una cattedra universitaria a Giuseppe Pitrè) rispetto a un contesto universitario inquinato
da storicismo idealista; dall’altro, all’idea, propria della critica italiana di ieri ma anche di oggi,
che le opere letterarie non tanto hanno valore per la loro capacità di scavare nell’umano fino al
suo essere profondo oltre il paraître, quanto per il loro tracimare nell’indefinito iperuranio della
Poesia. Qualcosa che, prescindendo dalle tecniche di analisi e scrittura di situazioni e uomini
concreti, non si riesce a capire cosa sia: come ebbe a denunciare acutamente ma inutilmente, un
notevole storico della letteratura quale Giuseppe Petronio.
Nessuno di questi limiti è presente nella lettura antropologica che Lia Giancristofaro ha
fatto dell’opera di Giovanni Verga. L’ esito positivo del suo lavoro si deve a ragioni di merito e
di metodo. L’avere scelto uno scrittore come Giovanni Verga, indubbiamente è stata una
condizione di favore. Lo Scrittore di Vizzini, particolarmente attento alle situazioni umane e alle
modalità espressive del popolo (lo testimoniano fra l’altro i suoi rapporti con Pitrè) riesce infatti
a darne una lettura antropologica. Non perché descriva ambienti e condizioni di gente reale,
pescatori, contadini, piccoli proprietari, ma per il fatto che ne individua in modo magistrale
l’assiologia sostantiva dei comportamenti e del destino. Il compito della Giancristofaro, almeno
in prima approssimazione, apparentemente non presentava dunque particolare complessità. La
sua lettura di Verga è stata di fatto un dialogo fra antropologi, anche se nel caso di quest’ultimo
con un antropologo senza sapere di esserlo, come dalle puntuali analisi della Studiosa risulta. Il
loro rapporto poteva ovviamente rischiare i soliti equivoci della critica letteraria italiana, se la
lettura non fosse stata sostenuta da una prospettiva sistematica e rigorosa, come di fatto si
testimonia.
La Giancristofaro con scelta intelligente inizia il suo discorso muovendo opportunamente
dall’interesse mostrato da Verga per l’opera di Giuseppe Pitrè, notando come sia nell’uno che
nell’altro il popolo sia “il protagonista corale”. I due non sono accomunati però solo
dall’attenzione per il popolo, ma dal valore assegnato a questo nel farsi della storia. In sostanza,
e l’ampia documentazione riferita dalla Giancristofaro lo dimostra in termini non questionabili,
non diversamente da Pitrè che cercava “la storia della Sicilia dove nessuno l’aveva ancora
cercato”, Verga voleva trovare la Sicilia nei comportamenti, nelle parole, nella vita degli
esclusi, dei dimenticati, dei “vinti” appunto.
In Verga c’è forse di più rispetto a Pitrè. Mentre in quest’ultimo la distanza tra
osservatore e osservato, non solo e non tanto per ragioni scientifiche ma per diversa sensibilità,
non si riduce mai; in Verga c’è uno sforzo costante per colmarla, per mostrare gli attori delle
narrazioni, con le parole sue: “faccia a faccia senza alcuna rappresentazione, come li aveste
4
conosciuto sempre, e foste nato e vissuto in mezzo a loro”. Il suo proposito naturalmente era un
obiettivo impossibile da realizzare per la diversa appartenenza sociale e culturale rispetto agli
uomini di cui narra. Attese le sue intenzioni, si può parlare semmai di più o meno
approssimazione alla realtà rappresentata. Di fatto, non sempre gli esiti raggiunti stanno dalla
parte del più, è però sicuro che il mondo popolare da lui restituito è molto più vicino alla verità
rispetto alla immagine proposta dalle opere di Pitrè.
Ancora una volta insomma il confronto tra uno scrittore e un antropologo, e quello
istituito della Giancristofaro è oltremodo illuminante, rivela la somiglianza del loro lavoro ma
ne denuncia anche la differenza. Gli antropologi descrivendo uomini perdono l’uomo, gli
scrittori rappresentando l’uomo trovano gli uomini. In sostanza nei casi migliori, rispetto ai fini
nelle opere degli uni e degli altri in genere si produce una inversione degli esiti. I primi,
chiamati a osservare l’ordito ne smarriscono intrami e stami, i secondi, narrando questi ultimi lo
recuperano. Smentendo le procedure deduttive proprie della ricerca scientifica, ma confermando
un antico suggerimento aristotelico, attraverso la conoscenza della parte ci fanno conoscere il
tutto. Forse perché ciascun nodo è indissociabile dalla rete dell’umano, o meglio, perché
ciascuna tessera del suo mosaico ne ritiene per intero il senso.
Il valore della lettura delle opere di Verga, condotta in modo informato e acribioso per
singoli temi dalla Giancristofaro, di tutto questo è una prova tranciante. Dalla scoperta che della
cultura popolare siciliana, intesa in tutto il suo spessore umano, le opere di Verga, ci dicono
molto di più di quanto impariamo dai venticinque volumi della Biblioteca delle tradizioni
popolari siciliane di Pitrè, ricaviamo infatti l’intero spessore di uno Scrittore le cui opere, in
forza della loro sostanza antropologica, salvano eventi e persone dall’oblio del tempo e li
consegnano alla memoria della storia. Questa la lezione della Giancristofaro: un debito che
difficilmente potremo ripagarle.
Antonino Buttitta
5