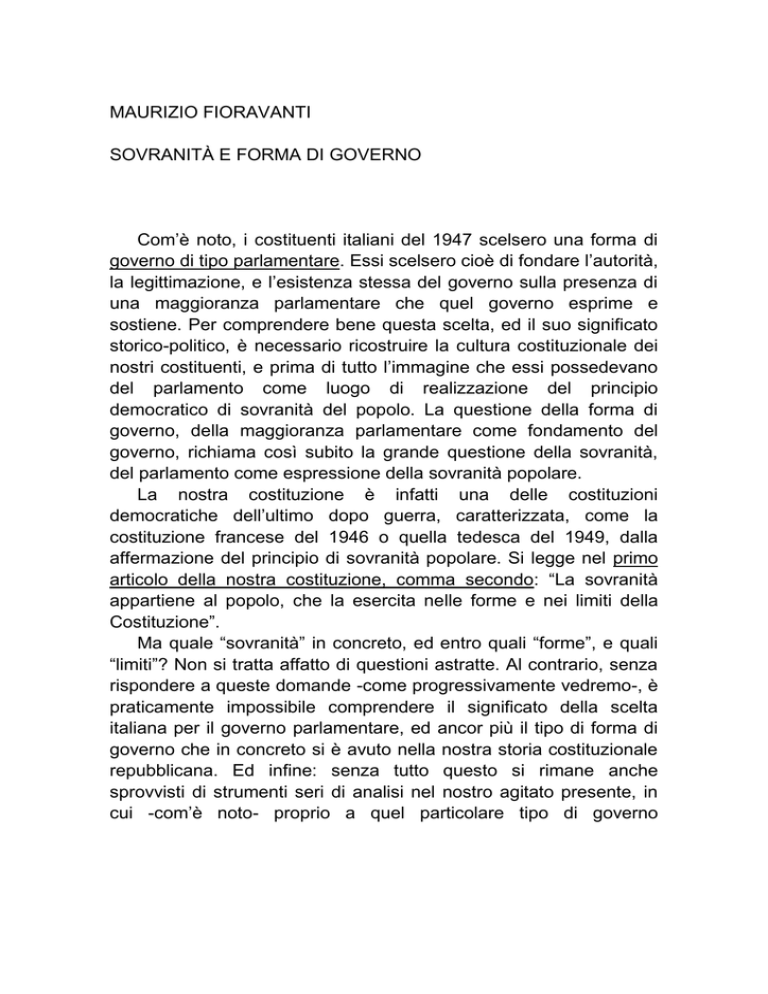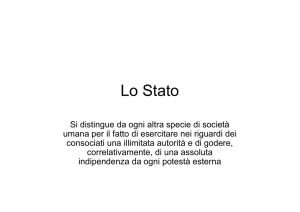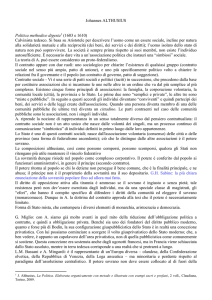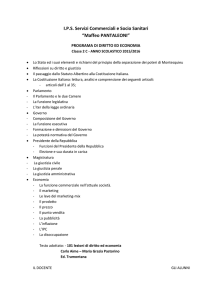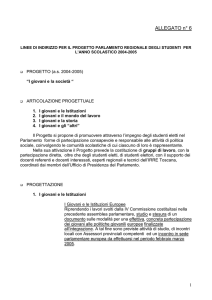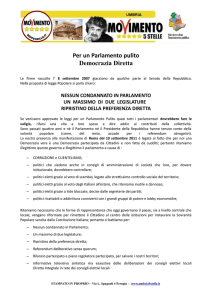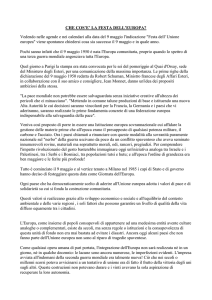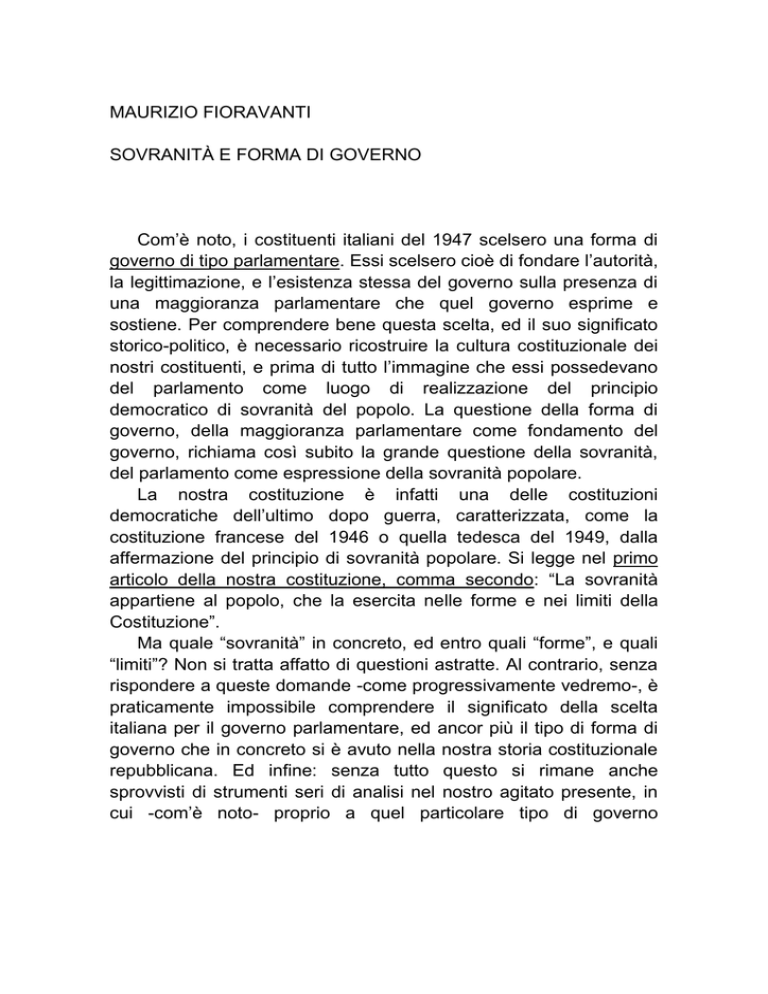
MAURIZIO FIORAVANTI
SOVRANITÀ E FORMA DI GOVERNO
Com’è noto, i costituenti italiani del 1947 scelsero una forma di
governo di tipo parlamentare. Essi scelsero cioè di fondare l’autorità,
la legittimazione, e l’esistenza stessa del governo sulla presenza di
una maggioranza parlamentare che quel governo esprime e
sostiene. Per comprendere bene questa scelta, ed il suo significato
storico-politico, è necessario ricostruire la cultura costituzionale dei
nostri costituenti, e prima di tutto l’immagine che essi possedevano
del parlamento come luogo di realizzazione del principio
democratico di sovranità del popolo. La questione della forma di
governo, della maggioranza parlamentare come fondamento del
governo, richiama così subito la grande questione della sovranità,
del parlamento come espressione della sovranità popolare.
La nostra costituzione è infatti una delle costituzioni
democratiche dell’ultimo dopo guerra, caratterizzata, come la
costituzione francese del 1946 o quella tedesca del 1949, dalla
affermazione del principio di sovranità popolare. Si legge nel primo
articolo della nostra costituzione, comma secondo: “La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione”.
Ma quale “sovranità” in concreto, ed entro quali “forme”, e quali
“limiti”? Non si tratta affatto di questioni astratte. Al contrario, senza
rispondere a queste domande -come progressivamente vedremo-, è
praticamente impossibile comprendere il significato della scelta
italiana per il governo parlamentare, ed ancor più il tipo di forma di
governo che in concreto si è avuto nella nostra storia costituzionale
repubblicana. Ed infine: senza tutto questo si rimane anche
sprovvisti di strumenti seri di analisi nel nostro agitato presente, in
cui -com’è noto- proprio a quel particolare tipo di governo
parlamentare sono ricondotti assai spesso molti dei mali che
affliggono la nostra Repubblica1.
Iniziamo dicendo questo: la sovranità popolare cui pensavano i nostri
costituenti non era affatto quella giacobina e radicale che era a loro nota
soprattutto attraverso il ricordo della fase più intensa, ed acuta, della
rivoluzione francese. Quella particolare versione della sovranità popolare si
era espressa in modo mirabilmente sintetico nell’articolo ventottesimo della
Dichiarazione dei diritti giacobina del 1793: “Un popolo ha sempre il
diritto di rivedere, riformare, cambiare la propria costituzione”.
Una formulazione di questo genere non poteva essere accettata dai
costituenti italiani, ed in genere nell’ambito delle costituzioni che si
producevano alla fine della guerra, dopo le tragiche esperienze di tipo
totalitario. Due erano i motivi in particolare che rendevano inaccettabile
quella idea cosi forte, ed estrema della sovranità popolare. In primo luogo,
era inaccettabile l’idea che la costituzione, cui era ora affidata la protezione
dei diritti fondamentali, potesse essere cambiata “sempre” secondo la
lettera dell'articolo sopra citato, cioè “ad ogni momento”, ogni volta che il
popolo sovrano non la ritenesse più conforme alla propria volontà. Dopo la
tragedia della guerra e degli stermini di massa era necessario mettere alcuni
punti fermi, fissare alcuni principi, come quello della inviolabilità dei diritti
fondamentali, che le nuove costituzioni intendevano porre al di là di ogni
espressione di carattere volontaristico, di ogni manifestazione di volontà
politica, per quanto legittimata dal basso in nome della sovranità del
popolo. Troviamo quindi un primo significato del già citato articolo primo,
comma secondo, della nostra costituzione: la sovranità “appartiene” sì al
popolo, ma il suo esercizio sta dentro i “limiti” dati dalla costituzione,
poiché in essa si trovano i principi ed i valori fondamentali comunemente
condivisi, che nessuno può violare. In una parola, nessuno è padrone della
costituzione, neppure il popolo sovrano.
Ma c’è anche una seconda ragione della profonda avversione
dei nostri costituenti per la concezione radicale della sovranità
popolare, ed è quella che forse più ci interessa, perché più vicina
alla nostra problematica della forma di governo. Com’è noto, quella
concezione era indissolubilmente legata alla grande idea della
Una buona ed equilibrata ricostruzione delle discussioni italiane in materia di riforme
costituzionali è in A. BARBERA-C. FUSARO , Semipresidenzialismi, a cura di A.
Pegoraro ed A. Rinella, Padova, Cedam, 1997.
1
democrazia diretta, della inalienabilità della sovranità popolare,
secondo la celebre formula di Rousseau. Per questo, in una
costituzione radicale si scrive sempre a chiare lettere che la
sovranità “risiede” nel popolo, per indicare che essa è stabilmente
nella titolarità del popolo, che può solo delegarne provvisoriamente
l’esercizio, ma solo a condizione di operare un controllo continuo, di
poter revocare ad ogni momento quelli che sono semplicemente
“mandatari”, o “agenti”, del popolo sovrano.
Una concezione di questo genere era evidentemente inconciliabile con
le esigenze delle democrazie che si dovevano ricostruire dopo la guerra.
Quelle democrazie avevano infatti in primo luogo il problema della
sicurezza, della stabilità: non solo sotto il profilo già precedentemente visto
dei limiti, della inviolabilità di alcuni valori e principi fondamentali, ma
anche da questo secondo punto di vista della stabile e permanente
legittimazione dei poteri costituiti, dei poteri che le nuove costituzioni
stavano istituendo. Il primo tra questi poteri era ovviamente il legislativo, il
parlamento, cui si voleva attribuire una forza ed una centralità ben
maggiore di quella che risultava dall’essere una semplice assemblea dei
mandatari e degli agenti del popolo sovrano, come nel modello radicale.
Tutto questo spiega perché molte delle pagine della nostra Assemblea
Costituente siano percorse da un vero e proprio timore nei confronti della
espressione diretta di sovranità da parte del popolo 2 , o anche perché la
formula più ricorrente, anche nella pubblicistica di partito, sia quella della
Repubblica parlamentare3.
Nel DOC. 1 si riproduce parte delle discussioni svoltesi in seno alla Commissione per
la Costituzione, in data 22 e 24 gennaio 1947, sul primo articolo della Costituzione. Da
notare l’intervento dell’onorevole Lucifero, appartenente all’ala destra della Costituente,
che provocatoriamente propone la formulazione radicale della sovranità che “risiede”
nel popolo, suscitando la reazione dei rappresentanti di tutte le forze politiche (La
Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente,
Camera dei Deputati, Segretariato Generale, Roma, 1970, vol. II°, pp. 138 e ss. e pp.
161 e ss.).
2
Nel DOC. 2 si riproduce il “Programma del Partito Comunista per la Repubblica
democratica dei lavoratori”, scegliendo di proposito un partito che avrebbe dovuto
essere legato, sulla base di certe genealogie storico-ideologiche, alla versione radicale e
giacobina della sovranità popolare. La genealogia in questione è ben visibile nel testo
per ciò che riguarda il primato della politica in funzione di riforma sociale, ma non per
la forma costituzionale, poiché su questo piano l’essenziale è che la pubblica venga
3
Torniamo dunque al nostro primo articolo della Costituzione: le
“forme” entro cui deve ricondursi l’esercizio della sovranità popolare sono
evidentemente prima di tutto quelle rappresentative-parlamentari. Si
potrebbe quindi sostenere, quasi a mo’ di conclusione: il popolo è sovrano
perché liberamente elegge un parlamento che lo rappresenta. Le cose non
erano pero affatto cosi semplici. I nostri costituenti infatti non intendevano
-come già abbiamo visto- correre i rischi insiti nel modello radicale, nelle
pratiche della democrazia diretta, nella idea stessa della sovranità del
popolo sulla costituzione e sui poteri costituiti, ma nello stesso tempo
avevano anche un altro pericolo da evitare, sul versante opposto: quello di
ricadere nella vecchia idea liberale ed ottocentesca della sovranità del
parlamento, dietro cui scompariva del tutto la figura del popolo sovrano. Ed
infatti tra i nostri costituenti era quasi unanime la volontà di superare i
confini, ritenuti angusti, del modello liberale ottocentesco, in cui il
parlamento era sì centrale, ma solo in quanto espressione della astratta
ragione della nazione, che si rendeva concreta solo grazie al ruolo
determinante delle aristocrazie borghesi, designate mediante pratiche
elettorali ristrette e censitarie.
Dunque, contro l’idea radicale della sovranità del popolo si afferma la
forza, la centralità, ed in qualche modo anche l’autonomia del parlamento,
ma solo a condizione che quest’ultimo raffigurabile in modo
sostanzialmente diverso dal passato, come luogo di autentica
rappresentazione del popolo sovrano. Da questo vero e proprio dilemma si
usci grazie allo straordinario e determinante ruolo che i nostri costituenti
attribuirono ai partiti politici.
Ed in effetti che cosa differenziava nel profondo il parlamento che si
doveva costruire dai parlamenti liberali e borghesi del secolo precedente?
Sarebbe facile rispondere: il suffragio universale, maschile e femminile.
Certo, non si tratta di una differenza di poco conto, ma non è tutto, e
sarebbe anzi riduttivo far coincidere il nuovo principio democratico con
l’affermazione piena ed irreversibile del suffragio universale.
La verità è che la differenza più profonda, la novità più forte, è data
dalla presenza dei partiti politici, dal fatto che essi pretendono ora di essere
molto di più di semplici associazioni di cittadini, o di raggruppamenti
parlamentari più o meno stabili. I partiti sono ora intesi come vere e proprie
organizzata “su base parlamentare”. Il documento sta in 1946. La nascita della
Repubblica, a cura di M. Ridolfi e N. Tranfaglia, Bari, Laterza, 1996.
istituzioni politiche, nel senso che la democrazia è caratterizzata nel
profondo dalla loro presenza. La costituzione stessa si è resa possibile,
come noto, perché il popolo italiano si e organizzato in partiti, e questi
hanno saputo disciplinare le molteplici spinte presenti in quel momento
storico, riconducendole a soluzioni di ordine e livello costituzionale,
trovando nei principi costituzionali la definizione dei necessari punti di
equilibrio e di convergenza.
Ma c'è di più, ed è ciò che più ci interessa: i partiti non sono solo i
protagonisti della fase eroica, della travagliata uscita dal precedente regime,
della fondazione, essi sono soprattutto ciò che servirà alla democrazia
italiana per esistere come tale e rafforzarsi nel tempo, per rendere concreto
il principio della sovranità popolare. Questo ruolo forte, ed ambizioso, dei
partiti politici è forse ciò che caratterizza più nel profondo, ed attraversa in
senso orizzontale, la discussione dei nostri costituenti, da Lelio Basso a
Palmiro Togliatti, ai rappresentanti del mondo politico cattolico, fino alla
stessa cultura giuridica, a questo livello rappresentata soprattutto da
Costantino Mortati4.
Torniamo ora, alla luce di tutto questo, alla grande idea della centralità
del parlamento. Come si vede, c’è ben più della affermazione del suffragio
universale o della ovvia, netta e decisa riaffermazione di quelle prerogative
parlamentari che il fascismo aveva cancellato. C’è la convinzione che
grazie all’opera che i partiti sapranno svolgere nella società, al loro lavoro
di organizzazione e sintesi della grande complessità degli interessi sociali
ed economici, si avrà un parlamento completamente nuovo, del tutto
trasformato dalla nuova democrazia dei partiti, che sarà molto di più del
luogo deputato allo svolgimento della funzione legislativa. Esso sarà anche
e soprattutto il luogo in cui i partiti medesimi renderanno visibili e presenti
le idealità e gli interessi esistenti nella società italiana. Quegli interessi non
saranno semplicemente e meccanicamente riprodotti e trasferiti in
parlamento, perché il compito dei partiti è anche quello di filtrare, di
selezionare, di predisporre alla sintesi politica, ma alla fine è nel
Si segnala qui l’imminente pubblicazione degli Atti del Convegno del 1921 Ottobre
1995 su Le idee costituzionali della Resistenza, in cui il tema del partito politico ha
avuto largo spazio. Uno dei massimi costituzionalisti italiani, Vezio Crisafulli, già nel
1966 criticava per altro l’ormai evidente decadenza del ruolo dei partiti politici voluto
ed immaginato dai nostri costituenti. Il DOC. 3 sta in V. CRISAFULLI, Stato, popolo,
governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, Giuffré, 1995.
4
parlamento che tutto questo lavoro confluisce; ed il parlamento è di
conseguenza centrale nel sistema politico perché è lì, e non altrove, che
diviene presente e visibile la società italiana come dato complesso,
organizzato per il tramite dei partiti. Questa società, sul piano
politico-costituzionale non più pensabile senza i partiti, finisce per
coincidere con la tradizionale figura del popolo sovrano, ed il cerchio si
chiude: il parlamento e centrale perché in esso si rende presente e visibile
il popolo sovrano.
Tutto questo costituisce anche la radice più profonda, di ordine
culturale, della straordinaria concordanza dei nostri costituenti a favore del
metodo elettorale proporzionale. Se i partiti non sono semplici strumenti di
organizzazione, ma -come sopra si diceva- vere e proprie istituzioni
politiche, stabilmente presenti nel tessuto concreto della vita democratica, e
se ciascuno di quei partiti, per il fatto stesso di esistere, esprime un aspetto,
un lato, un’inclinazione o tendenza, presente nella società ed in seno al
popolo sovrano, qualsiasi meccanismo di carattere maggioritario, che tende
a ridurre la complessità della rappresentanza parlamentare, o addirittura ad
eliminare dal parlamento uno o più di quei partiti, è certamente
inammissibile, e tale era per i nostri costituenti. Da un parlamento che
pretendeva di rappresentare la totalità del popolo sovrano non poteva essere
eliminata alcuna forza, per quanto piccola, che in quel popolo fosse
presente ed attiva.
C’è poi un’altra conseguenza di questa grande idea-guida della
centralità del parlamento, ed è quest’ultima che ancor più ci avvicina
alla nostra problematica della forma di governo. Se il parlamento
non è semplicemente uno dei poteri costituiti, istituiti e legittimati
dalla costituzione il potere per eccellenza, l’unico in definitiva
chiamato a realizzare il principio-cardine della sovranità popolare,
ogni tentativo di dare forza e consistenza propria all’altro grande
potere presente nelle democrazie contemporanee, il potere
esecutivo, diviene fragile e discutibile.
Non che i nostri costituenti non fossero sensibili nei confronti di questo
problema, anche a noi ormai ben noto sotto il profilo pratico-operativo
della stabilità dell’esecutivo e della efficacia della sua azione. Anzi, le
discussioni alla Assemblea Costituente tornano più volte su questo punto,
proponendo svariate soluzioni, che in seguito sono tornate decisamente alla
ribalta, con formulazioni ormai a tutti note: la sfiducia c. d. costruttiva, o la
fiducia c. d. presunta, o comunque particolari modalità nella proposizione
dell'una o dell'altra. Ma è come se nella discussione alla Costituente
esistesse una sorta di meccanismo implicito, che inesorabilmente faceva
cadere tutte queste proposte di razionalizzazione del governo parlamentare
e di stabilizzazione dell’esecutivo, pur essendo viva in tutti, o quasi, la
consapevolezza del problema.
Noi pensiamo ora di poter indicare la ragione, più o meno
segreta, di tutto questo. La verità è che i nostri costituenti
pensavano che esistesse un solo potere chiamato a mantenere
viva, e realizzare, la grande idea motrice della sovranità popolare, e
che questo potere fosse quello del parlamento. Il governo, in questa
logica, nient'altro è che la proiezione istituzionale del potere-base
insito nel parlamento, e non si traduce affatto in un vero e proprio
potere, in qualche modo paragonabile a quello del parlamento, e
quindi da riconnettere anch’esso, come potere distinto, al principio
democratico della sovranità popolare. Anzi, i nostri costituenti
vedevano con sospetto ogni tentativo di porre l’esecutivo a contatto
diretto con il popolo sovrano, di definire la sovranità popolare come
il potere d’indicazione dell’indirizzo politico di maggioranza da parte
del popolo. In ciò essi vedevano una pericolosa messa in
discussione della loro convinzione più profonda: che le maggioranze
che si formavano in parlamento attraverso la mediazione dei partiti
fossero per definizione le più conformi possibili alla volontà del
popolo sovrano, per il fatto stesso di prodursi in parlamento, nel
luogo in cui la sovranità popolare si realizzava, proprio grazie al
ruolo decisivo dei partiti.
La crisi della costituzione italiana, di cui oggi tanto si discute, è tutta
qui, coincide con la ben nota crisi del sistema dei partiti, che sembra aver
perduto gran parte della sua capacità di esprimere, attraverso l’istituzione
parlamentare, il principio-guida della sovranità popolare. Senza quella
forza originaria legittimante data dal sistema dei partiti, su cui tanto
confidavano i nostri costituenti, la semplice designazione parlamentare che
sta alla base del governo è apparsa fatalmente sempre più fragile, sempre
più frutto di pure mediazioni di carattere più o meno contingente, che non a
caso hanno dovuto far ricorso più volte, alla ricerca di un supplemento di
legittimazione, all’argomento mai tramontato del governo dei tecnici, delle
competenze specialistiche.
Si è trattato tuttavia di soluzioni provvisorie, perché in democrazia è
fatale il riemergere continuo della problematica della legittimazione del
governo sulla base del principio della sovranità popolare. Se questa
legittimazione non può più essere data per intero dal parlamento, perché
questo non può più pretendere di rappresentare il popolo sovrano nel senso
forte, immaginato e voluto dai nostri costituenti, è assai probabile che il
bisogno di fondamento democratico del governo cerchi soddisfazione
ritornando alla base, allo stesso popolo sovrano. Se si vuole rimanere nei
confini del governo parlamentare, è allora necessario che la maggioranza
parlamentare su cui si fonda il governo non sia semplicemente quella
possibile in un determinato momento in parlamento, ma la maggioranza
che corrisponde alla scelta di base a suo favore da parte del corpo
elettorale, di cui il parlamento in sostanza prende atto.
Questo è il cuore del problema che abbiamo di fronte: consiste
nel passaggio storico dal parlamento come rappresentazione
organica della totalità del popolo sovrano al parlamento come
rappresentazione della esistenza nel popolo sovrano di due indirizzi
fondamentali, uno di maggioranza, ed uno alla prova elettorale
risultato minoritario. Ma un risultato di questo genere arriva per
l’appunto al termine di un processo che ha natura storico-politica, e
non può essere prodotto artificialmente, con riforme ispirate a
“modelli” più o meno coerentemente scelti. Quel risultato
presuppone una profonda trasformazione del ruolo dei partiti politici,
non più gestori attraverso la mediazione parlamentare di vere e
proprie “quote” della sovranità, ad essi attribuite dall’esito della
competizione elettorale, ma componenti di coalizioni vincolate nel
loro complesso alla realizzazione di quei programmi che sono stati
presentati al corpo elettorale. Una trasformazione di questo genere
e di prevalente carattere sociale e politico, attiene al modo di
concepire il ruolo e la presenza dei partiti nella società, prima
ancora che nelle istituzioni, può essere favorita da determinate
regole sul piano elettorale, ma non può essere determinata e
prodotta dal puro dato formale della vigenza di nuove regole
costituzionali.
C’è solo un altro modo di rivalutare e salvare il governo parlamentare,
che era ben chiaro anche ai nostri costituenti. Questi posero sì il
fondamento del governo nella maggioranza presente in parlamento, ma
confidavano anche nel ruolo d’influenza, di mediazione, di arbitrato che
avrebbe svolto il Presidente della Repubblica. C’era una consolidata
tradizione europea del governo parlamentare che in questo senso li
confortava: quella particolare forma di governo aveva infatti avuto in
Europa, ed anche in Italia, una fondamentale struttura dualistica, entro cui
il governo era espressione della maggioranza parlamentare, ma anche frutto
della approvazione e del sostegno, più o meno diretto, del Capo dello Stato,
allora della monarchia.
È quindi un luogo comune quello che vuole che i nostri costituenti
abbiano inteso creare un Presidente debole. Essi intesero piuttosto creare un
governo parlamentare a maglie larghe, affidato per la sua effettiva
determinazione alla pratica applicativa, entro cui il parlamento avrebbe
dovuto essere sufficientemente libero nella individuazione della
maggioranza di governo, ma in cui anche il Presidente avrebbe dovuto
occupare uno spazio consistente, dedicato all’esercizio del proprio potere
d’influenza5.
È in effetti ciò che poi di fatto e accaduto. Alla prova dei fatti,
l’istituzione presidenziale si è rivelata in Italia tutt’altro che debole, tant’è
che non di rado , anche in tempi recenti, i Presidenti hanno in sostanza
attribuito ai governi quel supplemento di legittimazione di cui essi spesso
erano carenti. L’elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica,
che si ritrova oggi nella bozza di riforma approvata dalla Commissione
bicamerale, è sul piano storico l’ultimo anello di questa catena, ed ha in
questo senso profonde radici nella storia del governo parlamentare come
forma di governo di carattere dualistico, che si afferma sul piano storico
sulla base di una doppia legittimazione, da parte della maggioranza
parlamentare e da parte del Capo dello Stato. L’elezione popolare diretta
del Presidente rappresenta in questo senso il tentativo di ricercare, per
questa via, quel supplemento di legittimazione di cui il governo
parlamentare ha bisogno, e non il principio fondante di un’altra forma di
governo, vagamente definibile come presidenziale.
Esclusa, com’è noto, la soluzione del governo presidenziale, è soprattutto in questa
chiave che si discusse ripetutamente alla Costituente del ruolo del Presidente, ed anche
della ipotesi di una sua elezione popolare diretta. Si veda il DOC. 4, in particolare con
riferimento alle sedute del 12 marzo, del 19 settembre e del 22 e 23 ottobre 1947 (La
Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, cit. , vol. I°, pp. 349 e ss. , e vol.
1V°, pp. 2952 e ss. e pp. 3465 e ss. ).
5
Ma anche questa via, come quella precedente della investitura popolare
dell'esecutivo, non è affatto percorribile in astratto, non può risultare dalla
meccanica applicazione di un qualche modello preventivamente assunto
come ottimale. Essa presuppone che l’insieme degli attori politici, ed in
particolare il sistema dei partiti, non interpreti, e concretamente utilizzi,
l’elezione del Presidente in chiave antiparlamentare, come se si trattasse
della manifestazione di una volontà popolare di ordine e qualità “superiore”
rispetto alla volontà che si esprime nella elezione del parlamento. È
necessario anzi che la riforma costituzionale sia sorretta da una vera e
propria convenzione tra le forze politiche, che le impegni a non considerare
il Presidente come portatore di un indirizzo proprio, come tale
immediatamente contrapponibile a quello che si esprime nelle elezioni
politiche del parlamento. Non è poco, ed è soprattutto materia affidata
direttamente agli attori politici, su un terreno scarsamente predeterminabile
da regole formali che possano dirsi con sicurezza portatrici di risultati
univoci, come tali garantiti dalla semplice vigenza della regola.
Come ben si vede, ancora una volta la riforma costituzionale si colloca
in uno spazio che solo parzialmente è coperto dalle regole formalmente
intese, e dai modelli. Ciascuna regola, e ciascun modello, vale in rapporto
alle intenzioni effettive dei soggetti politici che propongono le une e gli
altri, che concretamente sono e saranno chiamati ad operare: ancora una
volta, la natura di ciascuna forma di governo, e dei processi di riforma di
ciascuna di esse, appartiene in senso profondo al campo della storia politica
e costituzionale.