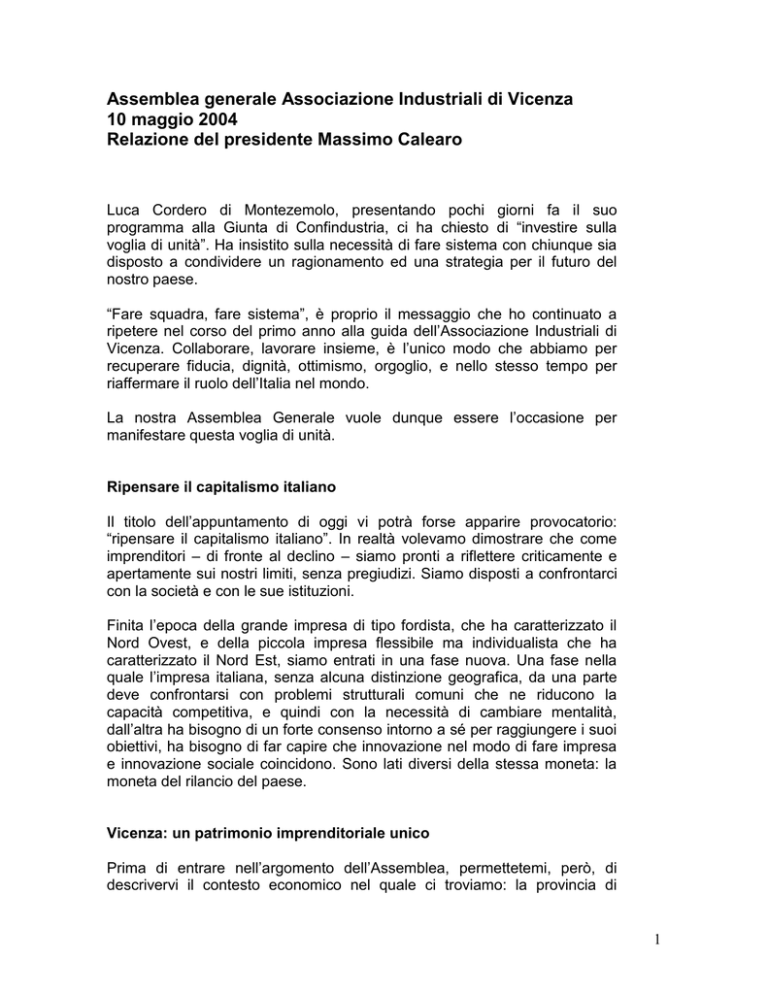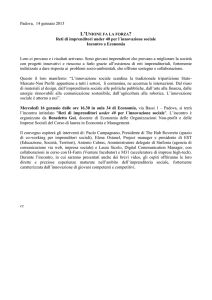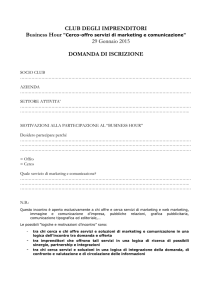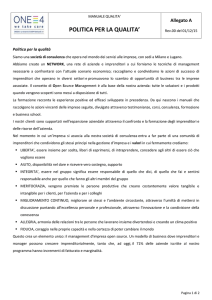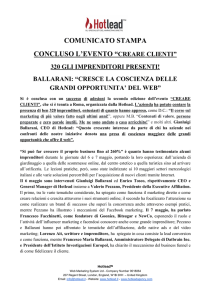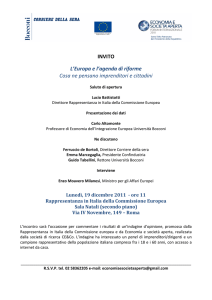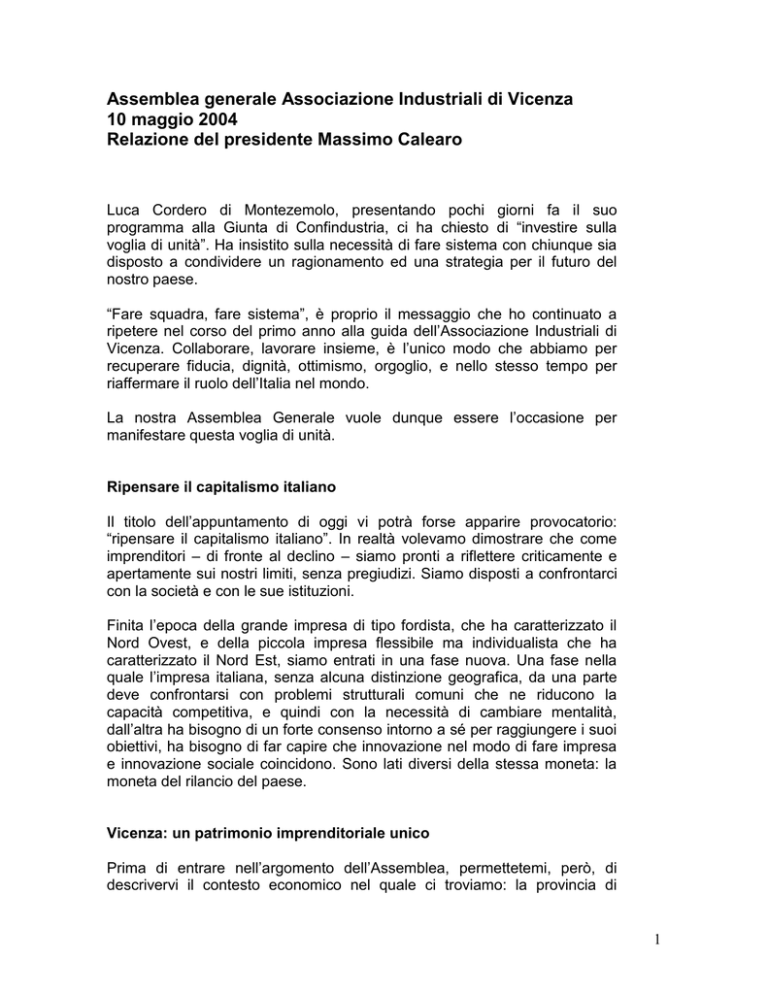
Assemblea generale Associazione Industriali di Vicenza
10 maggio 2004
Relazione del presidente Massimo Calearo
Luca Cordero di Montezemolo, presentando pochi giorni fa il suo
programma alla Giunta di Confindustria, ci ha chiesto di “investire sulla
voglia di unità”. Ha insistito sulla necessità di fare sistema con chiunque sia
disposto a condividere un ragionamento ed una strategia per il futuro del
nostro paese.
“Fare squadra, fare sistema”, è proprio il messaggio che ho continuato a
ripetere nel corso del primo anno alla guida dell’Associazione Industriali di
Vicenza. Collaborare, lavorare insieme, è l’unico modo che abbiamo per
recuperare fiducia, dignità, ottimismo, orgoglio, e nello stesso tempo per
riaffermare il ruolo dell’Italia nel mondo.
La nostra Assemblea Generale vuole dunque essere l’occasione per
manifestare questa voglia di unità.
Ripensare il capitalismo italiano
Il titolo dell’appuntamento di oggi vi potrà forse apparire provocatorio:
“ripensare il capitalismo italiano”. In realtà volevamo dimostrare che come
imprenditori – di fronte al declino – siamo pronti a riflettere criticamente e
apertamente sui nostri limiti, senza pregiudizi. Siamo disposti a confrontarci
con la società e con le sue istituzioni.
Finita l’epoca della grande impresa di tipo fordista, che ha caratterizzato il
Nord Ovest, e della piccola impresa flessibile ma individualista che ha
caratterizzato il Nord Est, siamo entrati in una fase nuova. Una fase nella
quale l’impresa italiana, senza alcuna distinzione geografica, da una parte
deve confrontarsi con problemi strutturali comuni che ne riducono la
capacità competitiva, e quindi con la necessità di cambiare mentalità,
dall’altra ha bisogno di un forte consenso intorno a sé per raggiungere i suoi
obiettivi, ha bisogno di far capire che innovazione nel modo di fare impresa
e innovazione sociale coincidono. Sono lati diversi della stessa moneta: la
moneta del rilancio del paese.
Vicenza: un patrimonio imprenditoriale unico
Prima di entrare nell’argomento dell’Assemblea, permettetemi, però, di
descrivervi il contesto economico nel quale ci troviamo: la provincia di
1
Vicenza, una delle più industrializzate d’Italia.
Complessivamente nella nostra provincia ci sono 18.200 imprese
manifatturiere, che insieme nel 2003 hanno generato un fatturato di 41
miliardi di euro e hanno esportato beni per 9,3 miliardi, quasi quanto l’intera
Grecia, con un saldo commerciale positivo di 4 miliardi. Le persone
occupate in queste imprese sono 193 mila, il 24% della popolazione. Poco
più di 12 dipendenti per azienda. Il tasso di attività è del 68% e quello di
disoccupazione del 2,6%. Il valore aggiunto procapite ha toccato i 22.200
euro, contro i 18.000 dell’Italia. Il peso dell’industria sul totale del valore
aggiunto è del 38,5%, nel Veneto è del 28,9%, in Italia del 22,9%.
Questi dati testimoniano di una forte vocazione manifatturiera, e di un
patrimonio di esperienze imprenditoriali unico e fra i più ricchi del paese.
Sono decine e decine le imprese vicentine che competono da autentici
campioni sulla scena mondiale.
Un sistema di piccole e medie imprese, che si trova oggi a fare i conti con
una lunga congiuntura economica negativa, con un cambio euro/dollaro
sfavorevole, con una evoluzione tecnologica rapidissima, ma più di tutto con
la concorrenza agguerrita, e a volte spregiudicata, dei produttori asiatici
proprio nei settori nei quali si è specializzata.
Nel 2003, rispetto all’anno precedente, il fatturato dell’industria vicentina è
diminuito dello 0,2%, la produzione dell’1,8%, e l’export ha subito un calo
del 21,4%. Spiegabile solo parzialmente con il trasferimento della
produzione all’estero.
E’ solo un problema congiunturale?
Il punto è se la cattiva congiuntura, il cambio euro-dollaro, la Cina sono le
uniche ragioni delle attuali difficoltà delle imprese vicentine e italiane, ed in
generale dell’economia, oppure se c’è qualcosa di più profondo, che
riguarda la struttura stessa della nostra industria. Se per caso siamo meno
preparati di altri a rispondere alle sfide del mercato globale.
E’ probabile che la seconda ipotesi sia quella valida, altrimenti non si
spiegherebbe perché, rispetto agli altri paesi avanzati, l’Italia fa così fatica a
crescere. Perché resta inchiodata a tassi di incremento del PIL dello zero
virgola.
C’è chi recentemente ha paventato un rischio declino per l’Italia. Per alcuni
siamo già entrati in un periodo di decadenza. Io sospendo il giudizio. E’
comunque vero che eventi eccezionali come l’11 settembre, la SARS, la
guerra in Iraq, l’avvio dell’euro, e quant’altro, non giustificano – o spiegano
solo in parte – la singolarità della nostra situazione.
2
Altri paesi, vedi gli Stati Uniti, più colpiti di noi dagli eventi citati, hanno
saputo reagire e hanno ripreso a crescere a ritmi vertiginosi, dell’ordine del
4,5%. Oggi USA e Cina stanno trascinando l’intera economia mondiale,
apparentemente senza alcun bisogno né dell’Europa, né tantomeno
dell’Italia.
Certo, pure l’economia continentale è in stallo, in apnea. Dovevamo
diventare l’area economica più competitiva al mondo. Siamo, invece,
l’ultima. C’è un problema Europa, ma all’interno di questa, c’è un problema
Italia. La rivalutazione dell’euro sul dollaro ha sì colpito l’export di tutte le
nazioni europee, ma in misura maggiore ha colpito l’export italiano che ha
perso più quote di mercato rispetto a Francia e Germania.
Europa: gigante economico, nano politico
Se gli eventi della cronaca internazionale non bastano a far luce sulle
ragioni del deteriorarsi della nostra economia, allora è necessario rivolgere
lo sguardo lungo altre direttrici.
A cominciare proprio dall’Europa.
Qualcuno ha definito il nostro vecchio continente, allargato a 25 paesi, lo
spazio minimo nel quale le imprese dovrebbero essere presenti, la
“piattaforma” verso la conquista di nuovi mercati.
Non ci possiamo però nascondere i mali di cui soffre questa Europa.
Lo scarto fra rilevanza economica e irrilevanza politica ci impedisce di
esercitare un’autentica leadership mondiale, ci indebolisce nel confronto con
altre aree, in primis Cina e Stati Uniti. Definire delle regole di governance
coerenti con la dimensione e la complessità dell’Unione, e approvare la
nuova costituzione sono dei passaggi fondamentali per non essere relegati
a esercitare un ruolo marginale sul piano internazionale.
La rigidità con la quale sono applicati i criteri definiti dal “Patto di stabilità e
crescita”, e l’enorme potere assegnato ad organismi burocratici le cui
decisioni non sono legittimate dalla volontà popolare, come la Banca
Europea e la Commissione Europea, non danno ai singoli paesi margini di
azione sufficienti per reagire rapidamente al modificarsi del contesto
economico esterno. C’è un eccesso di regole, che spesso riduce la capacità
competitiva delle imprese, a vantaggio delle loro concorrenti.
Lo squilibrio nella ripartizione delle risorse comunitarie è divenuto
inaccettabile. Basti dire che il budget assegnato alla ricerca è un decimo di
quello destinato alla politica agricola, la quale assorbe da sola il 50% del
bilancio dell’Unione. Siccome è proprio sul primato scientifico e tecnologico
3
che si gioca la partita del futuro, quello della ripartizione dei fondi è un nodo
da sciogliere.
Lo scorso 21 aprile Cina e Usa si sono incontrate per risolvere alcune
dispute economiche: dagli standard sulle comunicazione wireless, alla
copiatura dei prodotti; dalla violazione dei diritti sulla proprietà intellettuale
all’eliminazione di restrizioni normative imposte alle aziende americane che
intendono esportare in Cina, senza obbligarle a passare attraverso società
cinesi.
Dispute che toccano pure le nostre aziende, sulle quali si attende l’avvio di
un negoziato serio con la Cina, improntato alla difesa dei diritti dei produttori
europei.
Le lacune, e i ritardi, dell’Europa si riflettono sulle opinioni degli imprenditori.
Voglio sottoporre alla vostra attenzione alcuni brani estratti dalle numerose
lettere che alcuni associati mi hanno scritto negli ultimi mesi, dai quali ho
tolto qualsiasi riferimento diretto.
La prima lettera è del titolare di un’azienda meccanica, che esporta il 60%
della produzione negli Stati Uniti. Il problema è il cambio euro/dollaro. “Può
ben immaginare - mi scrive questo associato - che se avessimo voluto
aumentare i prezzi in funzione della svalutazione avremmo perso il mercato
… pertanto stiamo cercando di limitare i danni, sopravvivendo alla meglio,
nella speranza che il dollaro dopo le elezioni di novembre inverta il trend; la
cosa che ci ha stupiti – continua la lettera - … è che a livello comunitario
non si sia intervenuti e non si stia intervenendo in nessun modo”.
“Ti posso garantire – mi scrive un altro imprenditore – che stiamo
attraversando un momento di grande difficoltà sul mercato americano. Con
riduzione dei volumi e soprattutto compromissione dei rapporti con i nostri
clienti, frutto di lunghi anni di lavoro e sacrifici. Stiamo aprendo le porte alla
nostra concorrenza senza poter opporre resistenza, aspettando impotenti il
nostro declino”.
Gli stessi toni si ritrovano nella terza e ultima lettera che vi voglio citare,
dove si parla di un’Europa “che, per salvare la ricchezza di carta, uccide le
imprese…un Europa che non riesce a tessere rapporti di reciprocità
commerciale nemmeno con i paesi avanzati, figuriamoci con i nuovi mercati
emergenti … un’Europa che ha solo aggiunto un nuovo livello di burocrazia
da dover scavalcare per poter lavorare”.
C’è un punto di questa lettera che credo sia importante evidenziare.
L’imprenditore è titolare di un’azienda leader nel tessile: “I nostri politici ci
stimolano ad investire. Ci stimolano a fare ricerca. Francamente non credo
che 400 milioni di europei potranno diventare tutti dei nanotecnologi o dei
biotecnologi …Perché, quindi, buttar letteralmente via interi settori dove
4
ancora abbiamo competenze e vantaggi da poter sfruttare? Perché voler
annullare professionalità e competenze costate decenni di applicazione e
che, una volta perse, non sarà più possibile recuperare?”. Come dargli torto!
“L’industria manifatturiera non è una cosa del passato”, si legge nell’ultimo
numero della rivista “Il Mulino”. E’ vero. L’industria manifatturiera è una cosa
del futuro: è tuttora - e continuerà ad esserlo nei prossimi anni - il cuore del
sistema economico europeo e italiano. Senza le imprese industriali, banche,
servizi, università, per chi lavorerebbero? Da solo il terziario non sarebbe in
grado di sostenere l’economia. Puntare sullo smantellamento dell’industria
per dedicarci tutti alla finanza, al turismo o altro, sarebbe stupido. L’Italia,
ma lo stesso vale per l’Europa, per essere una potenza economica
mondiale ha più che mai bisogno dell’industria manifatturiera. Senza di essa
sarebbe sì condannata al declino.
Nonostante il diffondersi di opinioni critiche, come imprenditori abbiamo il
dovere di continuare a credere nell’Europa come alla nostra più grande
opportunità. E’ qui, in un ambiente culturalmente affine, che le piccole e
medie industrie italiane possono sperimentare modalità di crescita, imparare
a internazionalizzarsi, ampliare quote di mercato, misurarsi con le esigenze
di nuovi consumatori, allargare le loro conoscenze ed esperienze. Spetta a
noi combattere lo scetticismo che si sta diffondendo intorno e dentro
l’Europa.
Secondo un recente sondaggio della Fondazione Nord Est, eseguito su di
un campione di cittadini di 9 paesi dell’Unione, 4 dei quali di nuova entrata,
gli europei sono delusi dai risultati dell’economia, e nello stesso tempo
domandano istituzioni più autorevoli e maggiore peso politico esterno. Sono
delusi di ciò che è stato fatto. Chiedono ciò che ancora non si è riusciti a
realizzare. Siamo, dunque, in una tenaglia nella quale l’idea stessa di
Unione Europea rischia di rimanere soffocata. Per questo dobbiamo essere
molto chiari con noi stessi e con l’opinione pubblica. L’Europa va costruita
non perché è un buon affare, ma perché ci dà un ruolo su scala globale. La
risposta alle sfide della seconda fase della globalizzazione economica o è
continentale o non è. Per questo gli imprenditori sono i più interessati a far
sì che il progetto di integrazione sia completato e si arrivi agli Stati Uniti
d’Europa.
I dieci paesi entrati a far parte della UE lo scorso primo maggio, insieme
contribuiscono al 20% della popolazione comunitaria, ma solo al 5% del PIL
totale. Il divario da colmare è considerevole. Scommettere nella crescita di
questi paesi, esportare cultura imprenditoriale, migliorare il livello di
benessere dei loro cittadini con i nostri prodotti, sono i modi a nostra
disposizione per contribuire attivamente al successo dell’Unione.
5
Le ragioni interne delle difficoltà italiane
Torniamo però alla questione italiana: declino sì o declino no.
Anche le colpe dell’Europa non spiegano perché cresciamo così poco.
Ognuno dei paesi dell’Unione subisce gli effetti del nanismo politico, della
svalutazione dell’euro, della burocrazia di Bruxelles.
E’, quindi, venuto il momento di vedere se ci sono dei fattori interni, specifici,
che riguardano solo il nostro paese. Ovviamente questi fattori esistono.
A cominciare dalle tendenze demografiche e dall’invecchiamento della
popolazione, fenomeni di lungo periodo tali da influenzare radicalmente
aspettative, valori, priorità, politiche, con effetti profondi sulla tenuta dello
Stato Sociale, e sugli equilibri della spesa pubblica.
C’è poi la resistenza, o meglio l’inerzia, opposta dalla pubblica
amministrazione - dalla scuola alla sanità - alle riforme dirette ad aumentare
l’efficienza e a introdurre criteri di merito nel valutare i risultati.
C’è l’ancor insufficiente liberalizzazione del mercato dei servizi, dall’energia
ai trasporti, dalle telecomunicazioni al commercio, fino alle libere
professioni. In Italia si continua a vivere questa strana scissione fra aree
dell’economia protette da vincoli posti dallo Stato, dove la concorrenza è
bassa, e aree popolate da imprese piccole e medie, esposte in pieno alla
concorrenza internazionale.
C’è, infine, la perdurante arretratezza del nostro Paese, in materia di
formazione (vedi il basso numero di laureati rispetto agli altri paesi europei),
ricerca scientifica, utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, infrastrutture,
capacità di richiamare investimenti esteri.
Su tutti questi fattori, prevalgono i ritardi del sistema politico. Sia del governo
che dell’opposizione.
I limiti dell’industria italiana
Ma nemmeno l’industria italiana è esente da responsabilità.
Se dovessimo scattare oggi una fotografia della nostra realtà produttiva,
ecco cosa vedremmo:
• una scarsa presenza dell’Italia nei segmenti tecnologicamente avanzati,
dopo che negli anni precedenti sono stati abbandonati quelli nei quali
eravamo all’avanguardia, come la chimica, l’informatica, l’aeronautica
civile, le telecomunicazioni;
• una manciata di grandi imprese frutto delle liberalizzazioni degli anni ’90,
o tuttora di proprietà pubblica, concentrate per lo più sul mercato interno,
e comunque più piccole dei loro concorrenti;
6
• pochissime grandi aziende private, anche in questo caso più piccole dei
loro concorrenti esteri;
• un migliaio di medie imprese autentiche “multinazionali tascabili”, leader
nelle loro nicchie, molto vivaci e innovative, ma poco “sistemiche” e
comunque non in grado da sole di compensare l’assenza delle grandi;
• centinaia di migliaia di piccole imprese superspecializzate, di dimensioni
troppo ridotte per riuscire a sostenere le bordate dei nuovi produttori
asiatici, raggruppate in settori poco dinamici, a basso valore aggiunto e
facilmente attaccabili.
Questa fotografia non ci farebbe però vedere i nostri limiti “culturali”, le cui
conseguenze sulla vivacità del sistema industriale italiano possono essere
rilevanti:
• tendiamo a confondere gli interessi dell’impresa con quelli della famiglia;
• evitiamo la finanza, e preferiamo ricorrere ai consueti prestiti a breve
termine e alle garanzie sui capannoni;
• spendiamo poco in ricerca e innovazione rispetto ai nostri concorrenti;
• siamo molto attenti al prodotto e poco al servizio, al marketing, alla
qualità della relazione con il cliente;
• siamo restii a crescere, ad acquisire altre imprese o ad allearci per fare
massa critica.
Mi ha stupito la lettura dei risultati di una seconda indagine della Fondazione
Nord Est, eseguita per conto del Sole 24 Ore su di un campione di 1000
imprenditori italiani titolari di aziende con più di 10 dipendenti.
Solo il 10% delle aziende ha uno stabilimento produttivo o un ufficio
operativo all’estero. Ciò significa non essere abbastanza globali.
Il 48% degli imprenditori quando va all’estero preferisce ricorrere al “fai da
te”. Alla domanda su cosa si dovrebbe fare per rendere più competitive le
imprese, rispetto all’edizione 2003, aumenta la percentuale di quanti
sostengono che si debba continuare ad agire da soli, e diminuisce la
percentuale di chi ritiene utile formare consorzi o fondersi con altre aziende.
Appena il 5,4% degli intervistati pensa ad eventuali acquisizioni.
La maggior parte del campione colloca al di fuori della propria azienda i
motivi della scarsa competitività del sistema produttivo. Sono pochi quelli
disposti a riconoscere nella piccola dimensione o nei pochi investimenti in
innovazione altrettante valide ragioni della nostra difficoltà a fronteggiare
l’aggressività dei concorrenti esteri.
I risultati dell’inchiesta della Fondazione Nord Est confermano in pieno i
limiti “culturali” a cui ho accennato prima. Sono sempre più convinto che
l’individualismo, o piuttosto il “solismo”, l’incapacità di fare squadra, sia la
vera patologia del capitalismo italiano.
7
Un patto per lo sviluppo
Definito il quadro, come ne usciamo? Ne usciamo insieme. Nessuno di noi,
mi riferisco ai diversi interlocutori presenti oggi sul palco, ognuno a suo
modo rappresentante di una fetta della società, può farcela da solo.
Per uscirne insieme devono verificarsi almeno tre condizioni:
• la prima, prendere tutti coscienza della realtà della situazione, ed evitare
di nasconderci le difficoltà: la consapevolezza è un fattore indispensabile;
• la seconda, adottare un comportamento lontano da ogni falsa ideologia,
essere disposti a discutere civilmente e con mentalità aperta tutti i
problemi sul tappeto;
• la terza, darci una “missione”, come ha detto Montezemolo, recuperare lo
spirito del dopoguerra, quel senso di unità e di spinta in avanti che ci ha
consentito di creare il “miracolo italiano”.
A rischio di apparire noioso e di ripetermi, dobbiamo riuscire a “fare
squadra”, e mettere al servizio del paese le migliori energie di cui
disponiamo. Intorno ad un progetto, o se vogliamo ad un patto, articolato sia
a livello nazionale sia a livello territoriale. Un patto fra tutti i principali attori:
sindacati,
banche,
università,
organizzazioni
imprenditoriali.
E,
naturalmente, governo, classe politica, enti locali. Nel pieno rispetto delle
differenze e senza avere la pretesa di risolvere ogni tensione. Ciò sarebbe
impensabile e irrealizzabile.
Con quale obiettivo? Proporre un modello di sviluppo centrato su alcune
parole chiave: qualità, ricerca, innovazione, internazionalizzazione,
formazione, rispetto dell’ambiente.
Provo a fornire alcuni spunti di discussione.
Con il sindacato dovremo parlare di nuove povertà, di lavoro sommerso,
dell’applicazione della riforma Biagi, di come aggiornare e arricchire le
competenze dei lavoratori, della riforma del Welfare State, di come
riorganizzare la spesa pubblica per bilanciare le esigenze di sicurezza
sociale con la necessità di reperire le risorse necessarie per fare ricerca,
innovare, formare.
Nella fase di globalizzazione spinta degli anni ’90 tutti pensavano che
finanza e mercato potessero risolvere ogni problema. Oggi sappiamo che
non è così. Trascurare la dimensione sociale e quella etica è sbagliato, ed
sconsigliabile per la tenuta della stessa economia.
Tuttavia non si può dimenticare che un sistema industriale forte,
competitivo, dinamico, internazionalizzato, è utile alla difesa degli interessi
dei lavoratori, lavoratori che non costituiscono qualcosa a sé, ma sono il
8
patrimonio delle nostre imprese. Per questo è necessario riprendere il
dialogo con il sindacato, aiutando le componenti più aperte ad isolare quelle
frange estremiste i cui modi di agire sono deleteri per tutti.
Con le banche dovremo affrontare il tema strategico del finanziamento alle
PMI. Dopo i vari crack e le preoccupazioni sollevate, mi auguro che si
riprenda a fare sistema insieme. Un esempio è il primo bond territoriale
proposto proprio nel Veneto. La domanda ha superato ampiamente l’offerta
e il bond è stato collocato con un rating “tripla A” presso investitori
istituzionali. Ciò dimostra che è possibile sfuggire alla trappola del breve
termine, occorre solo un po’ di creatività e la disponibilità a escogitare
strumenti finanziari innovativi in grado di superare le barriere psicologiche
dei piccoli imprenditori. E’ importante che gli istituti di credito condividano
con noi il rischio di fare impresa: non per ragioni speculative, le cui
conseguenze abbiamo già visto, ma per aiutare le stesse imprese a
crescere, premiando le capacità imprenditoriali individuali, le buone idee, i
buoni progetti di business, senza guardare sempre e solo alle garanzie
offerte dal patrimonio personale.
Confindustria e ABI devono affrontare insieme questi temi ed elaborare un
prtogetto di largo respiro per sostenere gli impegni che la competitività
impone alle piccole e medie imprese.
Con le Università dovremo affrontare i temi della formazione avanzata e
della ricerca e dell’innovazione. La Riforma Moratti e il nuovo “Piano
nazionale della ricerca” sembrano andare nella giusta direzione, quella di
riconoscere chi ottiene dei risultati. Bisogna però uscire dalla cappa
“ideologica” che soffoca il rapporto università-impresa. Essere accusati di
voler “aziendalizzare” la scuola o la ricerca è anacronistico.
Bisogna avere il coraggio di scegliere in quali aree fare ricerca e nelle quali
possiamo essere i primi, e su queste concentrare gli investimenti, tenendo
conto delle potenzialità e delle caratteristiche del sistema produttivo.
Così come bisogna avere il coraggio di puntare su alcune Università e
alcuni Centri di ricerca e fare in modo che siano fra i migliori al mondo.
E’ concepibile che in Italia siano state avviate almeno una quarantina di
iniziative sulle nanotecnologie e in Inghilterra solo due, e si stia pensando
addirittura di unificarle?
Il localismo applicato alla ricerca scientifica è dannoso e fonte di spreco.
Perché nel Nord Est non si riesce a valorizzare quella splendida risorsa che
è l’area scientifica di Trieste, la città italiana con la più alta densità di
scienziati e ricercatori? Fare squadra significa anche capire quando è il
momento di mettere da parte l’orgoglio territoriale e cogliere le opportunità
dove si presentano.
Le responsabilità degli imprenditori
9
E noi imprenditori, cosa possiamo fare per contribuire a questa nuova fase
di rilancio dell’industria italiana? Semplicemente, possiamo continuare a fare
gli imprenditori: investire nella crescita delle nostre imprese, credere nelle
possibilità del paese, trasmettere, nonostante le difficoltà, fiducia nel futuro,
adeguando però la nostra mentalità al contesto attuale.
Vi voglio raccontare quanto ci ha detto Federico Faggin, inventore del
microchip, durante un recente viaggio di studio della Giunta
dell’Associazione nella Silicon Valley. Alla domanda se una piccola impresa
può fare ricerca, Faggin ha risposto che in California “tutte le imprese
nascono piccole, intorno ad un’idea innovativa, ma fin dall’inizio hanno
l’ambizione di diventare grandi, partono con l’idea di essere delle
multinazionali”. Perché solo così, ha aggiunto, “possono diventare
autonome e difendersi dal contrattacco dei concorrenti”. Avere una visione
globale è considerato determinante per il successo dell’impresa.
Otto delle attuali 25 maggiori aziende americane non esistevano o erano
piccole nel 1960. In Europa, invece, sono più o meno le stesse. Sempre
negli Stati Uniti una piccola azienda passa da 10 a 26 dipendenti in due
anni. In Europa, nello stesso periodo, passa da 10 a 11-12 dipendenti.
La morale è: non è importante se si è piccoli, è importante avere un
approccio globale, avere il mondo come orizzonte, non temere il confronto
con qualsiasi concorrente, essere alla frontiera delle nuove tecnologie.
Un’impresa che ragiona così, difficilmente resta piccola, in ogni caso diventa
la prima nella propria nicchia.
Al contrario, se un’impresa non si impegna nella ricerca, nell’innovare
prodotti, tecnologie, organizzazione e relazione con i clienti, se rifiuta
l’apporto della cultura manageriale, non sfrutta la leva finanziaria, non fa
formazione, ebbene, questa impresa, a prescindere da quanto grande essa
sia, è destinata ad essere spazzata via dal mercato e dalla concorrenza.
Un’impresa di questo tipo sarebbe però una contraddizione in termini.
Sarebbe la negazione dell’idea stessa di fare impresa.
Per questo ritengo corretto eliminare i sussidi a pioggia dati in modo
indifferenziato a tutte le imprese, e passare a forme di incentivazione,
possibilmente con meccanismi fiscali mantenuti nel tempo, accessibili
unicamente a quelle imprese che si impegnano seriamente a intraprendere
la strada della crescita e dell’innovazione a 360° gradi, compresa l’alleanza
con altre PMI per fare squadra e aumentare la massa critica.
I compiti della politica
Infine c’è la politica. A lei spetterebbe il compito di scegliere, di risolvere le
tensioni e i conflitti in vista dell’interesse generale della collettività. Non
sempre ultimamente ha mostrato di saperlo fare. Manca una lettura
10
concorde dello scenario. Le posizioni sono molto diverse; per alcuni si tratta
di dare un semplice stimolo alla domanda perché la macchina dell’economia
si rimetta in moto, per altri occorre definire una vera e propria strategia di
rilancio industriale.
Di cosa ci sarebbe, invece, bisogno?
Di aprire ulteriormente i mercati dell’energia, dei trasporti, dei servizi, delle
libere professioni. Di difendere e valorizzare le peculiarità della cultura
produttiva italiana, il “Made in Italy”. Di sostenere in modo fermo in Europa il
diritto di reciprocità nei confronti della condotta commerciale di altri paesi,
Cina in testa. Di definire quali sono le nostre priorità nella ricerca scientifica
e tecnologica. Di creare un ambiente favorevole alla crescita, il che significa
istituzioni autorevoli, norme chiare e facili da applicare, pubblica
amministrazione efficiente.
E’ fondamentale che la politica sia ben consapevole della delicatezza del
momento. Non serve invocare lo spettro del declino, per accorgersi che il
nostro paese si trova comunque ad un bivio: da una parte c’è il rischio di
essere marginalizzati, dall’altra c’è l’opportunità di consolidare e accrescere
il nostro peso culturale ed economico.
E’ poi importante che gli imprenditori, e le organizzazioni che li
rappresentano, abbandonino ogni desiderio di appoggiare questo o quello
schieramento. Gli imprenditori debbono scegliere la via dell’autonomia. Non
l’equidistanza, ma il confronto su progetti di sviluppo, modernizzazione e
innovazione del sistema. Oggi il futuro dell’Italia non è una questione di
destra o di sinistra, è un interesse generale dell’intero Paese.
Il Nord Est di fronte ad una svolta
Ora mi propongo di collegare quanto detto fin qui con la nostra realtà
territoriale, quella che tuttora per convenienza chiamiamo Nord Est.
Fino ad oggi noi ci siamo pensati come qualcosa a sé, di diverso dalle altre
regioni italiane. Ciò non è più vero. Questa diversità, unita ad una
predisposizione alla protesta, non ci ha portato in nessun luogo. Quali
risultati abbiamo ottenuto? Contiamo di più o di meno a livello nazionale?
L’unico modo per incidere nelle politiche nazionali è partecipare ad esse,
dare il nostro apporto di idee, essere più innovativi degli altri, ma in ogni
caso esserci.
Tra l’altro, come abbiamo visto, la situazione economica del Nord Est è la
stessa del resto del paese. La congiuntura negativa sta colpendo settori
trainanti della nostra economia e sta mettendo in difficoltà molte aziende.
Con l’aggravante che noi eravamo abituati a ritmi di crescita elevati, per cui
adesso ci risulta quasi impossibile accettare la situazione. Insomma, siamo
11
nella stessa barca, ci siamo accorti di avere gli stessi problemi di un’azienda
bergamasca, marchigiana o emiliana. E abbiamo compreso che per far
ripartire la barca dobbiamo remare tutti insieme.
Eppure per anni siamo stati un modello, ricostruito a posteriori, non
pianificato, ma comunque un modello con delle sue particolarità:
•
la piccola impresa, diffusa, dinamica e proiettata ai mercati esteri;
•
il valore del lavoro e del sacrificio personale;
•
il legame con il territorio, il campanile;
•
il forte consenso sociale, tutti volevamo uscire dalla miseria.
Come sapete da ormai nove anni la nostra Associazione commissiona al
prof. Ilvo Diamanti la realizzazione di un “Osservatorio sulla società
vicentina”, diventato un punto di riferimento per capire gli umori dell’intera
area.
Cosa rivela l’Osservatorio di quest’anno? Per sintetizzare quanto sta
accadendo, Diamanti ha coniato un’immagine suggestiva ed efficace, “post
Nord Est”. Cito quanto scrive nel suo rapporto: l’ipotesi è che stiamo vivendo
“una fase diversa, nella quale le condizioni costitutive del successo
economico e sociale precedente non funzionano più”.
Attenzione, non è cominciato il declino del Nord Est, è in corso un
passaggio da una fase ad un’altra. Mi piace usare la metafora della “terza
ondata”. La prima è stata quella dell’economia dell’emigrazione. La seconda
quella dell’economia della quantità. La terza, oggi, è – deve essere - quella
dell’economia della qualità.
Il post Nordest non sancisce dunque la crisi. Sono cambiate le condizioni
che avevano favorito e “costituito” lo sviluppo precedente. Oggi occorre
fondare lo sviluppo su condizioni, risorse, fattori del tutto nuovi, non solo
cambiare faccia, abito, ma mentalità, cultura, logica. Non è la fine
dell’industria, ma l’integrarsi di questa con i servizi, la ricerca. Materialità e
immaterialità diventano un unicum.
Post Nord Est significa che la piccola impresa non gode più dell’alleanza
“naturale” con la società, il territorio, non può dare questa alleanza per
acquisita. Deve ricostruirla, valorizzarla, e potrà riuscire a farlo solo se
investirà in qualità, in cultura, e in “politica”. Solo se la piccola impresa
comincerà a “pensare in grande”, ad avere una visione globale.
Di questo gli imprenditori sono ben consapevoli: il 75% è d’accordo sul fatto
che occorra migliorare la qualità della vita e del territorio. L’obiettivo è quindi
quello di progettare anche per Vicenza e per il Nord Est, un nuovo modello
di sviluppo, questa volta sì concordato e non lasciato al caso. Un modello
che abbia al suo centro il concetto di qualità. In senso generale:
dell’ambiente, della formazione, dell’innovazione, del modo di fare impresa,
12
delle relazioni sociali, delle infrastrutture.
Se riusciremo a coniugare il bello e il buono dello sviluppo avremo raggiunto
questo risultato. Ci stiamo già lavorando. Con la Provincia abbiamo firmato
un accordo per riqualificare le aree industriali. La Regione sta definendo il
proprio “Programma regionale di sviluppo”.
Anche qui è essenziale decidere le priorità, non ci possiamo permettere di
disperdere le poche risorse disponibili.
Con il federalismo e il decentramento gli enti locali, ed in particolare la
Regione, hanno acquisito competenze rilevanti, oggi hanno la concreta
possibilità di determinare i processi di sviluppo, di orientare le scelte in
materia di infrastrutture, innovazione, formazione. Il programma regionale è
un’occasione da non perdere per ridisegnare, insieme, coinvolgendo tutti i
soggetti interessati, il futuro dell’area nella quale viviamo.
Sono convinto che abbiamo ancora l’opportunità di essere per l’Italia una
sorta di laboratorio, dove sperimentare novità da replicare in altre regioni.
Con un approccio, però, diverso dal passato. L’idea di Nord Est è nata per
contrapposizione al Nord Ovest: l’Italia della piccola impresa contro quella
della grande impresa. Ma oggi anche il Nord Ovest sta cambiando.
La grande impresa non esiste più. Esiste solo l’Italia delle imprese. E come
ha detto nei giorni scorsi il presidente Ciampi, bisogna impegnarsi tutti per
“contrastare con successo la deindustrializzazione”. “Non possiamo
permetterci, ha affermato Ciampi, di perdere nemmeno un’impresa per
strada”.
Conclusioni
Per chiudere ho scelto una frase del teologo americano Michael Novak.
L’elemento specifico che caratterizza il capitalismo rispetto a tutti gli altri
sistemi economici, ha scritto, “è il valore assegnato all’intraprendenza e
all’iniziativa individuale: il ricorso all’ingegno e all’intuito dell’uomo per
inventare nuovi beni e servizi…La principale risorsa del capitalismo è il
capitale umano: conoscenza, know how, intuito, capacità”.
Ebbene, io continuo a credere in tutto ciò, nello spirito che anima la nostra
voglia di fare, che ci spinge ogni giorno a concepire nuove idee. Dobbiamo
cambiare qualcosa nel modo di farlo. Se ci riusciremo - e ci riusciremo l’Italia, e di conseguenza Vicenza e il Nord Est, avranno un grande futuro
davanti.
13