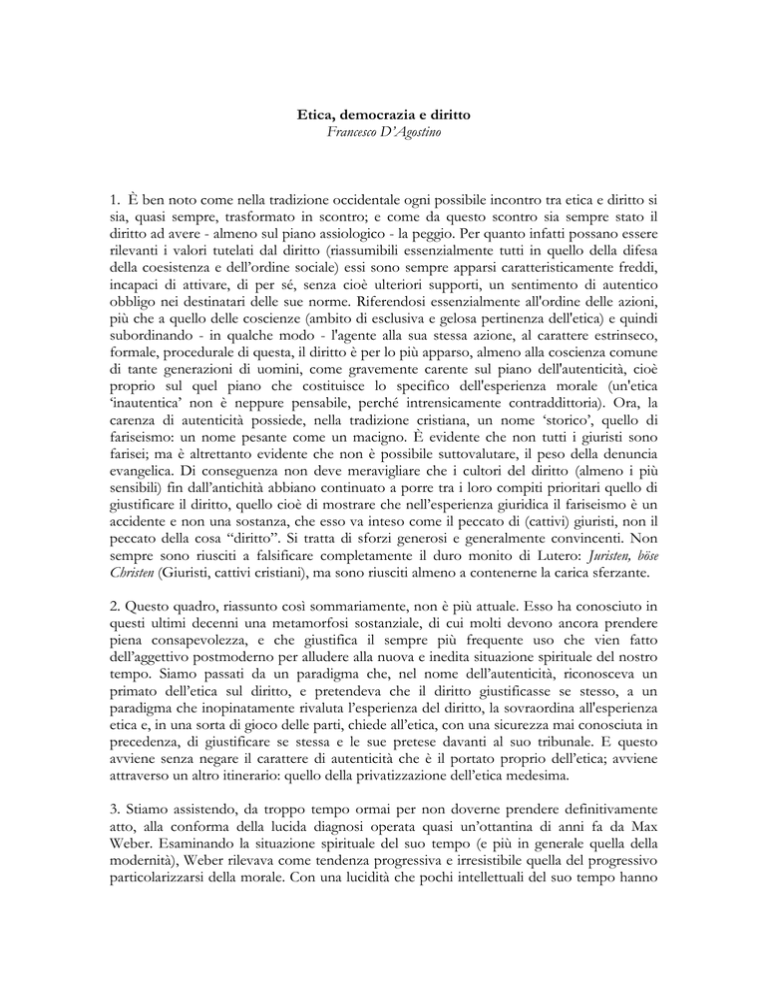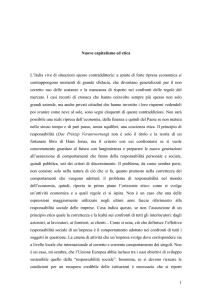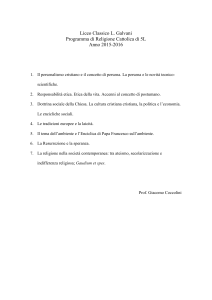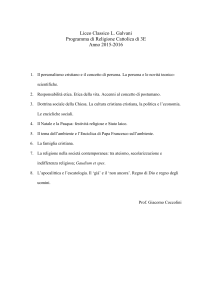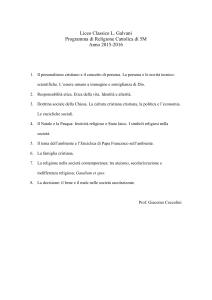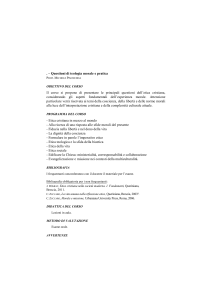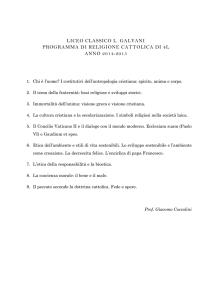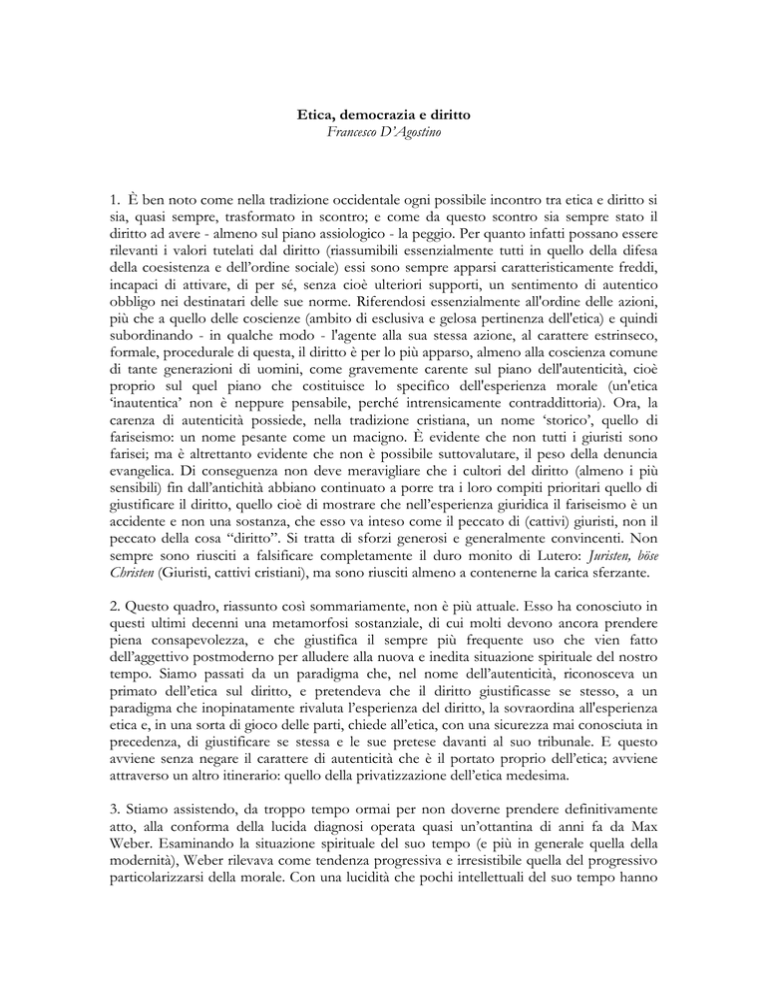
Etica, democrazia e diritto
Francesco D’Agostino
1. È ben noto come nella tradizione occidentale ogni possibile incontro tra etica e diritto si
sia, quasi sempre, trasformato in scontro; e come da questo scontro sia sempre stato il
diritto ad avere - almeno sul piano assiologico - la peggio. Per quanto infatti possano essere
rilevanti i valori tutelati dal diritto (riassumibili essenzialmente tutti in quello della difesa
della coesistenza e dell’ordine sociale) essi sono sempre apparsi caratteristicamente freddi,
incapaci di attivare, di per sé, senza cioè ulteriori supporti, un sentimento di autentico
obbligo nei destinatari delle sue norme. Riferendosi essenzialmente all'ordine delle azioni,
più che a quello delle coscienze (ambito di esclusiva e gelosa pertinenza dell'etica) e quindi
subordinando - in qualche modo - l'agente alla sua stessa azione, al carattere estrinseco,
formale, procedurale di questa, il diritto è per lo più apparso, almeno alla coscienza comune
di tante generazioni di uomini, come gravemente carente sul piano dell'autenticità, cioè
proprio sul quel piano che costituisce lo specifico dell'esperienza morale (un'etica
‘inautentica’ non è neppure pensabile, perché intrensicamente contraddittoria). Ora, la
carenza di autenticità possiede, nella tradizione cristiana, un nome ‘storico’, quello di
fariseismo: un nome pesante come un macigno. È evidente che non tutti i giuristi sono
farisei; ma è altrettanto evidente che non è possibile suttovalutare, il peso della denuncia
evangelica. Di conseguenza non deve meravigliare che i cultori del diritto (almeno i più
sensibili) fin dall’antichità abbiano continuato a porre tra i loro compiti prioritari quello di
giustificare il diritto, quello cioè di mostrare che nell’esperienza giuridica il fariseismo è un
accidente e non una sostanza, che esso va inteso come il peccato di (cattivi) giuristi, non il
peccato della cosa “diritto”. Si tratta di sforzi generosi e generalmente convincenti. Non
sempre sono riusciti a falsificare completamente il duro monito di Lutero: Juristen, böse
Christen (Giuristi, cattivi cristiani), ma sono riusciti almeno a contenerne la carica sferzante.
2. Questo quadro, riassunto così sommariamente, non è più attuale. Esso ha conosciuto in
questi ultimi decenni una metamorfosi sostanziale, di cui molti devono ancora prendere
piena consapevolezza, e che giustifica il sempre più frequente uso che vien fatto
dell’aggettivo postmoderno per alludere alla nuova e inedita situazione spirituale del nostro
tempo. Siamo passati da un paradigma che, nel nome dell’autenticità, riconosceva un
primato dell’etica sul diritto, e pretendeva che il diritto giustificasse se stesso, a un
paradigma che inopinatamente rivaluta l’esperienza del diritto, la sovraordina all'esperienza
etica e, in una sorta di gioco delle parti, chiede all’etica, con una sicurezza mai conosciuta in
precedenza, di giustificare se stessa e le sue pretese davanti al suo tribunale. E questo
avviene senza negare il carattere di autenticità che è il portato proprio dell’etica; avviene
attraverso un altro itinerario: quello della privatizzazione dell’etica medesima.
3. Stiamo assistendo, da troppo tempo ormai per non doverne prendere definitivamente
atto, alla conforma della lucida diagnosi operata quasi un’ottantina di anni fa da Max
Weber. Esaminando la situazione spirituale del suo tempo (e più in generale quella della
modernità), Weber rilevava come tendenza progressiva e irresistibile quella del progressivo
particolarizzarsi della morale. Con una lucidità che pochi intellettuali del suo tempo hanno
posseduto, Weber ha percepito la crisi della concezione tradizionale dell’etica come sistema
di valori assoluti e condivisi, un sistema strutturato rigidamente in una molteplicità di
singoli e specifici precetti (precetti che potevano anche venir continuamente violati sul
piano della prassi, ma senza che ciò venisse percepito come contraddittorio col fatto che
fossero tranquillamente riconosciuti come intrinsecamente validi, in quanto principi
generali di condotta, da parte di tutti). Costretta a rinunciare a una visione univoca della
realtà e alla pretesa di poterla descrivere compiutamente in termini di verità (costretta cioè a
rinunciare al pensiero metafisico), l’epoca moderna - questa è l’analisi weberiana - fallisce
altresì nel tentativo di continuare a difendere l’etica tradizionale e la sua gerarchia obiettiva
di valori e di norme. Il compiersi di questa dinamica conclude dando luogo a un paradigma
culturale assolutamente inedito, quello del politeismo etico (secondo l’icastica espressione
di Weber). La prospettiva postmoderna acquisisce (lentamente, ma ineluttabilmente) la
convinzione che è sforzo vano tentare di riportare ad unità, con la pazienza
dell’argomentazione razionale, le singole opzioni morali, perché tra i diversi valori che
presiedono all’ordinamento del mondo il contrasto è inconciliabile e le opzioni sono tanto
più autentiche quanto più si vivono e quanto meno si dialettizzano l’una con l’altra. E
soprattutto si convince che questo sforzo per l’unità, oltre ad essere improponibile sul
piano sia teorico che effettuale, non è nemmeno auspicabile sul piano assiologico, perché
implica un’opzione a favore di una uniformità etica, che non viene più vista come degna di
apprezzamento, ma come impersonale e quindi repressiva.
4. In questo orizzonte, per citare Hugo Tristram Engelhardt jr., gli uomini devono abituarsi
a considerarsi reciprocamente stranieri morali, cioè abitanti di un mondo che li costringe
sempre di più a vivere gli uni a fianco degli altri e ad interagire reciprocamente, ma che più
non pretende che essi parlino il medesimo linguaggio etico né che comunichino su di un
comune piano di valori. Pure, l’interazione tra le persone, anche se minima, richiede un
linguaggio. Ma non può trattarsi di un linguaggio etico, bensì di un linguaggio giuridico.
Esaminiamo più da vicino il pensiero di Engelhardt, che suscita interesse non per una sua
particolare originalità, ma perché si pone come estremamente rappresentativo di un
paradigma diffuso. A suo avviso, nessuna concezione materiale del bene può rendere
possibile il dialogo interpersonale nell’epoca postmoderna, cioè tra coloro che si
riconoscono reciprocamente come “stranieri morali”. Nel contesto etico rarefatto nel quale
viviamo, l’unica via che resta a nostra disposizione è quella dell’accordo, un accordo,
ovviamente, da basare non su buone ragioni - perché, come si è detto, la ragione
postmoderna si è dimostrata incapace di individuare un contenuto obiettivo, e quindi
buono, alla ragione -, ma al più sulla mera buona volontà di accordarci. Ciò che resta, a noi
uomini postmoderni, ci dice Engelhardt, è al più una sorta di diritto naturale minimo,
quello che fa riferimento alla possibilità che, con grande pazienza, le persone si mettano a
discutere tra loro per trovare, convenzionalisticamente, soluzione ai loro conflitti e in
generale alle modalità della loro coesistenza. È solo “l’autorità di un accordo comune che
può fornire un qualche sostegno generale ad una struttura morale che vincoli gli stranieri
morali”. La rivincita del diritto sulla morale sembra così giunta al suo pieno compimento. Il
diritto viene ad acquistare un primato sulla morale (anzi sulle morali) per gli stessi identici
motivi per i quali tradizionalmente esso appariva dotato, agli occhi dei moralisti di un
tempo, di un’eticità mediocre: per la sua intrinseca e irrimediabile carenza di autenticità.
L’autenticità, infatti, non è un carattere che cessi di caratterizzare l’etica; ma, in un sistema
politeistico, ne diviene il tallone di Achille. Infatti, proprio in quanto portatrici di una loro
specifica carica di autenticità, le molteplici etiche dell’epoca postmoderna si rivelano
insindacabili, incomunicabili e quindi non solo potenzialmente, ma effettualmente
conflittuali. In quanto autentiche, le etiche vanno rispettate; ma in quanto conflittuali vanno
ricondotte all’interno di un sistema di universale compatibilità. Questo sistema non può
avere carattere etico; solo il diritto, con la sua fredda esteriorità formale, è oggi in grado di
garantire il politeismo etico (così come nell'antichità ha garantito, fino a quando se ne è
data la necessità, il politeismo religioso).
5. L'epoca postmoderna ci rende quindi spettatori di un imprevedibile rovesciamento delle
parti. I giuristi non devono più giustificare se stessi e la loro vocazione. È l’etica piuttosto,
o meglio sono le etiche, quelle che devono presentarsi davanti al tribunale del diritto, per
venire in qualche modo da esso sanzionate, per essere riconosciute come lecite e
compatibili. Per quanto caro possa essere il prezzo per ottenere questo riconoscimento,
esso non sembra esorbitante agli occhi di chi, rassegnato al politeismo etico, sa valutare la
situazione che ne risulta: la vita etica, sia pur drasticamente privatizzata, viene in tal modo
riconosciuta dal diritto come insindacabile a livello pubblico. I conflitti etici scompaiono,
perché devono scomparire, perché il diritto, fedele alla sua promessa di garantire la pluralità
delle morali, si impegna a proibirli espressamente. Il mondo, attraverso l’ordine pubblico
garantito dal diritto, diviene e sempre più diverrà simile al bazar di cui parlano Clifford
Geertz e Richard Rorty: un luogo di incontro comune, circondato da innumerevoli club
privati esclusivi, una piazza nella quale si possono incontrare individui ai quali non
faremmo mai varcare la soglia di casa nostra, ma con i quali - fuori casa - possiamo anche
scambiare qualche parola o praticare una qualche forma di commercio; un mondo,
insomma, fondato su un difficile (ma non per questo impossibile) equilibrio di eticità
privata e pragmatismo pubblico. Il fatto poi che questa eticità privata meriti di essere
chiamata, come fa Rorty, narcisismo, è probabilmente indiscutibile, ma non per questo
falsifica il modello proposto.
6. Quale credito è possibile dare a un quadro come quello appena descritto? È la mera
descrizione di una realtà ineludibile? O si tratta piuttosto di una proposta (forse addirittura
generosa) volta, attraverso questo diritto naturale minimo, a costruire l’unica possibilità per
mantenere comunque all’etica uno spazio in un mondo dominato dalla tecnica e dal suo
freddo disinteresse assiologico? È vera probabilmente l’una e l’altra ipotesi. E ancor più
vero è che, nella croce del presente, altre ipotesi risolutive ai dilemmi della modernità non
sembrano presenti all’orizzonte. Le filosofie, è questo il senso di una profonda
osservazione di Hegel, non muoiono quando vengono confutate, muoiono quando si
percepisce quanto poco con esse “si possa andare avanti”. Le considerazioni che stiamo per
fare non possono quindi avere altra valenza che quella di un’indicazione, non di
un’affermazione.
6.1 Cominciamo con l’osservare che nel momento in cui si insiste con tanta forza sul tema
del primato procedurale del diritto sull’etica, in quanto il diritto è fondato su di un accordo,
si elabora, in buona sostanza, anche se rivedendola e correggendola, una versione moderna
di una tesi antica e venerabile, quella che pone il dialogo a fondamento del vivere sociale (e
più in generale della stessa filosofia). Infatti, l’accordo non può evidentemente che essere il
frutto di un dialogo: per giungere ad un accordo, quale che esso sia, è necessario
confrontare preventivamente le proprie posizioni, cioè incontrarsi dialogicamente. Ma il
dialogo - e questo è il punto fondamentale su cui bisogna richiamare l’attenzione - è
un’esperienza unicamente e profondamente umana: è possibile, cioè, solo tra persone, che
si riconoscano vicendevolmente come persone. Il riconoscimento, che del dialogo è il
presupposto, è, si badi, non solo empirico (riconosco che l’altro, quel singolo individuo che
mi si contrappone come altro, è come me), ma più propriamente ontologico (riconosco che
l’altro - come altro e non solo come mero individuo empirico - è come me) e nello stesso
tempo assiologico (riconosco che 1’altro - come altro e non solo come mero individuo
empirico - vale quanto valgo io). È solo a queste condizioni che può instaurarsi quel
dialogo che è condizione - per riprendere parole di Engelhardt - per realizzare
quell’“accordo comune che può fornire un qualche sostegno generale ad una struttura
morale che vincoli gli stranieri morali”. Nell’assenza di queste condizioni non possono
nascere né dialogo né accordo; o nascono, se nascono, dialoghi e accordi obliqui,
strumentali, ingannatori, forme pseudorelazionali, che la parte che nega il riconoscimento
(anche se a parole lo afferma) è pronta a rinnegare appena percepisca che le convenga farlo.
E non credo che sia a questo atteggiamento, cioè ad un accordo ipocrita, che i teorici del
primato del diritto procedurale possano riferirsi.
6.2. L’insistenza sul tema del dialogo può consentirci un’ulteriore ed essenziale
considerazione. Esistono, come ben sappiamo, diverse forme empiriche di dialogo; accanto
al dialogo con un interlocutore presente e loquente, possiamo pur porre il dialogo muto,
condotto attraverso gli sguardi, e al limite lo stesso dialogo con chi è lontano o con chi non
c’è più: un dialogo non meno autentico dei precedenti, se colui che lo instaura è disposto a
dialogare veramente, a lasciarsi cioè trasformare da questo incontro con un logos che è
altro-da-sé, che può non essere fisicamente presente attraverso la persona di un altro, ma
che può avere una presenza comunque estremamente forte, attraverso le diverse ‘potenze
dell’anima’: dal ricordo al desiderio, dal rimorso all’amore. L'altro mi provoca, se vogliamo
usare un lessico caro a Lévinas, fino al punto da prendermi come ostaggio; si impone cioè a
me e per me come termine ineliminabile di riferimento, non solo nella sua fisicità
immediata, cioè perché sia in grado di fronteggiarmi e di parlare effettualmente con me, ma
perché - come si è detto - in quanto è come me, è costitutivo di quell’io che io sono. L’altro
non è un intelletto col quale io dialettizzo le mie capacità intellettuali; l’altro è colui nel
quale io ritrovo me stesso e che per ciò solo può esigere (esplicitamente o implicitamente,
non importa), qualcosa da me: quel minimo almeno che è un trattamento secondo giustizia.
Da quanto abbiamo detto segue che, anche per chi creda a quella sorta di diritto naturale
minimo che dovrebbe condurre all’accordo, oltre che ovviamente per chi creda invece a un
diritto naturale massimo, non esistono, né possono esistere, stranieri morali. Si badi che
quello che qui viene in discussione non è la legittimità dell’esistenza di altre visioni del
mondo, né quella della molteplicità fattuale di professioni di fede (filosofica o teologica) in
altre assiologie: ma solo il fatto che questa molteplicità equivalga davvero ad un politeismo
etico e possa indurci a parlare di stranieri morali. L’essere straniero è categoria empirica,
rilevante sul piano della politica e forse su quello del diritto (ma solo sul piano del diritto
positivo, non su quello del diritto in sé); certamente non è categoria antropologica,
filosofica o teologica: lo dimostra appunto il fatto che con qualsiasi uomo, anche con uno
“straniero”, è possibile - di principio - aprire un dialogo e giungere ad un accordo, sul
presupposto di un comune riconoscimento. Nessuno è talmente straniero agli occhi di un
altro da rendere di principio impensabile la possibilità di parlare con lui. Nessun linguaggio
è di principio assolutamente intraducibile. Nessun valore etico - anche quello che ci appare
meno condivisibile - è totalmente incomprensibile, cioè incomunicabile.
7. È proprio da questo discorso che deve cercare di ripartire l’etica, se vuole sottrarsi al
disagio che vistosamente la caratterizza e che possiamo ormai ricondurre alla tentazione di
far assurgere la rilevazione fattuale della molteplicità sociologica delle morali al rango di un
valore (il politeismo etico, per l’appunto), che sotto l’apparenza di brillante descrizione della
pluralità delle visioni etiche del mondo, toglie loro ogni dignità, perché le rende tutte in
definitiva irrilevanti. Non esistono “stranieri morali”: questo principio deve essere assunto
come il postulato fondamentale di un’etica che sappia andare al di là della crisi
postmoderna. Ed è un postulato allo stesso tempo teoretico, etico e giuridico: è teoretico,
perché implica l'affermazione ontologica dell'eguaglianza tra tutti gli uomini, è etico, perché
implica l’affermazione assiologica della fraternità universale tra gli uomini, è giuridico,
perché fa oggetto di un pubblico confronto quel dibattito che l'etica tenderebbe a confinare
nello spazio esclusivo della coscienza interiore. È un postulato che impone a tutti di
continuare con tutti, nel rispetto delle posizioni di tutti, e senza mai stancarsi, l'indagine su
ciò che ci accomuna, come uomini, rispetto a ciò che ci divide. Nell'attesa che altri tempi
vengano a maturazione e che la perduta universalità dell'etica sappia riacquistare un suo
spazio, secondo modi che molti continuano ad auspicare, ma che pochi sono in grado di
progettare.
8. Vorrei avviarmi alla conclusione con alcune riflessioni sullo specifico contributo che i
cristiani possono portare nel nostro tempo alla dialettica diritto/morale.
Con tutte le dovute eccezioni, ritengo di poter dire che i cristiani non hanno ancora preso
fino in fondo coscienza della gravità e dell'ampiezza della sfida che proviene loro dal
paradigma postmoderno. Essi (peraltro ragionevolmente) continuano a compiacersi del
fatto che le legislazioni occidentali sembrano tuttora fortemente intrise di valori cristiani e
rimarcano come fatti tutto sommato eccezionali i singoli punti in cui le divergenze tra
l'etica cristiana e le legislazioni positive appaiono assolutamente irriducibili (caso tipico
quello delle legislazioni abortiste). Non avvertono però - se non in casi particolari - che
nell’orizzonte del postmoderno e del suo pluralismo corrosivo la comunità cristiana è
chiamata a operare una scelta estremamente difficile, che coinvolge la sua stessa identità: la
scelta di come inserirsi nel grande dibattito del politeismo etico, di come fronteggiare, cioè,
le sue pretese di neutralizzazione assiologica. Le possibilità che si danno sono,
naturalmente, articolate e diverse. Alcune sono chiaramente impraticabili. È ben difficile, ad
es., che i cristiani, di fronte alle provocazioni del politeismo etico (si pensi ad es. alla pretesa
di riconoscimento giuridico del matrimonio tra omosessuali) assumano uno spirito di
crociata, che apparirebbe marcato da una tra le poche e irredimibili colpe che il nostro
tempo stigmatizzi senza attenuanti, quella dell'intolleranza e della mancanza di rispetto per
l'alterità. I cristiani possono entrare nel dibattito etico postmoderno con spirito di
negoziazione: ma devono allora avere la consapevolezza che ciò implica un alto prezzo da
pagare, quel prezzo che Peter Berger ha chiamato un patteggiamento cognitivo (la rinuncia
cioè almeno ad alcuni elementi specifici della propria tradizione morale): e su quali siano i
giusti limiti di un patteggiamento cognitivo la riflessione è appena agli inizi. Possono
assumere un atteggiamento di protesta profetica: ciò comporta però per il cristianesimo -
bisogna esserne ben consapevoli - una sorta di autoghettizzazione culturale, cioè la
consapevole accettazione di una vera e propria riduzione del cristianesimo allo status di
sottocultura etica (senza per questo entrare in merito alla spinosa questione se esista
davvero uno spazio per il profetismo post Christum natum. È possibile anche - ma qui ci
troviamo di fronte a un atteggiamento a mio avviso suicida, anche se a volte lo troviamo
molto ben argomentato - cedere al fascino del relativismo e ritenere, con una buona dose di
ottimismo, che dall'esperienza della dispersione morale possa generarsi spontaneamente
una nuova (anche se oggi difficilmente immaginabile) tensione verso l'unità etica
dell’umanità.
9. Questo è il quadro: come si vede, articolato e composito. Quale delle ipotesi che
abbiamo elencato sia oggi materialmente prevalente, è questione empirica, che possiamo
anche accantonare. Quale tra queste ipotesi sia più coerente con l'identità cristiana è invece
questione filosofico-teologica e del massimo rilievo: e su di essa cercheremo di riflettere. Il
dato empirico, infatti, è in se stesso irrinunciabile e la sua acquisizione è doverosa e
preziosa; esso però è anche costitutivamente cieco. È necessario un intervento
ermeneutico, perché da esso e in esso si possa scorgere un orientamento. Dobbiamo saper
interpretare il nostro tempo, per trarre da esso gli insegnamenti di cui abbiamo bisogno. Il
problema però non è cosi semplice, dato che anche la scelta del criterio che dia sostanza
all'intervento ermeneutico possiede a sua volta una valenza ermeneutica. Siamo certamente
alla presenza di circolo, che peraltro per i teorici dell'ermeneutica non è vizioso, ma
virtuoso, qualora si riesca a non farsi travolgere dalla tentazione di cedere alla cattiva
infinità di questo processo. Peraltro, il cristiano possiede, nel riferimento teologico, un
ancoraggio che può metterlo al sicuro da questa tentazione. Il criterio che egli tenderà ad
assumere non avrà alcun carattere di neutralità (sarà quindi autenticamente ermeneutico),
ma non avrà nemmeno carattere soggettivistico, perché non rispecchierà la soggettività di
chi riceve il messaggio, ma l'oggettività di chi ne è la fonte. Il cristiano, in altre parole, è
portatore di un messaggio, che lo legittima, anzi gli impone di parlare nella comunità degli
uomini in cui vive, ma non in nome proprio, bensì nel nome di quella verità di cui egli deve
farsi apostolo. È questo il senso profondo del motto carissimo a San Giovanni Damasceno:
erò dè emòn men oudén, «non dirò nulla che provenga da me stesso» (evidente riformulazione
del logion di Gv VII,16).
Entriamo qui a contatto con una delle tante dimensioni paradossali che caratterizzano il
cristianesimo (e la sua etica), come religione che si fonda sulla pretesa dell'incarnazione
storica dell'assoluto. Il Dio, che si fa uomo, non ha potuto che farsi uomo nel tempo e
nello spazio; non ha potuto non assumere un’identità personale particolare, all’interno di
una comunità, di una cultura, di una tradizione di carattere locale. Ma il messaggio che
questo Dio incarnato ha lasciato alla sua Chiesa è di carattere universale. Da ciò consegue
che è un messaggio rivolto a tutti gli uomini.
Il cristiano, pertanto, vive la situazione di chi sperimenta costitutivamente, nella
quotidianità della sua esperienza, il paradosso dell'incontro dell'eterno col tempo. È un
incontro che non conosce limiti di esperibilità: anche se il suo luogo più proprio è
probabilmente quello della mistica e della spiritualità, o più in generale della preghiera, esso
si impone comunque come ineludibile sul piano dell'esperienza storica e politica,
nell'orizzonte della conoscenza scientifica e della creazione artistica, e - per quello che a noi
qui maggiormente interessa - dell'esperienza morale e dell'esperienza giuridica.
Comunicando il messaggio che ha ricevuto, e dando ad esso forma etica, il cristiano
comunica parole pronunciate e confinate nel tempo e nello spazio (e a sua volta le ripete
all'interno dei confini angusti del tempo e dello spazio); contestualmente, però, comunica
un messaggio che va oltre il tempo e lo spazio, che possiede i caratteri di quell'assoluto
dalla cui fonte esso proviene. Questa dialettica tra contingente ed eterno, poco avvertita in
epoche di compatta omogeneità morale, nelle quali i valori etici appaiono a tal punto
autoevidenti da non venire spesso nemmeno problematizzati, appare oggi invece in tutta la
sua evidenza paradossale.
Di questa paradossalità il cristiano non può evidentemente liberarsi, né sarebbe auspicabile
che se ne liberasse, perché ciò comporterebbe lo smarrimento della propria specificità. Ma,
naturalmente, il mero richiamo al paradosso non può essere fondamento adeguato per
l'iniziativa morale o per la prassi giuridica (o nemmeno - contro quello che pensava
Kierkegaard - per la predicazione). Il paradosso, il kerygma, costituisce il fondamento
dell'identità cristiana ma non ne costituisce il criterio storico di azione, che va cercato
altrove.
Non spetta allo studioso di etica e diritto fornire indicazioni operative, che la comunità
cristiana deve saper elaborare al proprio intorno, con le proprie forze endogene. Quello che
è però possibile fare è ribadire lo specifico carattere teologico che dovrà qualificare tali
indicazioni. Se il messaggio di cui il cristiano è portatore è un messaggio universale (per
quanto veicolato attraverso una storia che è sempre particolare), l'etica per la quale il
cristiano dovrà operare non potrà che essere un'etica universale, rivolta a tutti gli uomini, e
che risponda alle esigenze di verità presenti in tutti gli uomini e in tutte le culture. Il
cristianesimo, in altre parole, nel nome dell'assoluto alla cui parola ha il dovere di essere
fedele, è chiamato a farsi testimone vivente della possibilità storica che gli uomini siano
accomunati da una prassi morale non escludente, dalla quale risalti come principio
antologico la verità della loro pari dignità di esseri umani.
Questa pari dignità può incarnarsi in usanze estremamente diversificate e riconoscersi
fondata in tradizione culturali molto lontane tra loro. Ma perché la stessa parola dignità
abbia un senso è necessario postulare il primato dell'universale sul particolare,
dell'eguaglianza sulla differenza, dell’assoluto sulla storia e - se si vuole ricorrere a
espressioni filosoficamente ancora più forti - del bene sul male. Ciò comporta che il
cristiano sarà tanto più fedele a se stesso e alla propria vocazione, quanto meno il suo
discorso avrà unicamente se stesso e la propria tradizione come referente. Per parlare di se
stesso, il cristiano dovrà parlare di tutti gli uomini e per tutti gli uomini. Questo implica che
la pretesa della comunità cristiana abbia un carattere pubblico non diverso nel suo principio
da quello che legittima il potere pubblico dello Stato.
Non esistono, naturalmente, procedure tecniche che individuino le modalità specifiche con
le quali la comunità cristiana può avanzare all'interno di una società civile secolarizzata le
proprie istanze. Ma l'insistenza sul carattere pubblico della pretesa cristiana ci fornisce
qualche indicazione, mette a nostra disposizione alcuni criteri. Vediamoli più da vicino.
10. Il primo concerne il primato del cognitivo sul normativo, o , se così si preferisce dire,
l’antecedenza del vero sul bene. Prima di parlare dei valori, i cristiani vogliono parlare della
verità stessa delle cose, alle quali i valori devono far riferimento. Si tratta di un tema
teologico classico, che non cessa di manifestare anche oggi la propria fecondità. Se il vero è
antecedente al bene, il bene sarà in grado di accomunare tutti gli uomini ed avrà un senso la
ricerca (per quanto faticosa) di una giusta legislazione: è questo l’antico tema del bene
comune, come unico possibile fondamento della coesistenza sociale. Se invece si ritiene che
il bene non abbia nel vero il proprio fondamento, non si potrà che concludere - con
Nietzsche - che se è bene non è comune e se è comune non è bene (Jenseits von Gut und Böse,
43); bisognerà allora coerentemente ritenere che non può darsi possibilità alcuna per gli
uomini di fondare una coesistenza pacifica e non violenta: in assenza di una qualsiasi
misura comune, non ci sarà ragione perché il “bene” (soggettivo e incomunicabile) del più
forte non debba imporsi, proprio grazie alla forza, sul “bene” (parimenti soggettivo e
parimenti incomunicabile) del più debole. La pretesa cristiana va in direzione esattamente
opposta; facendo appello alla verità, essa resta lontana da ogni tentazione di proselitismo e
rivolge a tutti gli uomini un invito a un confronto ontologico, prima ancora che assiologico.
Il secondo criterio è strettamente dipendente dal primo, di cui costituisce una coerente
applicazione. La pretesa etica del cristianesimo è innanzi tutto una pretesa di
comunicazione; poiché la verità, per il cristiano, è in linea di principio conoscile, beninteso
al nostro livello e secondo le nostro categorie ermeneutiche, che sono essenzialmente
interpersonali, ne segue che il dovere di diffonderla e comunicarla possiede non solo una
valenza cognitiva, ma anche e soprattutto sociale e relazionale. Come dice San Tommaso,
communicatio facit civitatem (In VII Politicorum, I,1,37). È difficile esagerare l'importanza di
questo punto, che non solo trova echi profondi in tanta parte della teoria etica degli ultimi
anni, avvezza a insistere sul carattere dialogico e comunicativo dell'esperienza morale, ma ci
aiuta soprattutto a mettere in evidenza come l'universalità dell'esperienza sociale nella quale
i cristiani si riconoscono e verso la quale tendono (un’universalità pentecostale, è stato
efficacemente detto) ha sempre il carattere oltre che di presupposto, anche e soprattutto di
obiettivo.
Si evitano in tal modo due effetti parimenti perversi. Si sottrae l’esperienza religiosa al
rischio di ridursi, come ha detto Luhmann, a mero “parassita di situazioni sociali
problematiche”: attraverso il riferimento alla verità, il discorso etico della comunità cristiana
viene sottratto a ogni tentazione intimistica e/o irrazionalistica. E ancora: radicando la
comunicazione nella verità, si pone in essere l’unico modo credibile per lottare contro
l’erosione di fiducia nell'etica, che è l'esito coerente del politeismo etico che caratterizza il
mondo attuale e che costituisce una delle più paradossali fonti di nuovi conflitti sociali. Si
ridona cioè alla comunicazione una dignità, che non le possono fornire né la negoziazione,
né la mera tolleranza, né il cieco proselitismo. Una dignità dal prezzo altissimo (è né più né
meno che quello del sic vos, non vobis, il prezzo che paga colui che di fronte alla palese
menzogna altrui continua ostinatamente a dire la verità); un prezzo che la comunità
cristiana deve essere disposta a pagare fino in fondo, esattamente come, fino in fondo, e
con tanta maggiore consapevolezza, ha saputo pagarlo il suo maestro e fondatore.