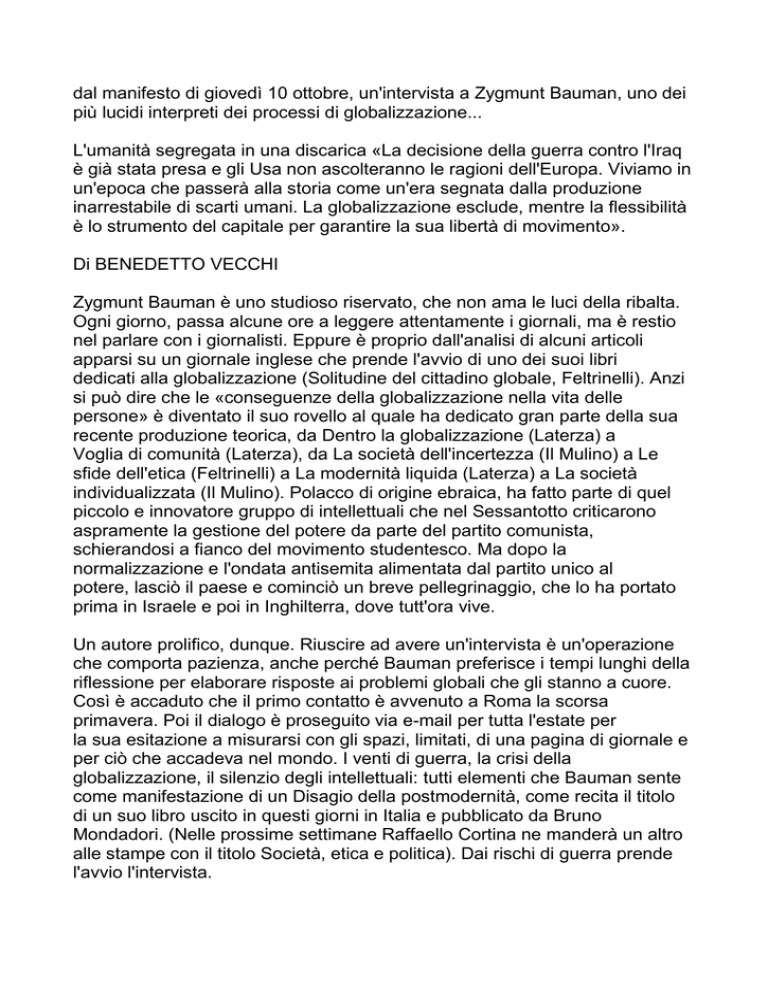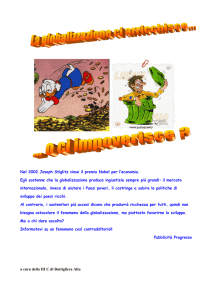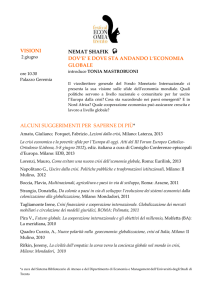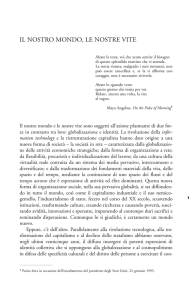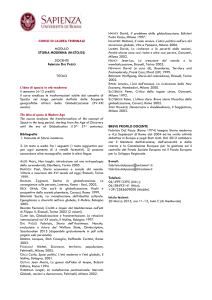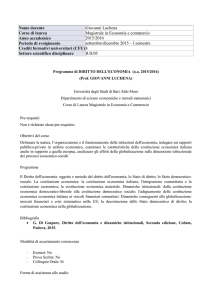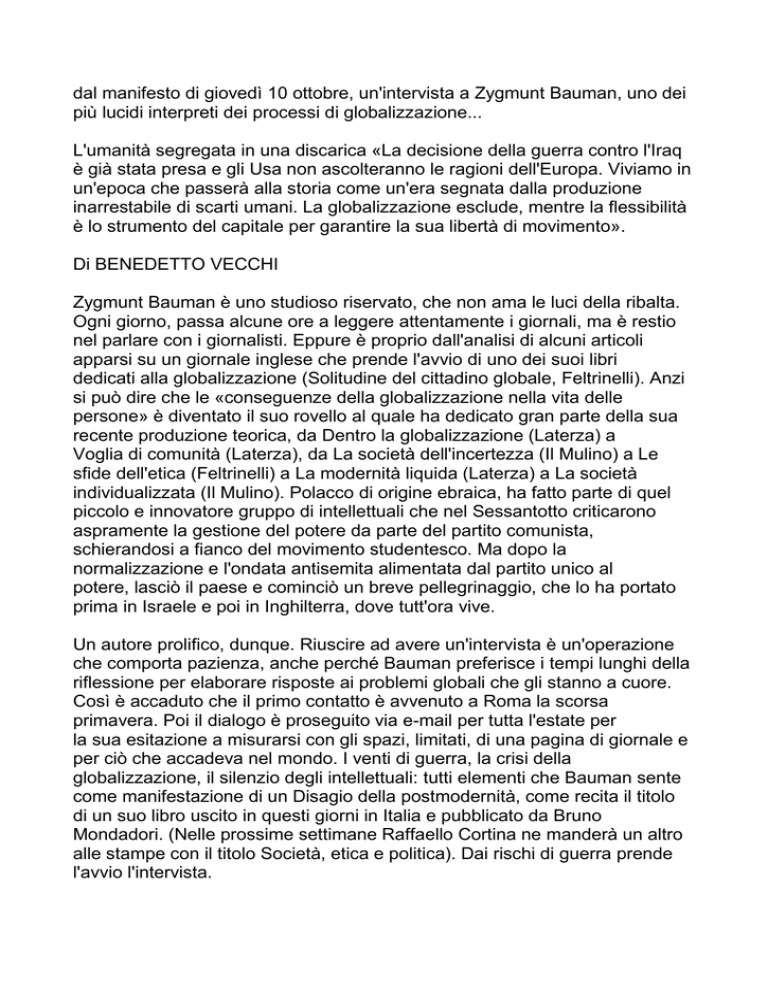
dal manifesto di giovedì 10 ottobre, un'intervista a Zygmunt Bauman, uno dei
più lucidi interpreti dei processi di globalizzazione...
L'umanità segregata in una discarica «La decisione della guerra contro l'Iraq
è già stata presa e gli Usa non ascolteranno le ragioni dell'Europa. Viviamo in
un'epoca che passerà alla storia come un'era segnata dalla produzione
inarrestabile di scarti umani. La globalizzazione esclude, mentre la flessibilità
è lo strumento del capitale per garantire la sua libertà di movimento».
Di BENEDETTO VECCHI
Zygmunt Bauman è uno studioso riservato, che non ama le luci della ribalta.
Ogni giorno, passa alcune ore a leggere attentamente i giornali, ma è restio
nel parlare con i giornalisti. Eppure è proprio dall'analisi di alcuni articoli
apparsi su un giornale inglese che prende l'avvio di uno dei suoi libri
dedicati alla globalizzazione (Solitudine del cittadino globale, Feltrinelli). Anzi
si può dire che le «conseguenze della globalizzazione nella vita delle
persone» è diventato il suo rovello al quale ha dedicato gran parte della sua
recente produzione teorica, da Dentro la globalizzazione (Laterza) a
Voglia di comunità (Laterza), da La società dell'incertezza (Il Mulino) a Le
sfide dell'etica (Feltrinelli) a La modernità liquida (Laterza) a La società
individualizzata (Il Mulino). Polacco di origine ebraica, ha fatto parte di quel
piccolo e innovatore gruppo di intellettuali che nel Sessantotto criticarono
aspramente la gestione del potere da parte del partito comunista,
schierandosi a fianco del movimento studentesco. Ma dopo la
normalizzazione e l'ondata antisemita alimentata dal partito unico al
potere, lasciò il paese e cominciò un breve pellegrinaggio, che lo ha portato
prima in Israele e poi in Inghilterra, dove tutt'ora vive.
Un autore prolifico, dunque. Riuscire ad avere un'intervista è un'operazione
che comporta pazienza, anche perché Bauman preferisce i tempi lunghi della
riflessione per elaborare risposte ai problemi globali che gli stanno a cuore.
Così è accaduto che il primo contatto è avvenuto a Roma la scorsa
primavera. Poi il dialogo è proseguito via e-mail per tutta l'estate per
la sua esitazione a misurarsi con gli spazi, limitati, di una pagina di giornale e
per ciò che accadeva nel mondo. I venti di guerra, la crisi della
globalizzazione, il silenzio degli intellettuali: tutti elementi che Bauman sente
come manifestazione di un Disagio della postmodernità, come recita il titolo
di un suo libro uscito in questi giorni in Italia e pubblicato da Bruno
Mondadori. (Nelle prossime settimane Raffaello Cortina ne manderà un altro
alle stampe con il titolo Società, etica e politica). Dai rischi di guerra prende
l'avvio l'intervista.
La guerra contro l'Iraq sembra inevitabile. L'Europa non riesce ad affermare
una posizione unitaria e autonoma dagli Stati uniti. Se sarà così, sarà
difficile parlare di Europa nel prossimo futuro, perché se sarà guerra
ridisegnerà il mondo dove gli Usa detteranno legge. Lei che ne pensa?
Come Martin Woollacott ha giustamente osservato su The Guardian «il
dibattito sull'Iraq è pleonastico – la decisone è stata presa», e «discutere se
la guerra sia giusta o sbagliata non influenzerà gli americani».
Possono ascoltare, se l'etichetta della diplomazia lo richiede, ma non
terreanno in gran conto qualunque cosa dirà l'Europa. Credo che la scelta
reale non sia quella, ampiamente urlata e strombazzata, tra l'unirsi
alla frenesia del «Dio benedica l'America» o assumere un atteggiamento antiamericano. Ritengo che il vero dilemma - un dilemma vitale - che tutti noi
abbiamo di fronte e dovremmo affrontare sia quello tra «Dio benedica
l'America» e «Dio benedica l'umanità».
Negli ultimi anni, i problemi posti dalla globalizzazione sono entrati
nell'agenda politica mondiale grazie alle mobilitazioni di un variegato
movimento sociale globale, il quale ha denunciato che esiste una
redistribuzione feroce delle ricchezze. In sintesi, nella società individualizzata
i rapporti di potere tra le classi, i gruppi sociali e tra il nord e il sud del mondo
sono basati sulle diseguaglianze. E' d'accordo?
Io stesso non saprei dirlo meglio. Il mondo però è diventato pieno, ma non è
uno. Il nuovo mescolarsi di culture e forme di vita è un'altra illusione, frutto
di generalizzazioni basate sull'esperienza della élite globale e forse anche
funzionale alla sua esigenza di autostima e di comfort spirituale. In realtà,
insieme al celebrato cosmopolitismo e all'ibridazione della élite affaristica e
del sapere, che è planetaria e sempre più extraterritoriale, anche il nuovo
pugnace tribalismo - che si traduce in un feroce territorialismo - è il prodotto
principale di una globalizzazione priva di vincoli politici.
Recentemente, lei ha affermato che viviamo in una «modernità liquida», dove
la «rivoluzione» di consuetudini, modi di essere è la regola dominante: un
mutamente incessante, senza soste che non consente di consolidare nuove
istituzioni. Tutto ciò provoca, sempre per usare un suo termine, un disagio
individuale e collettivo che agisce anch'esso come un caterpillar che tutto
distrugge. Siamo quindi in una situazione dove è impossibile un'analisi della
società?
Si, al giorno d'oggi il cambiamento è una condizione permanente del pianeta,
dei contesti locali, degli individui. I cambiamenti si susseguono e non
possono più tendere a «soluzioni finali» o essere organizzati in serie coerenti.
Inoltre, sono impossibili da prevedere, fortuiti. Così come è impossibile
prevedere le loro conseguenze, per non parlare della possibilità
di controllarle. Oggi questa è però una osservazione scontata. Ciò che non si
comprende a sufficienza è che ogni sviluppo «creativo» porta con sé
necessariamente una distruzione. Noi assomigliamo sempre di più agli
abitanti di Leonia, una delle Città invisibili di Italo Calvino, i quali se qualcuno
glielo chiedesse direbbero che la loro passione è «il godere delle cose
nuove e diverse». Per la verità, ogni mattina la popolazione «indossa
vestaglie nuove fiammanti, estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di
latta ancora intonsi, ascoltando le ultime filastrocche dall'ultimo modello
d'apparecchio». Ma ogni mattina «i resti della Leonia di ieri aspettano il carro
dello spazzatura» e qualcuno, guardando dall'esterno, si chiederebbe se la
vera passione dei suoi abitanti non sia piuttosto «l'espellere, l'allontanare da
sé, il mondarsi d'una ricorrente impurità».
Dato che gli abitanti di Leonia eccellono nella loro caccia alle novità, «una
fortezza di rimasugli indistruttibili che circonda Leonia, la sovrasta da
ogni lato come un acrocoro di montagne». Mi chiedo se la moderna
situazione non passerà alla storia, in primo luogo, come un gigantesco
aumento della produzione di rifiuti.
Parliamo infatti spesso di «spazzatura», degli scarti materiali che sporcano e
avvelenano il nostro «ambiente». Ma la più prolifica e dolorosa delle
innovazioni moderne sta emergendo dalla continua crescita di scarti umani.
La produzione di scarti umani è stata particolarmente copiosa in due settori
(ancora pienamente operativi e che lavorano a pieno regime) dell'industria
moderna.
Il primo settore riguarda la produzione e la riproduzione dell'ordine sociale.
Qualunque modello di ordine sociale è selettivo, e richiede che si tagli
via, si spunti, si segreghi, si separi o si asporti quelle parti della materia prima
umana che sono inadatte al nuovo ordine. Il secondo settore
dell'industria moderna noto per aver prodotto continuamente grandi scarti
umani è il progresso economico, che richiede a sua volta lo smantellamento
e l'annichilimento di un certo numero di modi e mezzi di integrare l'esistenza
umana che non soddisfano standard predefiniti di produttività e redditività.
Chi pratica forme di vita «svalutate» non può, di regola, essere inserito en
masse nei nuovi modelli di attività economica.
Questa produzione di «scarti» umani è stata comunque, per gran parte della
storia moderna, depotenziata, neutralizzata o almeno mitigata grazie a
un'altra moderna innovazione: l'industria dello smaltimento dei rifiuti. Questa
industria ha prosperato grazie alla trasformazione di ampie parti del globo in
immondezzai in cui confluiva tutto il «surplus» di umanità. La produzione di
rifiuti umani procede quindi senza sosta, fino ai picchi dei nostri giorni dovuti
ai processi della globalizzazione, ma è l'industria dello smaltimento dei rifiuti
che si è trovata in gravi difficoltà a causa dell'impraticabilità dei modi di
trattare gli scarti umani fin'ora inventati. A mio parere, dietro la confusione
attuale c'è la crisi dell'industria dello smaltimento degli scarti umani.
Lo rivela la disperata, sebbene largamente irrazionale e sbagliata, gestione
della crisi scatenata dallo spettacolo dell'11 settembre.
Lei è stato spesso accostato a Georg Simmel per la sua capacità di partire
dall'analisi del manifestarsi di alcune abitudini e mentalità per fornire una
lettura «generale» dei conflitti nella modernità. E' stato così per il fit-ness, è
stato così per il turismo di massa. Uno degli approdi del suo lavoro di
studioso è di cogliere la solitudine individuale in un mondo unificato, dove non
c'è riparo alcuno. Ma è pur sempre una solitudine che si manifesta in
aggressività verso l'«altro». Ricordo alcune sue pagine, molto belle, in
cui racconta di mobilitazioni contro presunti pedofili in una piccola città
inglese. Un'isteria che accompagna anche il razzismo strisciante che
vediamo manifestarsi in molti paesi europei?
Sono lusingato del suo paragone della mia opera a quella di Georg Simmel.
Io cerco solo, sebbene con risultati alterni, di collegare le ansie popolari
«localizzate» circa il «nemico alla porta» - che si tratti di un pedofilo, di un
malintenzionato, di un molestatore, di mendicanti, di «stranieri» (con il
terrorista come ultima aggiunta, particolarmente negli Usa) - alla marea
crescente dei sentimenti razzisti, o più correttamente xenofobi, in Europa. Per
parafrasare una nota frase, si può dire che uno spettro si aggira
sul pianeta: lo spettro della xenofobia. Astio e sospetti tribali vecchi e nuovi,
mai estinti o scongelati di fresco e riscaldati, si sono mescolati e
saldati alla paura, tutta nuova, per la sicurezza distillata da incertezze e
insicurezze vecchie e nuove dell'esistenza moderna.
Le persone spaventate a morte da una misteriosa, inesplicabile precarietà dei
loro destini e dalle nebbie globali che nascondono alla vista la loro
prospettiva, cercano disperatamente i colpevoli delle tribolazioni e delle prove
cui sono sottoposte. Le trovano, non sorprende, sotto il lampione più vicino,
nel solo punto obbligatoriamente illuminato dalle forze della legge e
dell'ordine: «sono i criminali a renderci insicuri, e sono gli estranei che
causano il crimine»; e così «è con le retate, il carcere e la deportazione degli
estranei che sarà ripristinata la sicurezza perduta o rubata».
Lei considera il welfare state come una delle migliori «trovate» del
capitalismo moderno. Sicurezza collettiva versus esplosione violenta della
società; garanzie sociali come unico rimedio agli effetti distruttivi della mano
invisibile del mercato. Ma anche questo sembra un retaggio del passato.
Ulrick Beck parla di società del rischio. Seguendo il suo percorso intellettuale,
si potrebbe parlare di una società del rischio altamente individualizzato. E'
d'accordo?
Lei ha di nuovo ragione. Penso che non ci sono, e non possono esserci,
soluzioni individuali a problemi prodotti socialmente, così come non ci sono e
non ci possono essere soluzioni locali a problemi creati globalmente.
Una piccola digressione. Il capitale nomadico in cerca di mercati redditizi e di
soste confortevoli, e le popolazioni sradicate, prive di territorio e vagabonde
in cerca di lavoro, pane, acqua da bere o pace, sono solo due dei «problemi
creati globalmente» che nessun potere locale ha le risorse per affrontare da
solo, sebbene tali poteri debbano misurarsi con le loro conseguenze. La
mobilità senza precedenti e virtualmente inarrestabile dei beni e delle finanze
mondiali li pongono oltre la portata di qualunque potere locale - non solo
municipale, ma anche nazionale. I poteri locali non possono fare molto per
arrestare la distruzione di mezzi di sostentamento e la dilagante
polarizzazione delle condizioni di vita, che mettono intere popolazioni in
movimento e aggiungono sempre più vigore alle pressioni dei
migranti; o per rallentare, per non dire interrompere, lo sfruttamento delle
risorse naturali, l'inquinamento dell'aria e delle riserve idriche, gli effetti
climatici legati ai gas dell'effetto serra o un consistente indebolimento dei
legami umani, la crescente fragilità dei mezzi di sussistenza e la
distruzione dei posti di lavoro. Quando gli amministratori di una città si
sforzano in tutti i modi di rendere potabile l'acqua del rubinetto,
vivibili le aree residenziali, di mettere scuole, ospedali e servizi sociali locali in
grado di accogliere e assimilare i nuovi arrivati nella città e
nel paese, di trovare lavoro ai disoccupati, placare l'irritazione crescente e
l'ansia dei residenti della città, essi cercano (invano) di trovare soluzioni
locali a problemi nati globalmente. Non potendo intervenire sull'incertezza in
modo sostanziale, essi cercano di indirizzare la paura e la rabbia
conseguenti verso oggetti che sono in grado di gestire, e che possono
mostrare di poter gestire: fastidi come le minacce alla sicurezza delle persone
e delle loro proprietà che vengono dai rapinatori, dai ladri di automobili, dai
mendicanti, da chi compie reati sessuali, da stranieri, da «stranieri tra noi».
Poco importa se queste minacce siano genuine o presunte, esse sono
sovraccariche emozionalmente: dalla loro soluzione ci si aspetta più di
quanto non siano in grado di dare. Allarmi antifurto, televisioni a circuito
chiuso, più poliziotti in servizio, pene più dure e politiche di immigrazione più
severe lasceranno le vere fonti di incertezza intatte, non dissiperanno le
paure e non vinceranno l'ansietà. E così, qualunque cosa si faccia, la
domanda di proteggere la sicurezza dei residenti urbani crescerà
senza sosta, e gli amministratori della città, impossibilitati a fare molto altro,
saranno disposti alla compiacenza...
Un'altra parola chiave dei suoi studi è: precarietà. Si è precari nel rapporto di
lavoro, nelle relazioni sentimentali, nelle forme di socialità. Prendiamo ad
esempio la precarietà nei rapporti di lavoro. Si è precari alla luce di una
richiesta sempre più pressante di mettere idee, inventiva, capacità
relazionale nella propria mansione. Siamo così condannati a vivere una
condizione paradossale: precari, ma creativi. E' questa la logica del
«capitalismo flessibile»?
La asimmetria di potere tra capitale e lavoro ha acquisito nella nostra epoca
una dimensione completamente nuova. Nell'epoca «solida moderna» i
boss delle imprese e i lavoratori potevano avere un controllo profondamente
diverso sulla propria capacità di azione effettiva, ma entrambi erano «legati al
terreno», erano cioè dipendenti dalla collaborazione con l'altra parte; nessuna
delle due parti poteva semplicemente fare le valige e andarsene. Entrambi gli
attori sapevano di essere destinati, in un modo o nell'altro, a restare in
compagnia gli uni degli altri, a incontrarsi ancora il giorno dopo, il giorno
dopo ancora, l'anno dopo. Quel «mutuo confinamento» generava ovviamente
conflitto, ma produceva anche uno sforzo a negoziare un modus vivendi
soddisfacente che rendeva la vita, magari una noiosa routine, ma
prevedibile, suscettibile di una programmazione a lungo termine. Questo
adesso è tutto finito. Inoltre, la asimmetria di potere tra capitale e lavoro non
si manifesta soltanto nella ricchezza di pochi e nella la povertà dei molti, ma
anche tra libertà di movimento e l'essere confinati in un posto.
Il capitale è libero di abbandonare una località non abbastanza obbediente e
servile, ma la grande maggioranza dei suoi dipendenti sono costretti a
restare dove sono, non essendo i benvenuti in nessun altro posto. Non la
meticolosa e odiosa supervisione e il controllo di ora in ora, ma la minaccia di
andare via senza preavviso al primo segno di disobbedienza è oggi il
fondamento della dominazione del capitale e il mezzo principale per ottenere
la disciplina. La sicurezza del capitale si basa semplicemente sulla
precarietà del lavoro.
In queste circostanze, la «sussidiarietà» è diventata, accanto alla
«flessibilità», l'espediente per fare del «buon management». I manager non
hanno bisogno, né hanno voglia, di gestire. Ora sta agli uomini e alle
donne che essi assumono dimostrare di meritare l'assunzione, farsi notare
dal capo, farsi avanti con idee che riempiano le tasche degli azionisti,
facciano vendere più prodotti, seducano un maggior numero di clienti e, allo
stesso tempo, dimostrare la propria superiorità rispetto ad altri candidati per
la stessa mansione. La «flessibilità» è un termine ingannevole:
significa inflessibilità del capitale a negoziare e a fare compromessi.
Di fronte a una descrizione senza appello della globalizzazione, lei sostiene
che comunque una via d'uscita c'è. In sintesi, lei ripropone una riedizione, per
quanto necessariamente aggiornata, del New Deal o del welfare state. Non le
sembra che sia troppo poco rispetto alla diagnosi che lei stesso fa
della «società individualizzata»?
Non ci sono soluzioni locali per problemi generati globalmente. Se lei mi
chiede come possiamo cambiare questo sviluppo, la mia risposta è: solo
affrontando di petto la sfida principale del nostro tempo - ossia, il bisogno
urgente di sottoporre gli attuali sfrenati, erratici, capricciosi processi di
globalizzazione al controllo politico e alla legge. L'unica soluzione
realistica, anche se lunga, consiste nello sviluppo di politiche planetarie e di
un potere planetario in grado di regolare le forze economiche e di affrontare
efficacemente i problemi planetari che tali forze, finché resteranno prive di
regolamentazione, creeranno tutti i giorni.
Gli stati-nazione erano le cornici istituzionali per la sicurezza collettiva contro
la sventura individuale. Ma i loro governi, spogliati di una gran
parte della loro passata sovranità, non riescono più a far quadrare i conti, né
possono dissociarsi dalla mischia globale in cui devono essere attori
obbedienti, col rischio altrimenti di «scoraggiare gli investitori» e di
fronteggiare una bancarotta. La polarizzazione dilagante della nostra epoca
ha le sue radici nel divorzio tra il potere e la politica; essa
può essere arrestata o almeno alleviata a condizione di un nuovo
matrimonio...