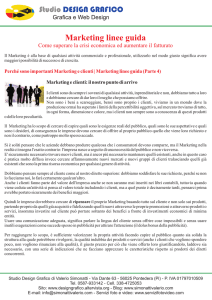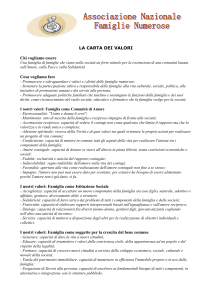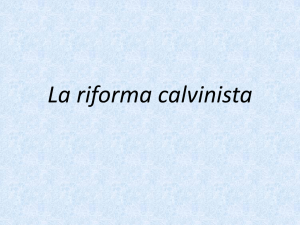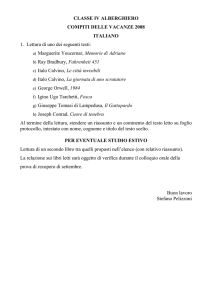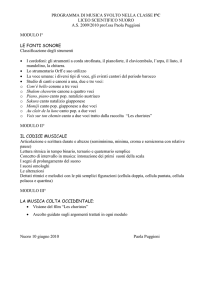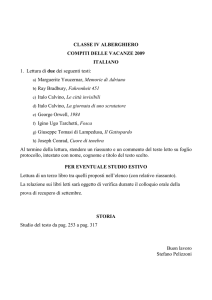Adriana Cavarero, A più voci
Introduzione
1. La voce secondo Calvino
Una voce significa questo: c’è una persona viva, gola, torace, sentimenti, che spinge nell’aria questa
voce diversa da tutte le altre voci.
ITALO CALVINO, Un re in ascolto
In una delle sue ultime, geniali, scritture, Italo Calvino ci regala la straordinaria figura di Un re in
ascolto. Inserito in una collezione dedicata ai cinque sensi, il re in questione rappresenta l’udito. Egli
siede immobile sul trono e tende l’orecchio per intercettare e decifrare i suoni che lo circondano.
Assediato dalla logica del suo stesso potere, la sola attività del monarca consiste in un controllo
acustico del regno. Nel palazzo che, come un grande orecchio, ha “padiglioni, trombe, timpani,
chiocciole, labirinti,”1 ogni suono è un indizio di fedeltà o congiura. Molte e incerte sono le spie da
interpretare: sussurri, rumori, vibrazioni, tonfi, laghi di silenzio. Ci sono naturalmente anche voci
umane nel palazzo. Ma “ogni voce che sa d’essere ascoltata dal re acquista uno smalto freddo, una
vitrea compiacenza”. Insomma, diventa una voce cortigiana, artefatta, falsa: non tanto per quello che
dice, ma proprio nella sua materialità sonora. Il re in ascolto lo sa, anzi, lo sente.
Come vuole la tradizione che risale al tiranno antico, il re di Calvino è prigioniero del suo stesso
sistema. La logica è quella ossessiva della violenza, della persecuzione e del sospetto: sempre
minacciato dal suo crollo imminente, il potere impone un’insonne vigilanza. La vigilanza è tuttavia, in
questo caso, di tipo esclusivamente uditivo. Come in un incubo sonoro, l’orecchio regale si amplifica in
una percezione tanto acuta e specializzata quanto impotente. Non può fare nulla il re: solo ascoltare,
intercettare suoni e interpretarne il senso. Ridotte alla loro materialità sonora – suoni fra suoni – le
parole non contano per la loro valenza semantica, ma soltanto per la loro sostanza fonica.
Disinteressandosi a quel che dicono, il re ne spia il timbro vocale, che è appunto artefatto, falso,
“freddo” e “vitreo” come la morte. Intonate allo strumento di morte che è tipico del potere, le gole della
corte, infatti, non sono più capaci di emettere la voce vera e inconfondibile della vita, ossia la voce che
“mette in gioco l’ugola, la saliva, l’infanzia, la patina della vita vissuta, le intenzioni della mente, il
piacere di dare una propria forma alle onde sonore”.
Un bel giorno, “quando nel buio una voce di donna s’abbandona a cantare, invisibile al davanzale di
una finestra spenta”, al re insonne capita tuttavia di udirla. Egli allora si riscuote, si ricorda finalmente
della vita e ritrova un oggetto per i suoi antichi desideri. La nuova emozione del re non dipende certo
dalla canzone sentita troppe volte, né dalla donna che non ha mai visto, precisa Calvino, bensì proprio
da questa “voce in quanto voce, come si offre nel canto”. Ciò che lo attira è “il piacere che questa voce
mette nell’esistere: nell’esistere come voce, ma questo piacere porta [il re] a immaginare il modo in cui
la persona potrebbe essere diversa da ogni altra quanto diversa è la voce”. Il re, insomma, scopre
l’unicità di ogni essere umano, così come essa viene manifestata dall’unicità della voce. Anzi, scopre
qualcosa di più: perché “la voce potrebbe essere l’equivalente di quanto la persona ha di più nascosto e
di più vero”, una sorta di nucleo invisibile ma immediatamente percepibile dell’unicità. Poiché questa
voce proviene dal mondo dei vivi che è fuori dalla logica mortifera del potere, per l’orecchio regale si
apre un orizzonte di percezione il cui statuto esistenziale è del tutto opposto a quello che gli rimandano
i giochi acustici del palazzo. Non si tratta più di captare suoni minacciosi e decifrarli, bensì di godere
l’ascolto della “vibrazione di una gola di carne”. Viva e corporea, unica e irripetibile, sovrastando con
la sua semplice verità sonora il frastuono inaffidabile del regno, una donna canta. E il re in ascolto si
distrae dalla sua ossessiva vigilanza.
Come al solito straordinario per invenzione, riflettendo sul tema della voce, il racconto di Calvino offre
una serie di spunti che fanno implicitamente tremare uno dei capisaldi della filosofia. Prima dell’entrata
in scena della donna che canta, si tratta di una voce che emerge da un sottofondo di segnali acustici nel
quale l’emissione vocale non ricopre un ruolo speciale rispetto agli altri suoni e rumori del palazzo.
L’identificazione del re con il senso dell’udito riduce infatti a puro suono anche le parole pronunciate
dagli esseri umani. Qui scatta appunto la fondamentale intuizione antifilosofica di Calvino:
incoraggiato dalla costitutiva falsità dei discorsi politici, il re-orecchio, al contrario di quanto fa da
secoli la filosofia, si concentra sul vocalico ignorando il semantico. Nell’ambito del regno, tuttavia, il
vocalico stesso, in quanto artefatto, è un segnale di incerta decifrazione al pari degli altri rumori del
palazzo. Non solo le parole dei cortigiani sono false, ma anche le loro voci. Esse si accordano ai
minacciosi rumori del sistema. Come per il suono di una porta che si chiude, in queste voci c’è un
suono freddo e artificiale. Non c’è vita. Il che significa che, percepita dall’orecchio che sta al centro del
potere, la voce umana diventa un segnale acustico fra gli altri, un rumore spersonalizzato da captare e
decodificare. La fonte umana di questa emissione sonora non rivela nulla di peculiarmente umano,
bensì si dissolve nel sistema generale dell’acustica politica come sistema di controllo del regno.
Infatti, nel racconto, la voce umana capace di rimanere tale senza confondersi con i rumori, e di rivelare
così ciò che è peculiarmente umano, viene da un luogo che è fuori dalla politica. Questa rivelazione non
ha affatto caratteri sorprendenti e, anzi, riguarda il più ovvio degli aspetti di quella che Hannah Arendt
chiama la condizione umana: l’unicità che fa di ognuno un essere diverso da tutti gli altri. “Quella voce
viene certamente da una persona, unica, irripetibile come ogni persona,” osserva infatti puntualmente
Calvino. Tale unicità sarebbe percepibile anche dallo sguardo ma, incentrando il racconto sul senso
dell’udito e ponendo la donna che canta nel buio di una finestra, lo scrittore procede nel suo
privilegiamento della sfera acustica attirando tutta la nostra attenzione sulla voce. Affinché l’orecchio
mostri il suo naturale talento a percepire l’unicità di una voce che, da sola, è in grado di attestare
l’unicità di ogni essere umano, chi la emette deve rimanere invisibile. La strategia di Calvino è precisa.
All’emissione fonica non corrisponde qui l’apparire di nessun volto. La vista non ha nemmeno il ruolo
di anticipare o confermare il concetto di unicità captato dall’orecchio.
L’orecchio del re, abituato all’effetto di spersonalizzazione del sistema acustico del regno, rimane
ovviamente sorpreso dal messaggio di questa voce. Come spesso accade all’orecchio della politica – e,
per ragioni affini, della filosofia – esso si esercita ben di rado a percepire la voce dell’esistente umano
in quanto unico. Sintomaticamente, gli sfugge proprio questa “vibrazione di una gola di carne” che
ripete parole con una voce irripetibile. Gli sfugge, insomma, la semplice verità dell’autorivelazione
vocalica dell’esistenza che può prescindere da ogni interferenza del semantico. La tipica libertà con cui
gli esseri umani combinano le parole, pur comprovandola, non è mai un indice sufficiente dell’unicità
di chi parla. La voce di chi parla è invece sempre diversa da tutte le altre voci, anche se le parole
pronunciate fossero sempre le stesse, come avviene appunto nel caso di una canzone.
Tale diversità, come sottolinea Calvino, ha a che fare con il corpo. “Una voce significa questo: c’è una
persona viva, gola, torace, sentimenti, che spinge nell’aria questa voce diversa da tutte le altre voci.”
“Una voce mette in gioco l’ugola, la saliva”: quando vibra la voce umana, c’è qualcuno in carne e ossa
che la emette. L’unicità non è una caratteristica dell’uomo in generale, bensì di ogni essere umano in
quanto vive e respira. Vale la pena, di nuovo, sottolineare che questa radice corporea dell’unicità è
anche percepibile dal senso della vista, ossia è un aspetto immediatamente visibile a chiunque guardi il
volto dell’altro. L’udito qui privilegiato da Calvino sposta tuttavia la percezione dell’unicità dalla
superficie corporea o, se si vuole, dal volto, al corpo interno, per di più guadagnando all’analisi il tema
assai prezioso della relazione. Caratterizzato da organi che, con cunicoli sensibilissimi, si internano
nella testa, il senso dell’udito ha il suo naturale referente in una voce che viene a sua volta da altri
cunicoli interni: la bocca, la gola, l’intrico del polmone. Il gioco fra emissione vocalica e percezione
acustica coinvolge necessariamente gli organi interni: implica il corrispondersi di cavità carnose che
alludono al corpo profondo, il più corporeo dei corpi. L’impalpabilità delle vibrazioni sonore, pur
incolori come l’aria, esce da una bocca umida e sgorga dal rosso della carne. Anche per questo, come
suggerisce Calvino, la voce è l’equivalente di ciò che la persona unica ha di più nascosto e più vero.
Non si tratta però di un tesoro inattingibile, di un’essenza ineffabile e, tanto meno, di una sorta di
nucleo segreto del sé, bensì di una vitalità profonda dell’esser unico che gode del suo rivelarsi
attraverso l’emissione della voce. Tale rivelazione procede appunto da dentro a fuori, spingendosi
nell’aria, con cerchi concentrici, verso l’orecchio altrui. Anche dal mero punto di vista fisiologico, essa
implica una relazione. Preso nella relazionalità dell’emissione vocalica che si diffonde all’esterno,
l’orecchio altrui è infatti in grado di percepire tutto “il piacere che questa voce mette nell’esistere:
nell’esistere come voce”. “Il piacere di dare una propria forma alle onde sonore” fa parte
dell’autorivelazione vocalica. L’emissione è godimento vitale, soffio acusticamente percepibile, dove il
proprio modella il suono rivelandosi come unico.
Crucialmente, nel racconto di Calvino, tale godimento viene dal canto di una donna. In un certo senso,
si tratta di un luogo comune, anzi, di uno stereotipo non privo di accenti misogini. Basti pensare alle
varie riletture che la tradizione ha fatto del canto femminile seduttivo, carnale e primitivo, che
risalirebbe alle Sirene omeriche o, piuttosto, alla lettura misogina che ne ha dato la tradizione.
L’inimitabile originalità con cui lo scrittore va notoriamente a rileggere l’immaginario tradizionale apre
tuttavia a orizzonti imprevisti il tema della donna che canta. Al contrario di quanto vuole la tradizione,
infatti, il canto femminile, non celebra qui la dissoluzione di chi lo ascolta nell’abbraccio primitivo di
un’armonia aorgica, bensì rivela all’ascoltatore l’unicità, vitale e irripetibile, di ogni essere umano.
D’altra parte, che la voce udita dal re sia la voce di un canto è ovvio. Non solo perché il canto esalta la
voce e la potenzia, ma soprattutto perché l’attenzione esclusiva del re verso il puro elemento vocalico, a
discapito di quello semantico, trova nel canto il suo ambito naturale di espressione. Come precisa il
racconto calviniano, l’orecchio regale ha infatti sentito anche troppe volte la canzone, né ci vengono
riferite le parole, che non hanno alcuna importanza, di questo canto. Ciò che attrae il re è appunto la
“voce in quanto voce, come si offre nel canto”. Tant’è vero che, conquistato dal piacere di dare una
propria forma alle onde sonore, “contagiato dal piacere di farsi udire” che questa voce manifesta, il re
tenta allora un duetto nel quale la voce femminile che lo chiama e la sua voce baritonale che la chiama
devono essere captate “insieme nella stessa intenzione d’ascolto”. Come c’era da aspettarsi, l’infelice
tuttavia non sa cantare. Se sapesse cantare – dice Calvino mediante la finzione di un discorso che il re
rivolge a se stesso – allora “quello che nessuno sa che tu sei, o che sei stato, o che potresti essere si
rivelerebbe in quella voce”. L’emissione fonica esaltata dal canto, la voce che spinge nell’aria e fa
vibrare l’ugola, ha appunto una funzione rivelatrice. Anzi, più che rivelare, essa comunica. Ciò che
comunica è precisamente l’unicità vera, vitale e percepibile di chi la emette. Non si tratta però di una
comunicazione chiusa nel circuito fra la propria voce e il proprio orecchio, bensì di un comunicarsi
dell’unicità che è, al tempo stesso, una relazione a un’altra unicità. Ci vuole almeno un duetto, un
chiamarsi e rispondersi: ossia una reciproca intenzione di ascolto, già attiva nell’emissione vocale, che
rivela e comunica ognuno all’altro.
In questo caso, l’altro è una donna. Ella è la fonte, l’inizio e il punto di contagio per il piacere e il
desiderio del canto scoperti dal re. Divertendosi a inscenare un duetto canoro di tipo operistico,
rigorosamente eterosessuale, Calvino si cimenta dunque con uno dei più celebri fra gli stereotipi della
cultura occidentale. Gli aspetti misogini sono ben noti. Secondo la tradizione, il canto si addice alla
donna ben più che all’uomo, soprattutto perché tocca a lei rappresentare la sfera del corpo in quanto
opposta a quella ben più importante dello spirito. Sintomaticamente, l’ordine simbolico patriarcale che
identifica il maschile con il razionale e il femminile con il corporeo, è lo stesso che privilegia il
semantico rispetto al vocalico. Detto altrimenti, anche la tradizione androcentrica sa che la voce viene
dalla “vibrazione di una gola di carne” e, proprio perché lo sa, la cataloga nella sfera corporea –
secondaria, caduca e inessenziale – riservata alle donne. Femminilizzati per principio, l’aspetto
vocalico della parola e, tanto più, il canto compaiono come elementi antagonisti di una sfera razionale
maschile che si incentra, invece, sull’elemento semantico. Per dirla con una formula: la donna canta,
l’uomo pensa.
Si capisce così ancor meglio perché, riconducendo la politica a un sistema acustico generale, Calvino
compia un gesto davvero rivoluzionario. Il re in ascolto si occupa infatti solo dell’ambito dei suoni e
trascura del tutto il semantico. Non c’è alcuna strategia razionale nel potere del re che ode il polifonico
“rombo di morte” emesso dal regno e trema a ogni rumore per la propria sorte. Pur assumendo
un’imprevista forma acustica, la politica non perde dunque le sue caratteristiche tradizionali: segnali di
morte, tranelli, minacce, falsità continuano a innervare la sua logica. Proprio questo retaggio della
tradizione consente tuttavia a Calvino di procedere nel suo gesto rivoluzionario e di portarlo a
conclusioni ancor più interessanti. Già inusitatamente privilegiata a discapito del semantico, la sfera
acustica, nel racconto, si sdoppia. Da una parte c’è il suono confuso, inaffidabile e mortifero del regno.
Dall’altra c’è il vocalico distinto, rivelatore e vitale che viene da altrove, da un luogo che sta appunto
fuori dalla sfera politica. Che questo luogo sia abitato da una donna risulta in tal modo un omaggio alla
tradizione e, tuttavia, un clamoroso riscatto. Ella infatti non rappresenta la consueta primitività della
sfera extra-politica, bensì la genuina verità di un vocalico che costringe la politica a misurarsi con
categorie impreviste.
L’osservatorio della tradizione androcentrica, che interpreta la differenza sessuale dal punto di vista del
semantico, viene così rimpiazzato da una prospettiva che la reinterpreta invece dal punto di vista del
vocalico. Mediante un doveroso omaggio alla tradizione che vuole la donna una creatura corporea,
canora e impolitica, il rivoluzionario privilegiamento del fonico consente a Calvino di significare
altrimenti proprio queste qualità stereotipiche del femminile. Ora, infatti, lei compare in scena proprio
per attestare la verità del vocalico: la quale, lungi dall’essere astratta come le verità poste dalla ragione,
proclama semplicemente che ogni essere umano è un essere unico ed è capace di manifestarlo con la
voce, chiamando e contagiando l’altro, e godendo, per di più, di tale reciproca manifestazione. In
sostanza, si tratta dunque di una verità – del resto, assai familiare all’esperienza quotidiana del vivere –
che afferma semplicemente l’unicità e la relazionalità degli esseri umani. Nella sapiente costruzione del
racconto di Calvino, essa può assumere un grande risalto perché emerge in netto contrasto con un
rumore del regno dove i suoni delle cose e le voci degli uomini hanno lo stesso statuto ontologico di
spie sonore, sostanzialmente ostili.
Minacciato da ogni suono, il re, infatti, è solo. La sua solitudine non ha però il timbro romantico di
un’esistenza estranea al sistema e ribelle alla sua logica, bensì sta al centro di esso come sua parte e
funzione. Diventa pertanto cruciale che la voce femminile del canto, nell’atto di rivelare l’unicità di chi
la emette, mostri al tempo stesso la valenza relazionale del vocalico. Destinata all’orecchio altrui, la
voce implica un ascolto, anzi, una reciprocità di godimento. Sfondando i confini del suo ruolo
esclusivamente acustico, il re è infatti spinto a divenire egli stesso una fonte sonora. Momentaneamente
sordo al frastuono del regno, egli scopre un mondo nuovo dove le voci umane comunicano innanzitutto,
a vicenda, la loro unicità. La scena si ribalta: non si tratta più di intercettare un suono per decodificarlo
e interpretarlo, bensì di rispondere a una voce unica che non segnala che se stessa. Non c’è nulla di
ulteriore dietro questa voce che ne sarebbe il veicolo sonoro, il segno udibile, il sintomo acustico. Essa
è paga di comunicarsi chiamando irresistibilmente in gioco la voce dell’altro.
Scoprendo di avere un corpo, una sola vita da vivere e di essere una persona unica al pari di ogni altra,
il re in ascolto canta. Ma allora, ovviamente, non è più re: bensì un essere umano radicato nella sua
condizione ontologica fondamentale. La semplice verità del vocalico fa cadere le corone senza che
nemmeno se ne senta il tonfo.
2. Cenni preliminari al tema della voce ovvero la filosofia chiude le orecchie
La phonè non dipende in maniera immediata dal senso, ma prepara al senso il luogo dove esso si dirà.
PAUL ZUMTHOR, La presenza della voce
Ogni voce “viene certamente da una persona, unica, irripetibile come ogni persona”, ci assicura
Calvino. Egli attira la nostra attenzione su quella che potremmo chiamare una fenomenologia vocalica
dell’unicità. Si tratta, al tempo stesso, di un’ontologia che riguarda la singolarità incarnata di ogni
esistenza in quanto essa si manifesta vocalmente. Ontologia e fenomenologia non sono del resto che
nomi – sin troppo tecnici, nonché indulgenti a un certo idioletto filosofico – per segnalare come, nel
registro della voce, riecheggi la condizione umana dell’unicità. La voce mostra inoltre che tale
condizione è essenzialmente relazionale. La semplice verità del vocalico, annunciata dalle voci senza
neanche la mediazione della parola, comunica i dati elementari dell’esistenza: l’unicità e la
relazionalità, ma anche la differenza sessuale e l’età, incluso il “cambio di voce” che, soprattutto nei
maschi, segnala la pubertà. Ci sarebbero dunque non pochi motivi per fare della voce il tema
privilegiato di una riflessione che riguardi il problema dell’ontologia. Ma appunto qui sta la sorpresa:
precedenti autorevoli, per questo genere di ricerca, straordinariamente mancano.
Nella produzione letteraria e filosofica occidentale, per quanto possa apparire strano, il racconto di
Calvino è infatti uno dei pochi testi che incoraggiano a indagare la voce in ciò che essa ha di più
proprio. La stranezza risulta, oggi, ancor più evidente non solo se si riflette sull’innegabilità di un
fenomeno che è alla portata di qualsiasi orecchio, ma soprattutto se si tiene conto della notevole fortuna
che il tema della voce riscuote nella riflessione contemporanea. Una ricerca sulla voce che voglia
accogliere i suggerimenti di Calvino trova nel pensiero della tarda modernità un orizzonte teorico
promettente e, allo stesso tempo, deludente. Da un lato, mai come nel Novecento e con una particolare
accelerazione negli ultimi decenni, la voce è diventata uno specifico oggetto di studio per varie correnti
di pensiero che l’hanno analizzata da diversi orizzonti interpretativi. D’altro lato, il semplice fatto
dell’unicità delle voci, nonché la relazionalità del vocalico, in questo ampio contesto di studi si sono
guadagnati ben poca attenzione. Sull’aspetto che è proprio della voce, oggi come in passato, la
tradizione è reticente.
Chiunque sia familiare allo statuto disciplinare della filosofia non può non nutrire motivati sospetti per
questa reticenza. Essa segnala un problema che ha a che fare con l’attitudine filosofica per
un’universalità astratta e senza corpo, dove regna il regime di una parola che non esce da nessuna gola
di carne. Calvino aiuta a focalizzare i termini elementari della questione. L’unicità della voce è un dato
incontrovertibile dell’esperienza, tecnologicamente provato dalle macchine digitali che ne tracciano lo
spettro, non un problema. Il problema nasce appunto dall’ostinazione con cui la filosofia non solo
trascura questo dato, ma primeggia fra le altre discipline nello sforzo di renderlo insignificante. La
storia di questa condanna all’insignificanza è ampia e complessa. Si tenterà, nelle pagine che seguono,
di ricostruirne in dettaglio i passaggi e di darne un’esposizione. In via preliminare, sarà tuttavia utile
fare qualche accenno al quadro generale.
Il primo posto se lo guadagna una semplice, quanto cruciale, constatazione. La tradizione filosofica non
si limita a ignorare l’unicità della voce, bensì ignora l’unicità in quanto tale, in qualunque modo essa si
manifesti. La singolarità irripetibile di ogni essere umano, l’unicità incarnata che distingue ciascuno da
ciascun altro è, per i gusti universalistici della filosofia, un dato superfluo, se non imbarazzante, nonché
epistemologicamente improprio. Per quanto sia scoraggiante, ciò non viene tuttavia a liquidare
l’importanza tematica della voce. La voce non può risultare un tema indifferente per un tipo di sapere
che si inaugura, in Grecia, come autochiarificazione del logos e, dopo vari ma coerenti sviluppi, durati
qualche millennio, approda nel Novecento alla tematizzazione ossessiva del linguaggio. Se nel logos_–
termine notoriamente multivoco che fra i suoi significati comprende anche quello di “linguaggio” – ne
va della parola, ne va infatti anche della voce. Per dirla con una formula, la parola rimanda ai parlanti e
i parlanti alla loro voce. Per quanto plausibile, non è però questa la via che imbocca la filosofia. Essa
intraprende invece un percorso che evita con precise strategie di imbattersi nella questione.
La strategia basilare, atto inaugurale della metafisica, consiste nel doppio gesto che separa la parola dai
parlanti e la fonda nel pensiero o, se si vuole, nel significato mentale, di cui la parola stessa, nella sua
materialità sonora, sarebbe espressione, significante acustico, segno udibile. La voce viene pertanto
tematizzata come voce in generale, emissione sonora che prescinde dall’unicità vocalica di chi la
emette, componente fonematica del linguaggio in quanto sistema della significazione. In questa forma
segnica e spersonalizzata, diventa l’oggetto specifico di una disciplina che, pur prendendo il nome
moderno di linguistica, risale per lo meno al Cratilo di Platone. Al di là della sua accelerazione
novecentesca e dei suoi complessi sviluppi, si può infatti rintracciare il percorso teorico che porta la
linguistica moderna a ereditare dallo statuto della metafisica una disattenzione programmatica per
l’unicità della voce. Il che, ovviamente, non intacca la legittimità degli studi linguistici né ne
diminuisce l’interesse, ma testimonia in modo esemplare di come i saperi rivolti al fenomeno della
parola possano occuparsi della voce senza preoccuparsi della singolarità di ogni voce. Detto altrimenti,
studiata dalla prospettiva del linguaggio e, tanto più, da una prospettiva che intende il linguaggio come
sistema, la voce diventa la sfera generale delle articolazioni sonore dove ciò che non suona è,
paradossalmente, l’unicità del suono. Il linguaggio in quanto codice, la sua anima semantica che aspira
all’universale, rende impercepibile, nella voce, il proprio della voce. L’unicità plurale delle voci non
sfonda il filtro metodologico dell’orecchio linguistico.
Del tutto differente, ma in grado di produrre risultati analoghi, è il filtro metodologico di un’altra
disciplina moderna di grande successo che rivolge esplicitamente i suoi interessi alla voce. Per quanto
tale disciplina si articoli in molteplici stili di approccio e mobiliti diversi orizzonti categoriali – come
del resto fa la linguistica – potremmo riassumerla sotto l’etichetta degli studi rivolti all’oralità. Questi
studi hanno innanzitutto il merito di evidenziare un tema importante: c’è un campo della parola dove la
sovranità del linguaggio si arrende a quella della voce. Si tratta, ovviamente, della poesia. I poeti
l’hanno sempre saputo – e, in un certo senso, nessuno l’ha mai saputo meglio di Platone –, ma la
teorizzazione del fenomeno, il suo divenire oggetto di una specifica prospettiva di ricerca, è appunto
recente. La sua data di nascita, nei primi decenni del Novecento, risale al dibattito sulla cosiddetta
questione omerica e, in particolare, sul ruolo dell’epica nelle culture orali che non conoscono la
scrittura o la utilizzano marginalmente. Proprio dalla riflessione sulla differenza fra oralità e scrittura –
categorie destinate a una fortuna dilagante nel corso del secolo – prende origine il vasto filone di ricerca
che recupera, per il tema della voce, un orizzonte specifico di trattazione. Data l’importanza di Omero
per la genesi di questa prospettiva teorica, l’accento cade soprattutto sulla centralità della sfera acustica
nella prestazione aedica. È la voce, con i suoi ritmi sonori, a organizzare le parole del canto epico. Il
semantico, non ancora asservito alle leggi congelanti della scrittura, si piega alla musicalità del
vocalico. Prediletto dall’epica, ma operante nella poesia in generale, l’ambito dei suoni viene così
crucialmente a rivelarsi come il lato musicale del linguaggio che sollecita l’area corporea del
godimento.
Proprio il rapporto fra godimento vocalico e poesia, focalizzato dagli studi sulle culture orali, assurge a
tema centrale di un altro tipo di approccio teorico, non meno importante e variegato, che sollecita la
riflessione contemporanea ad approfondire il tema della voce. Alla prospettiva che indaga l’oralità,
insistendo sulla sua contrapposizione alla scrittura, viene infatti ad affiancarsi una costellazione di
prospettive, per lo più influenzate dalla psicanalisi, che valorizzano ulteriormente la componente
pulsionale e presemantica della sfera acustica. Capace di organizzare non solo il canto, ma anche il
testo poetico, se non il testo in generale e dunque anche la scrittura, la voce viene in questo caso
soprattutto caricata di un ruolo eversivo rispetto ai codici disciplinanti del linguaggio. Essa compare
perciò, non tanto come medio della comunicazione e della trasmissione orali, quanto piuttosto come
registro di un’economia pulsionale, legata ai ritmi del corpo, che destabilizza il registro razionale su cui
si edifica il sistema della parola. Le due prospettive – del resto irriducibili a due precise scuole di
pensiero – non sono collegate e, per molti versi, risultano addirittura eterogenee. Tant’è vero che una
studia l’oralità in contrapposizione alla scrittura, mentre l’altra privilegia la testualità come ambito che
ha nella scrittura il suo principale paradigma. Le accomuna, tuttavia, una tendenza a “riscoprire”, in
senso positivo, quella potenza musicale e seduttiva della voce che la tradizione metafisica, a partire
dalla nota ostilità di Platone per Omero, si è costantemente preoccupata di neutralizzare.
Il lato più significativo della questione, ancora un volta, sta però nel fatto che non è solo questa
“riscoperta”, giocata in senso anti-platonico o, se si vuole, in senso anti-metafisico, ad accomunare le
due prospettive qui sommariamente indicate, bensì una sorprendente indifferenza per l’unicità della
voce. Anche nell’ambito delle teorie che vanno a sondare la corporeità della voce, i ritmi caldi della sua
emissione e il godimento dell’ugola e della saliva, la pluralità delle voci non assurge infatti a tema
degno di nota. Per quanto legata a pulsioni profonde e alla vitalità del respiro, per quanto caricata di
valenze eversive che destabilizzano i codici del linguaggio, la voce rimane una voce in generale. Sia per
gli studi sulle culture orali sia per quelli sulla vocalità del testo, non ci sono voci che, comunicandosi,
comunicano la loro unicità. C’è voce: una voce senz’altro radicata nella carnalità dei corpi, ma una
voce di tutti e di nessuno. Rispetto alla voce della linguistica, oggetto scientifico per un’analisi fredda
che la indaga dalla prospettiva del semantico per inglobarla in un sistema coerente, si tratta appunto di
una voce che sfida proprio la coerenza di questo sistema. L’attenzione alle risonanze del corpo non apre
tuttavia la sensibilità dell’orecchio all’annunciarsi vocalico di corpi singolari. La musicalità della parola
o, per dirla con Calvino, il piacere di dare una propria forma alle onde sonore, evita ancora una volta di
sintonizzarsi sull’ascolto delle voci plurali, diverse l’una dall’altra, da cui sgorga la sinfonia.
La condanna all’insignificanza, che la metafisica riserva all’unicità, continua dunque a funzionare da
schermo insonorizzante anche per quelle teorie che, riscoprendo la voce, intendono proprio farla
giocare, a seconda dei punti di vista, contro una scrittura o un linguaggio di cui postulano il marchio
metafisico. La questione, come già segnalato, è resa oggi ancor più paradossale dalla crescente fortuna
della voce come oggetto di studio e dal moltiplicarsi degli orizzonti disciplinari che se ne interessano.
Più la voce assurge a tema privilegiato di indagine, più l’usuale sordità nei confronti delle voci singolari
appare sorprendente.
Non sfugge a questa regola neanche un altro tipo di prospettiva che, proponendosi come una novità, in
tempi più recenti, va direttamente a tematizzare la voce in quanto voce. L’oggetto specifico della
ricerca viene questa volta individuato nell’ordine del vocale. L’espressione è del medievalista Paul
Zumthor, figura autorevole fra gli autori che ampliano l’orizzonte di riflessione sgorgato dagli studi
sull’oralità. Zumthor non manca di osservare, fra l’altro, quanto sia “strano che, tra tutte le nostre
discipline istituzionali, non esista ancora una scienza della voce”.2 Proponendo una distinzione fra
oralità e vocalità, egli definisce “oralità il funzionamento della voce in quanto portatrice di linguaggio”,
e “vocalità l’insieme delle attività e dei valori che le sono propri, indipendentemente dal linguaggio”.3
L’aspetto originale della vocalità, in quanto nuovo oggetto di studio, riguarda dunque un’analisi della
voce che prescinde dal tradizionale privilegiamento – non smentito dalle ricerche sull’oralità e sulla
testualità – del suo rapporto con il linguaggio. Viene così guadagnato un ampio e frastagliato orizzonte
d’approccio che apre nuove vie di interpretazione per il fenomeno della voce, facendo interferire campi
di ricerca multipli ed eterogenei. L’elenco dei saperi costretti a questa interferenza comprende, fra gli
altri, la filosofia, l’antropologia culturale, la storia della musica, la foniatria, la psicologia, la
cibernetica, l’etologia, nonché gli studi sull’oralità e quelli sulla comunicazione.4 È appunto la voce in
quanto voce, nelle sue molteplici manifestazioni, a orientare un’indagine che recupera, incrocia, ma
anche mette in crisi, la specificità dei vari canoni disciplinari. Crucialmente, anche in questa
prospettiva, la fenomenologia vocalica dell’unicità resta però sostanzialmente inindagata. Pur
affrancandosi dal dominio del linguaggio, la voce della vocalità insiste nel presentarsi come una voce in
generale.
Per molti versi preziosi, gli studi dedicati alla vocalità lo sono soprattutto per la loro netta
individuazione di un nodo teorico fondamentale: quello che lega la voce alla parola.
La voce è suono, non parola. Ma la parola costituisce la sua destinazione essenziale. Il lato cruciale di
ogni indagine sull’ontologia della voce – su un’ontologia vocalica dove sono appunto l’unicità e la
relazione a venire in primo piano – consiste proprio nel riflettere, senza pregiudizi metafisici, su questa
destinazione. Il pregiudizio fondamentale riguarda la tendenza ad assolutizzarla, di modo che, al di
fuori della parola, la voce sia un resto insignificante. Se si assolutizza il registro della parola, magari
identificandolo con un sistema del linguaggio di cui la voce sarebbe funzione, è infatti inevitabile che
l’emissione vocalica non indirizzata alla parola non sia altro che un resto. Si tratta, invece, di
un’originaria eccedenza. Detto altrimenti, l’ambito della voce è costitutivamente più ampio di quello
della parola: lo eccede. Ridurre questa eccedenza all’insensato – ossia a ciò che resta quando la voce
non sia intenzionata a un senso che si suppone come dominio esclusivo della parola – è uno dei vizi
capitali del logocentrismo. Tale vizio trasforma l’eccedenza in una mancanza. Più che una destinazione
essenziale, la parola diviene in tal modo, per la voce, un discrimine atto a produrre la drastica
alternativa fra un ruolo ancillare di vocalizzazione dei significati mentali e l’afferenza a un regno
extra-verbale di emissioni insensate, pericolosamente corporee, nonché seduttive e prossime
all’animalità. In altri termini, la tenaglia del logocentrismo metafisico nega radicalmente alla voce un
proprio orizzonte di senso che incida sul senso stesso della sua destinazione alla parola. Si capisce così
perché risulti cruciale la prospettiva, segnalata da Zumthor, che, indagando “l’insieme delle attività e
dei valori che sono propri della voce, indipendentemente dal linguaggio”, ritaglia per la vocalità un
ambito autonomo di riflessione. E si capisce anche perché, fra le due grandi radici dell’Occidente,
quella greca e quella ebraica, sia sintomaticamente la seconda a propiziare la sfida che l’ontologia
vocalica dell’unicità viene a lanciare contro le reticenze strategiche del logocentrismo.
Tale sfida – che, in sostanza, è lo scopo del libro che state leggendo – è ambiziosa ma semplice. In
termini elementari, essa consiste nel pensare il rapporto fra voce e parola come quello di un’unicità che,
pur risuonando anche e innanzitutto nella voce che non è parola, continua a risuonare nella parola, cui
la voce umana è costitutivamente destinata. Il comunicarsi vocalico dell’unicità, benché inerisca
esclusivamente al registro del suono, risulta infatti essenziale a questa destinazione. Il senso – o, se si
vuole, la relazionalità e l’unicità di ogni voce che costituiscono il nucleo di questo senso – transita dalla
sfera acustica alla parola. Proprio perché la parola ha una consistenza sonora, parlarsi è comunicarsi
nella pluralità delle voci. Detto altrimenti, l’atto del parlare è relazionale: ciò che in esso sempre e
prima di tutto si comunica, al di là degli specifici contenuti che le parole comunicano, è la relazionalità
acustica, empirica e materiale, delle voci singolari. Basta, ovviamente, intendersi sul significato del
termine parola.
A causa di una complessa vicenda, in cui la metafisica non svolge un ruolo secondario, nel lessico
moderno “parola” è infatti un nome multivoco e ambiguo che finisce spesso per indicare l’idea generale
della sfera verbale piuttosto che l’articolazione sonora, sempre contingente e contestuale, emessa dalla
bocca di qualcuno e indirizzata all’orecchio di qualcun altro. Il risultato è la mistificazione di un
fenomeno tanto ovvio quanto essenziale: c’è parola, perché ci sono dei parlanti. La sordità strategica
rispetto al comunicarsi plurale delle voci dipende precisamente dalla decisione, per così dire
metodologica, di prescindere dalla materialità elementare di questo fenomeno. Suggerito dalla
metafisica e capace di riscuotere grandi successi in vari ambiti disciplinari, il metodo consiste appunto
nel tematizzare la parola prescindendo dalla vocalità dei parlanti. L’unicità della voce rimane così
inavvertita perché, metodologicamente, non suona. Svincolata dalle gole di carne di coloro che la
emettono, la parola subisce una devocalizzazione primaria che le lascia soltanto il suono
spersonalizzato di una voce in generale.
Per contrastare gli effetti di questa devocalizzazione, occorre dunque adottare un altro metodo e,
precisamente, un metodo che trae ispirazione dal racconto di Calvino piuttosto che dai testi della storia
della filosofia. Fedele alla fenomenologia vocalica dell’unicità, esso consiste nell’ascoltare la parola in
quanto essa suona nella pluralità delle voci di coloro che, ogni volta e rivolgendosi l’uno all’altro,
parlano. In un certo senso, questo secondo metodo funziona dunque anche come un rovesciamento, se
non come una decostruzione, del primo. Sintonizzandosi sul registro fenomenologico dell’ascolto, esso
indaga la parola dalla prospettiva della voce invece che da quella del linguaggio. La parola, intesa come
parola che esce dalla bocca di qualcuno, più che essere il luogo verbale dell’espressione, è infatti il
punto di tensione fra l’unicità della voce e il sistema del linguaggio. Privilegiare l’uno o l’altro polo
cambia radicalmente gli assi interpretativi del quadro teorico. Apparentemente, si tratta di un gesto
facile, di un semplice rovesciamento di prospettiva, ma l’ampio ventaglio degli studi contemporanei
sulla voce testimoniano che le cose stanno altrimenti. Anche tematizzare la voce in quanto voce o, se si
vuole, la “vocalità”, non garantisce alcuna restituzione di senso al fenomeno dell’unicità vocalica se
non si ha l’accortezza e la pazienza di abbattere il filtro metafisico che da millenni ne blocca l’ascolto.
Oltre a rivendicare un’indipendenza dell’ordine del vocale rispetto al linguaggio, si tratta dunque di
protocollare le strategie che consentono al polo del linguaggio o, meglio, alla sua assolutizzazione, di
neutralizzare quella pluralità delle voci che costituisce l’altro polo della parola. Detto altrimenti, il
proprio della voce non sta nel puro suono, sta piuttosto nell’unicità relazionale di un’emissione fonica
che, lungi dal contraddirlo, annuncia e porta a destinazione il fatto specificamente umano della parola.
Secondo Roland Barthes – la cui speculazione è ormai divenuta un punto di riferimento obbligatorio
per le prospettive interessate alla vocalità nonché alla testualità e alla scrittura – il proprio della voce
starebbe invece in quel che egli chiama la sua grana. Piuttosto che la sfera del soffio e del respiro, essa
riguarda “la materialità del corpo che sgorga dalla gola, là dove si forgia il metallo fonico”.5
L’attenzione va dunque alla cavità orale, luogo erotico per eccellenza. La grana della voce concerne
soprattutto il modo in cui, mediante la voluttà dell’emissione sonora, la voce lavora nella lingua.
Interessato al canto come luogo primario della tessitura fonica e musicale da cui germina la lingua,
Barthes non manca di sottolineare che “la voce, corporeità del parlare, si situa nell’articolazione del
corpo e del discorso”, nel punto del loro interscambio.6 Compito della voce è dunque quello di fare da
tramite o, meglio, da snodo, fra corpo e parola. Sintomaticamente, nell’orizzonte di Barthes, non si
tratta però di un corpo di cui viene sottolineata la singolarità, né si tratta di una voce di cui è l’unicità e
la relazionalità a venire in primo piano. La grana si riferisce a una fisica della voce da intendersi come
“il modo in cui la voce sta nel corpo – o in cui il corpo sta nella voce”,7 ma sia la voce che il corpo
continuano a proporsi come categorie generali, anzi, nello spirito della speculazione barthesiana, come
categorie di un godimento spersonalizzante in cui, insieme al soggetto e all’individuo, si dissolve
evidentemente anche l’unicità incarnata (per altro, mai assurta a tema) di ogni concreto esistente. Il
situarsi, nella voce, dell’articolazione fra corpo e parola lascia così che la voce, pur avendo nella parola
– nella lingua – la sua essenziale destinazione, non porti l’unicità e la relazione come dono costitutivo
di questo destino. Detto altrimenti, indagando il tema della voce, Barthes incoraggia l’analisi a
focalizzarsi su un vocalico che, lungi dall’essere semplicemente una pura sonorità o, ancor peggio, un
resto, gioca la sua potenza in riferimento alla parola, ma scoraggia, al medesimo tempo, ogni
prospettiva che individui nell’unicità e nella relazione il senso fondamentale di questa potenza.
Sintonizzarsi sulla sonorità della parola e sottolineare il godimento corporeo, il canto della carne, la
pulsione ritmica da cui sgorga, non è infatti sufficiente per sottrarre la parola stessa dall’abbraccio
mortifero del logocentrismo. La macchina metafisica, che nega metodologicamente il primato della
voce sulla parola, va smontata non solo trasformando tale primato in un’essenziale destinazione, ma
tenendo sempre a mente che la strategia volta a neutralizzare la potenza della voce è anche una strategia
nella quale il darsi “a più voci”, diverse l’una dall’altra, del fenomeno della parola resta, per millenni,
inascoltato. Tale incapacità di ascolto ha molte e perniciose conseguenze. Essa, per esempio, fa sì che
anche le filosofie volte a valorizzare il “dialogo” e la “comunicazione” restino imprigionate in un
registro del linguaggio che ignora la relazionalità già messa in atto dal semplice comunicarsi, l’una
all’altra, delle voci. Tematizzare il primato della voce rispetto alla parola, infatti, significa anche aprire
nuove strade per una prospettiva che non solo può focalizzarsi su una forma primaria e radicale di
relazione non ancora catturata dall’ordine del linguaggio, ma è soprattutto in grado di precisarla come
relazione fra unicità. Nient’altro che questo è, del resto, il senso che la sfera vocalica consegna alla
parola in quanto la parola è appunto la sua destinazione essenziale. E si tratta, ovviamente, di un senso
che, tramite la parola, transita dall’ontologia alla politica.