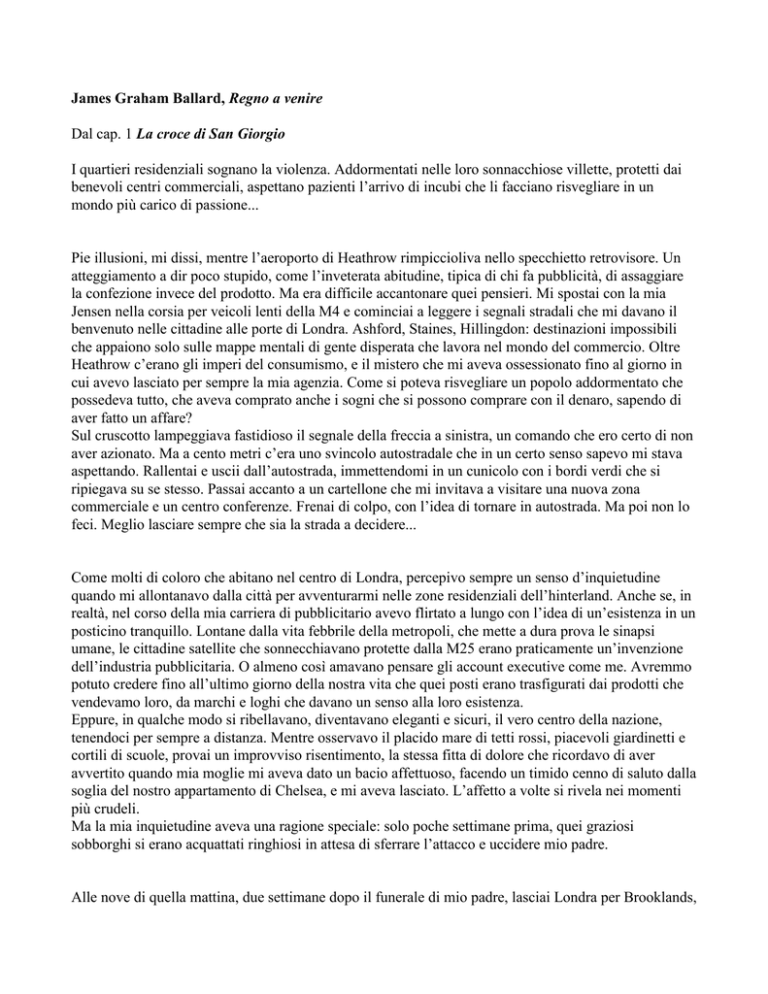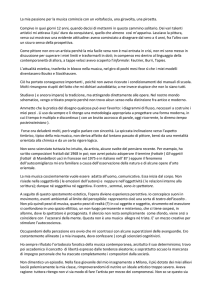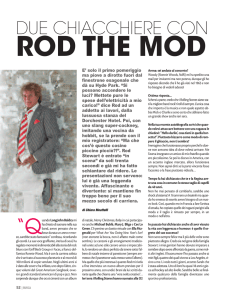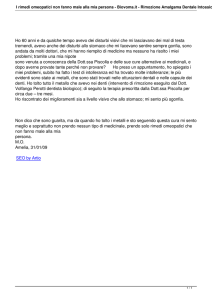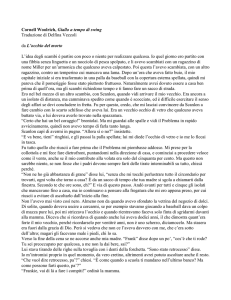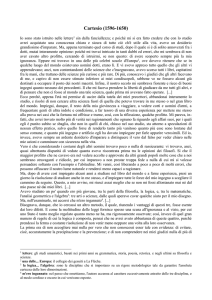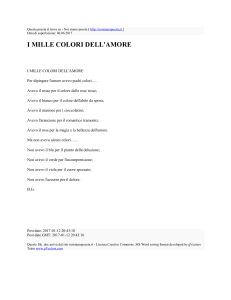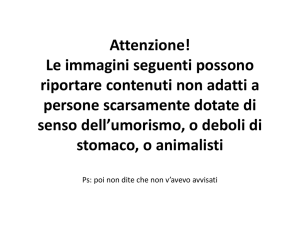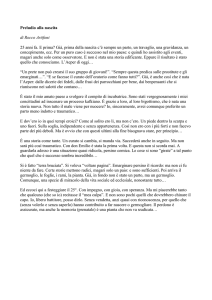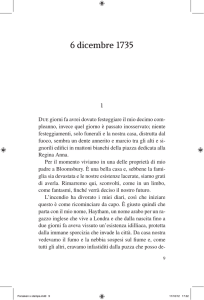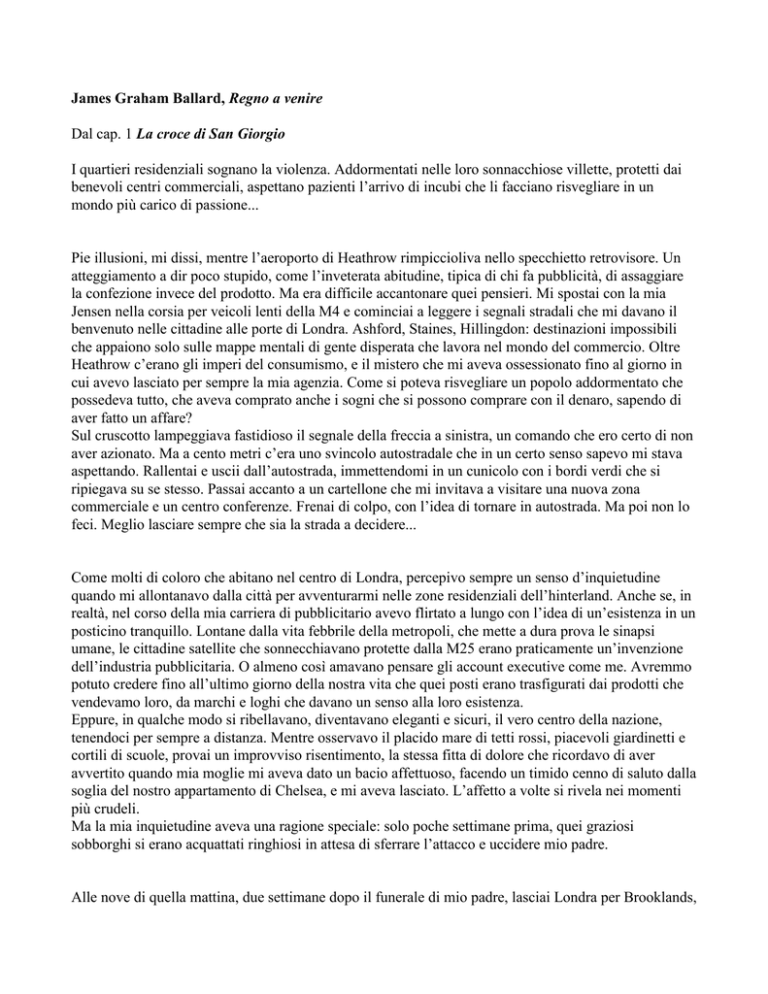
James Graham Ballard, Regno a venire
Dal cap. 1 La croce di San Giorgio
I quartieri residenziali sognano la violenza. Addormentati nelle loro sonnacchiose villette, protetti dai
benevoli centri commerciali, aspettano pazienti l’arrivo di incubi che li facciano risvegliare in un
mondo più carico di passione...
Pie illusioni, mi dissi, mentre l’aeroporto di Heathrow rimpiccioliva nello specchietto retrovisore. Un
atteggiamento a dir poco stupido, come l’inveterata abitudine, tipica di chi fa pubblicità, di assaggiare
la confezione invece del prodotto. Ma era difficile accantonare quei pensieri. Mi spostai con la mia
Jensen nella corsia per veicoli lenti della M4 e cominciai a leggere i segnali stradali che mi davano il
benvenuto nelle cittadine alle porte di Londra. Ashford, Staines, Hillingdon: destinazioni impossibili
che appaiono solo sulle mappe mentali di gente disperata che lavora nel mondo del commercio. Oltre
Heathrow c’erano gli imperi del consumismo, e il mistero che mi aveva ossessionato fino al giorno in
cui avevo lasciato per sempre la mia agenzia. Come si poteva risvegliare un popolo addormentato che
possedeva tutto, che aveva comprato anche i sogni che si possono comprare con il denaro, sapendo di
aver fatto un affare?
Sul cruscotto lampeggiava fastidioso il segnale della freccia a sinistra, un comando che ero certo di non
aver azionato. Ma a cento metri c’era uno svincolo autostradale che in un certo senso sapevo mi stava
aspettando. Rallentai e uscii dall’autostrada, immettendomi in un cunicolo con i bordi verdi che si
ripiegava su se stesso. Passai accanto a un cartellone che mi invitava a visitare una nuova zona
commerciale e un centro conferenze. Frenai di colpo, con l’idea di tornare in autostrada. Ma poi non lo
feci. Meglio lasciare sempre che sia la strada a decidere...
Come molti di coloro che abitano nel centro di Londra, percepivo sempre un senso d’inquietudine
quando mi allontanavo dalla città per avventurarmi nelle zone residenziali dell’hinterland. Anche se, in
realtà, nel corso della mia carriera di pubblicitario avevo flirtato a lungo con l’idea di un’esistenza in un
posticino tranquillo. Lontane dalla vita febbrile della metropoli, che mette a dura prova le sinapsi
umane, le cittadine satellite che sonnecchiavano protette dalla M25 erano praticamente un’invenzione
dell’industria pubblicitaria. O almeno così amavano pensare gli account executive come me. Avremmo
potuto credere fino all’ultimo giorno della nostra vita che quei posti erano trasfigurati dai prodotti che
vendevamo loro, da marchi e loghi che davano un senso alla loro esistenza.
Eppure, in qualche modo si ribellavano, diventavano eleganti e sicuri, il vero centro della nazione,
tenendoci per sempre a distanza. Mentre osservavo il placido mare di tetti rossi, piacevoli giardinetti e
cortili di scuole, provai un improvviso risentimento, la stessa fitta di dolore che ricordavo di aver
avvertito quando mia moglie mi aveva dato un bacio affettuoso, facendo un timido cenno di saluto dalla
soglia del nostro appartamento di Chelsea, e mi aveva lasciato. L’affetto a volte si rivela nei momenti
più crudeli.
Ma la mia inquietudine aveva una ragione speciale: solo poche settimane prima, quei graziosi
sobborghi si erano acquattati ringhiosi in attesa di sferrare l’attacco e uccidere mio padre.
Alle nove di quella mattina, due settimane dopo il funerale di mio padre, lasciai Londra per Brooklands,
una cittadina tra Weybridge e Woking sviluppatasi negli anni trenta attorno a un circuito
automobilistico. Mio padre aveva trascorso l’infanzia a Brooklands e, dopo una vita passata sugli aerei,
il vecchio pilota di linea era tornato lì a fare il pensionato. Mi ero rivolto ai suoi legali, per vedere se
l’esecuzione del testamento procedeva, per mettere in vendita il suo appartamento, ponendo così
formalmente fine a una vita della quale non avevo mai fatto parte. Secondo quanto diceva l’avvocato
Geoffrey Fairfax, dall’appartamento si poteva vedere il vecchio autodromo, un sogno di velocità che
evidentemente ricordava al vecchio tutte le piste aeree che riempivano ancora i suoi pensieri. Quando
misi via le sue uniformi e chiusi la porta, un’ultima barriera si alzò davanti all’ex pilota della British
Airways, un padre assente che un tempo avevo adorato come un eroe, ma che non vedevo praticamente
mai.
Quando avevo cinque anni, mio padre lasciò mia madre, una donna dalla volontà di ferro, ma con un
carattere particolarmente difficile. Aveva fatto milioni di chilometri, atterrando in alcuni tra gli
aeroporti più pericolosi del mondo, era sopravvissuto a due tentativi di dirottamento e alla fine era
rimasto ucciso da una pallottola vagante in un centro commerciale di una cittadina alle porte di Londra.
Quel giorno, un paziente in libera uscita da un ospedale psichiatrico era andato nel Metro-Centre di
Brooklands e aveva sparato a caso tra la folla, all’ora di pranzo, uccidendo tre persone e ferendone
quindici. Mio padre era stato stroncato da una singola pallottola. Un tipo di morte che uno si
aspetterebbe a Manila, a Bogotá o a Los Angeles est, non in una cittadina inglese con tanto verde
attorno. Purtroppo tutti i suoi parenti e gran parte dei suoi amici erano morti prima di lui. Mi occupai
del funerale ed ebbi modo di dargli l’ultimo saluto.
Mentre l’autostrada si allontanava alle mie spalle, l’idea di girare la chiave nella toppa della porta di
casa di mio padre mi appariva sul parabrezza come un visualizzatore head-up vagamente inquietante.
Lì avrei trovato ancora molto di lui: il suo sudore sugli asciugamani e sui vestiti, il bucato nella cesta
della biancheria, quel puzzo tipico dei vecchi bestseller sugli scaffali. Ma la sua presenza sarebbe stata
inscindibile dalla mia assenza, quei vuoti che avrei trovato ovunque come cellule vacanti di un alveare,
spazi che neanche suo figlio era stato in grado di riempire quando lui aveva abbandonato la famiglia per
un universo fatto di cieli.
Quegli spazi erano anche dentro di me. Invece di trascinarmi in giro per Harvey Nichols con mia
madre, o sorbirmi un’infinità di tè da Fortnum & Mason, sarei dovuto stare insieme a mio padre, a
costruire il mio primo aquilone, a giocare a cricket in giardino, a imparare ad accendere un falò e ad
andare sul dinghy. Avevo deciso di intraprendere una carriera nel mondo della pubblicità; una carriera
che sarebbe stata brillante fino al giorno in cui commisi l’errore di sposare una collega, ritrovandomi
così con una rivale che non avrei mai potuto sperare di battere.
Arrivai in fondo allo svincolo, davanti a me c’era un enorme camion che trasportava microvetture, così
nuove e scintillanti da far venire voglia di mangiarle, o quanto meno leccarle: mele caramellate alla
cellulosa che illuminavano il giorno. Al semaforo il camion si fermò – un toro di ferro pronto ad
affrontare la corrida della strada. Al verde ripartì fragoroso alla volta di una zona industriale poco
distante.
E già mi ero perso. Ero appena entrato in quella che la cartina stradale mi segnalava come un’area di
antiche cittadine della Valle del Tamigi – Chertsey, Weybridge, Walton – ma di cittadine nemmeno
l’ombra e attorno a me c’erano pochissime tracce di insediamenti urbani permanenti. Stavo
attraversando zone cresciute alla rinfusa tra una città e l’altra, una geografia di deprivazione sensoriale,
un territorio di strade a doppia carreggiata e stazioni di servizio, aree industriali e segnali stradali per
Heathrow, terreni agricoli in disuso pieni di serbatoi per butano, depositi con esotici rivestimenti di
lamiera. Passai accanto a un terreno industriale abbandonato, occupato in gran parte da un enorme
cartellone che annunciava l’ampliamento della zona sud di Heathrow e da uno spazio illimitato
destinato alle merci da trasportare, sebbene si trattasse di un terreno vuoto dove tutto era già stato
spedito a destinazione. Lì nulla aveva senso se non nei termini di una cultura transitoria da aeroporto.
Segnali di allarme che si allertavano a vicenda; il paesaggio era un susseguirsi di avvisi di pericolo.
Acquattate sui cancelli dei depositi, le telecamere a circuito chiuso e le frecce direzionali che
indicavano di tenere la sinistra pulsavano instancabilmente, indicando le oasi protette dei centri di
ricerca per l’alta sicurezza.
Apparve una schiera di villini, nascosti nell’ombra del terrapieno di un laghetto artificiale; l’unica
parvenza di un senso di comunità era data dalle distese di auto usate che lo circondavano. Dirigendomi
verso un ipotetico Sud, passai accanto a un take away cinese, un magazzino di mobili all’ingrosso, un
allevamento di cani da difesa e un tristissimo complesso residenziale che sembrava un carcere
riconvertito. Non c’erano cinema, chiese, né centri di attività amministrative o ricreative, e gli unici
indizi di qualcosa di culturale erano la schiera infinita di cartelloni che pubblicizzavano uno stile di vita
consumistico.
Sulla mia sinistra il traffico scorreva lungo una strada secondaria piena di auto familiari che cercavano
un posto dove parcheggiare. Trecento metri più avanti, una fila di vetrine che riflettevano il sole.
Dall’intrico di raccordi e autostrade era comparso un piccolo complesso residenziale. Il viaggiatore
smarrito trovava finalmente soccorso nell’insegna al neon di un negozio di attrezzi per il giardinaggio e
un’agenzia di viaggi che pubblicizzava “vacanze di lusso”.
Ero fermo al semaforo in attesa del verde, un’eternità compressa in pochi secondi. Come ottuse
divinità, i segnali stradali esercitavano la loro autorità su incroci deserti. Stavo abbassando il piede
sull’acceleratore, pronto a passare con il rosso, quando vidi dietro di me una macchina della polizia in
attesa. Come la cittadina, anche la macchina si era materializzata dal nulla, allertata dalla fantasia
ribelle di un autista smanioso alla guida di una due posti superpotente. Quel paesaggio schierato in
difesa aspettava che qualcuno commettesse un crimine. […]