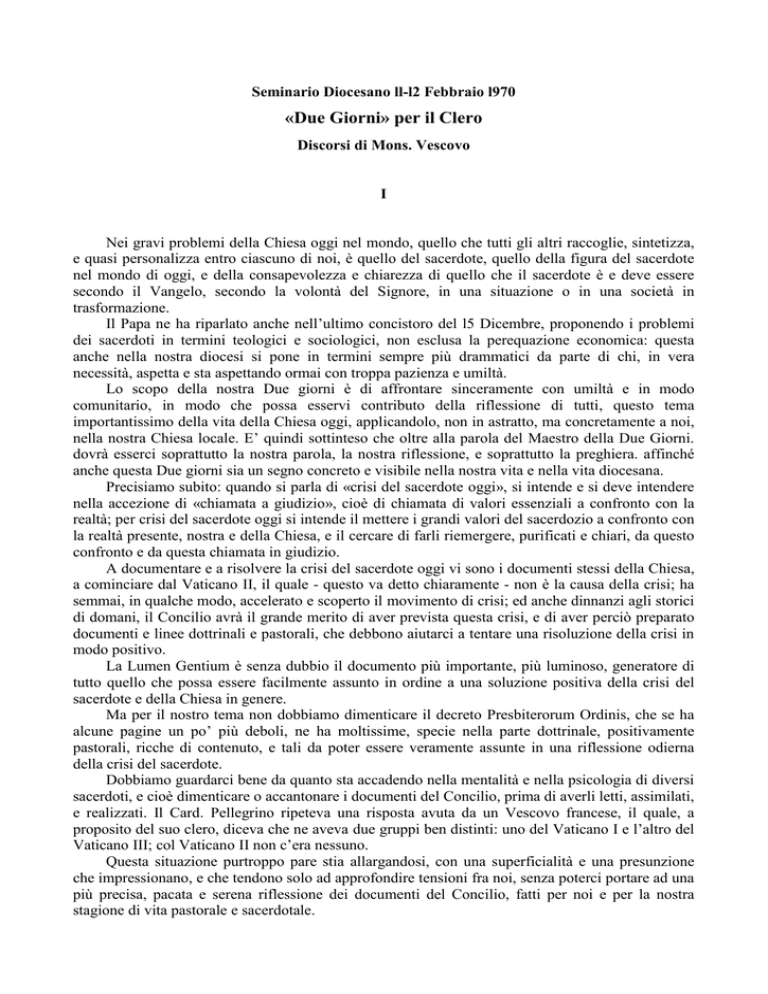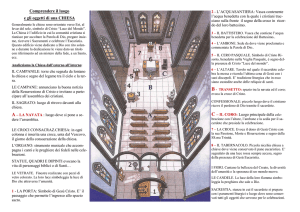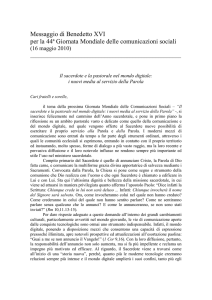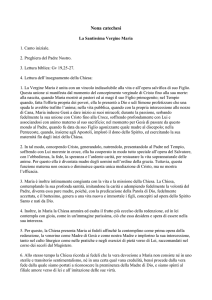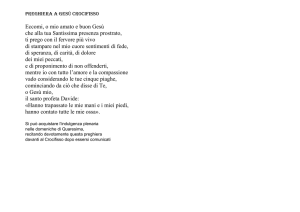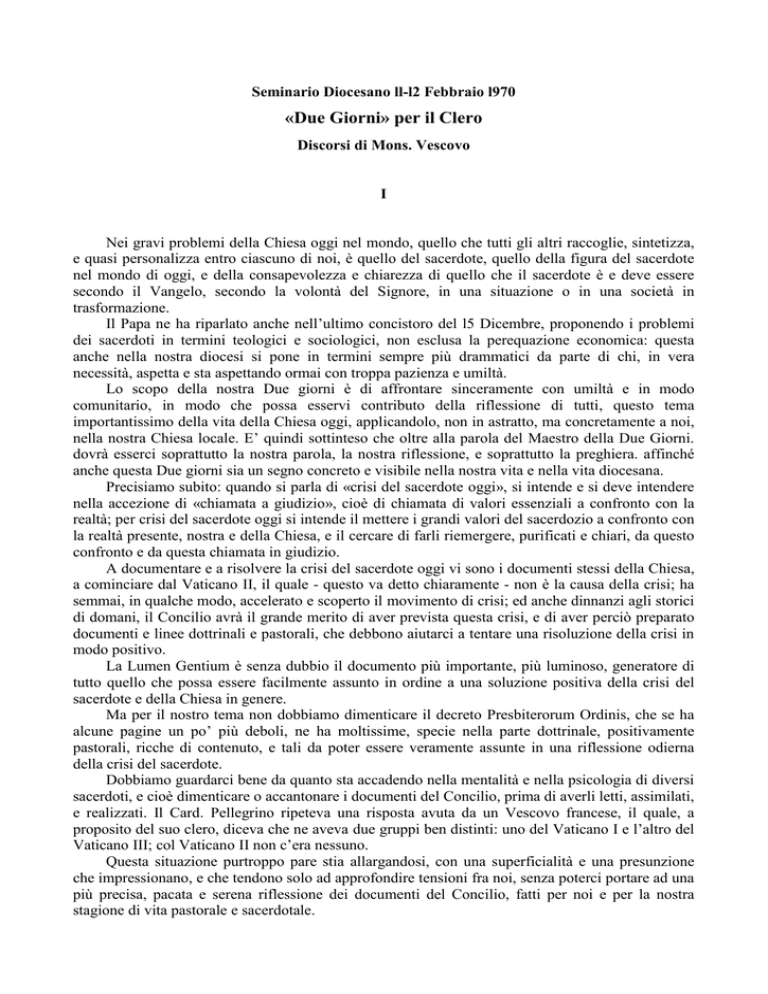
Seminario Diocesano ll-l2 Febbraio l970
«Due Giorni» per il Clero
Discorsi di Mons. Vescovo
I
Nei gravi problemi della Chiesa oggi nel mondo, quello che tutti gli altri raccoglie, sintetizza,
e quasi personalizza entro ciascuno di noi, è quello del sacerdote, quello della figura del sacerdote
nel mondo di oggi, e della consapevolezza e chiarezza di quello che il sacerdote è e deve essere
secondo il Vangelo, secondo la volontà del Signore, in una situazione o in una società in
trasformazione.
Il Papa ne ha riparlato anche nell’ultimo concistoro del l5 Dicembre, proponendo i problemi
dei sacerdoti in termini teologici e sociologici, non esclusa la perequazione economica: questa
anche nella nostra diocesi si pone in termini sempre più drammatici da parte di chi, in vera
necessità, aspetta e sta aspettando ormai con troppa pazienza e umiltà.
Lo scopo della nostra Due giorni è di affrontare sinceramente con umiltà e in modo
comunitario, in modo che possa esservi contributo della riflessione di tutti, questo tema
importantissimo della vita della Chiesa oggi, applicandolo, non in astratto, ma concretamente a noi,
nella nostra Chiesa locale. E’ quindi sottinteso che oltre alla parola del Maestro della Due Giorni.
dovrà esserci soprattutto la nostra parola, la nostra riflessione, e soprattutto la preghiera. affinché
anche questa Due giorni sia un segno concreto e visibile nella nostra vita e nella vita diocesana.
Precisiamo subito: quando si parla di «crisi del sacerdote oggi», si intende e si deve intendere
nella accezione di «chiamata a giudizio», cioè di chiamata di valori essenziali a confronto con la
realtà; per crisi del sacerdote oggi si intende il mettere i grandi valori del sacerdozio a confronto con
la realtà presente, nostra e della Chiesa, e il cercare di farli riemergere, purificati e chiari, da questo
confronto e da questa chiamata in giudizio.
A documentare e a risolvere la crisi del sacerdote oggi vi sono i documenti stessi della Chiesa,
a cominciare dal Vaticano II, il quale - questo va detto chiaramente - non è la causa della crisi; ha
semmai, in qualche modo, accelerato e scoperto il movimento di crisi; ed anche dinnanzi agli storici
di domani, il Concilio avrà il grande merito di aver prevista questa crisi, e di aver perciò preparato
documenti e linee dottrinali e pastorali, che debbono aiutarci a tentare una risoluzione della crisi in
modo positivo.
La Lumen Gentium è senza dubbio il documento più importante, più luminoso, generatore di
tutto quello che possa essere facilmente assunto in ordine a una soluzione positiva della crisi del
sacerdote e della Chiesa in genere.
Ma per il nostro tema non dobbiamo dimenticare il decreto Presbiterorum Ordinis, che se ha
alcune pagine un po’ più deboli, ne ha moltissime, specie nella parte dottrinale, positivamente
pastorali, ricche di contenuto, e tali da poter essere veramente assunte in una riflessione odierna
della crisi del sacerdote.
Dobbiamo guardarci bene da quanto sta accadendo nella mentalità e nella psicologia di diversi
sacerdoti, e cioè dimenticare o accantonare i documenti del Concilio, prima di averli letti, assimilati,
e realizzati. Il Card. Pellegrino ripeteva una risposta avuta da un Vescovo francese, il quale, a
proposito del suo clero, diceva che ne aveva due gruppi ben distinti: uno del Vaticano I e l’altro del
Vaticano III; col Vaticano II non c’era nessuno.
Questa situazione purtroppo pare stia allargandosi, con una superficialità e una presunzione
che impressionano, e che tendono solo ad approfondire tensioni fra noi, senza poterci portare ad una
più precisa, pacata e serena riflessione dei documenti del Concilio, fatti per noi e per la nostra
stagione di vita pastorale e sacerdotale.
Diciamo subito: la crisi del sacerdote oggi è crisi di fede, è un problema di fede. Se noi non
torniamo a porci in una luce di fede, che investa tutta la nostra esistenza, così come è descritta dalla
Dei Verbum, e cioè di ascolto religioso della Parola di Dio, per rispondergli in un totale abbandono,
e non già alla luce delle posizioni sociologiche del passato o di quelle auspicabili nel futuro, credo
che invano avremo denunciato la crisi del sacerdote oggi, e soprattutto invano avremo cercato di
risolverla.
Per aiutare me e voi a questo religioso ascolto della Parola di Dio sul nostro sacerdozio, ecco
qualche riflessione su alcuni lineamenti del nostro sacerdozio.
Gesù, che, sotto l’aspetto giuridico, nel suo popolo era un laico, fu in verità, come si esprime
l’epistola agli Ebrei, unico vero sacerdote del mondo. E la Sua morte, da un punto di vista storico,
non era affatto un rito culturale, ma un avvenimento profano, cioè l’esecuzione capitale di un uomo,
condannato come un delinquente politico. Questa morte, tuttavia, fu l’unica vera liturgia del mondo.
Una liturgia cosmica, per la quale Gesù entrò nel vero tempio al cospetto del Dio vivente, non nel
limitato ambito dello svolgimento liturgico, cioè nel tempio materiale; ma apertamente attraverso il
velo della carne, cioè attraverso il velo della morte, non offrendo qualche cosa, ma se stesso. E’ il
gesto dell’amore che dona tutto, che non dà nulla più e nulla meno di se stesso. Questo gesto, fu la
vera liturgia del mondo: l’ora della croce, segnò il giorno della riconciliazione cosmica.
E Gesù non si è chiamato, senza che per questo debba la sua posizione a una elezione
democratica. Egli sa di essere soggetto a una volontà divina, che nello stesso tempo è il luogo
intimo, la vera origine di tutta la sua esistenza. Egli non viene da se stesso, ma si riconosce come
mandato. Questo è così vero, che la missione non viene ad aggiungersi in un secondo momento
all’essere già costituito; la sua esistenza sussiste solo come missione; essere da un altro e per un
altro.
Se guardiamo a questa coscienza di Gesù e alla concezione della fede neo-testamentaria, viene
chiarita anche la struttura fondamentale dei ministeri cristiani: neppure essi si fondano su propria
autorizzazione, su semplice ragione di opportunità o su un accordo, ma sull’essere chiamati in
Colui, che è la Chiamata di Dio in persona, la «Parola» di Dio e da Dio.
Da questo nucleo cristologico, deve essere dedotto ciò che è essenziale nel concetto cristiano
di ministero. Esso ha il suo punto focale nella missione di Cristo e nella partecipazione ad essa.
In Mc. 3, l3-l9 la chiamata dei dodici viene descritta così: «Egli salì sul monte e chiamò quelli
che volle e vennero a Lui. Ed egli ne costituì dodici, perchè stessero con Lui e per mandarli a
predicare col potere di cacciare i demoni. Egli ne costituì dodici e diede a Simone il nome di
Pietro...», e seguono gli altri nomi. Dunque: Egli chiamò presso di Sè quelli che Egli stesso volle.
Con ciò, si rende subito concreto il punto di partenza del servizio neo-testamentario: da dove esso
provenga e come prenda forma nell’eletto.
Esso, secondo quanto qui si afferma, è prima di tutto risposta a una chiamata, e accettazione
della sua volontà. Questo è sottolineato fortemente dalle parole «ethelen autòs»: egli non chiama
coloro che han voglia di compiere questa missione, o quelli che accorrono, seguendo la propria
volontà; ma chiama quelli che Egli vuole. Così, per il ministero del Nuovo Testamento, la risposta
alla sua chiamata e l’accettazione della sua volontà, è qualcosa di essenziale. Questo ministero non
risulta dalla propria volontà, ma dall’udire, che si fa «ascolto» e «obbedienza». La sua volontà è il
punto centrale e determinante. In questo modo è già espressa una caratteristica fondamentale
permanente nel ministero della Chiesa; essa ha una grande importanza, sia dal punto di vista
dogmatico che spirituale. Questo ufficio poggia sull’ascolto vigilante, che si mette a disposizione
della chiamata di Cristo. Esso poggia sull’atteggiamento del servitore, che ha imparato a posporre la
propria volontà a quella di colui al quale appartiene. Per il titolare di questo ufficio, è essenziale
stare al servizio di un’altra volontà.
Il servo di Cristo viene requisito nella maniera sempre personale, tipica del ministero
profetico. Egli non ha a che fare con un privilegio ereditario, ma dipende da un rapporto di chiamata
e risposta. Il suo servizio può sussistere solo in questo dialogo di chiamata e di risposta. Appartiene
alla sua struttura, non il binomio carne e sangue, ma quello di parola e risposta, ascolto e
obbedienza a colui, del quale si dice: egli lo vuole. Il ministero neo-testamentario ha un rapporto
essenziale con la vocazione del pneuma e con la dimensione carismatica. Non è semplicemente
istituzione e burocrazia.
Nella successiva frase del nostro testo è descritta la struttura interna del servizio di cui
abbiamo detto il punto di partenza: «egli ne costituì dodici, perchè fossero con lui, e per mandarli a
predicare col potere di cacciare i demoni». In questa frase compaiono i due poli estremi dell’ufficio
sacerdotale e la tensione alle volte lacerante: l’essere con lui e il venir mandato; suoi
accompagnatori e suoi messaggeri. L’una visione sembra escludere l’altra: o essi rimangono con
lui, oppure vengono mandati e vanno, dove egli non può giungere.
Ciò che sembra una tensione difficilmente eliminabile, rimane la tormentante tensione di
questa chiamata per tutti i tempi; essa ci si ripresenta nella situazione odierna, come paradosso tra
vita interiore e servizio. Se la missione sacerdotale è testimonianza di Gesù davanti agli uomini è
naturale la premessa: prima bisogna conoscerlo, vivere in intimità con lui, trovare il vero posto
dell’esistenza nell’essere presso di lui. Per colui che, come sacerdote, tenta di parlare di lui agli
uomini, non c’è nulla di più importante di questo: abituarsi all’intimità con lui, a vivere vicino a lui,
a seguirlo; udire e vedere lui, e abituarsi a gustare il suo modo di essere e pensare: preghiera e
spirito di preghiera tanto la pienezza dell’esistenza sacerdotale, come lo sforzo di preparare altri ad
essa, devono essere indirizzati a questo: diventare capaci di udire lui e di vedere lui, di vivere presso
di lui, anche tra i rumori e le cose di questo mondo; ma, nello stesso tempo, tutto questo non può
condurre a separarsi, a eliminare i contatti con il mondo di ogni giorno. Il servitore di Gesù non
deve essere uno che si toglie dal volgo profano, per chiudersi nella cerchia degli eletti. Egli deve
essere l’antitesi vivente del fariseo: separato, solamente per poter essere mandato.
Ecco il secondo aspetto che caratterizza il servizio neo-testamentario: l’essere mandato per
predicare e poter continuare la sua opera: la distruzione del regno di satana e la costruzione del
regno di Dio. Il «servizio» del nuovo Testamento è dunque definito dalla chiamata di Gesù e
dall’essere mandato per gli uomini: vocazione che ha il suo punto perfettivo nella consacrazione
operata con il sacramento dell’ordine e missione.
La missione impone al prete di essere l’annunciatore di Gesù Cristo. Ma agire ed essere
nell‘uomo, stanno in rapporto inseparabile. Il compito di divenire apostolo di Gesù, richiede
all’uomo, non solo un determinato agire, ma tocca intimamente anche il suo essere. Se l’essere prete
è «stare in condizione di missione», «essere mandato» ciò significa che per il prete è essenziale il
suo a «essere per un altro ». Chi riceve una missione, non appartiene più a se stesso, e ciò in una
doppia prospettiva: egli si mette a disposizione di colui che egli rappresenta, e di coloro davanti ai
quali egli lo rappresenta. Stare in missione, comporta ancora una volta una duplice tensione
nell’esistenza: significa scomparire davanti a colui che invia; come araldo e messaggero, non
mettere avanti se stesso, ma tenersi fuori dal gioco; non predicare se stesso, ma rendere libera la via
e lo sguardo, per gli altri, senza infedeltà alla parola affidata: esser pronto a diminuire perchè egli
cresca. Imparare ciò, richiede un duro esercizio, che plasma tutto l’uomo; aggiungiamo ancora: egli
deve essere sempre pronto a stare accanto agli altri, ai quali è diretto il suo messaggio.
Ascoltiamo il Concilio:
«I presbiteri del Nuovo Testamento, in forza della propria chiamata e della propria
ordinazione, sono in un certo modo segregati in seno al Popolo di Dio: ma non per rimanere
separati da questo stesso Popolo o da qualsiasi uomo, bensì per consacrarsi interamente all’opera,
per la quale li ha assunti il Signore. Da una parte, essi non potrebbero essere ministri di Cristo, se
non fossero testimoni e dispensatori di una vita diversa da quella terrena; ma d’altra parte, non
potrebbero nemmeno servire gli uomini, se si estraniassero dalla loro vita e dal loro ambiente» (P.
O. 3).
«I sacerdoti sono specialmente obbligati a tendere alla perfezione, poiché essi, che hanno
ricevuto una nuova consacrazione a Dio mediante l’Ordinazione, vengono elevati alla condizione di
strumenti vivi di Cristo Eterno Sacerdote, per proseguire nel tempo la sua mirabile opera, che ha
reintegrato con divina efficacia l’intero genere umano» (P. O. l2).
Di fronte a tali esigenze, senza dubbio qualcuno potrebbe sentirsi poco sicuro. Può uno
mettersi a disposizione degli altri fino alla morte? La risposta può venire solo da un richiamo alla
cristologia, che anche qui deve far sentire il suo influsso. Gesù stesso era l’inviato dal Padre, Figlio
di Dio, essenzialmente con Dio. Come Cristo e con l’aiuto di Cristo, anche il suo ministro. Nel fatto
che chi così si perde, e scinde la sua esistenza contemporaneamente in due direzioni, trova
realmente se stesso, sta anche la promessa legata alle esigenze di una vita missionaria. Solo chi si
perde, può trovare se stesso realmente. Chi non si dona, non realizza se stesso. Ovviamente resta il
pericolo di perdersi solo in una direzione: o semplicemente nell’interiorità, oppure nella esteriorità.
L’impegno di colui che è assunto all’ufficio sacerdotale, deve mostrarsi nello sforzo di tendere,
sempre e con concretezza, verso ambedue le direzioni.
L’ufficio sacerdotale neo-testamentario è dunque strutturalmente vicariato, stare per un altro,
cioè per Gesù Cristo. Con ciò esso si distingue decisamente dall’ufficio sacerdotale non cristiano,
nel quale l’uomo è detentore autonomo del suo ufficio: egli stesso è bramino, sacerdote, mediatore
fra Dio e l’umanità, ha in sé la sua ragion d’essere, senza richiamarsi ad un altro. Il prete cristiano
invece, non è mediatore autonomo; rimane sempre vicario, sempre e solamente rappresentante; non
parla né agisce per sé, ma per colui che ha rappresentato e rappresenta tutti noi, e che vuole essere
ora rappresentato da noi.
Leggiamo il testo molto forte di Mt. 24, 45-5l. Esso costituisce un duro ammonimento ai servi
di Cristo, perchè rimangano servi, anche nella reale assenza del Signore, e non si atteggino a
signori. Qui si parla del fattore, preso a servizio da un padrone, e che dopo lunga assenza è visitato
da lui. Viene elogiato chi è rimasto veramente amministratore. Egli è contrapposto a colui che, per
la lunga assenza del padrone, si dà alla bella vita: egli fa da padrone, picchia i compagni, e con i
grandi conduce una vita lussuosa. La sua sorte, così è detto, sarà con gli ipocriti. Questo servo,
portatore di un compito ecclesiale, cessando di essere servitore e facendo da padrone, ha rinnegato
il Nuovo Testamento nella sua essenzialità. Mai egli può divenire padrone degli altri; sarà sempre
un compagno, con-servo. Questo trasferire il prete quasi all’ultimo posto, non è solo qualche cosa
di duro, ma anche molto utile e confortante. Infatti, il richiamo al carattere vicariale del ministero,
nel quale in definitiva rappresentiamo, in concreto, il vero sacerdote, conferma che l’operante è e
rimane Cristo stesso. Egli opera attraverso la nostra insufficienza. Egli è e rimane il vero operante.
Ciò significa che egli stesso tiene in mano le cose, e che noi, in nessun modo, possiamo venire
meno, così da rendere inefficace la sua volontà. Agostino, nella lotta contro i Donatisti, ha posto in
evidenza questa verità. I Donatisti volevano far dipendere la validità dei sacramenti dalla santità dei
preti. «In quale spaventosa situazione saremmo caduti», afferma Agostino. Quale ansia ognuno
dovrebbe avere di cadere nelle mani di un sacerdote, che non adempie ciò che è chiamato a
compiere! Quale sicurezza invece per il fedele, come pure per il ministro, sapere che nel nostro
agire, e anche nella nostra diserzione, rimane Cristo il vero operante, colui che veramente dona i
sacramenti, che in definitiva guida la sua Chlesa, anche per mezzo di insufficienti testimoni.
Concludo con parole di Ratzinger: Così, nella esigenza inaudita della nostra vocazione, che è
da Dio, esigenza che non deve però essere diminuita dalla consapevolezza della vicarietà, c’è una
santa tranquillità, che ci permette di svolgere il nostro servizio in una gioia serena e senza
angosce. Proprio quando noi iniziamo a tormentarci ansiosamente per il peso della responsabilità,
dobbiamo imparare a prenderci un po’ meno sul serio, e renderci conto che alla fine non siamo noi
che operiamo la salvezza del mondo, ma Cristo, il quale vuole che noi camminiamo per la nostra
strada - al seguito di Lui - senza angosce e nella gioia. Egli vuole che noi, senza voltarci indietro e
senza calcolo, mettiamo a disposizione la nostra debolezza, e ciò che è nelle nostre possibilità,
consapevoli d’altronde della nostra e altrui insufficienza. Dobbiamo affidarci a Lui, il vero sommo
Sacerdote operante, il quale solo, può donare a noi di compiere un retto servizio sacerdotale».
Queste sono cose di sempre nel nostro essere sacerdoti.
II
Nella conversazione precedente abbiamo raccolto qualche riflessione sul nostro sacerdozio
nell’ascolto della Parola di Dio, con lo scopo che la riflessione diventi preghiera personale di
ciascuno, e collaborazione comunitaria di tutti per una proficua e positiva soluzione della crisi del
sacerdote oggi.
Possiamo continuare le nostre riflessioni, riferendoci oggi al Decreto conciliare Presbiterorum
Ordinis. Questo decreto sul ministero sacerdotale, costituisce un enorme balzo in avanti. Prima del
Concilio, solo timidamente esegeti e biblisti osavano dire che il sacerdote è l’uomo della Parola di
Dio, della parola annunziata, della parola resa testimonianza e vita in mezzo al popolo cristiano.
Il Concilio nel P.O. ha detto finalmente questo, recuperando elementi di dottrina tradizionale e
patristica, messi un po’ in disparte dopo il Concilio tridentino, in forza anche della polemica
protestantica.
Tale decreto va perciò rimeditato, perchè stranamente, dopo queste solenni acquisizioni che
parevano finalmente una vetta raggiunta, dove si poteva davvero respirare a pieni polmoni, per
rivedere in tutta la sua grandezza e purezza il ministero sacerdotale, si comincia di nuovo a dubitare
su una parte e sull’altra. L’evangelizzazione pare non sia più il compito di nessuno. Stranamente si
comincia a dubitare della posizione di testimonianza del Vangelo in mezzo al popolo di Dio e di
guida attraverso la Parola di Dio, che il sacerdote stesso per primo deve ascoltare, e a cui egli stesso
deve dare il suo sì, senza mai giungere a sentirsi guida fuori del popolo di Dio, fuori della carovana,
e non invece con la carovana, in cammino con il popolo affidatogli.
Nel secondo capitolo del decreto, al quale va la nostra maggiore attenzione, l’accento
principale cade sui numeri 4, 5, 6, nei quali si dà la vera definizione del ministero presbiterale. Il
testo segue lo schema tradizionale delle funzioni di Cristo: profetica, sacerdotale e pastorale, ma
con il fine di mettere in luce, pur nello schema tradizionale, gli elementi nuovi. E’ già importante
che venga usato uno schema cristologico, per rendere comprensibile il senso della funzione
presbiterale. Del resto, lo svolgimento del tema nei numeri che consideriamo, attenua molto la
rigidità dello schema, e l’unità del ministero sacerdotale, del quale ogni volta si tratta, è messa tanto
in rilievo che, al confronto, la classica triade degli uffici perde di importanza. Già la descrizione
delle funzioni profetica e sacerdotale nei nn. 4 e 5 è così concatenata, che difficilmente si scopre
una distinzione della tematica.
Il testo conciliare indica subito la direzione scelta: «il popolo di Dio viene riunito innanzitutto
per mezzo della Parola del Dio vivente» (n. 4).
La Ekklesìa (chiesa = i chiamati insieme) si forma solo attraverso il «chiamare», attraverso la
chiamata del Logos, chiamata che si perpetua nella storia per mezzo di quanti Cristo sceglie e
chiama a rappresentarlo e a continuarlo in questo annuncio, in questa chiamata. Essa è la schiera di
coloro, i quali si sono riuniti attorno a questa chiamata, attorno al Logos incarnatus. Da questo
punto di vista, i concetti di «evangelizzazione» e «evangelizzare» diventano le parole-guida del
nostro testo. Possiamo affermare che l’idea della evangelizzazione è il punto, in base a cui il decreto
conciliare delinea e intende l’ufficio sacerdotale.
Questo ministero conseguentemente, non è altro che la continuazione di quel servizio di
evangelizzazione, che forma il nocciolo del messaggio di Cristo: «il regno di Dio è vicino, pentitevi
e credete alla buona Novella» (Mc. l, l5). Difficilmente si può sopravalutare l’importanza di questo
punto di partenza. Infatti, con la determinazione dell’ufficio in base al vangelo, è offerto un
concetto fondamentale della realtà cristiana: essa è fede nell’evangelo. Essa ha il suo inizio nel fatto
che è la percezione e l’accettazione di un messaggio, che ci viene dalla salvezza di Dio.
Ma se, conseguentemente, il prete è per essenza uomo del Vangelo, e la categoria principale,
in base a cui si deve intendere il suo servizio, è la missione; se egli è essenzialmente «missionario»
della lieta novella, questo incide in modo determinante sull’esistenza presbiterale e sul modello di
una formazione sacerdotale. Il sacerdote perciò deve essere un uomo che vive nella parola. che ne è
imbevuto, che ha famigliarità con essa. Egli deve trovare concretamente in questa parola, il punto
centrale della costruzione della sua esistenza; deve essere un uomo che riflette e ripensa sulla
parola. Evidentemente, non un pensatore accademico, ma un pensatore che impara a percepire la
parola sempre più come parola di Dio, in modo che essa diventa per lui effettivamente colloquio,
chiamata da parte di Dio e possibilità sua di parlare con Lui; diventa il roveto ardente, dal quale
risuona la voce che impegna anche lui e proprio lui. In tale incontro con la parola, dovrebbe nutrirsi
profondamente la sua preghiera. Questa non deve esistere in qualche modo accanto alle sue
«preoccupazioni di ufficio», come uno speciale luogo separato, il che può essere un peso. Un simile
«esser dentro» nella parola, rappresenta già da sé una introduzione alla preghiera. Al contrario, la
preghiera non può indugiarsi in una sfera adogmatica e sentimentale. L’udir la parola e il dialogare
con la parola – con colui che è la parola, Gesù il Cristo – sono due momenti, che si devono
compenetrare vicendevolmente. Solo così il presbitero può sentirsi chiamato a quel compito
fondamentale che il n. 5 gli impone: iniziare i fedeli alla preghiera – eos (fideles) ad spiritum
orationis semper perfectrorem adducunt.
Vorrei ora richiamare l’attenzione su due espressioni del testo conciliare, che sono usate l’una
accanto all’altra. Anzitutto si osserva che, nelle molteplici forme di annunzio, il presbitero ha
sempre il compito «di insegnare non una sua propria sapienza, ma la parola di Dio». Così ci
imbattiamo nel disinteresse, nel senso di «noncuranza del proprio tornaconto», che si addice al
«Vicario», all’ambasciatore. Si tratta di una continua eliminazione dell’io dalla nostra parola,
eliminazione che non è solo sforzo generico in vista della predica; ma chiama in causa tutto l’uomo
e, purificandolo, lo libera fino a farlo giungere a un vero disinteresse. Ciò dimostra come interiorità
e servizio si compenetrano a vicenda. Infatti, il «farsi prendere a servizio» per la predicazione,
significa che noi dobbiamo imparare a distaccarci da noi stessi e trovare quella libertà dall’io, che è
postulata dalla predicazione della parola di un altro. Di questa libertà, fa parte il coraggio di
annunziare anche quello che è giudizio per noi stessi.
Naturalmente è giusta l’esigenza che il predicatore debba regolarsi secondo quello che dice, e
con tutte le forze tenti di adempierlo. Ma sarebbe falso, se si volesse dedurre che uno può
annunciare solo ciò che fa. Ciò significherebbe una continua decurtazione del messaggio e una sua
contraffazione, poiché noi rimaniamo infinitamente lontani dalla parola. Noi dobbiamo comunicare tutto il messaggio, anche là dove si rivolta contro di noi, dove la spada della parola di Dio si
rivela con il suo doppio taglio. Disinteresse della predicazione, significa che noi facciamo la predica
anche a noi stessi, e ci facciamo colpire da essa. Inoltre esso esige da noi che, contro la tendenza
dello spirito del tempo, come pure contro un tradizionalismo pago di sé, osiamo pronunciare la
parola che spinge all’atteggiamento cristiano del non-conformismo di fronte a questo mondo.
Il «non sapientiam suam» del nostro testo può richiamare ad un’ulteriore problematica:
l’obbedienza ecclesiale e l’obbedienza della Chiesa. Per un verso, si richiama il presbitero a non
essere presentatore di una sua propria tendenza, di una sua esegesi o pietà privata, ma servitore della
parola di Dio nella Chiesa; e così di fronte ad essa, egli prima di tutto ha il compito di osservare il
disinteresse del messaggero. D’altra parte questo impegno al disinteresse vale nella Chiesa per tutti
i messaggeri o annunziatori della Parola di Dio.
La seconda considerazione, sulla quale vorrei richiamare l’attenzione, è questa: «non si può
esporre la Parola di Dio in termini generali e astratti, ma si deve applicare la perenne verità del
vangelo alle concrete circostanze della vita». La proposizione espone, con una perifrasi, il contenuto
della parola «aggiornamento», e propone il problema: come noi uomini di oggi, possiamo divenire
«contemporanei» di Gesù Cristo e del messaggio che egli annunciò al suo tempo? Poiché i termini
del problema sono questi: solo se riusciamo a divenire contemporanei alla parola, possiamo far
divenire la parola contemporanea al nostro tempo. Si affaccia l’enorme esigenza, che si cela sotto la
parola aggiornamento. Il compito cioè di rendere contemporanea al nostro tempo la parola di Dio e
di aggiornarla, può essere assolto solo, se noi predicatori siamo diventati contemporanei a questa
parola. Infatti, il luogo nel quale avviene la trasformazione dell’allora nell’oggi, può essere solo
l’esistenza del predicatore. Egli dischiude il suo «oggi» alla parola dell’allora, e la scopre nella
«presenzialità», in quanto essa si realizza in lui oggi. Così, dal nostro testo deriva l’esigenza che
l’uomo, il quale vuole annunciare la parola, deve prima averla assimilata nel suo presente; solo così
essa può divenire assimilabile per gli altri. Si richiede quindi un duplice movimento: noi dobbiamo
farci trasferire nella parola, per poterla portare in noi. Solo nell’uomo, la parola può divenire
contemporanea, e con ciò mettere in crisi l’oggi.
Da ultimo, in ordine ai numeri 4 e 5 del decreto P.O., osservo che il testo conciliare descrive le
diverse forme dell’annuncio della parola, e l’amministrazione dei sacramenti come modi con cui si
porta a termine il compito dell’evangelizzazione, e ciò in vista di uno sbocco nella celebrazione
eucaristica; essa è l’annuncio ufficiale del mistero pasquale della morte e risurrezione, per mezzo di
cui la ,Chiesa, introdotta nella «presenza» di quel mistero, viene resa effettivamente
«contemporanea» ad esso, oltrepassando ogni nostra possibilità. Secondo il decreto, la celebrazione
eucaristica è, perciò, il centro del ministero presbiterale, poiché essa è il centro
dell’evangelizzazione, il reale compimento del vangelo-annunzio della salvezza. La trasformazione
pasquale delle cose e dell’uomo attraverso la parola crocefissa e risorta, trova qui il centro; partendo
dalla presenza reale del Signore nelle specie eucaristiche, deve essere attuata la presenza reale negli
uomini; essi stessi devono essere «corpo di Cristo», segno di glorificazione e offerta sacrificale.
Così l’Eucarestia è designata come «culmen et fons» di tutta l’attività di evangelizzazione» (n.
5 P. O.). Da questo centrale annunzio, quale si realizza nella preghiera eucaristica, ogni altro
annuncio riceve consistenza.
Dopo queste note sui nn. 4,5 (Ministero profetico e sacerdotale), viene da considerare il n. 6
che tratta del ministero pastorale. Anche qui è determinante il rapporto al servizio del Vangelo. Nel
diritto canonico e nella dogmatica, si discute se il ministero della parola sia da rapportare all’ufficio
pastorale, (di governo) o a quello sacerdotale (di santificazione). Il ministero della Parola alle volte
appare in qualche modo superfluo, e di difficile sistemazione nell’insieme. Dal testo del Concilio si
dovrebbe trarre la conclusione che spetta alla parola, intesa nella sua profondità, coordinare e
sostenere il tutto. Essa fa scaturire da sé gli altri due elementi, – il governo e la santificazione –
come due manifestazioni della sua pienezza; allo stesso tempo essa li assume continuamente in sé.
Ciò ha moltissime conseguenze; più di quante uno a prima vista potrebbe pensare.
Infatti, all’idea del ministero pastorale, nella tradizione ecclesiale, è rapportato il concetto
della potestas, della «pienezza», del potere di giurisdizione. Dal nuovo contesto, viene da sé che
questo concetto si apre alla fraternità – carità – umanità, e con ciò appare di nuovo nel suo
contesto cristiano. Nel n. 6 si legge: «presbiteri, nomine Episcopi, familiam Dei, ut fraternitatem in
unum animatam, collìgunt; presbiteri cum omnibus, eximia humanitate ad exemplar Domini
conversari debent». Nel secondo capoverso si parla della nova lex charitatis, come fondamento
riassuntivo della reciprocità cristiana.
Si giunge così nuovamente alla figura del pastore, presentata dai Padri. Il vero pastore degli
uomini è il Logos, che prende su di sé nell’incarnazione la pecora smarrita, l’umanità, e ne diventa
effettivamente pastore.
Vorrei richiamare l’attenzione ancora su due frasi. La prima dice: «di ben poca utilità
sarebbero le cerimonie più belle, se non sono volte ad educare gli uomini» (n. 6 comma 2). Qui
viene respinto ogni culto, bastante a se stesso, ogni formalismo liturgico; il fine a cui si tende è
l’uomo. Più importante la seconda frase: «ma ai presbiteri, anche se tenuti a servire tutti, sono
affidati in modo speciale i poveri e i più deboli, ai quali lo Signore volle dimostrarsi particolarmente
unito, e la cui evangelizzazione è mostrata come segno dell’opera messianica» (n. 6 comma 2). Il
concetto fondamentale del Vangelo è volto ai poveri. Se si pensa infatti alla predica di Gesù a
Nazareth, e alle profezie cui si richiama, diventa chiaro che l’Evangelo è messaggio di gioia per i
derelitti e i poveri.
Ciò si riallaccia alla figura del pastore, che cerca colui che è perduto, e porta il messaggio di
gioia al dimenticato. In base a ciò, il presbitero è da definirsi come l’uomo che è posto per coloro
per i quali, altrimenti, non ci sarebbe nessuno. Esistono molteplici forme di povertà; anche la
povertà di parola, la povertà di vangelo è povertà che reclama l’evangelizzatore. L’idea missionaria
in senso stretto, è contenuta a giusto titolo nel nostro testo.
Se noi siamo onesti, dobbiamo dire che la routine dell’ordinaria amministrazione ecclesiale,
spesso soffoca questa esigenza originaria ,dell’evangelizzazione; siamo così presi da questa routine
amministrativa, che non ci sembra più possibile uscirne. Ciò forse non si può cambiare del tutto.
Ma, partendo dal significato essenziale del ministero presbiterale, si dovrebbe tentare con ogni
mezzo di porre in secondo piano questa routine, rispetto a ciò cui spetta il primo posto: cioè servire
a tutti la Parola, che ha il suo culmine e la sua fonte nella Parola o preghiera Eucaristica.
III
Nel capitolo 3° del P. O. il problema della vita del presbitero è visto, prima di tutto, come
tensione fra interiorità e servizio: un problema già incontrato. La risposta del testo potrebbe essere
formulata così: santità attraverso il servizio; servizio non accanto alla santità, bensì come forma ed
espressione della santità sacerdotale. Queste due cose, l’operare per l’uomo e l’intimità con Dio,
non stanno in concorrenza l’una accanto all’altra; ma il servire gli altri, è il modo in cui si esprime
la dedizione totale a Dio; è il «modo» di ventre «afferrato» da Lui, di essere presso di Lui.
Che in questo programma, che unifica il lavoro del prete e la sua vita interiore, non si tratti di
favorire un pragmatismo privo di interiorità e di spiritualità, risulta chiaramente dalla presentazione
del ministero o servizio fatto dal testo, già nel cap. 2°. Servizio, come abbiamo notato, è
essenzialmente evangelizzazione, trasmissione della parola, del senso che essa offre, e dell’amore
che intende. In nessun modo questa opera di servizio può essere concorrenza con la fedeltà a Dio. Io
posso evangelizzare, solo se io stesso vivo il vangelo. In altre parole: se io annuncio la buona
novella, non parlo solo agli altri, ma sempre anche a me stesso, e mi faccio colpire dal vangelo.
Ovviamente, la situazione non cambia per il fatto che la forma precipua di evangelizzazione è
la proclamazione sacramentale della morte e risurrezione del Signore. Infatti, la celebrazione dei
sacramenti non è svolgimento di azioni culturali, ma richiede l’imitari quod tractatis, l’effettivo
vivere con Dio; essa esige la nostra interiorità, e non sta accanto alla relazione con Dio, ma la forma
concretamente. La stessa cosa vale infine anche per il vasto campo del ministero pastorale. A questo
proposito, il testo afferma: «nella loro qualità di reggitori della comunità, praticano l’ascetica
propria del pastore di anime». Il che vuol dire, che l’ascesi di un pastore non sta in esercizi
spirituali di pietà che rimangono slegati «accanto» al suo compito, ma sta nell’ufficio stesso.
Mentre guida gli altri, egli stesso è guidato; poiché il dovere di formare gli altri forma lui stesso.
Se la definizione di presbitero come evangelizzatore e missionario, si richiama alla missione e
al compito stesso di Cristo, è segno di coerenza, che il testo del cap. 3 cerchi di ancorare alla
cristologia anche queste applicazioni spirituali. Il principio fondamentale di unità di una vita spesa
per il Vangelo, – così è detto –, è la sequela di Cristo, il cui cibo era il compimento della volontà di
Colui, che lo aveva inviato a realizzare la sua opera. In quanti modi il servizio al vangelo possa
impegnare l’uomo, si rivela a noi, volgendo la nostra attenzione a Gesù Cristo uomo. Per Lui il
tempo dell’annuncio della parola non durò a lungo; seguì poi il silenzio della croce. Ma anche la
croce è servizio. Nel dolore, l’uomo dà più che nella azione; non solo dona la sua forza, ma anche il
suo essere, se stesso. Ebbe origine qui, la vera e definitiva capacità di portare frutti. La croce
divenne evangelo, la croce, che è stritolamento dell’uomo. E anche il prete esperimenterà
l’evangelo come prova lacerante. Solo quando l’uomo vien fatto a pezzi giunge alla sua piena
grandezza. Il venir stritolato è terrificante; ma il dolore è anche ricco di frutti. Esso apre un varco,
che rende possibile uno sguardo nell’infinito.
Accanto al dolore e alla croce, la nostra attenzione su Gesù Cristo – uomo, può rilevare, quale
servizio al vangelo, la preghiera.
Nel sacerdote la Parola di Dio deve farsi preghiera; egli è uomo di preghiera, per iniziare i
fedeli alla preghiera.
L’interiorità e la spiritualità, l’intimità con Dio e la fedeltà della Lui, la disponibilità al Padre e
al Suo Cristo, l’accoglienza della croce: non v’è dubbio che non possono esistere nel Sacerdote, che
come dono di Dio attraverso la preghiera.
Vi è oggi una crisi della preghiera. Il mondo vive in virtù della preghiera dei cristiani. Ebbene,
che cosa ne è di questa preghiera? Nello smarrimento degli spiriti, nella febbrile ricerca di nuovi
rapporti col mondo, il contatto profondo con il Cristo diventa meno facile e intimo. E’ vero che,
intorno alle liturgie migliori della parola e dell’Eucarestia, il fervore si accresce; ma, tranne questi
momenti, la vita sembra estinguersi. Non si può vedere come non allarmante la solitudine delle
chiese, quando non vi si celebra qualche funzione, o l’abbandono dell’adorazione eucaristica.
Invano, e con troppo stridente contrasto con l’esempio del Signore e quello dei santi, si vorrebbe
considerare la vita dei contatti apostolici come un surrogato dei momenti di presenza davanti
a Dio. a porte chiuse, nel segreto del proprio cuore.
Mai come oggi la Chiesa ha avuto bisogno di preghiera, di anime oranti, di contemplativi
consacrati a questa missione, e di cristiani e sacerdoti, capaci di silenzio e di raccoglimento. La
forza della grazia che ha fatto fiorire la chiesa. richiede un contatto profondo con la grazia, e
solamente la preghiera può realizzare questo contatto. Quando nella Chiesa si abbassa il livello
della preghiera, anche la vita si affievolisce. Ebbene, questo livello oggi si è abbassato. Sarebbe
disonesto negarlo. Bisogna pertanto che ci scuotiamo; anzitutto noi sacerdoti, e, a contatto della
parola di Dio e dell’Eucarestia, ritroviamo il gusto e il significato della preghiera.
Il sacerdote, uomo di Dio, deve essere innanzitutto un «permanente in preghiera». Ciò
significa una costante e decisa disponibilità al colloquio personale con Dio, alla ricerca
approssimativa del suo volto e della sua oscura presenza. Ciò implica una famigliarità con il libro di
Dio, in ascolto religioso della Sua parola, che si fa risposta al suo appello, nella fede; che si piega in
adorazione silenziosa e in lode giubilante della sua grazia. Né questo comporterà per il sacerdote,
astrazione alienante dai bisogni dei fratelli e del mondo. Il contemplativo, osservano nel loro
messaggio i monaci contemplativi, cerca di unirsi più strettamente alla fonte divina, donde
scaturiscono le forze che spingono avanti il mondo, e di comprendere, in tale luce, i grandi disegni
dell’uomo. Il contemplativo ha l’impressione di essersi stabilito alle sorgenti stesse della Chiesa; la
sua esperienza non gli appare esoterica; ma, al contrario, tipica di ogni esperienza cristiana.
Se tante volte noi sacerdoti sacrifichiamo la preghiera personale all’azione; se anche la
riduciamo alla pura fedeltà materiale e giuridica delle pratiche obbligatorie, non è forse per
evasione e stanchezza, nel duro cammino della ricerca del Dio vivente e trascendente? Quale sarà
allora la nostra risposta agli increduli? Quale lo sguardo di fede sulle cose e sugli uomini, che
qualifica il nostro conversare a partire con loro? «Noi ci occuperemo indefessamente della
preghiera e del ministero della parola»; non va dimenticato questo preciso impegno degli apostoli.
Sottrarsi dunque all’attività anche apostolica per i momenti di pura preghiera, di
annientamento e di abbandono all’amore di Dio, è necessità vitale del nostro essere cristiani e
sacerdoti; ed è assicurarci la capacità di rimanere, anche operando, nella luce di Dio.
Non è possibile, perciò, per noi sacerdoti qualificare come una prescrizione difensiva pietistica
e superata, l’esortazione del concilio, ma dobbiamo, con fede umile e obbediente, farla programma
intenso della nostra vita: «Abbiano a cuore i presbiteri, se vogliono compiere con fedeltà il loro
ministero, il dialogo quotidiano con Cristo. Siano anche disposti a dedicare volentieri del tempo al
ritiro spirituale. In modi assai diversi – soprattutto con l’orazione mentale e con le varie forme di
preghiera che ciascuno preferisce – i presbiteri ricercano e implorano da Dio quell’autentico spirito
di adorazione, che unisce a Cristo, mediatore della nuova alleanza. Animati da questo spirito, sia
essi che i loro fedeli, potranno rivolgersi a Dio come figli adottivi, dicendo: Abbà, Padre mio» !
Ma la preghiera del sacerdote ha una sua dimensione tipicamente ecclesiale. Egli non è mai un
isolato né un solitario; la sua vita e il suo ministero sono impensabili, senza il riferimento costante e
costituzionale alla chiesa universale, alla chiesa locale, alla comunità eucaristica che egli convoca e
presiede.
La sua stessa «permanenza», in preghiera è frutto e impegno del suo essere fra gli uomini,
solidale alla loro pena e alla loro fatica, delegato davanti a Dio della loro inconsapevole supplica.
Però la preghiera del sacerdote si fa veramente ecclesiale, nel culto dello spirito, e non nel
ritualismo esteriore, attraverso la liturgia. E’ questo infatti l’esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo;
in essa, per mezzo di segni sensibili, viene significata e, in modo ad essi proprio, realizzata la
santificazione dell’uomo, e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle
sue membra, il culto pubblico integrale.
Ora il sacerdote non è il funzionario, ma il celebrante della liturgia; non può fare il regista
dell’azione liturgica; ma esserne protagonista, per rappresentare visibilmente Gesù, e garantire e
promuovere l’esercizio del Suo Sacerdozio, partecipato in diverso modo a tutto il popolo cristiano.
L’azione liturgica deve trovare il sacerdote tutto disponibile, tutto personalmente impegnato dal
profondo dell’animo, per farsi veramente voce della sposa, che parla allo Sposo, anzi voce del
Cristo, che unito al suo Corpo, si eleva al Padre.
Bisognerà che tutta la liturgia, dalla assemblea eucaristica alla celebrazione dei sacramenti,
investa la vita del prete, diriga la sua spiritualità di trascendenza e di incarnazione, qualifichi e
animi la sua preghiera, diventi il parametro della sua autenticità di uomo di Dio, e di uomo degli
uomini.
Particolare importanza nella preghiera ecclesiale del sacerdote, riveste l’Ufficio divino, il
breviario, ricevuto dalla Chiesa nel giorno del suddiaconato. Ricordiamo ancora l’entusiasmo di
quel giorno; ma forse, dopo i primi entusiasmi, dopo il primo ansioso e commosso – talvolta anche
scrupoloso – uso del breviario, cominciammo a sentire come un peso, quell’impegno quotidiano di
obbligati incontri con Dio. Il breviario ci è parso lungo; recitato senza slancio, e, se non
meccanicamente, senza una adesione amorosa, restò per noi cosa fredda, spesso distratta, priva di
riflessi sullo spirito e sulla vita; pesante! Il passo alla trascuratezza è stato breve; e il rinvio abituale,
o almeno facile, alle ultime ore della giornata, non sempre sicure, mai adatte, ci è parso giustificato
dalla impellenza dei doveri pastorali; che però lasciano posto per oziose chiacchierate, lunghe soste
davanti al video, o l’inutile inconclusivo sperpero di tempo.
Di quanta luce, di quante energie, di quanto conforto ci siamo così privati, pur avendone la
fonte a portata di mano! Perchè, cos’è il breviario? E’ un ripetuto quotidiano incontro col Signore
nel nome, per mandato e in comunione misteriosa, ma vera, con tutta la sua chiesa. E’ vera e propria
azione liturgica, nella quale Cristo associa a Sé la chiesa, Sua sposa amatissima, che prega così il
Suo Signore e rende il culto all’eterno Padre. E’ preghiera ad un tempo personale ed ecclesiale. Un
tale incontro col Signore è sempre fecondo per l’anima nostra e per le anime, delle quali portiamo la
pesante responsabilità; per la Chiesa tutta e per il mondo. Non ci sottraiamo ai nostri compiti
pastorali, nulla togliamo alle nostre sollecitudini per la parrocchia affidataci, non un briciolo di
tempo rubiamo alla cura dei piccoli, alla assistenza dei giovani, all’amministrazione parrocchiale,
quando riserviamo alle ore canoniche il breve tempo di una recitazione composta e meditata. Ma
anzi, vivifichiamo tutta la nostra attività, di spirito soprannaturale, sicché non degeneri in attivismo
umano; e tutta la riinnestiamo nel ceppo – l’unico fecondo – della vite vera ,che è Cristo.
Il breviario, preghiera della Chiesa, nutre e dilata in noi il senso della chiesa, e al nostro spirito
rende più facile l’intonarsi e l’adeguarsi alle dimensioni della Chiesa. Il breviario è educazione a
una pietà e a una ascesi veramente cattolica.
Non vi dirò di più, sacerdoti miei carissimi: vi ricorderò che «se il presbitero fa la preghiera
solo materialmente, egli non «rappresenta» la Chiesa; né pregare in nome della Chiesa serve a
garantire una preghiera che tale non è» (Marsili); e aggiungo: amate il breviario; amiamolo, oggi,
che i nostri figli, i laici migliori, ce lo invidiamo, e vi si accostano con avidità: non siamo noi a
sottovalutarlo! Diamogli lo spazio di tempo necessario per una recitazione corretta e devota;
diamogli, almeino nel limite del possibile – ma sempre, solo che sia possibile! – le ore
convenienti, evitando facili e assai discutibili criteri personali di compensazione o di dispensa;
salviamo la verità delle ore, perchè la preghiera acquisti il suo senso pieno e conservi la sua
meravigliosa efficacia. Nihil operi Dei praeponatur. Il breviario santificherà tutta la nostra
giornata: il breve incontro con Dio e con la Chiesa, ripetuto tra un contatto e l’altro con gli uomini e
con le realtà terrene, crea una atmosfera superiore, soprannaturale, nella quale la vita dello spirito e
le opere del ministero si muovono con sincerità ed efficacia. Oggi dunque, più che mai tentati come
siamo, di adagiarci e di perderci in una dimensione puramente orizzontale, dimenticando i ritmi e le
leggi della vera incarnazione, vescovi e sacerdoti, dobbiamo essere gli uomini della preghiera:
personale e ministeriale, ecclesiale e cosmica. Nella nostra vita orante, deve raccogliersi il gemito
della chiesa e il respiro del mondo; deve farsi storicamente attuale e presente la voce supplicante e
osannante del Cristo.
La preghiera è atto di fede e di umiltà. La crisi del sacerdote oggi è crisi di fede, di preghiera,
di umiltà. Dinanzi alla tentazione e al pericolo dell’avvilimento, del fallimento, della tristezza mi
piace invitarvi alla gioia, raccomandarvi la gioia per il grande dono del sacerdozio: è dono
dell’amore, e invita all’amore, all’amore pieno e perfetto. E l’amore è gioia e fecondità, perchè è
sacrificio. Siamo vicari dell’amore salvifico di Cristo, annunciatori della Parola di Dio, dispensatori
dei sacramenti, realizzatori instancabili di tutte le opere di misericordia corporali e spirituali. Molto
più volentieri siamo ascoltati, quando noi stessi godiamo, siamo entusiasti del nostro sacerdozio.
«In mezzo a questa generazione perversa e corrotta, risplendete come astri nel mondo, tenendo
ferma la Parola di vita: onde io abbia a gloriarmi nel giorno di Cristo, che non corsi invano, né
invano mi affaticai» (Fil. 2, l5 sg.).
Termino con le parole del Papa ai parroci e Quaresimalisti di Roma: questo ascolto sia
rinnovata obbedienza e grata fedeltà al Suo magistero, e impegno al dovere di ciascuno, di trovare
altri che subentrino nel nostro ministero sacerdotale.
Il Palpa ha detto: «Abbiamo sempre la fiducia che un prete, un vero prete, né bigotto, né
secolarizzato, ma vivente in intensità di sapienza e di sacrificio il suo sacerdozio al contatto con la
comunità, con quella giovanile specialmente, abbia la virtù, o meglio la grazia di accendere in altre
anime la fiamma che arde in lui dell’amore totale a Cristo Signore; e crediamo, che la presentazione
della vita sacerdotale, vissuta nella pienezza dell’immolazione, col sacro celibato che essa
comporta, all’unica dilezione di Gesù Maestro e Signore, di Gesù Sommo Sacerdote e unico
Agnello redentore, e insieme alla completa ed esclusiva sua sequela nel servizio pastorale del
Popolo di Dio, eserciti maggiore attrattiva ad abbracciare lo stato ecclesiastico, che non una formula
umanamente più naturale e apparentemente più facile, nella quale però dedizione a Cristo e
sacrificio di sé non abbiano più la perfetta ed esaltante coincidenza, che noi conosciamo. Tutto sta
nel capire; questo è il carisma condizionante; ma dobbiamo dubitare, che lo Spirito lo possa dare ai
figli più generosi della nostra generazione? La fortezza morale, il dono di sé, la dilezione a Cristo,
sacra e sovrumana, ma verissima, vivissima e dolcissima, staccata da ogni pur legittimo amore, la
croce insomma per la propria e per l’altrui salvezza, hanno più efficace incidenza nel cuore umano,
giovanile specialmente, che non quell’invito al sacerdozio, che fosse agevolato dalla combinazione
dell’amore naturale con quello soprannaturale. Cosicché, anche nell’assillante bisogno di vocazioni
ecclesiastiche, noi pensiamo che il celibato spiritualmente trasfigurato e trasfigurante, sia migliore
incentivo al loro reclutamento qualitativo e quantitativo, che non una flessione alla legge canonica,
che lo vuole integro e fermo, e che costruisce l’epilogo di fedeltà e di amore al Regno di Dio della
esperienza storica e dell’agone ascetico e mistico della nostra Chiesa latina.
Voi lo sapete, e con noi voi lo volete, figli e fratelli nostri. Siate benedetti ».