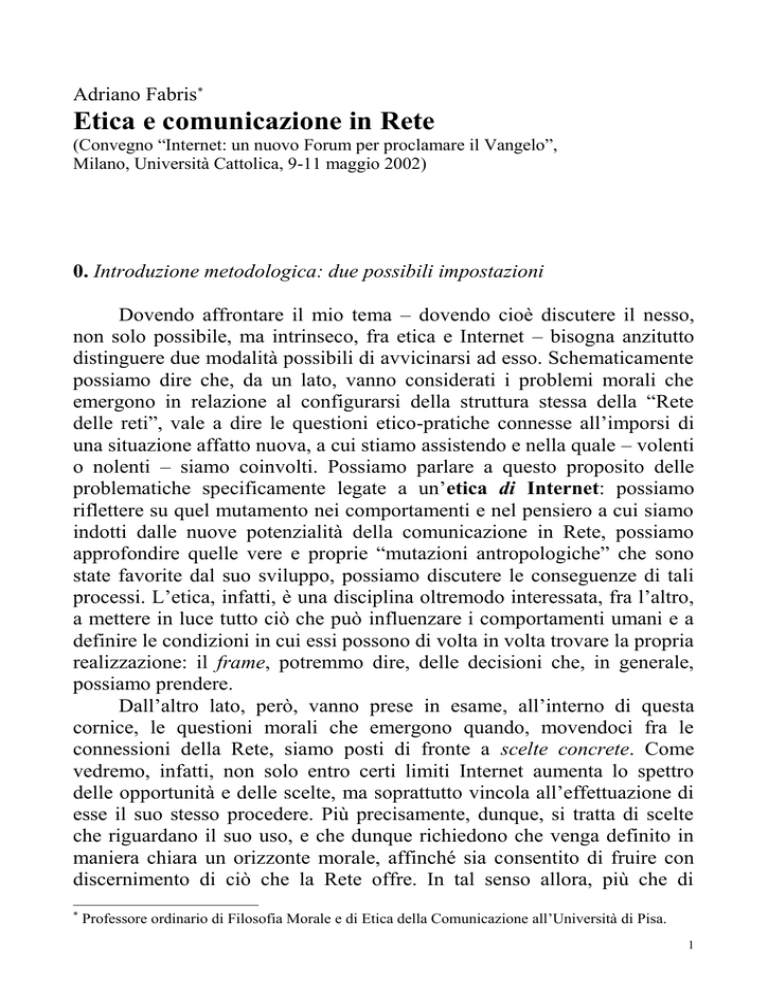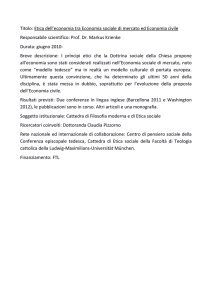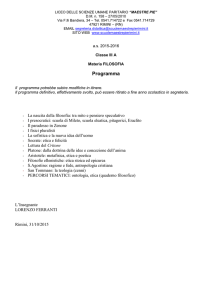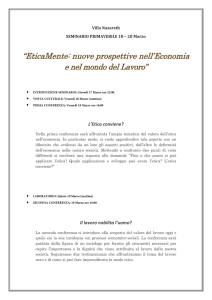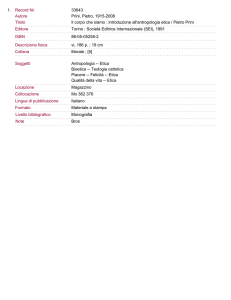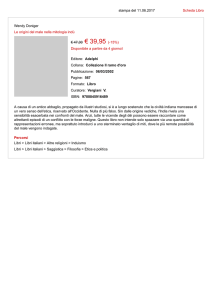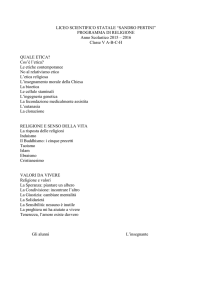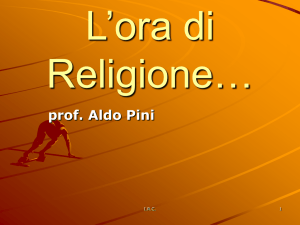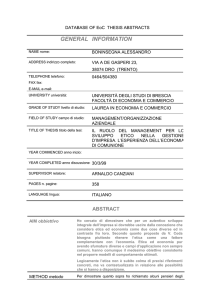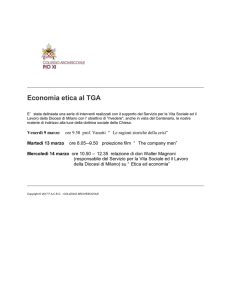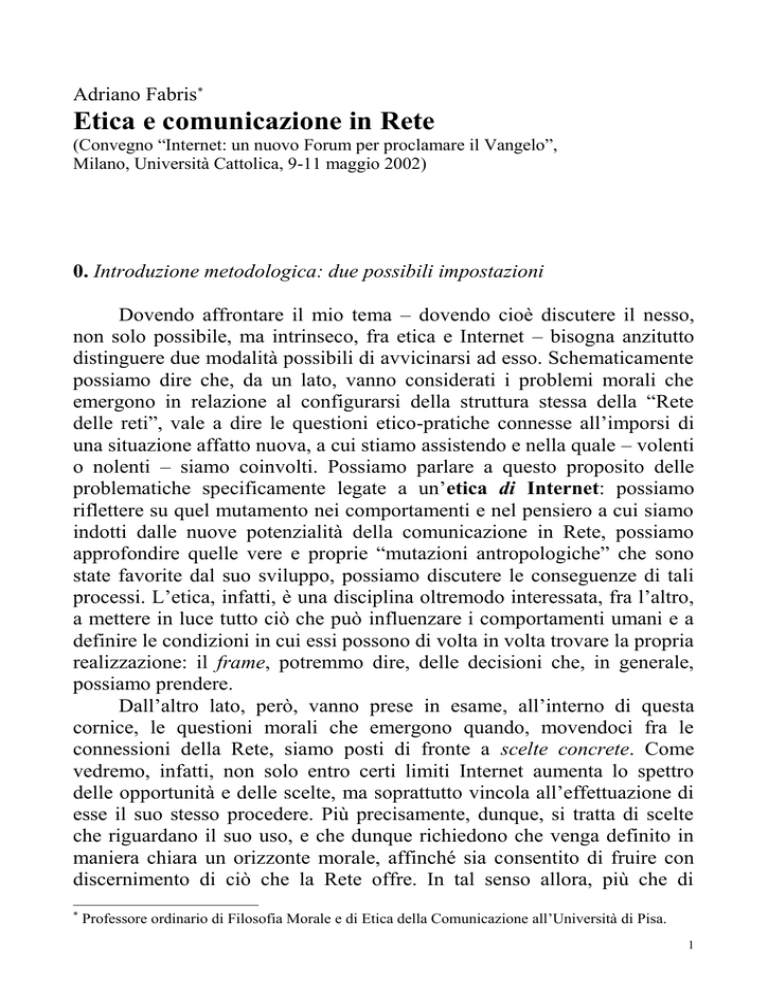
Adriano Fabris*
Etica e comunicazione in Rete
(Convegno “Internet: un nuovo Forum per proclamare il Vangelo”,
Milano, Università Cattolica, 9-11 maggio 2002)
0. Introduzione metodologica: due possibili impostazioni
Dovendo affrontare il mio tema – dovendo cioè discutere il nesso,
non solo possibile, ma intrinseco, fra etica e Internet – bisogna anzitutto
distinguere due modalità possibili di avvicinarsi ad esso. Schematicamente
possiamo dire che, da un lato, vanno considerati i problemi morali che
emergono in relazione al configurarsi della struttura stessa della “Rete
delle reti”, vale a dire le questioni etico-pratiche connesse all’imporsi di
una situazione affatto nuova, a cui stiamo assistendo e nella quale – volenti
o nolenti – siamo coinvolti. Possiamo parlare a questo proposito delle
problematiche specificamente legate a un’etica di Internet: possiamo
riflettere su quel mutamento nei comportamenti e nel pensiero a cui siamo
indotti dalle nuove potenzialità della comunicazione in Rete, possiamo
approfondire quelle vere e proprie “mutazioni antropologiche” che sono
state favorite dal suo sviluppo, possiamo discutere le conseguenze di tali
processi. L’etica, infatti, è una disciplina oltremodo interessata, fra l’altro,
a mettere in luce tutto ciò che può influenzare i comportamenti umani e a
definire le condizioni in cui essi possono di volta in volta trovare la propria
realizzazione: il frame, potremmo dire, delle decisioni che, in generale,
possiamo prendere.
Dall’altro lato, però, vanno prese in esame, all’interno di questa
cornice, le questioni morali che emergono quando, movendoci fra le
connessioni della Rete, siamo posti di fronte a scelte concrete. Come
vedremo, infatti, non solo entro certi limiti Internet aumenta lo spettro
delle opportunità e delle scelte, ma soprattutto vincola all’effettuazione di
esse il suo stesso procedere. Più precisamente, dunque, si tratta di scelte
che riguardano il suo uso, e che dunque richiedono che venga definito in
maniera chiara un orizzonte morale, affinché sia consentito di fruire con
discernimento di ciò che la Rete offre. In tal senso allora, più che di
*
Professore ordinario di Filosofia Morale e di Etica della Comunicazione all’Università di Pisa.
1
un’etica di Internet è necessario in questo caso parlare di un’etica in
Internet: della possibilità, cioè, di individuare e giustificare ciò che può
consentire un’adeguata regolamentazione della comunicazione in Rete.
Insomma: da un punto di vista morale due risultano gli aspetti da
considerare, e quindi in due parti, di ampiezza comunque diversa, si
articolerà il mio discorso:
1. Tematizzando un’etica di Internet, nel senso soggettivo del
genitivo, cercherò di precisare quale modello di comportamento la
Rete favorisce e sostiene. Si tratta di un passo necessario se si
vuole riflettere sulle possibilità e sui modi di governare i suoi
processi: giacché è appunto a partire da qui che dev’essere
giudicato il suo impatto sulla nostra vita, nell’insieme di
opportunità che la Rete ci offre e di pericoli ai quali essa ci
espone; ed è proprio questo sfondo generale, all’interno del quale
sono promossi particolari comportamenti e s’impone una specifica
mentalità, ciò che in primo luogo dev’essere sottoposto al vaglio
del principio per cui “i mezzi di comunicazione sociale sono
chiamati a servire la dignità umana aiutando le persone a vivere
bene e ad essere attive nella comunità”1.
2. Accennando poi, molto più in breve, alcuni aspetti di un’etica in
Internet cercherò non solo di formulare delle semplici prescrizioni
contingenti – ciò che in vario modo è stato già tentato, elaborando
una sorta di “galateo” dell’uso della Rete –, ma soprattutto di
collegarle a questo sfondo complessivo di comportamenti che
Internet promuove, individuando in esso alcune delle condizioni
alle quali il suo effettivo utilizzo deve comunque rispondere. Su
entrambi i versanti spero potrà venire un qualche contributo allo
specifico tema del convegno: soprattutto allo scopo di favorire un
uso eticamente consapevole della comunicazione in Rete, in vista
delle nuove forme di evangelizzazione che essa rende possibile.
1. Etica di Internet: struttura della Rete e questioni morali
Riguardo al mio primo tema, all’approfondimento cioè di quei
comportamenti che sono indotti e sollecitati dalle possibilità offerte dalla
1
Come viene detto in Etica nelle Comunicazioni Sociali, n. 2.
2
Rete, bisogna partire dalla messa in luce di alcuni elementi che sono propri
della struttura della Rete stessa, e valutarne le conseguenze sul piano degli
atteggiamenti diffusi. Non posso naturalmente esaminare che pochi aspetti,
funzionali al mio discorso e alle finalità di questo colloquio. Per gli
opportuni approfondimenti rimando a una letteratura secondaria che sta
diventando sempre più vasta e qualitativamente pregevole2.
Gli aspetti che soprattutto intendo toccare possono essere individuati
così:
1.1. La Rete cambia i modi in cui vengono compiute le scelte e sono
organizzati i processi di decisione. È qui in gioco una questione di
libertà.
1.2. La Rete muta, attraverso l’interattività, un ordine altrimenti
consolidato. È qui in gioco, soprattutto, una questione di senso.
1.3. La Rete risemantizza ulteriormente le tradizionali nozioni di
“potenza” e di “atto”, di “possibile” e di “reale”, già soggette a varie
peripezie nella storia del pensiero. Emergono le questioni connesse
all’ambito del virtuale e i problemi di un corretto modo di intendere
questa nozione.
1.4. Tutto ciò (e molto altro, certamente) viene compiuto in una
maniera quanto meno ambigua: tale cioè da poter consentire anche
comportamenti fra loro opposti. È qui in gioco la questione delle
conseguenze di tali processi.
Affrontiamo questi nodi, che – non credo sia il caso di sottolinearlo
ulteriormente – sono soprattutto nodi etici.
1.1. È indubbio, come già sottolineavo, che Internet, proprio per la
sua struttura ipertestuale, richiede che in ogni passo vengano compiute
delle scelte. Infatti un ipertesto – per usare le parole di colui che ha coniato
il termine: Theodor Nelson – è “un testo che si dirama e consente al lettore
Indico qui solo alcuni testi, fra quelli recenti nonché accessibili al pubblico italiano: F. Carlini,
Divergenze digitali. Conflitti, soggetti e tecnologie della Terza Internet, Manifestolibri, Roma 2002;
C. Catalbiano, M. Lori, G. Nuzzo, Ulisse e le sirene digitali. Internet e lo sviluppo della società
dell’informazione in Italia, Angeli, Milano 2002; P. D’Alessandro, Critica della ragione
telematica. Il pensiero in Rete e le reti del pensiero, LED, Milano 2002; P. D’Alessandro (a cura
di), Internet e la filosofia, LED, Milano 2001; P. Lévy, L’intelligenza collettiva. Per
un’antropologia del cyberspazio (1994), tr. it., Feltrinelli, Milano 1996; M. Migliozzi, G.
Ventricelli, I due volti di Internet. I limiti e le possibilità della Rete, Armando, Roma 2001; H.
Rheingold, La realtà virtuale (1991), tr. it., Baskerville, Bologna 1993.
2
3
di scegliere: qualcosa che si finisce al meglio davanti a uno schermo
interattivo” 3 . Risulta anche evidente, almeno agli occhi del semplice
fruitore, che la Rete si costituisce come un ramificarsi di possibilità, come
un ambito di potenziali connessioni a disposizione dell’utente. In effetti, è
la possibilità di connessione – la connettività, o anche, potremmo dire: la
“connettibilità” – ciò che costituisce Internet come spazio delle scelte. Ed è
a partire da qui che può realizzarsi tutto il potenziale di liberazione che la
Rete offre, consentendo a chi nella propria realtà non si può “muovere”
liberamente – in un senso metaforico o letterale – di farlo almeno in uno
spazio virtuale. Si comprende in tal modo l’intimo legame che sussiste fra
Internet e democrazia. Ma c’è di più. La struttura stessa della Rete, in
quanto essa è data dal collegamento di elementi autonomi e separati 4, è
tale da risultare aperta a sempre nuove integrazioni. Si tratta davvero di un
textum, di un “tessuto” in costante espansione, soprattutto da un punto di
vista quantitativo: potremmo dire, con un linguaggio ben noto, di una vera
e propria “opera aperta”.
Ecco dunque alcuni elementi che contraddistinguono Internet come
spazio delle decisioni: decisioni che, certamente, possono essere arbitrarie
oppure orientate in base a principî o esigenze assunti in via preliminare.
Ecco dunque delinearsi l’immagine della Rete come spazio di libertà:
quanto meno di una libertà che si esercita in modi particolari e seguendo
precise coordinate. Ebbene, non posso soffermarmi qui discutere se è
proprio vero tutto quello che Internet promette: se è vero che le scelte
compiute all’interno di una dimensione di connettibilità sono scelte in
senso proprio, oppure se esse risultano compiute, come già accennavo,
all’interno di una struttura rigida, programmata, con la quale si può
interagire solo in parte, giacché le regole del gioco risultano in qualche
modo già stabilite, anche se oggi ci vengono presentate mediante
un’interfaccia friendly che esalta l’interattività Né intendo approfondire i
caratteri di una liberazione che sembra voler acquisire realtà solo in quanto
si pone, propriamente, nello spazio del virtuale, qualificandosi perciò essa
stessa come virtuale, né insistere troppo sul carattere meramente
quantitativo del pacchetto di scelte che ci vengono proposte, sempre
Th. Nelson, Literary Machines 90.1, Muzzio, Padova 1992, p. 0/2. Continua Nelson:
“Comunemente inteso un ipertesto è una serie di brani di testo tra cui sono definiti i legami che
consentono al lettore differenti cammini”.
4
Ed anzi è nata, come sappiamo, per una preoccupazione di tipo militare: per garantire la possibilità
di dominio e di fruizione delle informazioni da parte di una stazione, qualora un’altra o le altre
fossero state impossibilitate a trasmettere.
3
4
integrabili e in espansione, ma non suscettibili di un atteggiamento
qualitativamente diverso che non sia quello, certamente radicale, di
spegnere il computer. Voglio invece domandarmi, più a fondo, qual è
l’idea di libertà che, propriamente, emerge in questi vari processi.
A ben vedere, si tratta di una libertà che è intesa soprattutto come
libertà di fruizione, sulla linea di quell’ampliamento delle possibilità e di
quel conseguente aumento di potere da cui una tale fruizione è motivata e
trova accrescimento. Tutto ciò è in linea con la trasformazione del concetto
stesso di “liberta” che lo sviluppo della tecnica rende possibile. E si
ricollega altresì alla necessità – in questo caso tipicamente consumistica –
di intendere la libertà di scelta come ampliamento dell’offerta nel quadro
di un menu ideale: un ampliamento che, come abbiamo visto, la Rete
sembra in grado di poter estendere all’infinito. Resta naturalmente da fare i
conti con questa idea, assumendone il carattere particolare e determinato, e
rendendoci conto che, anche e soprattutto, ulteriori aspetti debbono essere
considerati, i quali rinviano ad altri sensi di “libertà” e di “scelta”: in primo
luogo quelli legati all’idea di un agire non già come qualcosa che,
unicamente, risulta in costante espansione, bensì come ciò che è in grado,
liberamente appunto, di (auto)limitarsi. Ma questa altro non è che l’idea di
un agire responsabile.
1.2. D’altronde, la necessità del riferimento a una tale forma di agire
si riscontra immediatamente anche prendendo in esame il nostro secondo
punto: quello che riguarda la trasformazione, che la Rete comporta, della
nozione stessa di “ordine”. Com’è stato da più parti rilevato, già con il
medium televisivo si sono modificate le modalità dell’approccio al testo e
le caratteristiche della costruzione del testo stesso5. Tuttavia nel rapporto
con la Rete ancora più decisamente viene modificato, in virtù della
compossibilità dei percorsi che possono essere scelti, quell’ordine logico
che privilegiava la sequenzialità e al quale si collegava una particolare
concezione del tempo: quella per cui il tempo era inteso nel senso,
cronologico, della successione secondo un prima e un poi. Ora invece,
navigando nel web, al ragionamento sequenziale sembra sostituirsi il
pensiero simultaneo, alla cronologia il “tempo reale”, all’ordine
Cfr. ad esempio, oltre agli scritti di Marshall McLuhan, quelli del suo allievo D. de Kerckhove. Di
lui si veda soprattutto Brainframes. Mente, tecnologia, mercato (1991), tr. it., Baskerville, Bologna
1993. Considerazioni analoghe, da altri punti di vista, sono quelle svolte da R. Simone nel suo La
Terza Fase. Forme di sapere che stiamo perdendo, Laterza, Roma-Bari 2000 e da K.R. Popper,
Cattiva maestra televisione, a cura di G. Bosetti, nuova edizione, Marsilio, Venezia 2002.
5
5
prestabilito uno spazio d’anarchia. La Rete sembra allergica ad ogni
gerarchia, visto che tutto – siti religiosi e siti porno, chat di
approfondimento e indirizzi di promozione commerciale – appare come se
si trovasse sullo stesso piano6.
Questa, in effetti, è la “logica” dell’ipertesto: che è appunto un
collegamento di “testi” senza un ordine prestabilito che non sia quello che
si attua nella loro connessione. E tuttavia, proprio perché, di volta in volta,
si ha a che fare appunto con un textum, con un “tessuto”, l’utente ha
bisogno comunque di identificare un filo conduttore, una via in qualche
modo già tracciata, un orientamento preliminare e un senso che gli
consenta di seguirla. Ben lo sappiamo: chi non conosce l’indirizzo non va
da nessuna parte nel web; e a questo, certo, provvedono i motori di ricerca
o riviste, più o meno specializzate, in grado di suggerire percorsi agevoli e
adeguati. Ma una tale ricerca, ben lo si vede, è basata su di un’istanza, su
di un interesse ben preciso. È questo interesse, anzitutto, che ci fa da
guida, che ci consente di mettere ordine nello spazio che ci si apre in rete.
È a partire da qui che possiamo cercare un orientamento. E, soprattutto,
identificare un punto di riferimento che guidi la nostra ricerca.
Due sono allora le conseguenze che qui emergono. Da un lato,
l’atteggiamento che finiamo per assumere nelle nostre esplorazioni del
web è di considerare lo stesso ipertesto come un testo: un tessuto i cui fili
possono essere certamente diversi, ma debbono essere fatti emergere e
seguiti. Dall’altro, e soprattutto, la persuasione che si delinea con forza è
che vi è un referente che eccede la Rete, che non si risolve in essa e
rispetto a cui essa può trovare, di volta in volta, un provvisorio
ordinamento. Si tratta dell’uomo. In questo senso possiamo dire che
Internet risulta comunque una questione antropologica.
1.3. Ciò significa – e vengo al terzo aspetto che intendo brevemente
considerare – che il discorso sulle opportunità che Internet offre e sui
pericoli che sono legati al suo uso dev’essere inquadrato all’interno
dell’ambiguo rapporto dell’uomo con la tecnica: un rapporto che è
ambiguo in quanto, se è vero che la tecnica amplia e prolunga le possibilità
dell’uomo e il suo potere, fino a invadere il suo stesso spazio e a
trasformarlo radicalmente, è altresì vero che è pur sempre l’uomo che, di
Come sottolinea in un suo intervento Gianluca Nicoletti, nel caso della Rete “è un po’ difficile
stabilire il concetto del tutore, il concetto della gerarchia, il concetto del possesso, il concetto dello
spazio editoriale com’era tradizionalmente concepito in tutti i mezzi di comunicazione di massa”
(cfr. Aa.Vv., Chiesa in Rete. Internet: risorsa o pericolo?, Cittadella, Assisi 2000, p. 36.
6
6
fronte a questi eventi, può, se non proprio deve, porsi il problema del loro
senso. Aprendosi in tal modo a questioni che trascendono l’imporsi
fattuale e, appunto perciò, insensato di certi processi. Questo si riscontra
anche di fronte alla mutazione antropologica più significativa che avviene
nel cyberspazio: quella relativa alla nozione di “realtà”.
Non voglio soffermarmi, qui, sul problema della “realtà virtuale”:
un’espressione che, in senso stretto, indica quella particolare tipologia di
realtà simulata nella quale ci si può inserire interattivamente con l’aiuto di
particolari protesi ottico-tattili-auditive, in un ambiente tridimensionale
generato dal computer 7 . In effetti, se intendiamo questa espressione nel
modo che ho definito, l’andare in rete del normale utente non ha nulla a
che fare con un’esperienza di “realtà virtuale”. Il semplice navigare in rete
comporta invece l’esperienza di un altro tipo di realtà, che può integrarsi
con la vita di tutti i giorni e che può venire posta al servizio delle esigenze
che da essa promanano. Tutto ciò, in altre parole, è in grado di estendere
ulteriormente le potenzialità dell’uomo e di ampliare la sua stessa
percezione del mondo8.
È proprio a partire da tali considerazioni, allora, che possiamo
comprendere le precisazioni semantiche che Pierre Lévy introduce e
sviluppa nel suo noto libro Il virtuale 9 . “Virtuale”, qui, è qualcosa di
originariamente umano, qualcosa che rimanda alla nozione di “evento”, e
dunque alla dimensione dell’interazione uomo-macchina, piuttosto che ai
processi predeterminati che sono propri della macchina stessa e che si
svolgono nello spazio che essa circoscrive. Infatti, come Lévy afferma
molto chiaramente: “Mentre lo svolgersi puramente logico di un
programma informatico è riconducibile alla coppia possibile/reale,
l’interazione tra l’uomo e i sistemi informatici fa capo alla dialettica del
virtuale e dell’attuale”10. Il che significa, in altri termini: l’espansione dello
spazio virtuale della Rete favorisce e sviluppa potenzialità che sono
Cfr. su queste tematiche T. Maldonado, Reale e virtuale, Feltrinelli, Milano 1992.
A proposito del significato ristretto di “realtà virtuale” va tuttavia ancora segnalato, almeno, il
fatto che uno spazio virtuale così concepito denuncia tutto il suo carattere tendenzialmente
“assorbente” e “inglobante”: un aspetto che è certamente da non trascurare, nella misura in cui un
tale spazio è caratterizzato da una chiusura autoreferenziale, da una capacità di auto-organizzazione
stabilita dai rigidi vincoli del programma. È proprio questo carattere, a ben vedere, ciò che spaventa
coloro che, come ad esempio Virilio e Baudrillard, sottolineano con forza le conseguenze
“apocalittiche” connesse all’uso dei nuovi strumenti multimediali.
9
Qu’est-ce que le virtuel?, La Découverte, Paris 1995, tr. it., Cortina, Milano 1997.
10
Ivi, tr. it. cit., p. 7.
7
8
7
strutturalmente implicite nell’uomo, e che chiamano in causa ancora una
volta, da parte sua, l’esercizio della libertà.
1.4. Questo fatto non va dimenticato quando, molto giustamente, si
segnalano alcune conseguenze di segno negativo che, accanto a quelle di
carattere positivo, contraddistinguono i processi che stiamo esaminando.
Menzioniamone alcune: l’isolamento, ad esempio, a cui sembra spingere
l’uso degli strumenti multimediali; e poi la dissimulazione del proprio
carattere e della propria personalità che sono favoriti dalle interazioni
anonime e dai giochi di ruolo che si attuano nello spazio delle chat lines;
ma soprattutto, ponendoci in una prospettiva più globale, l’imporsi del
digital divide e il fatto che, in generale, Internet può farsi veicolo
incontrollato di ideologie e posizioni fra le più disparate. Tutto,
naturalmente, ciò non può che preoccupare; tutto ciò richiede di essere
governato11.
Ma l’uomo lo può fare. Se da un lato infatti, come abbiamo visto,
Internet provoca la trasformazione di concetti come quelli di “scelta”, di
“ordine”, di “virtuale” e – soprattutto – produce concretamente l’ambito in
cui tali concetti, caricati di nuovi significati, possono trovare la loro
esplicazione, dall’altro i suoi processi, lo abbiamo pure rilevato, chiamano
in causa, sempre e comunque, l’uomo stesso. A lui si richiede l’assunzione
di responsabilità del tutto nuove. Queste responsabilità, a ben vedere, sono
di due tipi: sono relative, appunto, alle conseguenze che l’uso delle Rete
comporta; riguardano, insieme, l’assunzione della Rete stessa come ambito
privilegiato di espressione e di azione. Su questi due versanti va dunque
sviluppata la possibilità di un’etica che si confronti con questi processi.
Come ho detto all’inizio: un’etica di Internet e un’etica in Internet12.
Si vedano in proposito i recenti documenti del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali
su Etica in Internet e La Chiesa e Internet.
12
Non sono molti gli studi specifici sull’argomento, almeno in ambito italiano (e non solo in esso).
Si possono menzionare comunque i volumi di D. Massaro e A. Grotti, Il filo di Sofia. Etica,
comunicazione e strategie argomentative nell’epoca di Internet, Bollati Boringhieri, Milano 2000;
V.E. Limburg, Etica dei media elettronici. I nuovi scenari della comunicazione, SEI, Torino 1997
(solo in piccola parte, comunque, utilizzabile per le nostre questioni). Ancora molto utile e
stimolante, anche se non parla propriamente di Internet, è il volume di G. Bettetini, L’occhio in
vendita. Per una logica e un’etica della comunicazione audiovisiva, Marsilio, Venezia 1985. Si
veda anche, dello stesso autore, insieme ad A. Fumagalli, Quel che resta dei media. Idee per
un’etica della comunicazione, Angeli, Milano 1998.
11
8
Possiamo dunque riepilogare in maniera più schematica ciò che è
stato detto finora. Abbiamo visto che Internet trasforma, ridefinisce e
struttura alcuni comportamenti umani. I nodi etici che sono emersi hanno
riguardato appunto gli ambiti della libertà, del senso, delle possibilità
dell’uomo e della loro realizzazione. Ecco perché Internet risulta
propriamente una questione antropologica. Non solo perché esso pone
l’uomo di fronte a determinate scelte, legate al suo uso od abuso, e apre
uno spazio ambiguo di conseguenze, delle quali è necessario tenere conto
per operare con il giusto discernimento. Ma soprattutto perché, considerata
la sua struttura e l’interagire dell’uomo con essa, la Rete dischiude già un
particolare spazio etico, prescrive già, in qualche modo, specifici
comportamenti. E dunque, da questo punto di vista, Internet è certamente
un mezzo da utilizzare, ma è anche qualcosa di più: è qualcosa che veicola
già, di per sé, e promuove certi atteggiamenti.
Il principale di essi è la connettività. L’imperativo di Internet è “stare
connessi”, e promuovere e incrementare le connessioni. Un tale implicito
comando, così formulato, naturalmente risulta equivoco: può significare la
richiesta di favorire una connessione alla Rete, senza impedimenti o
censure; può indicare l’esigenza di sperimentare ed ampliare le
connessioni nella Rete, al suo interno; può essere l’espressione di
un’istanza volta a tenere assieme, attraverso la Rete, i suoi vari utenti e
fruitori. “Stai in Rete” è dunque ciò che è richiesto perché la Rete sia:
affinché la sua virtualità sia reale per noi.
La connettività, in altre parole, realizza la Rete. Questa condizione
sembra anche essere il modo in cui viene ad esprimersi la chiusura della
Rete su di sé: quasi l’imperativo del suo autoalimentarsi, che rischia di
essere compiuto a spese dell’uomo che ad essa si collega. E, in questa
prospettiva, un tale collegarsi e incrementare i collegamenti non sarebbe
altro che una funzione della sopravvivenza e dell’espansione della Rete
stessa, alla quale il suo utente sarebbe asservito. Ma le cose, in verità, non
stanno proprio così. Lo spazio della Rete è lo spazio virtuale
dell’interazione. La connettività è essa stessa il frutto di una scelta, è essa
stessa sottoposta, costantemente, a una scelta dell’uomo: io posso sempre
non collegarmi; io posso sempre, come si diceva, spegnere il computer.
Qui emerge un ulteriore aspetto dell’etica di Internet, che si lega più
in generale alla struttura di ogni linguaggio inteso come sistema segnico.
Attraverso i segni io mi collego ad altro (alla cosa designata, all’uomo con
il quale comunico), ma nel contempo, proprio per mezzo di essi, io
9
distinguo questo “altro”, lo metto a fuoco, e mi differenzio da esso. Ecco
perché anche nella connettività, che alimenta la Rete e di cui la Rete si
alimenta, è sempre insita anche una presa di distanza: una presa di distanza
anche dallo spazio sempre incrementabile che essa disegna. Ed è grazie a
questa presa di distanza che si può evitare l’assorbimento all’interno di una
dimensione virtuale.
È perciò, è rendendomi conto di ciò, che io sono sempre in grado di
spegnere il computer. Non solo. È proprio a questo punto, quando mi
pongo consapevolmente di fronte all’ambito a cui la macchina mi fa
accedere, che scopro di aver bisogno di indicazioni chiare di
comportamento, le quali vanno ben al di là di quanto la Rete, con la sua
struttura, è in grado di suggerirmi o di impormi.
Riassumendo, insomma: un’etica di Internet può essere pensata come
apertura di uno spazio di scelte, che debbono essere compiute a partire da
valori consapevolmente assunti. Ma l’ambito in cui queste scelte possono
poi concretamente realizzarsi è dato dalla struttura stessa di Internet, dalla
sua “logica”, dai nodi etici che la Rete, dal canto suo, è in grado di
risemantizzare e di trasformare. Questo sfondo, in generale, è dato dal
principio di connettività, che la Rete impone e alimenta. Ma, come accade
ogni qual volta si fa uso di segni e di simboli, il legame che viene attuato
comporta anche un distacco, una presa di distanza. Si può dunque scegliere
riguardo allo spazio stesso delle scelte. Solo a partire da qui possiamo
scoprirci in grado di governare eticamente questi processi.
2. Etica in Internet: etica ed etichetta
Proprio in questo quadro – all’interno di ciò che ho chiamato l’“etica
di Internet” – va pensato e può trovare una sua possibile configurazione
ciò che bisogna più precisamente definire l’“etica in Internet”:
quell’insieme di comportamenti che si debbono seguire utilizzando le
possibilità del web e navigando in rete. A questo proposito sono state già
elaborate specifiche indicazioni e prescrizioni, che si fondano su motivi di
carattere giuridico, di opportunità, o anche di semplice galateo. C’è stato
addirittura chi, come Arlene Rinaldi, ha elaborato dieci comandamenti a
cui ci si deve rifare nell’uso del computer13.
Cfr. www.fau.edu/rinaldi/net/intro.html . I comandamenti sono:
1. Non userai un computer per danneggiare altre persone
13
10
A ben vedere, però, in questo come in altri casi, più che di etica si
tratta di etichetta. O più precisamente, come si dice, di netiquette. D’altra
parte, non essendo Internet gestito da un ente supervisore, unico e
riconosciuto, ogni utente è in qualche modo chiamato ad assumersi le
proprie responsabilità e a trovare in se stesso le motivazioni che
consentono di seguire un comportamento corretto. Vi sono, certamente, siti
a cui possono essere segnalati gli eventuali abusi. Ma allo stato attuale,
nella misura in cui è oltremodo difficile comminare sanzioni, siamo ancora
demandati a meccanismi di autoregolamentazione del sistema e, appunto,
al senso di responsabilità dell’utente. Ciò vale, lo ripeto, in casi e
situazioni anche sensibilmente diversi fra loro. Giacché un conto sono
violazioni perseguibili anche penalmente (si pensi agli hackers, o all’uso
di siti web da parte di pedofili, speculatori o truffatori); un conto sono le
violazioni del galateo del web ( ad esempio l’inondare la posta elettronica
altrui di una quantità di messaggi inutili: il cosiddetto spamming; oppure le
questioni che si collegano ai modi, non sempre trasparenti, di interagire
all’interno di una chat); un conto, infine, sono le questioni di carattere più
propriamente morale14.
Rispetto ad esse, quelle che appunto investono in maniera specifica
le questioni legate a un’“etica in Internet”, è necessaria non solo
un’adeguata collocazione nel contesto più generale delle problematiche
della Rete e dei nodi etici che esse coinvolgono – l’“etica di Internet” –, né
unicamente – sebbene ciò risulti fondamentale – l’indicazione di quei
valori di fondo ai quali richiamarsi nelle scelte concrete che vengono di
volta in volta compiute. Insieme a tutto ciò, e come condizione del suo
realizzarsi, va soprattutto fatta emergere e va effettivamente sperimentata
una consapevolezza, da parte dell’uomo, sia dei limiti del suo agire, sia del
carattere limitato di quegli stessi prodotti della tecnica che, pur tendendo
all’autonomia e all’autoalimentazione, ancora dipendono da lui. È in
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Non interferirai con il lavoro al computer di altre persone
Non curioserai nei file di altre persone
Non userai un computer per rubare
Non userai un computer per portare falsa testimonianza
Non userai o copierai software che non hai dovutamente pagato
Non userai le risorse di altri senza autorizzazione
Non ti approprierai del risultato del lavoro intellettuale altrui
Penserai alle conseguenze sociali dei programmi che scrivi
10. Userai il computer in modo da dimostrare considerazione e rispetto.
14
Tocca questi argomenti Barbara Fiorentini nel suo e-v@ngelo. La pastorale nell’era di Internet,
Berti, Piacenza 2001.
11
questo senso del limite – volendoci esprimere con un linguaggio cristiano:
è in questo senso di creaturalità – che risiede la radice ultima dell’essere
responsabili. E dunque di un’etica come tale. Anche di fronte a fenomeni
che, al pari di Internet, sono in grado di aprire nuove possibilità e orizzonti
inediti nel mondo in cui viviamo.
12