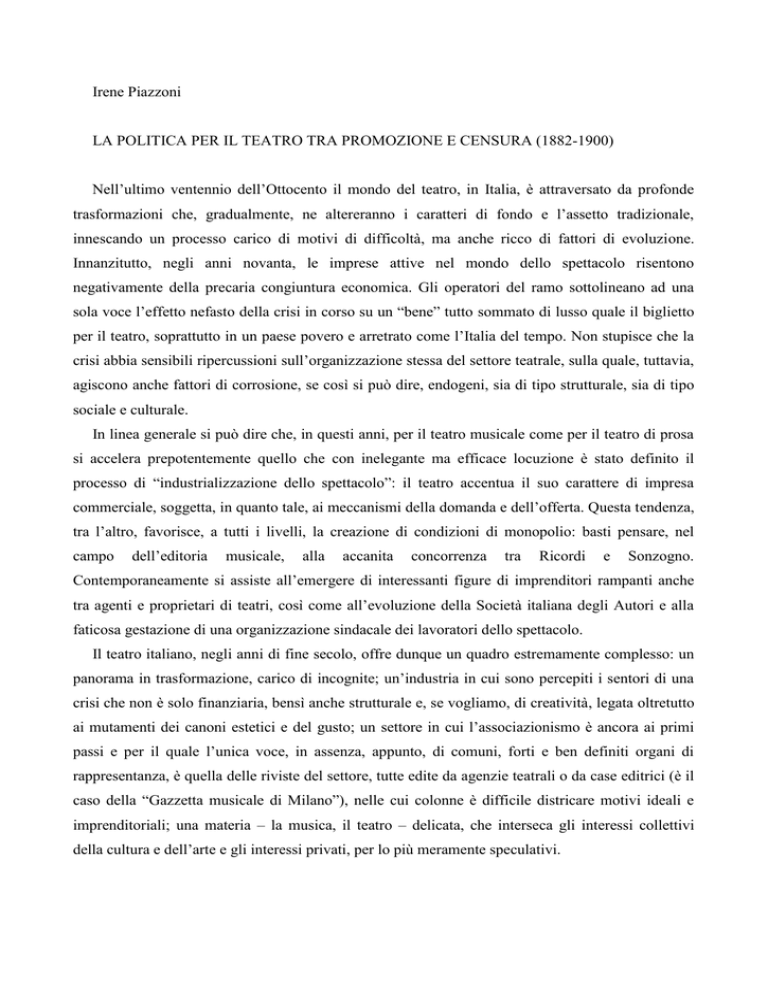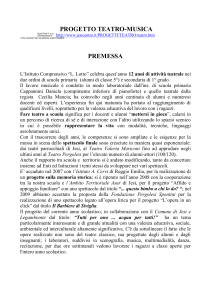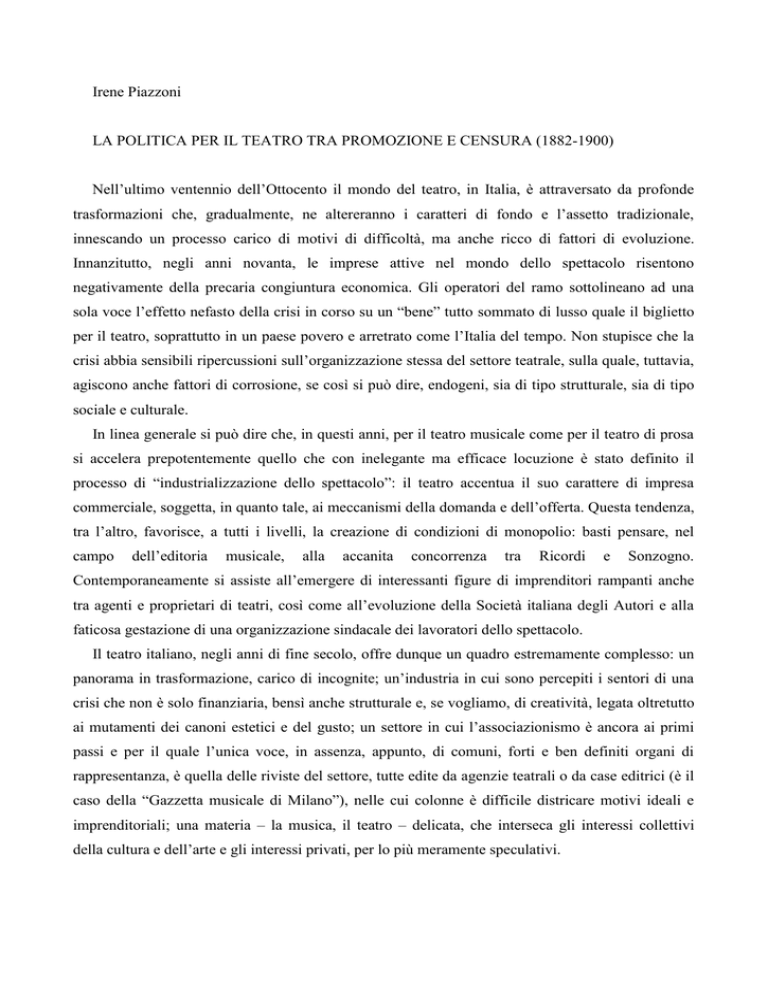
Irene Piazzoni
LA POLITICA PER IL TEATRO TRA PROMOZIONE E CENSURA (1882-1900)
Nell’ultimo ventennio dell’Ottocento il mondo del teatro, in Italia, è attraversato da profonde
trasformazioni che, gradualmente, ne altereranno i caratteri di fondo e l’assetto tradizionale,
innescando un processo carico di motivi di difficoltà, ma anche ricco di fattori di evoluzione.
Innanzitutto, negli anni novanta, le imprese attive nel mondo dello spettacolo risentono
negativamente della precaria congiuntura economica. Gli operatori del ramo sottolineano ad una
sola voce l’effetto nefasto della crisi in corso su un “bene” tutto sommato di lusso quale il biglietto
per il teatro, soprattutto in un paese povero e arretrato come l’Italia del tempo. Non stupisce che la
crisi abbia sensibili ripercussioni sull’organizzazione stessa del settore teatrale, sulla quale, tuttavia,
agiscono anche fattori di corrosione, se così si può dire, endogeni, sia di tipo strutturale, sia di tipo
sociale e culturale.
In linea generale si può dire che, in questi anni, per il teatro musicale come per il teatro di prosa
si accelera prepotentemente quello che con inelegante ma efficace locuzione è stato definito il
processo di “industrializzazione dello spettacolo”: il teatro accentua il suo carattere di impresa
commerciale, soggetta, in quanto tale, ai meccanismi della domanda e dell’offerta. Questa tendenza,
tra l’altro, favorisce, a tutti i livelli, la creazione di condizioni di monopolio: basti pensare, nel
campo
dell’editoria
musicale,
alla
accanita
concorrenza
tra
Ricordi
e
Sonzogno.
Contemporaneamente si assiste all’emergere di interessanti figure di imprenditori rampanti anche
tra agenti e proprietari di teatri, così come all’evoluzione della Società italiana degli Autori e alla
faticosa gestazione di una organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo.
Il teatro italiano, negli anni di fine secolo, offre dunque un quadro estremamente complesso: un
panorama in trasformazione, carico di incognite; un’industria in cui sono percepiti i sentori di una
crisi che non è solo finanziaria, bensì anche strutturale e, se vogliamo, di creatività, legata oltretutto
ai mutamenti dei canoni estetici e del gusto; un settore in cui l’associazionismo è ancora ai primi
passi e per il quale l’unica voce, in assenza, appunto, di comuni, forti e ben definiti organi di
rappresentanza, è quella delle riviste del settore, tutte edite da agenzie teatrali o da case editrici (è il
caso della “Gazzetta musicale di Milano”), nelle cui colonne è difficile districare motivi ideali e
imprenditoriali; una materia – la musica, il teatro – delicata, che interseca gli interessi collettivi
della cultura e dell’arte e gli interessi privati, per lo più meramente speculativi.
Ora, qual è la politica adottata dai governi di Crispi, di Giolitti, di Di Rudinì nel settore della
musica e del teatro? Qual è la risposta delle istituzioni alle insistenti richieste di intervento, alle
molteplici accuse di indifferenza?
Come è noto, l’arte musicale e drammatica dalla costituzione del Regno è di competenza del
ministero della Pubblica Istruzione, al bilancio del quale sono inscritti i fondi ad essa destinati:
fondi che ammontano a circa 480 mila lire per il 1883, mentre lo stato di previsione della spesa per
l’esercizio finanziario 1895-96 contempla, a favore del settore dello spettacolo, un budget più
elevato e più articolato – in totale 583 mila lire – ma sempre decisamente contenuto. Tali fondi sono
quasi completamente assorbiti dal mantenimento dei conservatori del Regno e, per una cifra assai
più modesta, dalla Scuola di declamazione di Firenze; qualche spicciolo è riservato a sussidi vari e
alle spese di missione per i membri della Commissione permanente per l’arte drammatica e
musicale.
Tale organismo è attivo dal 1882, istituito dall’allora ministro della Pubblica Istruzione Guido
Baccelli, con il compito di dare un parere «su tutte le questioni relative all’insegnamento musicale e
drammatico, alle riforme da apportare nell’ordinamento degli istituti, alle controversie dei concorsi,
ed intorno a quanto si riferisce all’arte stessa», come recita il decreto di istituzione. Gli uomini
chiamati a comporre la Commissione sono i più autorevoli rappresentanti del mondo della musica e
del teatro italiani del tempo.
Sempre su sollecitazione del ministero, la Commissione partorisce in quegli anni un numero
consistente di proposte, discute di teatri stabili, di un Liceo drammatico per istruire i giovani nella
lettura e nella recitazione, di statuti e regolamenti per scuole di musica e di declamazione, di
programmi e ordinamenti dei Conservatori, di studi musicali, del canto corale e del suo
insegnamento nelle scuole elementari e normali; per quanto concerne in particolare il teatro di
prosa, in concreto il suo lavoro, e in definitiva la ‘polpa’ della promozione governativa, si limiterà
alla gestione del concorso drammatico nazionale.
I fondi destinati alla musica e al teatro sono anche utilizzati per sussidiare scuole di recitazione e
società filodrammatiche, numerosissime e in crescita nella penisola in questo periodo e tutte solerti
nel bussare alle porte del governo per rimediare qualche spicciolo. I documenti dell’archivio del
ministero dimostrano che, rispetto al primo ventennio postunitario, i cordoni della borsa si sono
senza dubbio allentati, anche se i sussidi concessi sono poche briciole: 50, 100, 150, al massimo
500 lire concesse a qualche istituzione particolarmente raccomandata dai prefetti e, preferibilmente,
a scopo di istruzione. Tuttavia è agevole evincere, anche nella varietà e nella disorganicità della
documentazione conservata, che le società gratificate con i sussidi più generosi sono quelle romane,
a conferma di una attenzione maggiore riservata al patrimonio culturale della capitale. Anche
l’esigenza di una scuola di declamazione a Roma, su modello di quella, statale, che opera a Firenze
da molti anni, è sentita e manifestata reiteratamente negli ambienti artistici e nelle sfere
governative: essa, infine, sarà istituita nel luglio 1896 e annessa a Santa Cecilia. Di assai meno
agevole realizzazione sarà invece un progetto di intervento a favore del teatro musicale della
capitale. Le permanenti difficoltà finanziare del municipio e l’agguerrita opposizione alla “dote”
sorta in seno al Consiglio comunale inducono nel 1887 il sindaco Torlonia a sollecitare il concorso
pecuniario del governo a favore dell’Apollo e dell’Argentina. In questa circostanza la risposta del
ministro della Pubblica Istruzione, Michele Coppino, non può essere più chiara: nel bilancio del
ministero non è contemplato alcun capitolo da cui attingere la somma occorrente. Non solo:
«più che all’incoraggiamento dei pubblici spettacoli, è compito del Ministero della Pubblica Istruzione provvedere
ad un più largo sviluppo, di cui grande è il bisogno, della istruzione ed educazione musicale, mediante le scuole e gli
istituti che esclusivamente e più direttamente sono ordinati, al detto scopo, e i quali sono al certo, per la diffusione della
cultura e l’incremento dell’arte, i fattori più efficaci».
Insomma, compito del Ministero non è quello di «pensare agli spettacoli».
Intorno all’ambizione di investire Roma del ruolo di centro culturale di riferimento per la nazione
si inserisce anche una delle questioni più dibattute in quegli anni, quella del teatro stabile. Nella
riunione del 12 marzo 1888 la Commissione permanente per l’arte drammatica e musicale ha
all’ordine del giorno la discussione sulla istituzione di un «Teatro stabile in Roma con repertorio a
base di preponderante nazionalità»: si suggerisce «la periodica riproduzione del teatro comico e
tragico nazionale, così detto classico, come delle commedie italiane rappresentate con plauso
nell’ultimo trentennio e delle migliori novità così italiane che straniere». Dunque, come del resto
per le condizioni del concorso drammatico, i criteri di scelta nell’ambito del repertorio italiano non
fanno alcun riferimento ai soggetti, ai contenuti e agli obiettivi, bensì alla consacrazione conferita
dalla tradizione letteraria, alla qualità e al successo. Non si entra, cioè, nel merito del portato
simbolico, del messaggio, né delle scelte stilistiche e dell’indirizzo estetico delle opere teatrali da
inserire nei programmi, prediligendo una accezione, se vogliamo, “debole” di quell’aggettivo,
«nazionale», che dovrebbe caratterizzare il repertorio del teatro stabile: esso ha il compito di
divulgare, semplicemente, il migliore teatro italiano, senza peraltro escludere il migliore teatro
straniero. Anche tale progetto, tuttavia, si rivelerà di difficile attuazione.
Per quanto invece riguarda la censura, l’evento saliente è la promulgazione della nuova legge di
Pubblica Sicurezza nel marzo 1889. Il testo della legge, nella sua prima versione, prevede
l’inserimento e la esplicazione di quelle “norme speciali” non meglio identificate da quella in vigore
(emanata nel 1865) e solo stabilite nel relativo regolamento, senza però mutarle nella sostanza. Una
lunga discussione parlamentare, svoltasi alla Camera il 10 e il 12 novembre 1888, porterà ad una
modifica di tali norme, rafforzando le garanzie per gli autori e per il pubblico. Il dibattito fa
emergere due diversi punti di vista in merito al ruolo dello Stato: quello di chi sostiene l’opportunità
che lo Stato non debba farsi carico della tutela della morale, lasciando ai cittadini tale attività di
“controllo”, e quello di chi, come Crispi, crede in uno Stato «educatore», lontano però, lontanissimo
dai modelli statali che l’hanno preceduto:
«Lo Stato deve essere educatore. Non basta l’insegnamento, o signori, senza educazione. Gli esempi dei Governi
passati, che spesso si ripetono, non valgono nelle condizioni attuali del paese, e sarebbe ingiusto che si portassero
contro il Governo attuale, il quale ha origine dalla popolare elezione ed è responsabile dinanzi al Parlamento».
Per il resto non si registrano sensibili cambiamenti: i criteri da seguire per la revisione delle
opere teatrali rimarranno quelli stabiliti in una circolare del 1852 da Filippo Galvagno, ministro del
Piemonte sabaudo, ribaditi e puntualizzati in numerose circolari degli anni successivi, anche dopo la
proclamazione del Regno: sono proibite le opere, o parti delle opere, che rechino offesa al Re, al
Parlamento, ai sovrani e capi di stato esteri, che invitino al disprezzo o alla violazione delle leggi
dello Stato, che offendano i principi della moralità e del pudore, la religione cattolica e i culti
tollerati, la vita privata delle persone e i principi costitutivi della famiglia.
In conclusione, se, attraverso le carte d’archivio, si penetra all’interno delle stanze del Ministero
della Pubblica Istruzione e ci si immerge nell’opera svolta in quegli anni da uomini politici,
funzionari e membri della Commissione competente nel settore dello spettacolo, si ricava
l’impressione di una costante ma rabdomantica ricerca di soluzioni e modelli, di progetti,
esperimenti, piste iniziate e non più percorse: insomma di un lavoro alacre, anche se dispersivo e, a
conti fatti, poco efficace. Se invece non si oltrepassa questa soglia, se ci si attiene ai risultati
ottenuti, ai progetti portati a termine, alle riforme intraprese, l’impressione è addirittura quella di
una certa noncuranza e, sul piano delle realizzazioni, di una politica inadempiente.
Al sostanziale immobilismo dei governi italiani nel settore della musica e del teatro negli ultimi
vent’anni del secolo concorrono molteplici fattori. A prescindere dalla esiguità dei fondi a
disposizione, a cui le difficoltà finanziarie degli anni novanta certo non consentono di porre
rimedio, va messo in conto anche il desiderio, allora diffusamente avvertito dalla classe dirigente
liberale, di smarcarsi da uno stile di governo di stampo assolutista, oltre a un certo scetticismo nei
confronti della valenza educativa del teatro. Non a caso nei discorsi parlamentari, negli interventi
politici, ma anche nelle pagine della pubblicistica specializzata, il motivo della funzione educativa
del teatro suona come un vuoto refrain, da accennare en passant, non supportato da alcuna
impalcatura teorica, e nemmeno da una pallida idea delle sue concrete possibilità di esplicazione.
Sono sotto gli occhi di tutti, semmai, le preferenze del pubblico italiano, soprattutto di quello
popolare, che cerca negli spettacoli un’occasione di divertimento: come indurlo a ripiegare
volontariamente su altri generi di spettacolo, quelli educativi appunto? E con quali criteri
individuarli, senza scivolare in diktat estranei ad una concezione squisitamente liberale dello Stato,
senza suscitare un vespaio di polemiche sulle scelte attuate e senza cozzare contro gli ideali di cui
sono depositarie altre componenti della società italiana, ad esempio i cattolici? Un uso del teatro in
chiave educativa è possibile esclusivamente all’interno delle istituzioni statali deputate
all’istruzione, vale a dire, in primis, nella scuola. In effetti proprio nei primi decenni postunitari
fiorisce l’editoria teatrale destinata all’infanzia, pressoché totalmente votata alla trasmissione di
valori edificanti volti a formare il buon cittadino: la patria, la famiglia e le regole del vivere civile.
D’altra parte il recitare stesso è considerata una pratica educativa, anche per gli adulti: i prefetti
raccomandano caldamente il sostegno alle filodrammatiche, viste con simpatia perché
contribuiscono, a loro avviso, a tenere lontano il popolo dalle lusinghe del vizio e del gioco. In
questo caso è la pratica del teatro in sé che è vista come un valore positivo: in questa ottica, infatti,
nessuno sente l’esigenza di preoccuparsi di giudicare il grado di valenza morale delle opere
rappresentate.
Un discorso analogo può essere svolto a proposito dell’uso del teatro in funzione della
costruzione dell’identità nazionale: le statistiche del tempo mostrano in modo eclatante che la
commedia d’oltralpe e la musica straniera sono particolarmente apprezzate dagli italiani che
frequentano i teatri: la difesa del repertorio nazionale, solo all’interno del quale possono essere
trasmessi i valori patri, è dunque un’ardua impresa, oltretutto in contrasto con i princìpi che
regolano, in un regime liberale, il mondo della cultura e dell’arte, princìpi improntati all’apertura,
allo scambio, alle contaminazioni.
Non a caso gli uomini politici del tempo si trovano a proprio agio quando l’incoraggiamento
all’arte teatrale e musicale si traduce in un intervento sul piano dell’istruzione e della formazione,
nella convinzione che il compito precipuo di uno stato liberale sia quello di innalzare il livello di
cultura generale. Pensiamo alle parole di un Ferdinando Martini, ex commediografo e appassionato
cultore dell’arte drammatica – e in quanto tale particolarmente sensibile alle questioni ad essa
inerenti – rivolte a Cavallotti in merito al progetto di un Liceo drammatico a Roma:
«Credo anch’io che, pur tenendo presenti le difficoltà finanziarie del momento, qualcosa si possa e si debba fare,
specie nel senso di promuovere con l’insegnamento quella cultura intellettuale onde si giova assai l’arte in genere, e
l’arte drammatica in particolare».
Sulla scarsa incisività della politica governativa a favore del teatro pesano, inoltre, l’incertezza
sui mezzi e i modi per attuare una promozione efficace e la mancanza di interlocutori organizzati e
concordi all’interno del mondo teatrale. Nel maggio del 1890 si apre a Roma, nei locali del Teatro
Nazionale, il quarto congresso drammatico, inaugurato dall’allora ministro della Pubblica Istruzione
Paolo Boselli. Nel suo discorso il ministro ammette la necessità che il governo eserciti una
«provvida tutela» «sopra tutte le manifestazioni dell’ingegno, sopra tutte le espressioni dell’arte»,
ma sottolinea la difficoltà di recepire indicazioni chiare e univoche dal mondo dello spettacolo:
«Se tutti in fatti gli amatori e cultori dell’arte drammatica sono stati o sono concordi nell’ammettere l’opportunità di
provvedimenti governativi, le forme indicate per questi provvedimenti sono state tante quanti sono stati i proponenti;
tante, cioè, può dirsi, quanti sono gli autori e gli attori, senza pregiudizio dei critici di professione e dei critici
d’occasione. I progetti pubblicati in proposito formano una biblioteca e dimostrano una fantasia che applicata alla
produzione teatrale avrebbe dato al repertorio quella varietà che, a quanto leggo e odo spesso, ancora gli manca».
Ora, secondo il ministro, quella che «ha potuto sembrare indifferenza governativa» è in parte
giustificata da tale «discordanza di pareri», o, meglio, non è che la «naturale conseguenza» delle
divisioni, della incertezza, della pluralità di posizioni e opinioni, rispetto alle soluzioni da prendersi,
che smussano le armi di quanti operano nel settore teatrale, stemperandone il potere rivendicativo.
Inoltre, prosegue il ministro, la pubblica autorità,
«ove pure fosse competente nelle questioni tecniche dell’arte, non potrebbe per certo presumere di risolverle
coll’illuminato e fecondo assolutismo di un tempo oggi che in tempi siamo di parlamentarismo universale e di
democrazia dominante».
Le forme dei provvedimenti governativi in favore dell’arte, insomma, «non possono essere
suggerite da una ispirazione individuale, sia pure provvidamente efficace, ma devono essere il
risultato di un accordo collettivo».
È superfluo osservare che le discussioni tenutesi durante il congresso e i voti espressi in ben
quattordici ordini del giorno saranno dimenticati immediatamente. L’imperversare della crisi non
favorisce la formulazione di progetti comuni e il coordinamento, semmai accentua le divisioni.
Tutti contro tutti: editori contro impresari e direzioni teatrali, artisti contro impresari, Società degli
autori contro singoli detentori di patrimoni di commedie, commediografi contro impresari, agenti
teatrali contro capocomici e contro commediografi e via discorrendo. Tutti a invocare i
finanziamenti statali, a protestare contro le tasse, a difendere la libertà artistica e quella delle
imprese; ognuno, d’altra parte, pronto a sbandierare le ragioni dell’arte, la tutela della cultura, gli
ideali, beninteso sempre pro domo sua.
Con ciò si vuole dire che se la civiltà musicale italiana si sta eclissando, se il teatro drammatico
non riesce a diventare veicolo di identità nazionale o di educazione popolare né di fatto è mai
seriamente investito di tale ruolo, le responsabilità non vanno attribuite esclusivamente alle
inadempienze del governo e del parlamento, ma individuate anche nel tessuto stesso della società in
tutti i suoi segmenti. Nel gennaio del 1898 compare sulla “Rivista politica e letteraria” un articolo a
firma L’Italico e intitolato Senza pilota. Sotto lo pseudonimo si cela Primo Levi, direttore del
mensile romano, «forte» giornalista (come lo definirà Teodoro Rovito) e scrittore d’arte, già
direttore della Riforma ai tempi di Crispi, tra il 1878 e il 1893, a lungo redattore della “Tribuna” e
grande appassionato di musica. Nel suo articolo, dedicato al teatro italiano, in particolare a quello
operistico, Levi scrive che se un tempo «l’aspirazione popolare, la volontà nazionale, parlò…
cantando», se il melodramma «ebbe parte ingentissima in quel lavoro di propaganda italofila da cui
uscì un ambiente europeo così favorevole alle nostre rivendicazioni nazionali e politiche», ora
quella gloria si è appannata e la musica teatrale non è più «una cosa sola con la psiche nazionale»,
un elemento della vita pubblica. Levi ha di che lamentarsi: tristi tempi corrono per i teatri lirici della
penisola, molti annaspano, il San Carlo è aperto, ma è forse «peggio che se fosse chiuso», mentre la
Scala è chiusa davvero, «ad obbrobrio dei milanesi, e fra la loro indifferenza». Alle radici di questa
decadenza, in effetti, vi è un «disamoramento generale» – così lo definisce Levi – per il teatro
d’opera. E non è estraneo a tale disamoramento la nuova filosofia «che informa oggi i criteri
artistici fondamentali». Come spiega l’autore dell’articolo:
«In ragione della sua spontaneità, inevitabilmente minore, l’arte s’è fatta oggi più scrupolosa; in ragione della sua
minore forza creatrice, essa ha duopo [sic] oggi di maggior corredo di dottrina».
Il melodramma, in altri termini, va perdendo i suoi connotati di genere popolare e, in qualche modo,
di consumo, di un tempo; d’altra parte si recupera lo studio della musica sinfonica, anche se solo da
parte di una élite. Ma è un risultato, questo, maturato grazie alla iniziativa, privata, di pochi
encomiabili singoli, mentre le autorità governative latitano. Accusa Levi:
«Non è, dunque, soltanto in fatto di politica coloniale, come s’è detto e letto in questi giorni, che l’Italia si è
mostrata, si mostra, posseduta da mania suicida».
Una «mania suicida» che non è «soltanto nell’ente governo, ma in qualunque altra entità
costituita»: in primo luogo nelle amministrazioni municipali, responsabili delle difficoltà dei teatri
lirici. Non solo dunque, «la vita nazionale è senza pilota», ma anche quella che ora definiremmo la
società civile ha le proprie responsabilità:
«Con una aristocrazia, che non ha tradizioni politiche, o ne ha tali, in gran parte, da dover essere rinnegate; con una
grassa borghesia, che la emula nei vizi permanenti, non nelle antiche virtù; con una borghesia magra, il cui primo
pensiero deve necessariamente essere quello di ingrassare; ed un popolo i cui felici istinti vengono traviati alla esclusiva
preoccupazione di bisogni materiali, a cui non si dà, d’altronde, sufficiente ragione, chi siede al timone è necessario in
Italia più che ovunque altrove».
La sensibilità del crispino Levi nei confronti della valenza “nazionale” della musica, in questi
anni di fine secolo, non è così diffusa. Sulle prime ci si può lasciare ingannare dalle tante parole
spese a favore della difesa dell’arte. In realtà impera la concezione del teatro e della musica come
impresa. Basta leggere la lucida, benché incompleta, analisi sulle ragioni della «crisi teatrale»
condotta in un corposo articolo comparso sulla “Rivista musicale italiana” nel 1899 da Giovanni
Ferrero per avere la misura di quanto il teatro lirico italiano sia dominato dalle leggi del profitto.
«Merce»,
«mercato»,
«leggi
essenziali
del
commercio»,
«richieste
del
compratore»,
«liquidazione»…: si stenta a credere, a scorrere le righe del saggio di Ferrero, di trovarsi
nell’empireo della musica. Ci imbattiamo in platee gremite di “portoghesi”, in amministratori che
concedono la “dote” per abitudine e per assicurare qualche profitto a «quattro bottegai», in
speculatori ingordi, in impresari ed editori che, per avidità, iniziano a «far sgusciare fra le merci
offerte al pubblico qualcuna di poco prezzo», i primi «infeudando» i maggiori teatri e sfruttandoli
d’accordo con i secondi, a spese delle finanze comunali e grazie agli alti prezzi imposti agli
spettatori. E, poi, quali spettatori? Eccolo il pubblico italiano, secondo Ferrero:
«da noi si va a teatro per molte ragioni: l’ultima è quella di penetrare il significato d’un’opera d’arte, la penultima
d’udir gorgheggiare una bella voce di soprano, e – sopprimendo le ragioni intermedie – la prima è quella di “ammazzar
la sera”, lavorar di binocolo, far visita, ecc…».
L’amara conclusione: nei teatri italiani «l’arte non entra che pel buco della serratura».
In questo stato in cose, non è solo il ministero della Pubblica Istruzione, con i suoi magri bilanci,
a farsi i conti in tasca. Le ragioni dell’economia e quelle del profitto sono sulla bocca di tutti. I
detrattori della dote lesinano sui sussidi ai teatri, mentre i sostenitori ricorrono continuamente alle
cifre e ai giri di cassa, sottolineando l’utile economico che deriva dalla “industria”, come la
chiamano, teatrale, e i suoi riflessi sull’occupazione e sul commercio.
Il pubblico è ormai dipinto con i tratti di un despota che chiede distrazione, divertimento,
emozioni; è un pubblico che si reca a teatro non solo per abitudine e decoro, un pubblico che
sceglie, e quindi va conquistato. I riferimenti in merito non si contano sulle colonne dei giornali
specializzati. Scrive Giovanni Trisolini a proposito della concorrenza tra Ricordi e Sonzogno:
«Il publico [sic], il vero publico, cioè quello che paga, si preoccupa ben poco che gli spartiti siano dell’uno piuttosto
che dell’altro editore, purché abbia la varietà degli spettacoli e la bontà dell’esecuzione».
Un altro critico parla di pubblico
«o povero o taccagno o pieno di esigenze, perché per cinque lire vorrebbe godere ogni sera una prima dell’Otello o
del Falstaff, comodamente seduto in poltrona, con la carrozza pronta sotto l’atrio, la cena al Gambrinus…, e dopo la
cena qualche altro svago, che non specifico per non offendere i buoni costumi».
Insomma, per dirla con Angelo Carrera, il teatro italiano, negli anni di fine secolo, «attraversa
una crisi di evoluzione»:
«Quando l’avrà attraversata tutta, ne uscirà, io spero, rinvigorit[o] per lungo tempo. Se poi intanto avremo il trionfo
del socialismo, allora l’arte andrà per conto dello Stato – come nel Duemila del Bellamy – e allora…».
Dietro l’angolo, in verità, non vi è il socialismo, né, per il momento, l’arte di Stato. Dietro
l’angolo vi è, semmai, il trionfo dell’iniziativa privata, della concorrenza e dello spettacolo inteso,
più che come occasione di arricchimento culturale, come ludus, e, se vogliamo, come momento di
consumo. Quando gli affari torneranno di nuovo a fiorire, alla svolta del secolo, nella mutata
congiuntura economica, i più abbracceranno con entusiasmo il nuovo, spensierato corso, come il
simpatico e intraprendente direttore dell’”Arte drammatica”: «Oggi tutto cammina, tutto corre e…
guai a chi rimane indietro!».