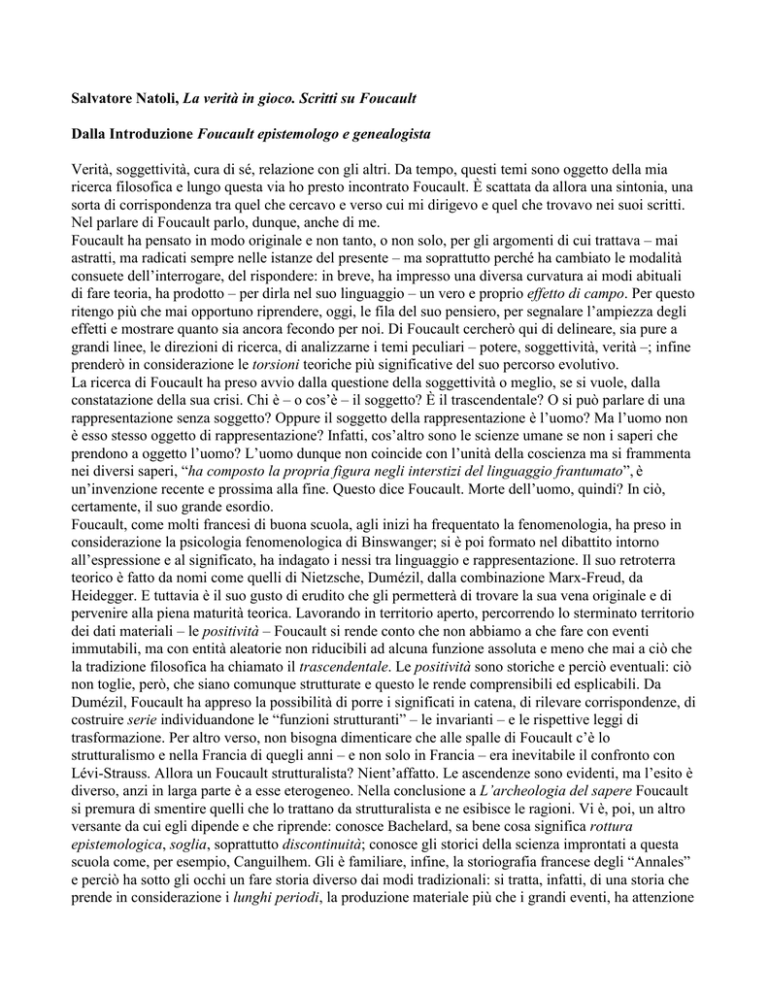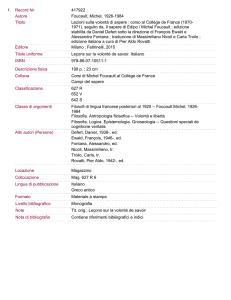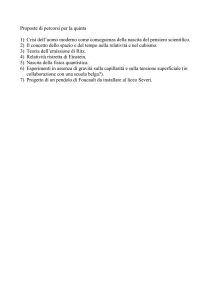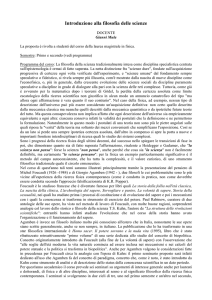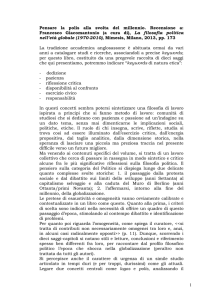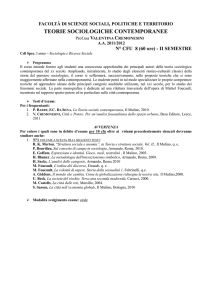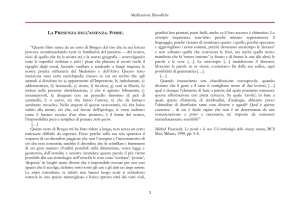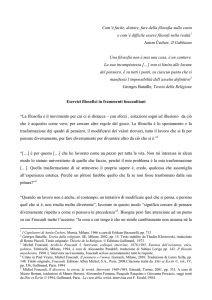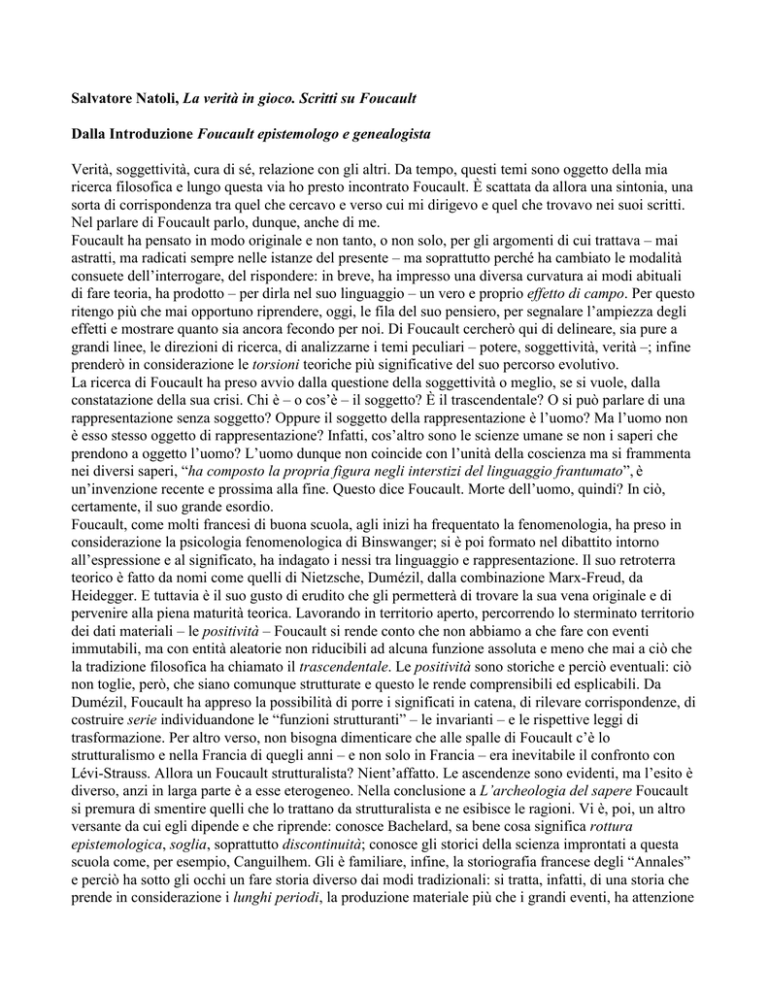
Salvatore Natoli, La verità in gioco. Scritti su Foucault
Dalla Introduzione Foucault epistemologo e genealogista
Verità, soggettività, cura di sé, relazione con gli altri. Da tempo, questi temi sono oggetto della mia
ricerca filosofica e lungo questa via ho presto incontrato Foucault. È scattata da allora una sintonia, una
sorta di corrispondenza tra quel che cercavo e verso cui mi dirigevo e quel che trovavo nei suoi scritti.
Nel parlare di Foucault parlo, dunque, anche di me.
Foucault ha pensato in modo originale e non tanto, o non solo, per gli argomenti di cui trattava – mai
astratti, ma radicati sempre nelle istanze del presente – ma soprattutto perché ha cambiato le modalità
consuete dell’interrogare, del rispondere: in breve, ha impresso una diversa curvatura ai modi abituali
di fare teoria, ha prodotto – per dirla nel suo linguaggio – un vero e proprio effetto di campo. Per questo
ritengo più che mai opportuno riprendere, oggi, le fila del suo pensiero, per segnalare l’ampiezza degli
effetti e mostrare quanto sia ancora fecondo per noi. Di Foucault cercherò qui di delineare, sia pure a
grandi linee, le direzioni di ricerca, di analizzarne i temi peculiari – potere, soggettività, verità –; infine
prenderò in considerazione le torsioni teoriche più significative del suo percorso evolutivo.
La ricerca di Foucault ha preso avvio dalla questione della soggettività o meglio, se si vuole, dalla
constatazione della sua crisi. Chi è – o cos’è – il soggetto? È il trascendentale? O si può parlare di una
rappresentazione senza soggetto? Oppure il soggetto della rappresentazione è l’uomo? Ma l’uomo non
è esso stesso oggetto di rappresentazione? Infatti, cos’altro sono le scienze umane se non i saperi che
prendono a oggetto l’uomo? L’uomo dunque non coincide con l’unità della coscienza ma si frammenta
nei diversi saperi, “ha composto la propria figura negli interstizi del linguaggio frantumato”, è
un’invenzione recente e prossima alla fine. Questo dice Foucault. Morte dell’uomo, quindi? In ciò,
certamente, il suo grande esordio.
Foucault, come molti francesi di buona scuola, agli inizi ha frequentato la fenomenologia, ha preso in
considerazione la psicologia fenomenologica di Binswanger; si è poi formato nel dibattito intorno
all’espressione e al significato, ha indagato i nessi tra linguaggio e rappresentazione. Il suo retroterra
teorico è fatto da nomi come quelli di Nietzsche, Dumézil, dalla combinazione Marx-Freud, da
Heidegger. E tuttavia è il suo gusto di erudito che gli permetterà di trovare la sua vena originale e di
pervenire alla piena maturità teorica. Lavorando in territorio aperto, percorrendo lo sterminato territorio
dei dati materiali – le positività – Foucault si rende conto che non abbiamo a che fare con eventi
immutabili, ma con entità aleatorie non riducibili ad alcuna funzione assoluta e meno che mai a ciò che
la tradizione filosofica ha chiamato il trascendentale. Le positività sono storiche e perciò eventuali: ciò
non toglie, però, che siano comunque strutturate e questo le rende comprensibili ed esplicabili. Da
Dumézil, Foucault ha appreso la possibilità di porre i significati in catena, di rilevare corrispondenze, di
costruire serie individuandone le “funzioni strutturanti” – le invarianti – e le rispettive leggi di
trasformazione. Per altro verso, non bisogna dimenticare che alle spalle di Foucault c’è lo
strutturalismo e nella Francia di quegli anni – e non solo in Francia – era inevitabile il confronto con
Lévi-Strauss. Allora un Foucault strutturalista? Nient’affatto. Le ascendenze sono evidenti, ma l’esito è
diverso, anzi in larga parte è a esse eterogeneo. Nella conclusione a L’archeologia del sapere Foucault
si premura di smentire quelli che lo trattano da strutturalista e ne esibisce le ragioni. Vi è, poi, un altro
versante da cui egli dipende e che riprende: conosce Bachelard, sa bene cosa significa rottura
epistemologica, soglia, soprattutto discontinuità; conosce gli storici della scienza improntati a questa
scuola come, per esempio, Canguilhem. Gli è familiare, infine, la storiografia francese degli “Annales”
e perciò ha sotto gli occhi un fare storia diverso dai modi tradizionali: si tratta, infatti, di una storia che
prende in considerazione i lunghi periodi, la produzione materiale più che i grandi eventi, ha attenzione
per i dati minimi, i processi anonimi tramite cui si vengono a mano a mano strutturando le istituzioni. È
muovendo da queste premesse disciplinari e teoriche che Foucault elabora la sua epistemologia. Gli
eventi, nel loro infinito germinare e morire, sono riconoscibili perché è possibile ricostruire i modi e i
tempi della loro formazione, identificare gli strati che li costituiscono, individuarne strutture. Un
qualsiasi plesso di fenomeni si articola a diversi livelli, interseca strutture altre e ne rimane implicato:
serie discrete, dunque, ma insieme unità di senso; interferenze, influenze, reciproche deformazioni,
adattamenti.
Una qualsiasi struttura è costituita dall’insieme delle sue procedure: è quel che fa e fa quel che è, non è
mai un dato inerte, ma, al contrario, è un’unità di senso e insieme un centro di forza. Meglio una
composizione di forze e – qui la lezione di Nietzsche – un luogo di scontro, di selezione tra energie
vitali. Ma quel che nella storia si impone non prende piede attraverso atti di forza semplici e singolari,
bensì è l’esito di strategie differenziate, di interdizioni e insieme di saperi. Tutto ciò, nel tempo, dà
luogo a processi di istituzionalizzazione che si assestano, infine, in istituzioni così potenti che sembra
non abbiano mai avuto nascita.
In questo progressivo strutturarsi, i saperi non sono eterogenei al potere ma, al contrario, l’esercizio del
potere genera saperi e il sapere si struttura e si consolida in potere. Tanto basta per comprendere perché
in Foucault la teoria si trasformi in un accertamento del da dove e del come, si dispieghi effettivamente
come genealogia, si formuli, formalmente, come epistemologia storica. I celebri titoli foucaultiani
confermano tutto questo: “Storia della follia”, “Archeologia del sapere”, “Nascita della clinica”. Sono
queste le ragioni per cui, in Foucault, l’analitica del potere è divenuta un terreno di ricerca privilegiato.
Nell’affrontare la “questione del potere” Foucault non è un analista dei sistemi politici, e non fa storia
delle dottrine e neppure una sociologia del potere, ma a diverso titolo è tutte queste cose insieme e
anche altro: ritiene infatti che le teorie correnti di filosofia politica siano ancora implicate in larga parte
nel problema della sovranità. Al contrario, “ciò di cui abbiamo bisogno è una filosofia politica che non
sia costruita intorno al problema della sovranità, dunque della legge e dell’interdizione. Bisogna
tagliare la testa al re: non lo si è ancora fatto nella teoria politica”. Lo Stato infatti “è sovrastrutturale in
rapporto a tutt’una serie di reti di potere che passano attraverso i corpi, la sessualità, la famiglia, gli
atteggiamenti, i saperi, le tecniche, ecc., e tutti questi rapporti sono in una relazione di
condizionante-condizionato nei confronti di una specie di metapotere che è strutturato per l’essenziale
intorno ad un certo numero di grandi funzioni d’interdizione”. Il potere si distribuisce in una rete di
relazioni e per darne conto è necessario dipanare queste reti, analizzare i poteri diffusi, i diversi centri
di forza. Per farlo bisogna procedere a una microfisica del potere.
Foucault è, dunque, epistemologo per quell’aspetto che analizza lo strutturarsi formale dei saperi, il
loro costituirsi come discipline; è genealogista perché indaga sull’insieme di procedure che hanno
permesso a un certo sapere piuttosto che a un altro di impiantarsi e prevalere e di mutarsi in potere. E
viceversa. In questa sua analisi Foucault sta sempre sulla soglia, indugia in quell’intervallo
inafferrabile, in cui poteva prendere avvio qualcosa d’altro rispetto a ciò che poi ha avuto corso, in
quello spazio di silenzio in cui qualcosa è stato messo a tacere nel momento in cui cercava di accedere
al linguaggio, qualcos’altro invece ha avuta accesso alla parola. Per catturare questi spazi e dar voce a
questi silenzi, Foucault chiede ausilio alla metafora, diviene gongorista suo malgrado, letteralizza più
che mai la sua scrittura. Ciò gli capita soprattutto in contesti teorici o astratti (come Le parole e le cose
e L’archeologia del sapere); in quelli storiografici trova ausilio nell’erudizione.
È noto poi che nei suoi scritti ha fatto spesso professione di antifilosofia: infatti non si definiva filosofo,
ma non accettava neppure d’essere definito storico, né altro. Non amava, in generale, essere etichettato,
non voleva essere costretto in un “genere letterario”, voleva essere libero da un qualsiasi statuto
disciplinare che predefinendo le aspettative avrebbe impedito a molti di cogliere l’originalità del suo
modo di fare teoria. Per questo di fronte a una precisa richiesta di disciplinarietà – “sei storico, filosofo
o cos’altro?” – risponde: “il mio discorso non determina il luogo da cui parlo, ma addirittura evita il
terreno su cui potrebbe appoggiarsi”. Non c’è un luogo specifico da cui Foucault parla e in certo senso
parla da un non luogo. Per accertare, infatti, come nascono i discorsi non ci si può identificare con
nessuno di essi, ma si è obbligati a tenere una posizione deangolata, a guardarli quasi di sbieco per
identificare il terreno da dove essi emergono, considerare le condizioni che permettono loro di prendere
avvio. Si può allora dire che Foucault abiti una terra di nessuno? Impossibile. Al contrario, egli si
muove alla frontiera, corre al margine di ogni confine perché il suo è un “discorso su dei discorsi che
non intende trovare in essi una legge nascosta, un’origine sepolta che non dovrebbe far altro che
liberare; non intende nemmeno stabilire per se stesso la teoria generale di cui i discorsi sarebbero i
modelli concreti. Si tratta di sviluppare una dispersione che non si può mai ricondurre ad un sistema
unico di differenze, che non si riferisce a degli assi di riferimento assoluto; si tratta di operare un
decentramento che non lascia privilegi a nessun centro”.
L’antifilosofia di Foucault è un gesto filosofico che per tradizione appartiene alla filosofia: da Bacone e
Cartesio – tanto per fare qualche esempio – al “filosofare con il martello” di Nietzsche. Chi, infatti, non
pratica abitualmente la filosofia di raro è interessato a definirsi non filosofo, caso mai capita che ne sia
attratto. Foucault si dichiara dunque antifilosofo perché vuol evitare un’etichettatura che sente
convenzionale e restrittiva, ma laddove non corre questo rischio rivendica per sé la filosofia come
attività, la pratica effettiva del filosofare. “Ma che cos’è dunque la filosofia oggi – voglio dire l’attività
filosofica – se non lavoro critico del pensiero in se stesso? Se non consiste, invece di legittimare ciò che
si sa già, nel cominciare a sapere come e fino a qual punto sarebbe possibile pensare in modo diverso?”
Ma cos’è mai stata la filosofia se non sospetto dell’ovvio? L’esercizio della filosofia consiste, infatti,
“nel sapere in quale misura il lavoro di pensare la propria storia può liberare il pensiero da ciò che esso
pensa silenziosamente e di permettergli di pensare in modo diverso”.