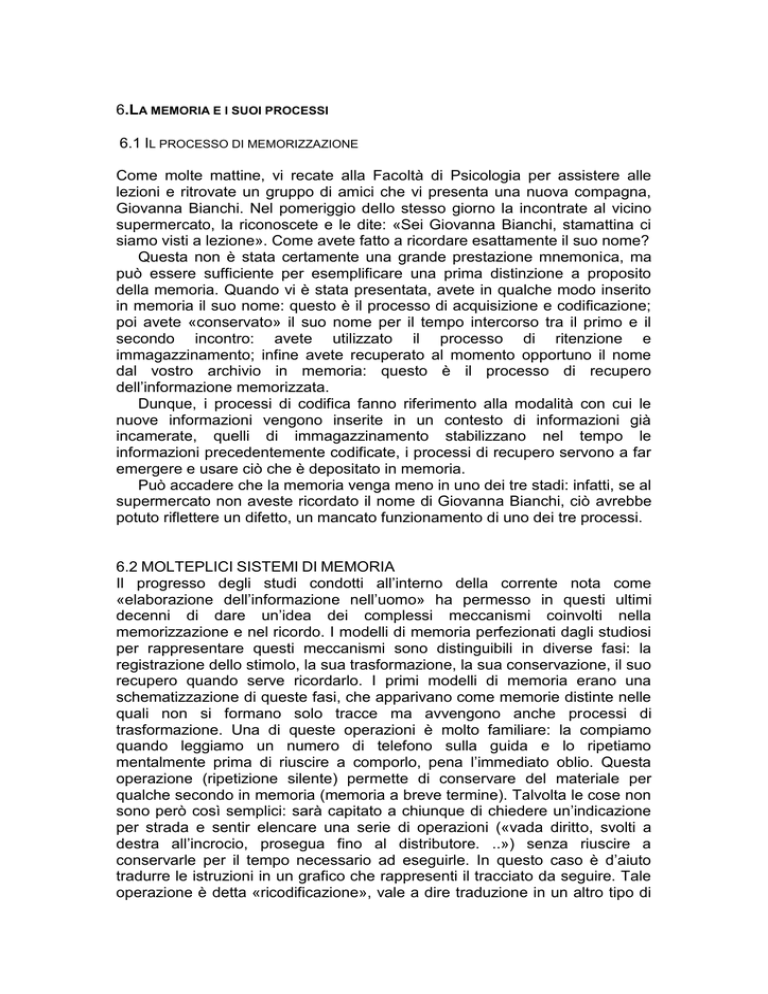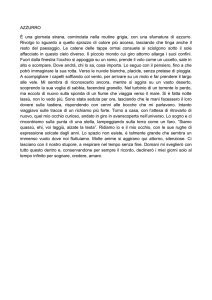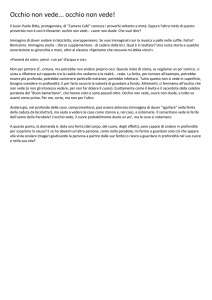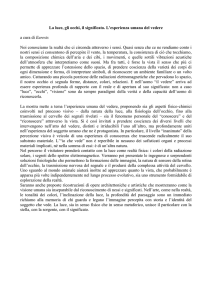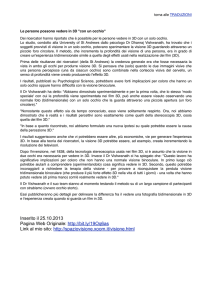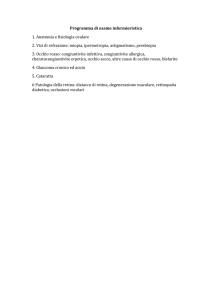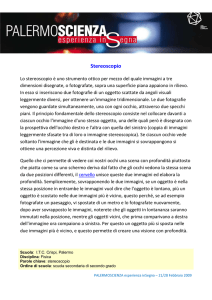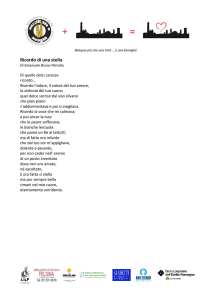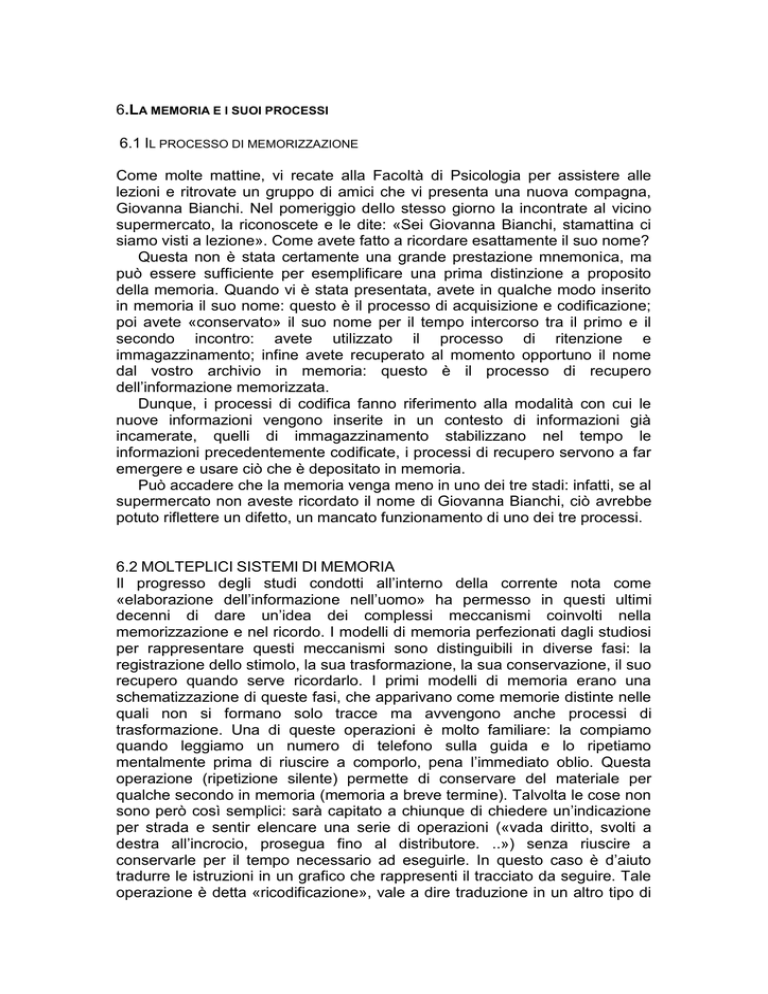
6.LA MEMORIA E I SUOI PROCESSI
6.1 IL PROCESSO DI MEMORIZZAZIONE
Come molte mattine, vi recate alla Facoltà di Psicologia per assistere alle
lezioni e ritrovate un gruppo di amici che vi presenta una nuova compagna,
Giovanna Bianchi. Nel pomeriggio dello stesso giorno la incontrate al vicino
supermercato, la riconoscete e le dite: «Sei Giovanna Bianchi, stamattina ci
siamo visti a lezione». Come avete fatto a ricordare esattamente il suo nome?
Questa non è stata certamente una grande prestazione mnemonica, ma
può essere sufficiente per esemplificare una prima distinzione a proposito
della memoria. Quando vi è stata presentata, avete in qualche modo inserito
in memoria il suo nome: questo è il processo di acquisizione e codificazione;
poi avete «conservato» il suo nome per il tempo intercorso tra il primo e il
secondo incontro: avete utilizzato il processo di ritenzione e
immagazzinamento; infine avete recuperato al momento opportuno il nome
dal vostro archivio in memoria: questo è il processo di recupero
dell’informazione memorizzata.
Dunque, i processi di codifica fanno riferimento alla modalità con cui le
nuove informazioni vengono inserite in un contesto di informazioni già
incamerate, quelli di immagazzinamento stabilizzano nel tempo le
informazioni precedentemente codificate, i processi di recupero servono a far
emergere e usare ciò che è depositato in memoria.
Può accadere che la memoria venga meno in uno dei tre stadi: infatti, se al
supermercato non aveste ricordato il nome di Giovanna Bianchi, ciò avrebbe
potuto riflettere un difetto, un mancato funzionamento di uno dei tre processi.
6.2 MOLTEPLICI SISTEMI DI MEMORIA
Il progresso degli studi condotti all’interno della corrente nota come
«elaborazione dell’informazione nell’uomo» ha permesso in questi ultimi
decenni di dare un’idea dei complessi meccanismi coinvolti nella
memorizzazione e nel ricordo. I modelli di memoria perfezionati dagli studiosi
per rappresentare questi meccanismi sono distinguibili in diverse fasi: la
registrazione dello stimolo, la sua trasformazione, la sua conservazione, il suo
recupero quando serve ricordarlo. I primi modelli di memoria erano una
schematizzazione di queste fasi, che apparivano come memorie distinte nelle
quali non si formano solo tracce ma avvengono anche processi di
trasformazione. Una di queste operazioni è molto familiare: la compiamo
quando leggiamo un numero di telefono sulla guida e lo ripetiamo
mentalmente prima di riuscire a comporlo, pena l’immediato oblio. Questa
operazione (ripetizione silente) permette di conservare del materiale per
qualche secondo in memoria (memoria a breve termine). Talvolta le cose non
sono però così semplici: sarà capitato a chiunque di chiedere un’indicazione
per strada e sentir elencare una serie di operazioni («vada diritto, svolti a
destra all’incrocio, prosegua fino al distributore. ..») senza riuscire a
conservarle per il tempo necessario ad eseguirle. In questo caso è d’aiuto
tradurre le istruzioni in un grafico che rappresenti il tracciato da seguire. Tale
operazione è detta «ricodificazione», vale a dire traduzione in un altro tipo di
scrittura dell’informazione che ci è stata comunicata. La ricodifica può
avvenire anche dal piano visivo al piano linguistico: se vediamo su una
piantina il percorso da seguire possiamo memorizzarlo così: «all’incrocio a
destra e poi a sinistra».
Memorizzare è quindi un procedimento complesso che ha come fase
ultima l’archiviazione o la registrazione di ciò che è avvenuto nella fase finale.
Per quanto innovativa, questa visione della memoria si sarebbe rivelata
riduttiva, o meglio inadatta, a spiegare la generalità dei fenomeni mnestici. La
successione lineare di stadi di trasformazione, che termina con
l’archiviazione, non riesce a farci comprendere perché a volte quanto è stato
memorizzato non coincide con ciò che viene ricordato successivamente, il
che starebbe ad indicare che le tracce mnestiche non sono statiche ma
subiscono delle trasformazioni una volta che sono state impresse. Questo
modello lineare non si accorda soprattutto con quanto esaminato nel capitolo
sulla percezione. Abbiamo visto infatti che il frutto delle nostre osservazioni
non coincide con quello che è esistente: vediamo qualche cosa in più o in
meno, ma anche qualche cosa di differente. La memoria infatti non è la
registrazione esatta di quello che c’è, ma soggiace alle «aggiunte» o alle
«sottrazioni» che la nostra mente ha operato. Lo studio del ricordo deve
quindi essere combinato con lo studio delle modalità di «attribuzione di
significato», ovvero dell’interpretazione di ciò che vediamo.
La memoria, come deposito di conoscenze, finisce per avere un ruolo
attivo non solo nel processo percettivo ma anche nel complesso di tutta
l’attività cognitiva. La cosiddetta «interpretazione in base al contesto» diventa
il caso più rappresentativo del coordinamento delle attività percettive,
attentive e mnestiche e ci sarà di aiuto per capire in che modo gli studiosi
hanno ricostruito un modello complesso di funzionamento della cognizione.
La memoria, al pari di altre componenti del sistema cognitivo, è
estremamente complessa e numerosi ricercatori hanno cercato di di
analizzarla proponendo differenti modelli.
Alcuni studiosi (Atkinson e Shiffrin, 1968) hanno cercato di descrivere
l’archittetura basilare del sistema della memoria in termini di magazzini,
proponendo l’esistenza di tre sistemi di memoria: la memoria sensoriale, la
memoria a breve termine (MBT) e la memoria a lungo termine (MLT).
Baddeley e Hitch (1974) hanno dimostrato che la memoria a breve termine è
un sistema complesso e hanno affermato che tale concetto avrebbe dovuto
essere sostituito con quello di memoria di lavoro; autori come Tulving (1972)
hanno proposto altri modi per esplorarla.
6.3 MODELLO LINEARE DI MEMORIA
6.3.1.Memoria sensoriale.
Qualsiasi tipo di informazione (immagine, suono, sensazione tattile) deve
essere conservato, seppur per un brevissimo periodo di tempo, al fine di poter
decidere se tale informazione deve essere elaborata in modo più specifico o
può essere immediatamente abbandonata. Si tratta quindi di una forma di
persistenza dello stimolo piuttosto che di una «archiviazione» vera e propria;
questo sistema si chiama memoria iconica se riguarda gli stimoli visivi, o
memoria ecoica se riguarda quelli uditivi.
Facciamo caso a fenomeni di questo genere quando siamo colpiti da una
luce molto forte e continuiamo a rimanere per qualche istante colpiti da quella
luce anche se essa si è spenta, oppure quando vediamo il movimento di un
fiammifero o di una luce simile ad una linea luminosa in un ambiente buio.
Sperling (1960) dimostrò che uno stimolo, costituito da configurazioni di
lettere e numeri, «sostava» per pochi decimi di secondo in un particolare
archivio cui diede il nome di «memoria iconica»: esso non subiva particolari
forme di elaborazione, e Sperling sostenne che veniva conservato in forma
«grezza» perché anche la più elementare forma di riconoscimento è opera di
operazioni successive, intervenute dopo che lo stimolo è stato recuperato
dalla memoria iconica.. Questo recupero deve essere compiuto molto
velocemente perché il decadimento della traccia iconica, come abbiamo
detto, è rapidissimo. Nel modello di Atkinson e Shiffrin (1968, 1971), il primo
nel quale la memoria appare articolata in differenti magazzini e in sistemi di
elaborazione dell’informazione, la memoria sensoriale è il primo stadio della
complessa catena di processi che porta all’immagazzinamento in un archivio
permanente di quanto abbiamo appreso.
6.3.2.Memoria a breve termine
La nozione di memoria a breve termine (MBT) si giustifica con
un’osservazione comune: ci sono materiali (vocaboli, numeri) che una volta
sentiti vengono ricordati per qualche secondo e poi, se non vengono trovati
sistemi particolari di memorizzazione, spariscono. Il cercare di tenere a mente
per alcuni secondi un numero telefonico è un esempio che ritroviamo nella
vita quotidiana dell’utilizzo del magazzino a breve termine. Un modo atto a
mantenere questo materiale nella memoria a breve termine consiste nel
ripeterlo mentalmente (ripetizione subvocalica o rehearsal).
È questa una delle più controverse nozioni della psicologia cognitiva. Il
modello-tipo, che prevede l’esistenza di queste due memorie e che può
essere identificato in quello che proposero Atkinson e Shiffrin nel 1968, è
stato messo in discussione per due ordini di motivi. In primo luogo tutti gli
elementi distintivi fra memoria a breve e memoria a lungo termine apparivano,
ad un esame più approfondito, molto confusi. Ad esempio, si riteneva
inizialmente che le tracce nella memoria a breve termine venissero
conservate sotto forma di informazioni «fonologiche» mentre nella memoria a
lungo termine si manteneva solo il significato di vocaboli e frasi. Questa
distinzione si rivelò solo in parte congruente con i risultati ottenuti nelle
successive ricerche. Tuttavia, a mettere in discussione la convinzione
secondo cui l’informazione viene trattata in uno stadio a breve e quindi in un
secondo stadio a lungo termine furono una serie di studi che misero in luce
funzioni molto più complesse della semplice archiviazione temporanea delle
informazioni. Tale archiviazione è solo un momento di un complesso
trattamento delle informazioni che si svolge in un apparato costituito da una
parte «pensante» e da una parte con semplici funzioni di registrazione delle
informazioni. Ad esempio, nel fare il calcolo a mente di una moltiplicazione
con fattori di più cifre dobbiamo eseguire una serie di operazioni più
«semplici» (moltiplicazioni parziali di singole cifre, addizioni, ecc.) in un certo
ordine. Per fare questo dobbiamo seguire un programma «dettato» dalla parte
pensante e tenere a mente i risultati parziali raggiunti. Questo apparato, una
volta raggiunto lo scopo, viene ripulito da tutte le nozioni memorizzate e reso
disponibile per un altro compito. Illustreremo però più avanti la «memoria di
lavoro» e la sua attività.
6.3.3.Memoria a lungo termine
Il sistema della memoria a lungo termine (MLT) è in grado di contenere un
numero elevatissimo di informazioni e di conservare il materiale a tempo
indeterminato, ricorrendo a diversi tipi di codificazione e rievocazione, ad
esempio in forme verbali o di immagine mentale; essa si differenzia quindi
dalla memoria a breve termine sia in termini di durata sia in termini di
capacità.
Nella MLT sono conservate tutte le conoscenze che ci servono per interagire
in modo adattivo con il mondo esterno e le altre persone: il linguaggio, i
concetti, le esperienze personali, le abilità motorie acquisite nel corso della
vita; in generale, non siamo consapevoli delle infinite informazioni che essa
contiene. Secondo il modello le informazioni sono relativamente inattive: esse
potrebbero essere paragonate ai file di un dischetto, che rimangono
accantonati nel supporto finchè non vengono richiamati e aperti nel deposito a
breve termine, e qui utilizzati.
Si possono introdurre ulteriori distinzioni all’interno della memoria a lungo
termine. Tulving (1972), come vedremo in seguito, ad esempio distingue tra
memoria semantica e memoria episodica.
6.4 UNA METAFORA ALTERNATIVA: LA MEMORIA DI LAVORO
Il modello della memoria di lavoro è stato proposto nel tentativo di eliminare
alcuni difetti del modello sequenziale di memoria, troppo semplicistico.
Il concetto di working memory è stato sviluppato da Baddeley e dai suoi
collaboratori che negli ultimi 20 anni hanno messo in luce le importanti
proprietà di questo tipo di memoria (Logie e Denis, 1993, per una rassegna); il
modello, a differenza di quello di Atkinson e Shiffrin (1968), si occupa sia
dell’immagazzinamento provvisorio dell’informazione, sia dell’elaborazione
attiva. La memoria di lavoro, più che un archivio di informazioni, è un vero e
proprio apparato all’interno del quale sono in funzione componenti
propriamente mnestiche, oltre che altre componenti grazie alle quali vengono
eseguiti confronti fra le informazioni, vengono condotti ragionamenti, vengono
fatte previsioni, eseguiti calcoli aritmetici, prese delle decisioni.
Nella figura 1 è schematizzata l’organizzazione della memoria di lavoro
nella quale sono indicati 3 componenti: la componente articolatoria
(articulatory loop), la componente visuo-spaziale (visual sketch pad) e
l’esecutivo centrale (central executive).
Per componente articolatoria si intende un archivio temporaneo di
memoria che trattiene le informazioni sotto forma di «linguaggio silenzioso»,
ad esempio una parola pronunciata mentalmente. Questa prova, utilizzata da
Salamè e Baddeley (1982) ne rivela l’esistenza: un soggetto deve osservare
dei numeri che compaiono su uno schermo e tenerli a mente. Allo stesso
tempo da una cuffia gli vengono fatte sentire delle parole più o meno sensate,
che gli si dice di ignorare. Il ricordo dei numeri risultava disturbato dalla
comparsa di queste parole e l’effetto aveva i valori massimi quando i vocaboli
assumevano un suono simile a quello dei numeri (fette, sotto, piove, dunque,
nei). Secondo i due ricercatori i numeri venivano archiviati in una memoria
fonologica in cui finivano anche le parole udite dalle quali scaturivano effetti di
interferenza.
La funzionalità di questa memoria è compromessa dalla cosiddetta
«soppressione articolatoria» che mostra il suo effetto nel caso in cui si
richieda la reiterazione della pronuncia di una sillaba che paralizza la
ripetizione subvocalica: chiedere al soggetto di ripetere in continuazione ad
alta voce una parola o una sillaba, ad esempio «the – the – the – the»
provoca una specie di incapacità di usare la memoria di lavoro. Gli effetti di
questa attività si manifestano quindi sull’operazione nota come rehearsal. La
componente fonologica ha dunque un ruolo importante in una serie di attività
cognitive come la comprensione linguistica e il fare i conti mentalmente.
Componente visuo-spaziale. – Perché questa distinzione fra visivo e
spaziale? Le informazioni visive memorizzate si riferiscono a ciò che gli occhi
registrano. Le informazioni spaziali possono invece essere raccolte anche se
non siamo in grado di vedere; se, ad esempio, siamo al buio riusciamo in
genere a capire da dove proviene un rumore, abbiamo un’idea vaga di dove si
trovi un oggetto o dove possa essere finito cadendo.
La memoria visuo-spaziale è importante in molti compiti, ad esempio nella
lettura. Quando leggiamo, lo sguardo coglie circa 4-5 parole (circa 3 caratteri
a sinistra e 15 caratteri a destra), colpo d’occhio piuttosto povero che non
spiega la capacità del lettore di guidare il suo sguardo in qualsiasi parte della
pagina che sta leggendo. Questa capacità discende dalla possibilità di
ricordare in quale settore della pagina siano state lette certe informazioni.
La formazione di immagini mentali si avvale principalmente di questa
memoria ma anche la pianificazione del movimento non può farne a meno.
Per preparare un seppur semplice gesto occorre farsi un’idea delle distanze e
predisporre la successione delle azioni; mano a mano che l’azione procede
bisogna verificare la bontà delle azioni svolte e avere costantemente l’idea del
punto a cui si è arrivati.
Esecutivo centrale. – Ha compiti di coordinamento delle funzioni appartenenti
alle componenti fonologica e visivo-spaziale; infatti da sole queste non
spiegano lo svolgimento dei compiti nei quali hanno pure una parte rilevante.
L’esecutivo centrale ha il ruolo di programmare l’azione, distribuendo le
risorse cognitive in modo opportuno e controllando se i risultati raggiunti sono
accettabili. È in questo componente della memoria di lavoro che può maturare
la decisione di iniziare un compito o di interromperlo.
La componente fonologica non è in condizione di assicurare la
comprensione di un messaggio verbale, ma è l’esecutivo centrale a stabilire
se è necessario «ripassare» fonologicamente il materiale non capito. È per
questo che a volte, quando non capiamo quello che abbiamo udito, lo
ripetiamo (ad alta voce o in maniera silente).
È lo stesso esecutivo centrale che registra i significati che riusciamo a
ricavare e che ricava il significato globale degli avvenimenti.
6.5 MEMORIA ESPLICITA E MEMORIA IMPLICITA
Come abbiamo visto in precedenza, gli psicologi hanno studiato inizialmente
la memoria chiedendo ai soggetti di eseguire un compito basato sul recupero
consapevole (utilizzo della memoria esplicita); in periodi più recenti si sono
invece interessati alla comprensione dei fenomeni di memoria implicita,
definita anche memoria senza consapevolezza. In questo caso l’esecuzione
dei compiti è facilitata dalle esperienze precedenti e l’informazione ad esse
relative è recuperata in modo inconscio; essa avviene, secondo Schacter
(1987), quando “l’informazione che stata codificata nel contesto di un
particolare episodio viene in seguito espressa senza che ci sia un ricordo
consapevole o deliberato”. La distinzione tra memoria esplicita e memoria
implicita è nata dall’osservazione e dallo studio delle lesioni delle aree
associative limbiche del lobo temporale. Recentemente, studiando i pazienti
con danni cerebrali, si è riusciti a localizzare le aree del cervello deputate a
queste due funzioni: la memoria implicita generalmente è legata con
l’addestramento all’esecuzione di compiti, motori o percettivi di tipo riflesso,
mentre quella esplicita ha a che fare con la conoscenza di fatti relativi a cose,
a persone, a luoghi.
I ricercatori, in laboratorio, talvolta studiano la memoria implicita sottoponendo
i soggetti a compiti di completamento di parole in cui viene presentato un
frammento della parola con la richiesta di completarlo in modo da formare la
prima parola che viene loro in mente.
Supponete di dover di inserire le sei lettere mancanti nella parola: esp - - - - - ; dato che abbiamo appena parlato della memoria esplicita, sarà probabile
che riempiate gli spazi con le lettere l i c i t a, rispetto a colui che non ha
avuto da poco la vostra stessa esperienza.
Considerato che le persone non riescono a riferirne i contenuti, la memoria
implicita è chiamata anche memoria non dichiarativa o procedurale e si
riferisce alla conoscenza delle cose; ad esempio, noi sappiamo di aver
mangiato a colazione latte con frollini e che Padova si trova nel Veneto. Il
nome di compagni, la data del compleanno della mamma, gli studi fatti, il
contenuto di una conversazione, sono tutte informazioni che vengono
depositate nella memoria dichiarativa.
Le diverse forme di memoria implicita comportano l’intervento di regioni
cerebrali diverse; “Per esempio le memorie acquisite per condizionamento
verso uno stimolo che incute paura hanno una componente emozionale e si
ritiene interessino l’amigdala. Le memorie acquisite mediante un
condizionamento operante necessitano l’intervento dello striato e del
cervelletto.” (Kandel, 2003).
La memoria esplicita, al contrario di quella implicita, è molto flessibile e
richiede la capacità di associare insieme numerosi e diversi elementi
informativi.
Tulving ha proposto per primo l’ipotesi che la memoria esplicita possa essere
ulteriormente divisa in una memoria episodica ed una memoria semantica.
La prima si riferisce alle informazioni di carattere generale che possediamo a
proposito del mondo, cioè «all’immagazzinamento e all’utilizzazione di
conoscenze che riguardano le parole e i concetti, le loro proprietà e relazioni
reciproche». La memoria episodica ha a che fare con quello che noi
ricordiamo quindi si riferisce all’immagazzinamento e al recupero di eventi o
episodi esperiti personalmente; usiamo la memoria episodica quando ci
ricordiamo di aver visto ieri proprio quel film al cinema, o di aver avuto uno
scambio di battute con il collega in ufficio, o l’incontro con Sara, o quando
ricordiamo l’appuntamento di domani mattina alle dieci con uno studente. La
memoria episodica sarebbe dunque organizzata cronologicamente.
La seconda riguarda la conoscenza di fatti e nozioni a carattere generale e si
riferisce invece «all’immagazzinamento e al recupero di eventi ed episodi
temporalmente databili, localizzabili spazialmente ed esperiti personalmente»
(Tulving e Thomson, 1973). Quindi usiamo la memoria semantica per
apprendere e ricordare i concetti e le nozioni imparate a scuola o nei libri: è
un’informazione semantica ricordare che la formula dell’acqua è H 2O o che
letto e materasso sono più associati fra loro di materasso e bocca. La
memoria semantica sarebbe organizzata in modo tassonomico ed
associativo.
Essa è regolata dal principio della specificità della codifica: «soltanto ciò che è
stato immagazzinato può essere recuperato e il modo in cui qualcosa può
essere recuperato dipende dal modo in cui è stato immagazzinato» (ibid.). Ciò
aiuta a capire due importanti funzioni della memoria: la registrazione accurata
delle esperienze e la disponibilità delle conoscenze generali basilari allo
svolgimento di tutte le funzioni cognitive.
6.6 L’OBLIO: PERCHE’ DIMENTICHIAMO?
Come abbiamo già visto il tempo di permanenza di un’informazione in
memoria è un fattore di primaria importanza per il ricordare o dimenticare. La
velocità con cui un ricordo si estingue è variabile: può dipendere dalla
profondità del livello di elaborazione ma anche dalle circostanze in cui si
cerca di recuperarlo.
Per oblio si intende la perdita di informazioni che prima si possedevano,
l’impossibilità di recuperarle.
I vari tentativi di spiegare le cause dell’oblio si sono rivolti a tre teorie,
nessuna delle quali è comunque pienamente soddisfacente: il decadimento
della traccia di memoria, l’interferenza e l’impossibilità di recupero. Secondo
la teoria del decadimento, l’oblio è un fenomeno naturale e fisiologico; con il
passare del tempo, i processi metabolici del cervello determinano un
decadimento della memoria. Questa ipotesi stabilisce che in mancanza di
ripetizione mentale l’informazione si dissolve come succede al fuoco che si
spegne se non è alimentato con nuova legna. Quindi, la ripetizione verbale
non rinforzerebbe gli elementi presenti nella MBT ma solo impedirebbe loro di
sparire gradatamente.
I dati sperimentali evidenziano che il semplice passare del tempo non è
sufficiente a spiegare il fenomeno dell’oblio. Pochi di noi, per esempio,
cercherebbero di spiegare la ruggine che si forma su un cancello di ferro non
verniciato imputandone la causa al passare del tempo, ma sosterrebbero che
la reazione chimica del ferro (ossidazione) ne sia il motivo: il tempo in sè non
può causare tale reazione.
Nè il tempo può far dimenticare, affermano coloro che sostengono l’ipotesi
dell’interferenza; secondo questa posizione l’oblio sarebbe riconducibile
all’interferenza da parte di altre informazioni, attività ed esperienze. Questo
fenomeno è stato studiato sperimentalmente usando liste di parole o sillabe
senza senso da imparare a memoria.
Gli studiosi hanno evidenziato due tipi di interferenza: l’interferenza proattiva
e quella retroattiva.
Nel primo caso un vecchio apprendimento, quindi precedente, si afferma nei
confronti di uno nuovo; per esempio, il ricordo del vecchio numero di cellulare
interferisce con l’apprendimento di quello nuovo. Quando vi viene invece
richiesto di ricordare l’informazione precedente, una volta terminato il compito
di apprendere la nuova, siete incapaci di farlo, e possiamo allora parlare di
interferenza retroattiva.
Secondo altri studiosi è possibile spiegare l’oblio in relazione all’impossibilità
di accedere alla traccia mnestica.
Nella vita quotidiana ci sono molte prove del fatto che possediamo nella
nostra memoria informazioni alle quali non riusciamo ad accedere; pur
conoscendo un determinato nome, non riusciamo a farcelo venire in mente,
producendo quel fenomeno noto ingenuamente come “avere la parola sulla
punta della lingua”.
6.8. LE MNEMOTECNICHE
Per evitare di disperdere irrimediabilmente del materiale e per mantenerlo
vivo in memoria chiunque adotta degli espedienti particolari: dal classico nodo
sul fazzoletto al più moderno note-book computer, passando attraverso gli
appunti e l’agendina telefonica. In tali casi il materiale assume una importanza
relativa, nel senso che non necessita di una archiviazione duratura nel tempo;
se invece deve permettere di raggiungere obiettivi più importanti e
impegnativi, deve essere ricordato per mezzo di mnemotecniche. Queste
procedure permettono in genere di usare elementi più semplici o più facili da
elaborare rispetto al richiamo pedissequo dell’informazione: essi
consentiranno, una volta attivati, di richiamare la stessa informazione.
Rivedere occasionalmente una fotografia, ad esempio, «fa tornare alla
memoria» una vacanza, un’amicizia che non sarebbe stata altrimenti ricordata
nei suoi particolari.
Le mnemoniche possono essere suddivise fra sistemi e tecniche, visive o
verbali; i primi sono metodi mnestici generali molto sofisticati e applicabili a
diversi tipi di materiali, mentre le seconde si riferiscono a materiali ben definiti
e non esportabili ad altro materiale.
Tra le tecniche mnestiche verbali ricordiamo le rime, le parole chiave, gli
acronimi e gli acrostici, mentre il metodo fonetico è il più importante fra i
sistemi. Per quanto riguarda i metodi visivi, si parla di associazioni visive e
storie, sistema dei loci peg system (Roncato e Zucco, 1993).
6.10 I LIVELLI DI ELABORAZIONE: UN APPROCCIO DIVERSO
Durante gli anni Settanta iniziarono a levarsi alcune critiche al modello
modale di Atkinson e Shiffrin: Craik e Lockhart (1972) avanzarono una
diversa teoria per lo studio della memoria che poneva l’accento sul ruolo della
codifica durante l’apprendimento. La teoria dei livelli di elaborazione (LDE),
pur non rifiutando totalmente la distinzione tra MBT e MLT, sosteneva
l’esistenza di diversi livelli di elaborazione che differiscono per profondità,
definita da Craik (1973) «in termini di significatività estratta dallo stimolo,
piuttosto che in termini di numero di analisi effettuate su di esso».
Secondo questa teoria la memoria a lungo termine è determinata
principalmente dall’elaborazione che avviene al momento dell’apprendimento:
ne consegue che un’elaborazione profonda permette una migliore ritenzione a
lungo termine.
Questi studiosi eseguirono una serie di esperimenti usando la tecnica di
apprendimento incidentale: ai soggetti veniva presentata una lista di parole e
dovevano rispondere ad una domanda su ciascuna delle parole presentate, al
fine di portare l’elaborazione dell’informazione verso uno dei tre livelli
considerati: ortografico, fonologico e semantico. Ad esempio: la parola CANE
è scritta a lettere minuscole o maiuscole? La parola fa rima con pane? È un
animale domestico?
Certamente l’analisi richiesta dalla prima domanda necessita di un
controllo molto superficiale del termine poiché ne considera solo le
caratteristiche fisiche, ma per rispondere all’ultima domanda si deve compiere
un’analisi più attenta, dovendo valutare il significato della parola stessa:
l’elaborazione semantica è dunque più profonda e dà luogo a una traccia
mnestica di maggior durata. Gli autori evidenziarono così che l’attività
cognitiva costituisce un sistema indirizzato alla percezione e alla
comprensione degli eventi.
Alla teoria dei livelli di elaborazione sono state sollevate alcune obiezioni:
manca una misura indipendente della profondità dell’elaborazione perché nei
compiti orientati non è possibile determinarla con precisione, né essere certi
dell’effettivo livello di elaborazione impiegato dal soggetto. Baddeley (1986,
1990) la ritiene una teoria molto generale poiché non specifica i meccanismi
che soggiacciono al processo mnestico e perché l’ipotesi dell’unicità del
sistema è fuorviante, e per Shiffrin (1993) non è nemmeno logicamente
sostenibile.
6.10.1 Livelli di codifica e ricordo
Abbiamo già riferito, come le ricerche sui livelli di codifica abbiano
rappresentato un’importante indicazione per coloro che volessero stabilire i
rapporti fra comprensione e ricordo. Anche se la nozione di «livello di
profondità» non è mai stata precisata a sufficienza per permettere di collegare
il ricordo (o l’oblio) ai diversi gradi di profondità, è fuori dubbio che esiste, ed è
stata dimostrata, una connessione fra la complessità della struttura chiamata
ad aggregare dei frammenti e la capacità di ricordo.
Cosa vuol dire allora esattamente essere superficiali o profondi nel cercare
significati in ciò che ci circonda? È già stato chiarito che la nostra
osservazione può essere pilotata dall’alto (a guida concettuale o top-down):
ebbene, questa osservazione può essere «ispirata» da conoscenze più o
meno complesse e potrà svolgersi in tempi più o meno lunghi. Prendiamo una
lastra radiografica; è difficile che chi è digiuno di nozioni mediche e di
radiografia possa vedere qualche cosa di significativo. Può darsi che individui
la sagoma di un osso, ma è molto più probabile che veda chiazze bianche su
sfondo scuro, ombre, profili sfumati, ecc. Questa è un’osservazione
superficiale; il medico vedrà invece «oltre» o «dietro» quelle ombre qualche
cosa di particolare: questa è un’osservazione profonda pilotata dalle sue
conoscenze.
L’analisi in profondità ha bisogno di tempo. Gli studiosi che per primi
affrontarono questo problema usarono il tempo che i soggetti impiegavano
per rispondere a certe domande come indice della profondità di elaborazione
dei significati a cui erano arrivati. Se non c’è tempo a sufficienza per
l’osservatore questi non potrà arrivare a livelli profondi di elaborazione del
significato. Quindi il procedimento di elaborazione del significato è legato a
due risorse fondamentali: le conoscenze e il tempo.
6.10.2 Livelli di elaborazione linguistica
Tra le parole di questa lista ce n’è qualcuna scritta in modo inesatto perché
ha, mischiati a caso, caratteri maiuscoli e minuscoli. Le si individui.
RETE, COMMessa, fronte, richiamo, PLataNo, ZUCCHERO, StiRaRE, libro,
orgoglio, bisonte, PONtE, CINEMA, cantina, scOGlio.
Tra le parole di quest’altra lista ce ne sono alcune che si riferiscono alla
scena «cambio di una ruota». Le si individui.
PAGINA, NUVOLA, BULLONE, SCORTA, MAGLIA, LUCE, CANDELA,
CHIAVE, SBANDAMENTO, FRONTE, CAVO, FRENO, FOGLIA, CHIODO.
Ora si cerchi di ricordare e si scrivano tutte le parole che si sono
esaminate, ovviamente senza guardare le due liste.
Si conti quante parole si sono ricordate. Sono di più quelle della prima lista
o quelle della seconda?
Questo esercizio ha alcuni difetti e serve solamente a familiarizzare con le
prove studiate per esplorare differenti livelli di codifica. Quando si esegue la
seconda prova si sa già che si dovrà ricordare qualcosa e quindi l’effetto
sorpresa, che funzionava con la prima lista di parole, non può più essere
proposto: dunque i risultati delle due prove non sono comparabili. Craik e
Tulving (1975) eseguirono vari esperimenti a sostegno della teoria dei LDE; ai
soggetti era presentata, ciascuna preceduta da una domanda. I quesiti
potevano variare per attivare tre differenti livelli di elaborazione di profondità:
qello fisico, quello acustico o quello semantico. I risultati delle ricerche
evidenziarono che più elevato era il livello di elaborazione relativo alle
domande, più elevato era il livello di richiamo corrispondente.
Possiamo tentare di replicare l’esperimento in questo modo.
Si leggano le seguenti istruzioni ad un soggetto: In questo foglio troverà
scritta una domanda e, accanto, una parola. Risponda semplicemente SÌ o
NO alla domanda. Lo scopo dell’esperimento è quello di saggiare la sua
prontezza di riflessi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La parola fa rima con «gente»
MENTE
La parola è scritta in maiuscolo
SEDIA
La parola fa rima con «casco»
FRUTTO
La parola indica un vegetale
GERANIO
La parola è scritta in minuscolo
ZOLFO
La parola può essere messa al posto dei puntini nella frase:
«Il .... era in ritardo e riuscì a prenderlo»
TRENO
La parola indica un quadrupede
GIRAFFA
La parola può essere messa al posto dei puntini nella frase:
«Era pericoloso perché la fiamma si era spenta e il .... fuoriusciva»
GAS
La parola fa rima con «lontano»
LIBRO
La parola indica un uccello
LEPRE
La parola può essere messa al posto dei puntini nella frase «Quando il ....
si levò, la mamma si svegliò»
SOLE
La parola può essere messa al posto dei puntini nella frase: «Si era
appoggiato a uno .... perché era stanco di stare in piedi» STUZZICADENTI
La parola è scritta in maiuscolo
SEDIA
La parola indica un felino
VIPERA
La parola indica un utensile
CACCIAVITE
La parola fa rima con «sasso»
ARCO
La parola può essere messa al mposto dei puntini nella frase: «Dopo aver
sciolto la .... in un contenitore poté dissetarsi»
NEVE
La parola indica un’imbarcazione
GONDOLA
La parola è scritta in caratteri maiuscoli
STRACCIO
La parola può essere messa al posto dei puntini nella frase: «Dopo aver
aperto la valigia si accorse che aveva dimenticato il ....» TROMBONE
Ora si chieda alla persona che ha risposto a queste semplici domande se
ricorda le parole che ha esaminato dopo la lettura di ogni singola domanda.
Questi mostrerà probabilmente un po’ di disappunto per non essere stato
avvertito che bisognava anche tenere a mente le parole. Si cerchi di avere
quante più risposte possibili vincendo la sua resistenza per completare il
compito di ricordo incidentale, che prevede l’elaborazione spontanea delle
parole non assoggettate a strategie di apprendimento o memorizzazione.
Si indichino le parole ricordate correttamente, distinguendole per livelli di
elaborazione. Ci sono delle differenze fra i vari livelli? Le parole elaborate a
livello grafico o strutturale (è minuscola o maiuscola?) vengono ricordate in
misura uguale o inferiore a quelle elaborate a livello più profondo (fonologico,
semantico o frasale)?
3. L’ATTENZIONE
Nel capitolo sulla percezione abbiamo visto che non c’è una stretta
corrispondenza fra realtà e mondo percepito in quanto quest’ultimo può
mostrare proprietà e organizzazioni in una certa misura differenti dal mondo
reale. Abbiamo analizzato i fattori che possono essere ritenuti i massimi
responsabili di questa discrepanza, distinguendo fra fattori primari e fattori
secondari. I fattori primari influenzano il modo di percepire le cose
indipendentemente dalla nostra volontà e dalle nostre conoscenze, dando
origine a organizzazioni percettive che non sono modificabili dai nostri sforzi
attentivi. I fattori secondari sono invece frutto dell’apprendimento perché essi
non sono altro che la manifestazione della forza delle nostre aspettative e
delle nostre abitudini: esse fanno sì che si veda in modo coerente con le
nostre conoscenze del mondo. Per effetto di ciò il mondo percepito può
contenere immagini distorte oppure maggiori o minori elementi rispetto al
mondo reale.
Il linguaggio corrente è ricco di vocaboli e di espressioni che colgono
queste discrepanze: «non mi sono accorto», «non ho notato», «non ho fatto
caso» lo diciamo riferendoci a situazioni nelle quali ammettiamo di non aver
percepito qualche cosa di presente o realmente accaduto. Parliamo di
«distrazione» quando vogliamo invece sottolineare il fatto che non era
naturale né giustificabile che ci sfuggisse qualche cosa: l’attenzione o qualche
cosa nei meccanismi che la governano non hanno funzionato. Cosa può
essere successo in un caso del genere? Possiamo trovare una prima risposta
in alcune espressioni correnti. Infatti, quando diciamo «Non me l’aspettavo,
l’ho visto solo all’ultimo momento» vogliamo intendere che la nostra
osservazione è stata diretta in una certa parte del campo che sulla base delle
nostre aspettative era ritenuta importante, distogliendola quindi da altre parti.
Da cosa è provocata a sua volta la distrazione? Ognuno di noi è capace di
elencare una serie di cause. Sappiamo, ad esempio, che ci è impossibile
stare attenti a tutto quando siamo bersagliati da molti stimoli o quando non
riusciamo a concentrare i nostri sforzi su un particolare obiettivo. In altre
parole, per essere attenti bisogna essere capaci di distinguere ciò che è
importante da ciò che non lo è, ma per farlo occorre saper far appello alla
maggior quantità di risorse possibili.
Questa premessa ha fatto emergere due questioni. L’attenzione agisce
come un filtro, orientando e selezionando le osservazioni ma, al tempo
stesso, facendo sì che la maggior parte dei nostri sforzi (risorse cognitive)
venga concentrata su un solo obiettivo. L’atto di «prestare attenzione»
sarebbe perciò sia un’operazione di selezione, sia uno sforzo di
concentrazione delle energie che, disperse, non assicurerebbero risultati
apprezzabili.
I problemi fondamentali sui quali si è focalizzato l’interesse dei ricercatori in
merito ai processi attentivi riguardano:
• Le operazioni cognitive che rendono possibile il filtraggio e i criteri con i
quali viene condotta la selezione delle informazioni. Questo è uno dei
problemi più difficili da risolvere, in primo luogo perché nel cervello e negli
organi di senso non è rintracciabile un organo che disponga di queste
capacità di filtraggio e in secondo luogo perché occorre determinare con
precisione i criteri di analisi. Possiamo ipotizzare che si riesca a seguire un
discorso perché si seleziona la voce che lo produce e l’intensità del suono,
seguendo un criterio fisico, ma nessuno ci impedisce di credere che la
selezione sia fatta in base al contenuto: si segue quel discorso perché esso
ha determinati elementi di interesse, mentre se ne scartano altri perché
irrilevanti. Possiamo spiegarci con un’analogia molto semplice: se in un
esame vengono scartati coloro che risultano più alti di 1,75 cm, ci si attiene a
un criterio fisico, ma se selezioniamo coloro che si dimostrano preparati in
regolamenti del gioco del calcio agiamo sulla base di un criterio di contenuto
più profondo.
• Ciò che viene bloccato dal filtro rimane estraneo a ogni altra attività
cognitiva? L’attenzione impedisce l’accesso alla mente a tutto ciò verso cui
non è diretta? Oppure c’è una qualche forma di influenza da parte di ciò che
viene scartato?
• Ci si deve dedicare a un solo compito, oppure è possibile condurne e
concluderne più d’uno contemporaneamente? Se l’attenzione impone una
selezione dei compiti, perché a volte riusciamo a fare due cose nello stesso
tempo? Si tratta forse di uno dei problemi più controversi. È comunque chiaro
che i limiti dell’attenzione non sono gli stessi limiti dell’azione, dato che
quest’ultima può aver luogo anche in assenza di controllo vigile.
Numerose sono le ricerche e le teorie sull’attenzione; in questo capitolo
saranno considerati solo alcuni degli aspetti studiati. Lo schema sotto
riportato mostra alcuni argomenti nell’ambito dell’attenzione e le possibili
relazioni tra loro.
ATTENZIONE
ATTENZIONE SELETTIVA
(elabora un solo input)
UDITIVO
(ad es. shadowing)
VISIVO
(ad es. riflettore con
fascio di luce
variabile)
ATTENZIONE DISTRIBUTIVA
(elabora tutti gli input)
SOMIGLIANZA
DEI COMPITI
PRATICA
(ad es. effetti sulla
automaticità)
DIFFICOLTA’ DEL COMPITO
3.1 ATTENZIONE SELETTIVA
Per attenzione selettiva si intende la capacità di isolare uno stimolo fra tanti
e di rispondere solo a quello, elaborando le informazioni che sono ritenute di
una certa rilevanza al fine di raggiungere gli scopi che ci siamo prefissi. Ad
esempio, quando seguiamo il discorso di una persona che ci parla in una
stanza affollata, la nostra attenzione diventa selettiva perché ignoriamo i
discorsi di altre persone e tutto ciò che può interferire con l’intenzione di
ascoltare proprio il nostro interlocutore.
L’attenzione selettiva comporta una serie di competenze tra loro connesse:
l’integrazione, che implica la capacità di porre in relazione le
caratteristiche e i differenti aspetti della situazione, in funzione della sua
complessità;
il filtraggio, inteso come la capacità di selezionare le informazioni rilevanti
e di ignorare quelle non pertinenti;
la ricerca, cioè la capacità di individuare un oggetto presente nel campo
visivo;
la facilitazione, definita come quel meccanismo di regolazione in base al
quale l’elaborazione precedente influenza l’elaborazione delle
informazioni successive, facilitandola o peggiorandola.
Questo tipo di attenzione può focalizzarsi su stimoli rivolti alle modalità
sensoriali (visiva, uditiva, ecc.) oppure su informazioni originate da posizioni
spaziali, nonché su elementi che fanno parte di determinate categorie o classi
(Allport, 1989; Umiltà, 1994).
3.2 ATTENZIONE DIVISA
Se chiedessimo al soggetto di eseguire due compiti studieremmo situazioni
di attenzione divisa (o distribuita); in queste occasioni possono verificarsi delle
interferenze tali per cui l’esecuzione di uno dei due compiti disturba
l’esecuzione dell’altro. L’origine di questi disturbi può essere riconosciuta nel
fatto che l’individuo dispone di risorse limitate che possono rivelarsi
insufficienti quando voglia conquistare più di un obiettivo. Quello che era
sufficiente per portare a termine un compito si rivela perciò insufficiente a
portarne a termine due: la conseguenza sarà che ambedue avranno
un’esecuzione lacunosa, difettosa, più lenta o più difficoltosa. In particolare,
se i compiti da eseguire sono molto simili, è stato dimostrato che l’interferenza
è maggiore a causa del fatto che essi richiedono operazioni simili difficilmente
eseguibili contestualmente (McLeod, 1977; Wickens, 1984).
Secondo alcuni studiosi è possibile dirigere l’attenzione a più cose
contemporaneamente; i sostenitori di tale posizione affermano infatti che le
risorse cognitive sono perfettamente divisibili tra i diversi compiti e possono
essere destinate alle singole attività in quantità graduate. L’attenzione è
considerata come una risorsa, una sorta di serbatoio di energia di dimensioni
rigorosamente limitate che il sistema di elaborazione può utilizzare in diverse
quantità e in diversi modi per l’attuazione dei compiti assegnati. Tale energia
può essere quindi contemporaneamente distribuita più o meno intensamente
all’uno o all’altro compito, in modo tale però da non esaurirne la riserva
(Kahneman, 1973; Norman e Bobrow, 1975; Hirst, 1986). Il modello studiato
da Kahneman è particolarmente importante perché cerca di unificare la teoria
strutturale e quella della capacità. Egli infatti afferma che esiste nell’individuo
una capacità limitata nell’esecuzione delle attività mentali, il cui limite però
varia in funzione delle necessità operative imposte via via dalla situazione del
momento. Il sistema di allocazione «invia» la quantità di risorsa attentiva alle
diverse attività in corso sulla base del livello attuale della capacità, delle
intenzioni del momento e della valutazione delle richieste rispetto alla
capacità, aumentando o diminuendo mano a mano il flusso di energia verso i
diversi compiti. Quando le richieste aumentano (maggiori difficoltà di
esecuzione, nuovi compiti, ecc.) il sistema di valutazione richiede la
disponibilità di nuove riserve e segnala al sistema di allocazione le variazioni
da apportare al flusso di energia. Se le richieste crescono al punto di superare
il limite massimo di riserva disponibile, le attività del soggetto interferiscono
tra loro (interferenza di capacità, non di struttura) causando o
l’accantonamento di un compito o una cattiva esecuzione di tutti i compiti.
Gli studi di Spelke et al. (1976) e di Hirst et al. (1980), fautori della
possibilità di dividere l’attenzione fra due compiti piuttosto che della sua
alternanza, hanno affermato che due attività relativamente complesse
possono essere svolte con successo e senza interferenze qualora sia
presente una certa quantità di pratica.
Queste convinzioni sono state smentite da altri autori ma si può comunque
ipotizzare che la pratica possa in qualche modo aiutare l’esecuzione
contemporanea di due compiti: c’è la possibilità di adottare nuove strategie
nella loro esecuzione per limitare le interferenze, c’è quella di ridurre o
semplificare le richieste proposte alle risorse attentive, o quella di consentire
un modo più corretto e costruttivo nell’utilizzo delle risorse specifiche.
Altre ricerche (Reed, 1988) hanno dimostrato che l’attenzione può essere
divisa fra compiti diversi con perdita di accuratezza ma con guadagno di
flessibilità: si può concentrare la propria attenzione su ciò che appare più
importante o che è diventato più importante, adattandosi prontamente ai
cambiamenti della situazione. Questo è un grosso vantaggio dal punto di vista
dell’adattamento, anche se diventano più frequenti errori e interferenze capaci
di compromettere in qualche misura il risultato finale.
3.3 LE TEORIE DELL’ATTENZIONE
L’oggetto principale delle teorie che hanno studiato l’attenzione selettiva è
l’identificazione del punto in cui essa si manifesta all’interno del processo di
elaborazione dell’informazione.
Nell’assunto che la selezione si renda necessaria per la limitatezza delle
capacità del sistema cognitivo, la teoria del filtro di Broadbent (1958), parla di
un unico processore centrale a capacità limitata che può essere utilizzato, a
fronte di una molteplicità di compiti, per lo svolgimento di uno solo di essi
mentre gli altri restano in attesa di essere presi in esame, una volta che il
primo sia completato o, a sua volta, «sospeso». Ad esempio, guidare la
macchina e fumare sono attività svolte apparentemente nello stesso
momento, ma che in realtà vengono eseguite, seppur per brevissimi periodi,
in modo esclusivo e alternato.
Questo modello definisce l’esistenza di un processo selettivo precoce che
inizialmente immagazzina e analizza gli stimoli esterni, sulla base delle loro
caratteristiche fisiche, per un breve periodo e in modo parallelo, cui fa seguito
una elaborazione più lunga e attenta, di tipo seriale, alla quale ha accesso
solamente uno degli stimoli precedentemente esaminati. Le due fasi del
processo attivano rispettivamente il sistema sensoriale e quello percettivo.
L’attenzione diventa quindi un filtro che esclude gran parte delle informazioni
e concentra l’ulteriore analisi solo sullo stimolo selezionato, poiché appunto la
capacità del sistema percettivo è limitata e ne evita così il sovraccarico
informazionale.
Le caratteristiche del modello sono dunque:
• l’esistenza di uno speciale meccanismo deputato alla selezione
dell’informazione;
• l’utilizzo di uno dei canali del sistema sensoriale per selezionare fin
dall’inizio gli input che si presentano;
• il completamento dell’elaborazione dello stimolo nell’ambito del sistema
percettivo, limitato nelle sue capacità;
• il perdurare per un breve periodo nel sistema sensoriale degli stimoli non
elaborati sotto forma di caratteristica fisica di identificazione o di selezione.
Dalle ricerche sull’attenzione selettiva e dai numerosi studi condotti negli
ultimi decenni sul filtraggio delle informazioni sono venute alcune risposte al
problema che riguarda il «destino» di ciò che viene trascurato a seguito di
questa selezione.
Le prime ipotesi partivano dalla convinzione che ci fosse una specie di
«collo di bottiglia» attraverso cui passavano solo alcune informazioni (stimoli),
mentre le altre venivano bloccate. Ne consegue che, in teoria, queste ultime
non avrebbero dovuto lasciare tracce nel soggetto: se ipotizziamo che sia una
barriera superficiale ad arrestare un messaggio, dobbiamo anche ammettere
che questo messaggio non subisca alcuna forma di elaborazione del
significato. È come se selezionassimo dei candidati in base alla loro altezza o
al colore dei calzoni piuttosto che alla conoscenza della materia d’esame,
come detto in un esempio precedente: ricorriamo quindi a un metodo di
filtraggio molto rudimentale.
Tuttavia si dimostrò che questo «blocco» agiva solo in parte, perché ciò
che si pensava essere stato bloccato mostrava, malgrado tutto, di avere
influenzato la memoria. Occorre dunque ammettere l’esistenza di una qualche
forma di riconoscimento del materiale e si è teorizzata l’entrata in azione non
di un vero filtro, bensì di un meccanismo «attenuatore» capace di
neutralizzare solo in parte l’influenza di quegli stimoli che dovevano essere
trascurati o che erano esclusi dall’attenzione.
Treisman (1960, 1964) ipotizzò che il filtro, in realtà, riduce ma non
cancella l’informazione, che deve subire una specie di processo gerarchico:
prima c’è l’analisi delle caratteristiche fisiche, dei pattern fonici o visivi, poi
quella basata sulle strutture grammaticali, sui significati delle parole, sulla
congiunzione dei singoli elementi in «oggetti unici» (Treisman e Gelade,
1980). Anche particolari istruzioni o aspettative del soggetto possono
modificare l’obiettivo dell’attenzione. L’esistenza di queste altre forme di
attivazione dell’attenzione favorisce allora il percepire degli input che,
secondo la teoria iniziale, avrebbero dovuto essere cancellati. Nasce così la
teoria del filtro attenuato.
3.4 L’ELABORAZIONE AUTOMATICA:
ATTENZIONE E PRATICA
Siamo quindi capaci di compiere certe azioni con molta precisione e senza
che esse disturbino altre attività in corso. Queste azioni sono definite
automatizzate perché sembrano «andare avanti da sole», cioè senza
l’esercizio di controlli e correzioni sul loro andamento. Esse dimostrano che
siamo capaci di fare più cose allo stesso tempo e che l’attenzione non viene
più attivata per lo svolgimento di queste attività. Ad esempio, riusciamo a
portare alla bocca il cibo e al tempo stesso siamo in grado di ascoltare una
persona; camminiamo per strada e parliamo con il nostro accompagnatore.
Mangiare e percorrere a piedi un tratto di strada sono attività automatizzate,
vale a dire azioni che sono state ripetute molte volte e che, grazie a questo
esercizio, sono diventate altamente perfezionate: sappiamo esattamente cosa
fare e quando farlo senza pensarci su o dover scegliere. Questa abilità è
frutto dell’esercizio che ci ha permesso di selezionare, fra tutti i gesti possibili,
quelli più efficaci e utili.
L’automaticità gode di questi attributi fondamentali (Eysenck, 1990):
•
i processi automatici sono veloci;
• i processi automatici non riducono la possibilità di eseguire altri compiti
(perché non richiedono attenzione);
•
i processi automatici si svolgono senza esserne consapevoli;
• i processi automatici sono coercitivi, cioè si producono anche quando
lo stimolo che li innesca non è frutto di osservazioni volontarie.
Tuttavia l’esecuzione basata su un’abilità acquisita di comportamenti
automatici può essere intralciata dal controllo conscio: provate a correre in
bicicletta mentre monitorate coscientemente ogni vostro movimento.
Shiffrin e Schneider (1977), che si pongono in evidenza fra gli studiosi
dell’argomento, distinguono fra processi automatici, che sembrano essere
relativamente numerosi, e processi controllati o parzialmente automatici. I
primi sono inconsci, non richiedono attenzione, non sono plastici (cioè non
possono essere corretti per essere adattati alle circostanze), sono
relativamente rapidi e non sono più correggibili tramite apprendimento. I
secondi si basano sul controllo conscio, richiedono attenzione, pianificazione,
controllo dei risultati intermedi e finali, dispongono di una limitata capacità,
sono adattabili alle diverse situazioni e richiedono un tempo relativamente
lungo per la loro esecuzione (Shallice, 1994). Effettuando esperimenti su
compiti visivi essi hanno potuto individuare che i processi controllati, nel caso
di utilizzo dell’attenzione focalizzata, evitano o limitano gli errori di
elaborazioni non preventivate, essendo più lenti ma flessibili.
Alcuni processi automatici non possono esser portati a livello del controllo
conscio e di rado si pensa a tutte le sequenze coinvolte nell’esecuzione di
molti comportamenti automatici. Di fatto, processi come quello di guidare
l’automobile, che in una fase iniziale sono controllati, possono diventare
automatici: una volta acquisita l’esperienza nella guida, in alcune situazioni
“normali” (scarso traffico, tempo sereno, ecc.), non ci si preoccupa di porre
tutta quell’attenzione che veniva prestata prima.
Altri comportamenti invece possono essere totalmente controllati
intenzionalmente, ad esempio allacciarsi le scarpe, per quanto ciò avvenga
raramente.
Cheng (1985) critica la teoria che affida alla pratica la trasformazione del
controllo in automatismo poiché non si capisce se essa renda più efficaci e
veloci i vecchi processi o se li sostituisca con altri completamente nuovi.
Logan (1988) afferma che la pratica aumenta la disponibilità di conoscenze di
base e ciò permette un più veloce recupero nella memoria dell’informazione
che si rende necessaria in quel momento, dando quindi origine a una
azione/reazione più rapida; l’automatizzazione avviene perchè accumuliamo
gradualmente conoscenze relative a specifiche risposte date a specifici
stimoli.
Quando un bambino comincia ad apprendere come eseguire delle
sottrazioni o delle addizioni, applica inizialmente una procedura generale,
quella del contare, nel considerare una coppia di numeri. Successivamente, in
seguito alla ripetizione pratica, egli memorizza conoscenze su particolari
coppie di numeri: il bambino può richiamare dalla memoria le specifiche
risposte a specifiche combinazioni di numeri per quanto, se necessario, possa
tornare alla procedura generale del contare.
Egli propone l’esempio di una corsa fra l’algoritmo che definisce lo
svolgimento del compito e il processo della memoria che ripesca le
conoscenze di base immagazzinate in passate esperienze: «La performance
è automatica quando la memoria vince la corsa» (Logan, Taylor e Etherton,
1996). L’automatismo è quindi un aspetto della memoria ed è l’attenzione che
codifica gli input e li riporta in primo piano, una volta memorizzati (teoria
dell’esempio – instance theory).
In realtà non esistono azioni puramente automatiche e azioni puramente
controllate. In ogni nostra azione, anche la più automatizzata, c’è una
componente attentiva e cosciente. Nessuna azione, per contro, può essere
portata a termine senza un qualche tipo di automatismo: infatti, se dovessimo
prestare attenzione a tutto ciò che facciamo saremmo lenti, incerti, impacciati.
Schneider e Fisk (1982) scoprirono che due compiti potevano essere svolti
bene, dopo una certa pratica, sia separatamente che contemporaneamente
qualora fossero di diversa tipologia (uno automatico e l’altro controllato),
mentre due compiti che prevedono l’utilizzo dell’elaborazione controllata non
possono dare risultati efficienti se eseguiti insieme.
Cerchiamo di capire in che modo un’azione automatica si svolge fuori dal
controllo attentivo. Dobbiamo per questo occuparci di comportamenti
cosiddetti superappresi: consideriamo la lettura. Quando impariamo a
riconoscere dei simboli (le lettere dell’alfabeto) e ad assegnare loro un suono
procediamo molto lentamente. Nella fase successiva dobbiamo combinare i
simboli per leggere le parole, e anche in questa fase i passi sono lenti. A
mano a mano che ci esercitiamo diventiamo sempre più veloci e precisi, fino a
riuscire a capire in poco tempo il contenuto di un brano. Arrivati a questo
punto l’attività di lettura è automatizzata e può svolgersi addirittura fuori dalla
portata della nostra coscienza e attenzione. Ne è una prova il cosiddetto
effetto Stroop (1935), al cui successivo esercizio rimandiamo, che dimostra
che un’attività altamente automatizzata come la lettura viene innescata non
solo all’insaputa del soggetto ma addirittura contro la sua volontà. È da tener
presente però che i processi che innescano l’effetto Stroop sono in qualche
modo evitabili (Kahneman e Henik, 1979) e dunque non perfettamente
automatici. Ad esempio, l’utilizzo in questo test di parole di due lingue diverse,
quella nativa e un’altra appresa dal soggetto, indica che l’effetto Stroop non è
riducibile qualora la parola sia scritta in una lingua straniera, mentre è
maggiormente controllabile se essa è scritta nella lingua nativa (Tzelgov,
Henik e Leiser, 1990).
Una teoria completamente diversa circa l’automatismo dell’elaborazione è
quella proposta da Norman e Shallice (1980) e Shallice (1982). Essi
intendono identificare i diversi livelli di funzionamento dell’elaborazione,
piuttosto che i suoi diversi tipi di controllo:
• completo automatismo, guidato da
organizzati, utilizzato in situazioni abituali;
schemi predefiniti o piani
•
parziale automatismo, privo di controllo totalmente cosciente ma dotato
di un processo di confronto o catalogazione competitiva (contention
scheduling) che viene utilizzata per appianare conflitti fra schemi, sulla base
di priorità e informazioni contingenti;
• controllo cosciente di supervisione (supervisory attentional system),
temporaneo, modificabile e limitato dalla capacità attentiva.
3.6 ERRORI COMPORTAMENTALI
Sarà capitato a tutti di andare in una stanza per prendere un oggetto, fare
qualcos’altro e tornare senza niente in mano, oppure di non mettere l’acqua
nella macchinetta del caffè. Questi errori non sono dovuti al cattivo
funzionamento della propria mente ma sono comuni fenomeni di
disattenzione. Sono state proposte varie forme di classificazione, ma è
possibile fare riferimento allo sviluppo parallelo degli studi di Reason (1979,
1984) e di Norman (1981, 1988) che, con il termine di action slips o lapsus,
definiscono in generale l’esecuzione di un’azione non voluta. «Uno slip è un
errore che si produce quando una persona fa un’azione che non era nelle sue
intenzioni» (Norman, 1981).
Secondo questo studioso lo svolgimento di un’azione è dettato dallo
schema di attivazione-produzione (activation-trigger schema) in cui esiste una
organizzazione gerarchica composta dall’intenzione, dalla quale dipende la
scelta delle conoscenze da attivare, l’attivazione delle conoscenze, cioè il loro
richiamo dalla memoria e l’essere pronti a metterle in pratica, e infine l’inizio
dell’azione, il prendere la decisione di agire e iniziare l’esecuzione vera e
propria.
Gli errori possono essere attribuiti a una formulazione inadeguata
dell’intenzione, a una elencazione generica o lacunosa delle azioni da
compiere: cercare la leva di avanzamento del rullo in una macchina da
scrivere elettrica, significa aver dimenticato di trovarsi in un contesto diverso
da quello generalmente valido nell’utilizzo della macchina da scrivere
meccanica. Gli errori definiti di cattura o di attivazione non intenzionale
(capture slips) indicano che l’azione programmata secondo le intenzioni è
interrotta a causa di un elemento esterno (luogo, contesto, persone) che fa
compiere un’altra azione; entrare in camera per prendere un libro sul
comodino ma prepararsi per andare a letto ne è un esempio: l’ora tarda e la
«normalità» dell’andare a letto rispetto al cercare un libro possono essere
stati i fattori di distrazione nell’errore di cattura.
Un altro errore tipico dell’attivazione delle conoscenza è la perdita
dell’attivazione: l’azione è permeata da un basso livello di interesse tanto da
essere perfettamente dimenticata. E’ ciò che capita quando ci si reca in un
luogo della casa e, una volta giunti, ci si chiede che cosa si è andati a fare o
quando si versa dell’acqua in un bicchiere una seconda volta senza rendersi
conto di averlo già fatto in precedenza. Per quanto riguarda la fase di avvio,
l’errore avviene perché non si attua l’azione o la si attiva al momento
sbagliato.
Le distinzioni fatte da Reason sono abbastanza simili a quelle appena
descritte: la sua teoria dice che l’azione è originata da una spinta o bisogno,
cui segue l’intenzione, vale a dire la formazione di un progetto per il
conseguimento di un risultato; infine si verifica l’istruzione per agire o sistema
d’azione. È paradossalmente più facile che l’errore accada quando la pratica
e l’abilità sono già ben acquisite piuttosto che quando non si sappia cosa fare:
nel primo caso Reason parla di un controllo aperto (open-loop) che permette
un minor impegno dell’attenzione, data l’abitudinarietà, mentre nel secondo
caso la necessità di vedere cosa succede via via che si compie l’azione, il
feedback fornito dall’esito del suo parziale svolgimento, obbligano l’individuo a
usare un controllo a circuito chiuso (closed-loop), ossia una maggiore
attenzione in ciò che fa, evitando così l’errore o la dimenticanza.
La descrizione fatta dai soggetti cui lo studioso aveva chiesto di annotare
qualsiasi errore essi avessero compiuto durante un certo periodo di tempo
(metodo dei diari), gli permise di identificare questi tipi di errore:
• errori di immagazzinamento o difetti di archiviazione (40%): si tratta di
dimenticanza o non corretto ricordo dell’intenzione o dell’azione (non mi
ricordo se ho già zuccherato il tè);
• errori di controllo (20%): la sequenza delle azioni non viene sottoposta
a un sufficiente controllo (volevo fermarmi nel negozio di alimentari ma ne
ricordai troppo tardi; ero già arrivato a casa);
• errori di subroutine o difetti del sistema intenzionale (18%): gli stadi che
compongono la sequenza di azioni vengono omessi, riordinati o ne vengono
inseriti di nuovi (cerco di togliermi gli occhiali ma mi accorgo di non averli);
• errori di discriminazione (11%): non si è capaci di discriminare
esattamente tra oggetti-stimolo necessari al compimento dell’azione; sono
dovuti a confusione di attributi percettivi, funzionali, spaziali e temporali degli
stimoli (si stende la crema da barba sullo spazzolino da denti);
• errori di ricostruzione del programma o difetti del sistema d’azione
(5%): si tratta della combinazione inappropriata di una serie di azioni (scartare
un cioccolatino e mettere in bocca la stagnola).
Come si possono limitare le conseguenze negative dei lapsus?
Nella routine quotidiana, è più probabile compiere meno lapsus se
riceviamo appropriati feedback dall’ambiente: ad esempio, il posizionamento
degli oggetti per la rasatura in un contenitore su uno scaffale e quelli per la
pulizia dei denti in un altro contenitore posto su un altro scaffale, o un amico
che è in vostra compagnia potrebbe dirvi di fermarvi al supermercato prima di
andare a casa. Adottare modalità per ottenere feedback utili potrebbe ridurre
la probabilità di commettere errori. Norman evidenzia che un tipo di feedback
valido coinvolge le funzioni obbliganti (forcing functions): si tratta cioè di
creare dei vincoli fisici che rendono quasi impossibile eseguire comportamenti
automatici che possono portare ad un lapsus. Se dovete uscire di casa
portando con voi alcuni oggetti, potreste metterli davanti alla porta in modo da
bloccare l’uscita e non farvi uscire senza di essi.
2 -LA PERCEZIONE
2.4 GLI ENIGMI DELLA PERCEZIONE
Chi affronta per la prima volta lo studio della psicologia rimane di solito
sorpreso del fatto che questa materia si occupi di percezione: non ci si
aspetta, infatti, che lo psicologo sia interessato alla percezione visiva perché
risolvere i disturbi della vista è competenza dell’oculista. Questo è quanto ci
induce a credere il senso comune, ma possiamo facilmente dimostrare che
anche chi ha un’ottima vista può avere una percezione visiva molto lacunosa
o errata della realtà che gli sta di fronte. Quanto detto per la percezione visiva
vale, fatte le debite differenze, anche per gli altri tipi di percezione.
A tutti sarà capitato di cercare qualche cosa e di non riuscire a vederla pur
avendola davanti agli occhi; non si tratta di una circostanza eccezionale, frutto
di chissà quale ottenebramento della mente; è piuttosto la manifestazione
esasperata di una certa autonomia del mondo percepito rispetto al mondo
reale: quello che noi tutti vediamo, buona vista o qualche difetto a parte,
corrisponde in genere solo parzialmente a quello che esiste nella realtà e a
quello che viene registrato dal nostro occhio. Ciò che percepiamo può essere,
al contrario, particolarmente fedele a dispetto del fatto che gli occhi non sono
in condizione di registrare certe dimensioni, come ad esempio la profondità. Il
mondo, così come lo percepiamo, risulta molto meno distorto di quanto
saremmo indotti a credere considerando i limiti dei nostri organi di senso: un
mondo tridimensionale si proietta sulla retina e perde in questo modo la
corporeità perché si appiattisce su una superficie. Se teniamo anche conto
che essa è ricurva allora dobbiamo ricordare che tutto ciò che è rettilineo
viene distorto nell’occhio. È facile constatare che la penna che abbiamo in
mano ci appare diritta qualunque sia l’angolo o la prospettiva da cui la si
guarda.
Il primo problema che la psicologia deve affrontare è stabilire quali
differenze ci sono fra ciò che percepiamo e ciò che esiste nella realtà. Una
delle circostanze in cui tale differenza si manifesta in modo vistoso è data
dalle cosiddette illusioni ottico-geometriche. Nella figura 3 sono riprodotti
alcuni di questi casi.
Nell’illusione di Müller-Lyer due segmenti uguali appaiono di lunghezza
differente se ai loro estremi vengono disegnati dei segmenti obliqui: il
segmento compreso fra angoli convessi appare più corto. Nell’illusione di
Münsterberg dei segmenti verticali paralleli appaiono inclinati quando si
trovano compresi fra rettangoli bianchi e neri alternati.
Delle illusioni ottico-geometriche, semplici disegni che ingannano
l’osservatore sulle caratteristiche dei loro elementi, si può dare solo una
grossolana classificazione. Alcune di basano sulle nostre interpretazioni di
indici di profondità ambigui ed incoerenti; altre usano la nostra tendenza a
vedere gli oggetti della stessa grandezza indipendentemente dalla loro
distanza dall’osservatore, altre ancora comportano distorsioni nella direzione
degli elementi o nella grandezza degli angoli che gli elementi formano tra loro.
In altri casi ciò che percepiamo non è né distorto né lacunoso rispetto alla
realtà, anzi contiene qualche cosa in più. Il caso illustrato nella figura 4, noto
come completamento amodale, è forse quello più eloquente; infatti la figura
4a è formata da tre quadrati, ma è vista da chiunque come una
configurazione composta di due elementi: un quadrato bianco posto sopra un
rettangolo nero. In altre parole alcuni elementi presenti nella figura 4a, cioè i
due quadrati neri, vengono unificati a formare un’unica sagoma.
Nella figura 4b si vede chiaramente un quadrato sopra un cerchio. Non ci
sono assicurazioni sul fatto che la seconda sagoma sia un cerchio, ma è la
nostra percezione che la completa fino a farla diventare un cerchio
parzialmente nascosto.
Le figure presenti nel campo percettivo visivo tendono a completarsi dietro ad
altre che le nascondono parzialmente (effetto schermo); il termine “amodale”
significa che la presenza della parti nascoste si realizza comunque: esse
sono presenti percettivamente anche se non esiste corrispettivo fisico o
fisiologico.
Uno dei problemi che la psicologia della percezione ha affrontato già ai
suoi esordi è il seguente: ci sono differenti modi per unificare componenti
distinte; in questi casi, quali criteri vengono seguiti? Vediamo un secondo tipo
di unificazione, in questo caso «dinamica». Due luci vicine tra loro si
accendono e si spengono secondo una cadenza precisa: quando si spegne la
prima l’altra si accende, e non vediamo due luci ma una sola luce che si
sposta rapidamente dal posto in cui si trova la prima al posto in cui si trova la
seconda. Questo movimento, che non è reale ma puramente «mentale», è
detto movimento stroboscopico. Anche in questo caso si opera
un’unificazione, perché al posto di due luci che si accendono e si spengono
con intermittenza si vede una luce sola, costantemente accesa, ma in
movimento.
Altre particolarità della percezione visiva confermano il fatto che esse
hanno «qualche cosa in più» non rispetto al mondo esterno ma rispetto al
«mondo dei sensi».
Con questo termine intendiamo la fotografia della realtà costruita dagli
organi di senso, nel caso specifico dall’occhio. Esso non può trasmettere al
cervello una riproduzione fedele della realtà per un fatto molto semplice: può
«inquadrare» la realtà solo da una particolare angolazione (e quindi molti
oggetti e dettagli possono risultare nascosti) e ne dà una rappresentazione
«piatta». Con questo aggettivo si intende qualificare una rappresentazione
bidimensionale, cioè una riproduzione su un piano di qualche cosa che si
trova in uno spazio tridimensionale. Sulla parete interna dell’occhio (retina)
una realtà tridimensionale viene schiacciata e deformata.
Oggetto di interesse degli psicologi è la constatazione, di cui abbiamo
parlato poc’anzi, della capacità della mente di andare oltre i limiti imposti
dall’anatomia e che le distorsioni dell’occhio vengono corrette dal cervello. Noi
vediamo una realtà tridimensionale e non piatta, e non vediamo certe
deformazioni prospettiche che caratterizzano ad esempio fotografie e disegni,
cioè riproduzioni bidimensionali simili a quelle che giacciono sulla retina.
Vedremo di capire come la mente, o il sistema visivo, riesca a superare
queste limitazioni; ci saranno delle dimostrazioni riguardanti la costanza
percettiva, la percezione del movimento stroboscopico, la disparità retinica e
così via.
Questa capacità di vedere qualche cosa in più rispetto a ciò che è visto
dagli occhi è una capacità di cui l’essere umano dispone fin dalla nascita e
che non si ottiene tramite l’esercizio. Non è escluso, tuttavia, che la nostra
mente riesca a «vedere più in là» anche in virtù dell’esercizio. In altri termini il
mondo percepito dalla mente contiene sia configurazioni che si impongono in
forza di principi innati sia configurazioni che traggono origine dalle
esperienze, dagli sforzi di impadronirsi delle leggi che rendono l’ambiente
prevedibile in tutto o in parte.
In che modo l’esperienza ci insegna a vedere? Il caso più comune è quello
del riconoscimento: individuiamo, in mezzo a molti stimoli, delle configurazioni
che ci sono familiari, ad esempio la sagoma di una persona in una situazione
confusa, di notte, nella nebbia, ecc. Oppure individuiamo delle lettere
dell’alfabeto o delle parole scritte su una superficie in cui ci sono molti altri
segni. Addirittura noi vediamo qualcosa di familiare anche in una situazione in
cui appaiono solo elementi confusi e casuali: sarà capitato a tutti di vedere in
una nuvola una sagoma familiare o sulla cresta delle montagne il profilo di un
volto umano. Questa capacità da parte della mente di imparare a riconoscere
e di attribuire significati influenza in modo determinante la nostra condotta ed
è alla base di attività complesse come la lettura. Leggere non è altro che
riconoscere dei segni, ma richiede molto esercizio; è bene sottolineare
tuttavia che durante l’esercizio non solamente si «sveltisce» l’operazione di
riconoscimento o la si rende più precisa, ma si perfeziona un vero e proprio
piano di esplorazione percettiva dello scenario entro cui agiamo, che può
essere la semplice pagina di testo oppure tutto il contesto della nostra azione.
Che significa esattamente questo? In parole semplici un buon lettore non è
solamente colui che riconosce velocemente le lettere dell’alfabeto e
altrettanto velocemente le mette insieme per individuare parole e frasi. La sua
abilità consiste principalmente nel guardare in modo «mirato» il materiale che
ha di fronte per cercare in esso ciò che è più significativo, quelle parole che in
misura maggiore di altre determinano il significato della frase o del testo.
Perciò un buon lettore non è colui che scorre velocemente le righe
registrando puntigliosamente ogni carattere, bensì «l’esploratore attivo» in
grado di anticipare in qualche misura il contenuto del testo e di cercarvi gli
elementi di novità. La lettura perciò è l’esempio più significativo del modo in
cui «impariamo a guardare».
Questo apprendimento è una modalità complessa di interazione con
l’ambiente che permette a ognuno di noi di guardare in modo utile, funzionale,
produttivo ma, spesso, anche errato. Più che guardare, e cioè registrare
passivamente la presenza di certi particolari nell’ambiente, si studia
l’ambiente, si cerca di individuarvi configurazioni generali o organizzazioni di
insieme, lo si confronta con esperienze precedenti e lo si esplora in particolari
zone. È questo uno degli aspetti più importanti dell’attività cognitiva e verrà
trattato quando più avanti parleremo di attenzione.
Il modo in cui osserviamo l’ambiente nel quale si svolge la nostra attività è
guidato in buona parte dalle nostre conoscenze, e a volte esse inducono delle
aspettative così forti da farci credere di avere visto realmente ciò che invece è
frutto delle nostre previsioni o convinzioni. Tuttavia, parlare di stretto rapporto
fra percezione e conoscenza significa parlare di memoria oltre che di
attenzione. È bene perciò non dimenticare l’originario programma di chi avviò
quell’importante settore di studi noto come Human Information Processing
(elaborazione dell’informazione nell’uomo): i processi cognitivi sono un
intreccio di memoria, percezione, attenzione, linguaggio; distinguere il ruolo
dell’uno senza tener conto di quello degli altri è una forzatura che può
impedire di rilevare importanti relazioni e interdipendenze fra i processi
cognitivi.
2.5 VISIONE MONOCULARE E BINOCULARE
Abbiamo già detto che la visione monoculare è quella che in realtà si forma
nei nostri organi di senso, ma come è possibile «vedere» il mondo
tridimensionale? Gli indizi di profondità, monoculari o binoculari, ci aiutano a
dare una risposta. I primi, basati sull’informazione che proviene da un solo
occhio, sono ad esempio l’accomodazione (la messa a fuoco dell’oggetto), la
sovrapposizione, il chiaroscuro (spesso usati nelle rappresentazioni pittoriche)
e tendono a definire la percezione della profondità; i secondi rappresentano il
mezzo per definire la distanza dell’oggetto dal piano visivo o da un altro
oggetto e permettono di percepire la tridimensionalità e la profondità.
Si chiuda un occhio, si osservi intorno, poi lo si apra: che differenze si
riscontrano? Si faccia eseguire la stessa semplice prova a un’altra persona e
le si chieda se trova delle differenze. Quali differenze ci si dovrebbe aspettare
di evidenziare tra la visione monoculare e la visione binoculare?
Per capire alcune di queste differenze si eseguano le seguenti prove.
• Si chiuda l’occhio destro. Si fissi un oggetto posto a qualche metro di
distanza, si prenda una penna e, tenendola dritta davanti all’occhio, si faccia
in modo che si sovrapponga all’oggetto fissato. Ora si apra l’occhio destro e
si chiuda l’occhio sinistro. La penna non è più allineata con l’oggetto. In che
direzione è spostata e perché?
• Si rifaccia questa prova con i due occhi aperti. Si punti verso l’alto l’indice di
una mano tenendolo davanti agli occhi a 15-20 cm. Si tenga con l’altra
mano una penna in verticale a una distanza di 40 cm e la si sposti verso
destra o verso sinistra fino a quando appare allineata con il dito. Ora si fissi
il dito: la penna è scomparsa completamente dietro di esso?
Si sposti adesso lo sguardo sulla penna, sempre tenendo dito e penna alla
stessa distanza. Il dito riesce a nascondere la penna? Si ponga la massima
attenzione a ciò che si vede.
• Si tenga la penna a 40 cm. Le si sovrapponga l’indice dell’altra mano: a
questo punto la penna appare nascosta. Ora, sempre tenendo la penna al
suo posto, si avvicini lentamente il dito al naso. La penna riappare dietro al
dito?
Si confrontino le proprie osservazioni con i seguenti commenti forniti da un
altro soggetto.
«Quando fisso il mio dito vedo due penne, una a destra e l’altra a sinistra
del dito».
«Quando fisso la penna mi pare di vedere due dita e la penna in mezzo a
loro. Se avvicino il dito alla penna questa sparisce dietro. Quando lo avvicino
al naso è come se comparissero due penne ai lati del dito».
Perché si ha la percezione sdoppiata di alcuni oggetti? Da cosa dipende?
Le immagini doppie non sono il frutto di stratagemmi particolari ma sono
presenti in tutte le normali condizioni in cui si ha la visione binoculare.
2.7 PROCESSI PRIMARI E SECONDARI:
DUE MODI DI ANDARE OLTRE L’INFORMAZIONE DATA
Abbiamo già messo in luce il fatto che l’immagine del mondo che si forma
nella nostra mente non coincide interamente con il mondo reale né con
quanto viene inviato dall’occhio al cervello. Alcune di queste differenze
consistono in elementi aggiuntivi rintracciabili nel mondo percepito: in altre
parole il mondo come appare a noi ha delle proprietà «in più». Kanizsa (1980)
parla di «modi di andare oltre l’informazione data» e ne distingue due tipi:
primari e secondari. La distinzione è adottata per mettere in luce la differenza
della loro origine che nel caso dei secondari è rintracciabile nella pratica,
nell’esercizio, nell’apprendimento, nella memoria, nel ragionamento. I modi
primari invece rappresentano forme di completamento e di integrazione che
non sono apprese ma «innate».
Le strutture primarie sono più «potenti» di quelle apprese perché formano
l’organizzazione fondamentale e su di esse possono prendere forma altre
organizzazioni; le strutture secondarie possono essere cancellate da quelle
primarie, ma non può succedere il contrario.
2.5.1. Processi primari
Un modo particolare di andare oltre l’informazione data è l’interpolazione
percettiva. Essa comprende, ad esempio, il fenomeno del completamento
visivo nel punto in cui c’è la macula cieca. C’è infatti una parte della retina
nella quale non esistono fotorecettori perché da lì si dipartono le innervazioni
del nervo ottico (è in posizione eccentrica di 13-19° in direzione nasale).
Ci si ponga il libro di fronte a una distanza di 40 cm, si chiuda l’occhio destro
e si fissi con l’altro il cerchio nero in questa pagina: con la coda dell’occhio si
vedrà anche la croce. Si faccia attenzione a essa e si cominci ad avvicinare il
libro al viso tenendo sempre l’occhio fisso al cerchio. Che cosa si vede? Si
provi ora ad allontanare il libro. Che cosa si vede?
Se si avvicina il libro agli occhi a un certo punto la croce scomparirà ma,
se si continua il movimento di avvicinamento, riapparirà. Se si inverte il
movimento, a un certo punto essa scomparirà perché la sua proiezione cade
sulla macula cieca. Normalmente non si vedono sparire gli oggetti che si
proiettano sulla macula perché interviene un fenomeno di interpolazione
percettiva (primario).
Kanizsa dà risalto a un’altra forma di completamento, il completamento
amodale, già descritto poco fa con l’unificazione dei due quadrati neri, che è
opera di processi primari, non appresi, né volontari.
2.8 COMPLETAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO
Possiamo vedere la differenza fra processi primari e secondari in questo
esempio, che Kanizsa discute come esempio di processi primari che possono
eliminare l’ambiguità.
Nel primo disegno (figura 6) qualcuno vede il numero 13, qualcun altro la
lettera B. Il completamento amodale fa vedere la B, mentre le nostre
conoscenze possono accettare un 13 o una B a seconda del contesto in cui si
trova il segno ambiguo (secondo e terzo disegno).
La differenza fra le due «operazioni» con le quali si elimina l’ambiguità è
molto importante. Nel primo caso la B «emerge» per effetto di principi di
organizzazione non appresi. Nel secondo e nel terzo caso deriva
dall’applicazione di nozioni apprese.
2.9. FIGURA E SFONDO
Quando osserviamo una scena individuiamo e riconosciamo delle sagome
che possiamo descrivere con maggiore o minore precisione. Esse sono
alcune fra quelle che si disegnano sulla nostra retina: questa selezione è
l’effetto di differenti fattori. Si tratta di importanti fattori di tipo esclusivamente
«figurale», come quelli che permettono alle figure più piccole di emergere,
rendendo molto difficile l’emergere delle figure più grandi (figura 7).
Di una scena, diventano figure le parti cui destiniamo maggiore attenzione:
mentre leggete queste righe, le parti del campo visivo circostanti, anche se
ben visibili, non assumono lo stesso «rilievo», tanto che vi può sfuggire il
verificarsi di loro cambiamenti. Ad esempio, se stiamo osservando con
attenzione una persona che sta arrivando, incerti della sua identità, può
passare inosservata un’altra persona che ci ha fatto un cenno di saluto.
Il rapporto che esiste fra figura e sfondo è complesso. Vediamo la figura e
non lo sfondo, eppure non può esistere una figura senza sfondo. L’esempio
che di solito viene portato a dimostrazione è l’arcinota figura di Rubin (profili di
due volti umani bianchi posti uno di fronte all’altro) in cui si possono vedere
due profili naso contro naso, oppure un vaso i cui contorni sono esattamente i
due profili simmetrici. O si vede l’uno o gli altri, non entrambi; ovvero, le linee
simmetriche possono essere il confine di una sola figura, non di due, perché
da una parte del confine c’è la figura, dall’altra lo sfondo.
Lo studio del fenomeno figura-sfondo ha portato le seguenti conclusioni:
a) tendono ad essere viste come figura le parti del campo più chiare,
quelle convesse, quelle circoscritte, le più regolari, quelle orientate
nelle direzioni dello spazio orizzontale e verticale;
b) il confine che sta tra due diverse figure appartiene solo all’area che si
realizza come figura e di essa costituisce il margine o contorno
(funzione unilaterale dei margini).
2.10 L’ORGANIZZAZIONE FIGURALE
Abbiamo visto che l’esistenza unitaria di oggetti unitari in campo fisico non si
giustifica necessariamente con quelle dei corrispondenti oggetti fisici e che il
segmentarsi del campo in parti col carattere di figura e in altre col carattere di
sfondo obbedisce a precise condizioni di stimolazione. Wertheimer (1923) ha
studiato i principi secondo cui gli elementi del campo visivo si aggregano
spontaneamente in un tutto.
Alcuni dei principali fattori di organizzazione sono: la vicinanza, la
somiglianza, la chiusura, al continuità di direzione e l’armonia di forma.
Vicinanza - La figura 10a consta di un insieme di punti (un campo omogeneo)
che non lasciano distinguere alcunchè.
Figura 10°
E’ sufficiente tuttavia una diminuzione delle distanze tra i punti, che si traduce
in una loro maggiore densità, (figura 10b) per fare assumere il ruolo di figura
alla zona delimitata da margini che sono tra loro più vicini.
Questo ci aiuta a distinguere, all’interno di un vasto insieme di elementi, un
insieme meno numeroso di componenti.
Figura 10b
Somiglianza - Se al posto di operare degli spostamenti, modifichiamo il colore
di alcuni punti, pur rimanendo questi perfettamente equidistanti tra loro, della
stessa grandezza e forma, essi si configurano in colonne verticali o righe
orizzontali. Gli elementi che possiedono un qualche tipo si somiglianza
tendono ad unificarsi tra di loro.
Questo ci aiuta a distinguere tra due oggetti adiacenti o sovrapposti in base
alle differenze di tessitura o grana visiva.
Figura 11
Continuità - E’ il principio per cui in figura 12. vediamo due linee continue
composte da a-b e c-d anzichè quattro segmenti o linee spezzate. Questo ci
permette di decidere a quale oggetto appartiene una determinata linea, nel
caso in cui due o più oggetti si sovrappongano.
d
a
c
b
Figura 12
Chiusura - Potete vedere il disegno della figura13 in due modi: considerando
la parte concava si vedono 3 O, considerando quella convessa si formano tre
X). L’aggregazione in tre “O” non è più determinata dalla vicinanza e dalla
somiglianza ma in virtù del principio di chiusura.
Figura 13
Noi quindi tendiamo a vedere le forma come delimitate da un margine
continuo e a non riconoscere le eventuali interruzioni di tale continuità.
Questo ci aiuta a percepire le forme come complete anche quando sono
parzialmente nascoste da altri oggetti.
Movimento comune - Se i puntini della figura 14, contrassegnati da una
freccia, si muovessero insieme verso la stessa direzione, li percepiremmo
come un unico oggetto ce si sposta. Questo ci permette di distinguere un
oggetto in movimento dallo sfondo.
Figura 14
Armonia di forma - Il nostro sistema percettivo ha la tendenza ad elaborare
produzioni percettive nella forma più elegante possibile: ordinate, semplici,
regolari e simmetriche.
Questo fa sì che la figura di sinistra abbia più probabilità di apparire come un
unico oggetto rispetto a quella di destra, percepita come l’insieme di due
oggetti sovrapposti.
Figura 15