
Organizzazione, controllo e gestione di
una Terapia Intensiva di Cardiochirurgia
Ciro Scognamiglio
(Rianimazione di Cardiochirurgia)
A.O.R.N. ”V. Monaldi” di Napoli
Azienda di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
Si definisce tale l’Ospedale che possiede
almeno tre strutture di alta specialità
organizzate in aree funzionali omogenee con
un’organizzazione dipartimentale dei servizi
(DMS 29/01/1992)
CARDIOCHIRURGIA
Sala da Risveglio
Terapia Intensiva
Rianimazione
Area Critica
Che valuta la criticità dell’ospite in
tutte le sue manifestazioni
Marketing competitivo
Studio delle esigenze di mercato
Programmazione delle esigenze di mercato
Contesti concorrenziali definiti
Rapporto migliore con la clientela
Adeguamento alle esigenze clienti/utenti
Proiettare l’immagine verso un consenso e
una credibilità
Marketing relazionale
Elasticizzare l’offerta in base alle
modificazioni socio-antropologiche del
bacino d’utenza
Considerare l’area geografica di
appartenenza
Rivalutare le risorse umane e strutturali
Benchmarking strategico
(rapporti relazionali)
Riduzione degli attriti per i cambiamenti
Adozione di pratiche innovative
Crescita della responsabilizzazione
Coinvolgimento dei dipendenti
Benchmarking strategico
(rapporti gestionali)
Crescita della competitività
Definizione di progetti
Aumento degli indici di soddisfazione
Sviluppo della qualità (sotto tutte le forme)
Dalle categorie alla catena
Dalle categorie di identificazione citate, si
passa alla catena del valore cioè le attività
primarie della struttura (Pronto Soccorso,
Accettazione, Degenze mediche, Degenze
chirurgiche, Prestazioni ambulatoriali, Day
Hospital)
Chi accede alla struttura?
Patologie valvolari
Patologie coronariche
Patologie da dissezioni
Patologie aneurismatiche
Patologie da dilatazione cardiaca (trap.)
Indagini strumentali cruenti
118
Interdisciplinarietà
Per le enormi professionalità afferenti, il
centro diventa riferimento per le attività di:
Cardiologia
Emodinamica
Elettrostimolazione
Chirurgia vascolare (e generale)
Diagnostica invasiva
Infezioni ospedaliere?
Il coefficiente di infezioni ospedaliere non
può oscillare oltre il range dato dall’OMS.
In considerazione dei periodi “caldi” l’OMS
considera ottimale una oscillazione tra il 5%
e il 7%
Il nostro centro, per l’anno 2003, ha potuto
vantare valori più bassi
Un incubo lungo una notte!
L’attività chirurgica e l’alta tecnologia necessaria per
assistenza in Terapia Intensiva sviluppano criteri
di emarginazione dati dalla somma dell’esclusione
e dell’elusione manifestando:
Delusione
Insoddisfazione
Agitazione
Insofferenza
Il potere della “non”
integrazione
Dal MOBBING al BURNOUT
Obiettivi assistenziali
Individuazione della patologia
Applicazione dei processi terapeutici
> terapia funzionale
> dimensione relazionale
Filosofia del Nursing
Abdellah
Adam E.
Bizier N.
Henderson V.
Johnson
King
Levine
Nightingale Florence
Orem D.
Orlando
Parse R.R.
Peplau
Riehl
Rizzo Rosemary
Rogers
Roy
Travelbee
Wiedenbach
Crazy List
1937 John Everything
1941 Paul Explainable
1959 Mitchell Is One
1963 Patty Foolishness
1972 Pitt Among So
Many
1984 Arnold Questions
Ogni cosa
spiegabile
è una
sciocchezza
fra tante
domande
Bisogni
MASLOW
> fisiologici
> sicurezza
> sociali
> stima
> autorealizzazione
Bisogni
HARRINGTON
Consapevolezza e delega
Impegno e coinvolgimento
Partecipazione e leadership
Dalla parola alla storia
Malato
> Degente
>> Paziente
>>> Utente
>>>> Cliente
CLIENS = Cliente
Nell’aziendalizzazione si parla di
cliens (che si mette sotto la
protezione di qualcuno) dalla parola
latina che riporta al nostro “cliente”
Processi
I processi sono rappresentabili come
alberi della qualità
Sistema del tutto
compensativo
L’infermiere si sostituisce del tutto al
paziente compensando le attività che
il paziente non è in grado di effettuare
Sistema in parte
compensativo
L’infermiere interagisce con le
capacità limitate del paziente
Sistema educativo di supporto
L’infermiere diventa educatore per il
corretto reinserimento del paziente
nella società
Tipi di intervento
Fisioterapici
Analgesici
Psico-sociologici
Antropologici
Di controllo:
farmaci
dieta
Monitorizzazione e controllo del
paziente in Rianimazione di
Cardiochirurgia
Dall’accettazione alla dimissione
Accoglienza
Completato l’intervento l’ospite viene
accompagnato al modulo di Terapia
Intensiva con assistenza respiratoria
continua ed infusione di farmaci
inotropi mediante pompe elettriche
computerizzate
Accoglienza
All’accoglienza dell’ospite
provvederanno :
Un cardiochirurgo
Un anestesista
Due infermieri
Controllo immediato
Uno dei due infermieri avrà cura di :
Registrare l’ospite
Preparare la documentazione
Richiedere un Rx torace
Praticare un ECG
Praticare una emogasanalisi
Controllare l’esatta monitorizzazione del paziente
EMOGASANALISI
Ph
Pco2
Po2
Hco3
SBC
Hb
Ht
K
Na
Ca
Cl
Gluc
Monitoraggio
L’infermiere ha in gestione gli apparecchi per
monitorare :
L’attività elettrica del cuore
La respirazione
Il bilancio idro – elettrolitico
La diuresi
cioè le funzioni vitali che potrebbero risultare
compromesse
Monitoraggio
L’infermiere è la prima persona che deve
sapere cogliere ogni segno di miglioramento
o di peggioramento
L’osservazione del paziente critico dipende
da un nursing attento, da una valutazione
costante, da un controllo critico degli
strumenti ad esso connessi
Monitoraggio
L’infermiere deve avere:
Alto livello di preparazione
Alto livello di conoscenza
Preparazione adeguata
Preparazione responsabile
Psicologia
(dolore reale e dolori nascosti)
L’infermiere:
Deve avere un atteggiamento adeguato
Essere pronto a comunicare
Avere risposte chiare e comprensibili
Rispettare gli ideali del paziente
Deve considerare la persona in tutte le sue
dimensioni
Essere al centro di una società multi – etnica
Piano Assistenziale
In Terapia Intensiva è indispensabile
formulare un piano assistenziale :
Che non sia vincolato a stantii protocolli
Che tenga conto dei diversi monitoraggi
Che sia rispondente ai bisogni di igiene e
cura posturale
Che sia di prevenzione alle infezioni
Piano Assistenziale
Il piano assistenziale comprende il periodo
di assistenza tra la pre-estubazione e la postestubazione
Ha cura della corretta gestione del tubo
endotracheale
Considera la corretta somministrazione
della terapia
Assistenza pre-estubazione
Nell’immediato post-operatorio il paziente si
presenterà con i seguenti presidi:
Tubo orotracheale
Catetere venoso centrale
Due o più vie di infusione periferiche
Due drenaggi mediastinici e, all’occorrenza,
uno o due drenaggi pleurici
Assistenza pre-estubazione
Una via arteriosa
Il catetere vescicale
Il sondino naso-gastrico
Due o quattro elettrodi intra-cardiaci
collegati ad un pace-maker provvisorio
Assistenza pre-estubazione
Cosa occorre fare all’arrivo del paziente in
Terapia Intensiva?
Collegamento al respiratore automatico in
MMV
Monitoraggio continuo della pressione
arteriosa (PA), della pressione venosa
centrale (PVC), elettrocardiografico (ECG)
e della temperatura centrale e periferica
Assistenza pre-estubazione
Collegamento dei drenaggi al sistema di
aspirazione
Controllo delle perdite ematiche e della
funzione respiratoria
Monitoraggio orario della diuresi e del
bilancio idrico
Collegamento degli elettrodi temporanei al
pace-maker esterno
Assistenza pre-estubazione
Esecuzione su carta di un ECG completo
Verifica pervietà del drenaggio gastrico
Monitoraggio dell’equilibrio acido-basico e
della ventilazione polmonare, fatto con
prelievo dalla linea arteriosa, da eseguire
con regolarità
Esecuzione di Rx torace non appena i
parametri emodinamici si siano stabilizzati
Assistenza pre-estubazione
Broncoaspirazione al bisogno
Verifica della pervietà del circuito
respiratorio interno (controllare che il tubo
oro-tracheale non sia ostruito da coaguli o
secrezioni o non sia “sposizionato”)
Manutenzione delle vie venose e arteriose
Assistenza pre-estubazione
Controllare il corretto funzionamento delle
pompe elettriche computerizzate per
l’infusione di farmaci inotropi
Programmare l’esecuzione di un prelievo
venoso per gli esami ematochimici con
attenzione agli indici della coagulazione e
delle infezioni
Estubazione
1.
2.
3.
L’estubazione, o deconnessione del
paziente dal ventilatore automatico, è una
manovra difficile e delicata che deve tener
conto delle condizioni del soggetto nella
sua globalità
Guanti sterili
Siringa monouso
Sondino per broncoaspirazione
Estubazione
(eventuali problemi)
Agitazione del paziente
Broncostenosi
Tubo orotracheale ostruito da secrezioni
Presenza di sangue
Tubo orotracheale non in sede
Tubo orotracheale bloccato dal sondino
naso-gastrico
Tubo oro-tracheale
Il tubo oro-tracheale :
E’un cilindro aperto da entrambi gli estremi
con una curvatura anatomica
E’ provvisto di una cuffia nella parte distale
che lo fissa alla trachea
Nella parte prossimale, che sporge dalla
bocca, lo collega al respiratore artificiale
con una miscela di gas tra 50% e il 60%
Intubazione
L’intubazione provoca condizioni
fisiologiche nuove alterando il
riscaldamento e l’umidificazione dei gas
ispirati e il normale drenaggio delle
secrezioni tracheo-bronchiali
Indipendentemente dalle condizioni che
hanno reso necessaria la manovra, la
sorveglianza dovrà essere costante e attenta
Intubazione
(complicanze)
Estubazione accidentale
Mancata tenuta della cuffia
Ostruzione del tubo tracheale per secrezioni
o sanguinamento
Morsicatura o inginocchiamento del tubo
per compressione sulla parete
Intubazione
(problematiche)
Le problematiche, favorite da fattori locali
dovuti al materiale usato, alle metodiche di
connessione al ventilatore e a quelle di
nursing, sono:
Edema della glottide,broncospasmo
Disfonia, disfagia
Faringiti, laringiti
Fistole (specie nei pazienti lungodegenti)
Intubazione
(controllo)
La manovra terapeutica che può garantire il
fine ottimale dell’intubazione è la tracheobroncoaspirazione che consente la
rimozione delle secrezioni presenti
nell’albero bronchiale.
Due infermieri
Un infermiere e un medico
Rx torace
Ufficializza uno “status” iniziale
Valuta una patologia di base nel suo decorso
o nelle sue complicanze
Visualizza la posizione dei tubi di
drenaggio, cateteri, punti sternali,
pneumotoraci, altro……
Rx torace
(difficoltà)
La difficoltà è quella di eseguire l’esame
radiografico nella posizione più corretta
possibile e di fare assumere, al paziente, la
stessa posizione nei successivi controlli.
Da ricordare: dare al paziente una posizione
eretta per evidenziare un pneumotorace
sospetto o un versamento pleurico (aria
verso l’alto e liquido verso il basso)
Rx torace
(limiti ed errori)
Nonostante i protocolli e le indicazioni mirate,
i limiti e gli errori di un torace a letto sono:
Potenza limitata
Una distanza breve tra tubo e film
Identificazione errata della silhouette
cardiaca data dalla posizione supina
Rx torace
(limiti ed errori)
Sforzo inspiratorio ridotto
Maggiore insufflazione polmonare data dal
ventilatore
Sposizionamento del tronco
Errata attribuzione del radiogramma
Linea arteriosa
Consente di monitorare la pressione
arteriosa sistemica
Consente di eseguire prelievi ematici per i
controlli emogasanalitici, ematochimici e
colturali
Linea arteriosa
E’ una via di accesso arterioso diffusa per la facile
reperibilità e per la presenza di anastomosi con
l’arteria ulnare
Il catetere deve essere controllato per verificare
l’eventuale presenza di fenomeni ischemici e il
corretto funzionamento del sistema
Si provvederà alla sua disinfezione periodica
Linee di infusione
Il paziente si presenta con , almeno, tre vie di
infusione:
Due periferiche
Una giugulare sinistra
Linee di infusione
(giugulare sinistra)
Incannullata con un catetere a tre vie, viene
utilizzata per:
Infusione dei liquidi relativi al fabbisogno
idrico e calorico quotidiano
Somministrazione della terapia endovenosa
Misurazione della pressione venosa centrale
(PVC)
Infusione di farmaci inotropi
Linee di infusione
(giugulare sinistra)
La velocità di infusione dei liquidi non deve essere
inferiore a 10ml/h per non favorire un habitat
batterico ed è preferibile usare una pompa
peristaltica
Cambio dei rubinetti, filtri, tappini e deflussori
ogni 24 ore
Attenzione all’utilizzo contemporaneo di farmaci
non compatibili tra loro (Perfan!) e specificare il
nome e la concentrazione su ogni pompa di
infusione
Vie periferiche
Utilizzate per infondere sangue,
emoderivati, liquidi di supporto (mai per
soluzioni contenenti potassio o inotropi a
concentrazione acida o oleosa!!)
Rimosse non appena si riterrà inutile avere
altre vie per eventuali situazioni critiche
Cateterismo vescicale
Il catetere vescicale è utilizzato per
monitorare la diuresi oraria e per lo
svuotamento della vescica nei pazienti che
vanno incontro a fenomeni di ritenzione
urinaria
Il più usato è il Foley il lattice fissato alla
vescica grazie al gonfiaggio di un
palloncino situato alla punta distale
Cateterismo vescicale
A livello prossimale sono presenti due vie:
Una per il gonfiaggio del palloncino
Una per la fuoriuscita dell’urina e che sarà
connessa al sistema di raccolta a circuito
chiuso
Cateterismo vescicale
E’ buona regola mantenere il catetere in sito
per breve tempo:
Sostituire il sacchetto di raccolta ad ogni
dubbio
Pulire il meato urinario con sostanze idonee
ogni giorno
Eseguire controlli colturali in situazioni
sospette e secondo protocolli
Drenaggio toracico
Il paziente presenterà due drenaggi
mediastinici e due pleurici per aspirare
eventuali raccolte ematiche nello spazio
pericardico e pleurico, per permettere una
riespansione polmonare e per impedire
eventuali tamponamenti cardiaci
Il sistema di aspirazione utilizza il dispositivo
monouso di raccolta chiamato Pleur Evac
Drenaggio toracico
Prevenire coaguli o “tappi” usando la
pratica definita “mungitura”
Medicare i punti di inserzione dei tubi ogni
giorno
Eventuali campioni di liquido raccolti
saranno controllati microbiologicamente
Drenaggio gastrico
Si arriva allo stomaco mediante un sondino
che sfrutta, come via di accesso, la via
nasale
Il drenaggio gastrico ha lo scopo di svuotare
lo stomaco del ristagno, di accumulo di aria,
di provvedere ad una alimentazione liquida,
di praticare una terapia orale altrimenti
impossibile
Monitoraggio
elettrocardiografico continuo
Si tratta del modello di controllo più diffuso.
La funzione cardiaca viene valutata:
In termini di frequenza cardiaca e ritmo
cardiaco
In valutazione della funzionalità del sistema
cardiaco di conduzione
Nel rilevare le alterazioni della frequenza
cardiaca in tempo reale
Monitoraggio
elettrocardiografico continuo
Nel rilevare le alterazioni del ritmo cardiaco
Nel fare una diagnosi rapida delle aritmie
pericolose o potenzialmente fatali
Monitoraggio della
temperatura
Sono due le temperature rilevate e studiate per
analizzare la situazione termica del
paziente:
La temperatura centrale che riflette la
situazione degli organi interni
La temperatura superficiale, o periferica,
che identifica lo stato di perfusione del
paziente
Monitoraggio della Pressione
Venosa Centrale (PVC)
Il monitoraggio elettronico della Pressione
Venosa Centrale (PVC) costituisce una
procedura fondamentale per ricavare utili
informazioni relative alle condizioni di
riempimento del ventricolo destro
Monitoraggio della Pressione
Venosa Centrale (PVC)
Incrementi della PVC possono aversi:
Nel cuore polmonare acuto (da embolia
polmonare)
Da infarto miocardico a carico del ventricolo
destro
Tamponamento cardiaco
Pericardite costrittiva
Valvulopatia tricuspidalica o polmonare
Aumento del ritmo venoso (da eccessiva infusione
di liquidi)
Monitoraggio della Pressione
Venosa Centrale (PVC)
La riduzione della PVC ci indicherà:
Diminuzione della volemia (emorragia,
perdita di liquidi corporei di varia natura)
Vasodilatazione venosa (con riduzione del
ritmo di sangue al cuore destro)
Tecnologia
Lo sviluppo tecnologico ci impone una
capacità di adattamento ai nuovi presidi ed
al loro corretto uso e gestione:
Swan-Ganz
Respiratore Domiciliare
Emofiltrazione
Picco
Contropulsazione Aortica
Swan - Ganz
Una volta inserito, il gonfiaggio del
palloncino farà apparire l’onda di pressione
incuneata PCP
Il rilievo del suo valore è un indice del
riempimento e del funzionamento delle
sezioni sinistre del cuore e serve per i
calcoli emodinamici
Respiratore Domiciliare
Ormai tutti i Respiratori Domiciliari
hanno le stesse caratteristiche degli
apparecchi in dotazione presso le
strutture ospedaliere
Respiratore Domiciliare
Assist Control Ventilation
(ACV) – il ventilatore
fornisce atti meccanici a
frequenza preselezionata
Intermittent Mandatory
Ventilation (IMV) – a
frequenza preselezionata
permette il respiro
spontaneo tra un atto
meccanico e l’altro senza
sovrapporsi alla
meccanica e riducendo il
rischio di alcalosi e
iperventilazione
Pressure Controlled
Ventilation (PCV) –
ventilazione con ciclaggio
a pressione
completamente controllata
dal ventilatore
Pressure Support
Ventilation (PSV) –
permette di determinare, al
paziente in respiro
spontaneo, il volume
dell’inflazione e la durata
del ciclo respiratorio
Respiratore Domiciliare
Positive end Expiratory
Pressure (PEEP) – Si
può aggiungere un
dispositivo limitatore di
pressione che arresta
l’espirazione al
raggiungimento di una
pressione preselezionata;
si può ventilare il
paziente con volumi di
inflazione elevati e
frequenze respiratorie
rapide (iperventilazione)
La PEEP migliora lo
scambio gassoso
diminuendo lo shunt
intrapolmonare e
aumenta la compliance
polmonare
Respiratore Domiciliare
Continuous Positive Airway
Pressure (CPAP) – E’ utilizzata per lo
svezzamento del paziente dal
respiratore automatico poco prima
della sua estubazione e può essere
erogata anche attraverso maschere o
caschi con valvole pressurizzate
regolabili per evitare l’intubazione
Emofiltrazione
Sfrutta la differenza di pressione che
permette al soluto di attraversare una
membrana (come avviene nel
glomerulo renale). Più facilmente
passa l’acqua (ultrafiltrato) che
contiene prodotti del metabolismo,
elettroliti e aminoacidi
Picco
Attraverso un catetere posto in arteria femorale si
potrà rilevare:
La gittata cardiaca in continuo (CO)
Lo stroke volume (SV)
Le resistenze vascolari sistemiche (SVR)
La pressione arteriosa (PA)
La frequenza cardiaca (HR)
La contrattilità (dPMAX)
Volume di sangue intratoracico (ITBV) o precar.
il danno polmonare (EVLW)
Contropulsazione Aortica
Il dispositivo è inserito
in arteria femorale,
fatto avanzare in aorta,
con l’estremità appena
sotto l’arteria
succlavia sinistra
Il pallone si sgonfia in
sistole e si gonfia in
diastole
La metà dei
posizionamenti
avviene nel
postoperatorio
E’ diventato un ausilio
per i trapianti cardiaci
Le complicanze:
ischemia degli arti
inferiori e setticemia
Contropulsazione Aortica
Indicazioni:
Circolazione
extracorporea
Trapianto cardiaco
Infarto miocardico acuto
con shock cardiogeno
Insufficienza mitralica
acuta
Angina instabile
Controindicazioni:
Insufficienza aortica
Dissezione aortica
Protesi in aorta
toracica
Enzimi
Mioglobina
Troponina I
Troponina T
Ckmb
Ckmm
Ckbb
Ckmb mass
2/3 ore (precocissimo)
6/8 ore (precocissimo)
muscolo cardiaco
muscoli lisci
muscoli cerebrali
indicizzato
Conclusioni
Perché ? >>>>>>
Conoscenza
Per chi ?
>>>>>>
Saper essere
Per cosa ? >>>>>>
Saper fare
Infermiere = Manager Sanitario
Dal Vomiting (copia) di Abrahamson
al Problem solving (soluzione) di
Schimdt al Problem finding (trovare)
di E. Morin al Problem setting
(fissare) e al Just-in-time (disporre
del pezzo giusto al momento giusto)
[email protected]
cellulare 338 9810603

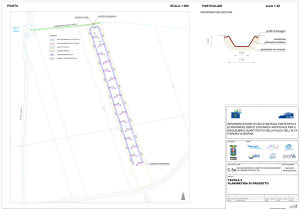
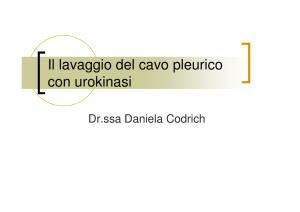
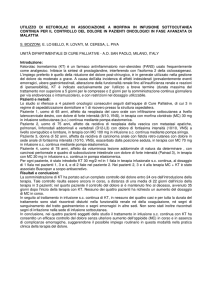
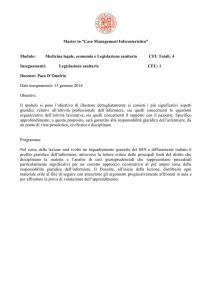

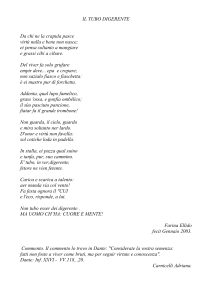
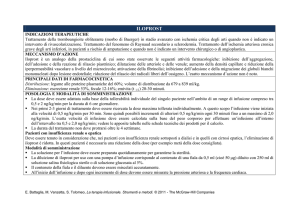


![Mamma ieri oggi domani [in formato ppt]](http://s1.studylibit.com/store/data/003094957_1-c4f1c0699f9fef959b534da05457c2af-300x300.png)