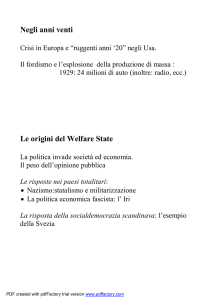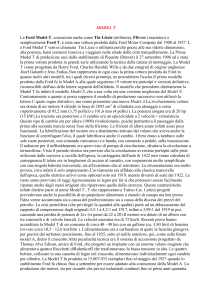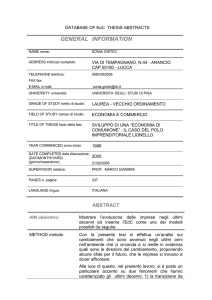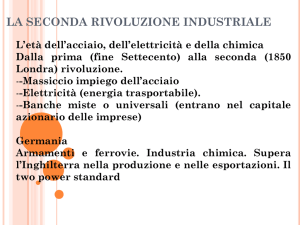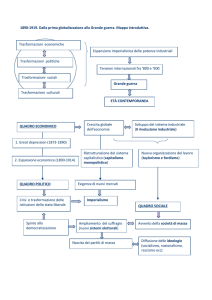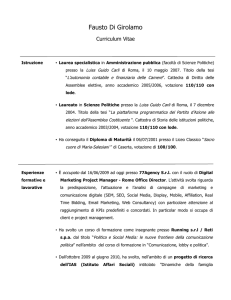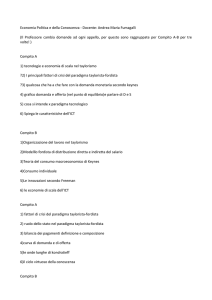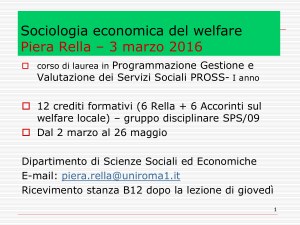Critica del fordismo della scuola regolazionista
di Ferruccio Gambino
Questo articolo è stato pubblicato nel volume collettivo Eugenia Parise (a cura di), Stato Nazionale, lavoro e moneta,
Napoli, Liguori, 1997, pp. 215-240.
Introduzione
Alcune categorie quali fordismo, postfordismo e produzione immateriale, adoperate in anni recenti
per descrivere le metamorfosi della produzione, si sono rivelate arnesi piuttosto spuntati[1]. Qui mi
occuperò dell'uso del "fordismo" e del "postfordismo" da parte della scuola regolazionista, che ha
impresso una particolare torsione al primo termine ed ha coniato ex novo il secondo. Scopo di
questo intervento è di contribuire a rompere l'incantesimo pacificante nel quale i regolazionisti
hanno adagiato il fordismo e il postfordismo.
Dalla metà degli anni Settanta e sulla scorta dell'opera di Michel Aglietta[2] e poi di altri esponenti
della scuola regolazionista, tra cui Boyer, Coriat, Lipietz, il fordismo è venuto assumendo un
significato neutro, dovuto sì a una certa disinvoltura storiografica, ma anche alla retrocessione dei
movimenti delle classi sociali a mero riferimento astratto[3].
Per fordismo la scuola regolazionista intende essenzialmente un sistema produttivo basato sulla
catena dimontaggio, il quale sia capace di una produttività industriale relativamente elevata[4].
L'attenzione della scuola regolazionista non va tanto alla nota inflessibilità del processo di
produzione, alla necessaria dequalificazione della forza-lavoro, alla struttura rigida del comando e
della gerarchia produttiva e sociale del fordismo, né tantomeno alle forme e ai contenuti del
conflitto industriale generato sul suo terreno, quanto alla regolazione dei rapporti di produzione da
parte dello stato come luogo di mediazione e di aggiustamento istituzionale delle forze sociali.
Chiamerò questa interpretazione "fordismo regolazionista", mentre chiamerò "fordismo
presindacale" l'accezione in cui il fordismo è stato ordinariamente usato in Europa dai primi anni
Venti sino agli anni Settanta[5].
Il fordismo regolazionista
Cercherò qui di seguito di esporre brevemente la periodizzazione che del fordismo regolazionista
hanno dato i suoi ideatori, poiché ritengo che essa sia cruciale ai fini della comprensione del suo
scarto semantico rispetto al fordismo presindacale, del quale intendo poi delineare i tratti essenziali.
Secondo i regolazionisti, il fordismo penetrerebbe nei gangli vitali della metalmeccanica
statunitense e ne diventerebbe il catalizzatore in un periodo indefinito, ma verosimilmente negli
anni Venti, erogando alti salari e costituendo la punta di diamante del consumo di massa di beni
durevoli. Dopo essere passato attraverso il laminatoio della Grande Depressione e della Seconda
guerra mondiale, esso sarebbe alla base dell'espansione della keynesiana domanda effettiva negli
Stati Uniti, dove assicurerebbe un regime di welfare e quindi di stabile riproduzione sociale
complessiva, presumibilmente dalla fine degli anni Quaranta. Negli anni Cinquanta, tale sistema
riproduttivo si irradierebbe dagli Stati Uniti verso ipaesi dell'Europa occidentale e il Giappone.
Stando alla periodizzazione della scuola regolazionista, quindi, la grande stagione del fordismo
risulta in realtà alquanto breve, poiché esso converge - ma solo sulla carta - con il keynesismo
all'incirca alla fine degli anni Trenta; può poi affermarsi concretamente alla fine degli anni
Cinquanta e durare sino alla fine degli anni Sessanta, quando entra in crisi irreversibile. A quel
punto si aprirebbe il periodo - nel quale saremmo tuttora immersi - del postfordismo.
A ragione, la scuola regolazionista può rivendicare il merito dell'interpretazione che associa le
trasformazioni dei processi di valorizzazione ai mutamenti intervenuti nella sfera socio-politica e
viceversa. Questa posizione è stata poi fatta propria e sviluppata con i contributi sull'apparato statale
e sui suoi rapporti con il capitale moderno e contemporaneo da Hirsch e Roth in Germania e Jessop
in Gran Bretagna[6]. Secondo Jessop, la scuola regolazionista si compone di quattro principali
indirizzi di ricerca[7].
Il primo indirizzo, aperto da Aglietta, studia i regimi dell'accumulazione nonché i modi della
crescita secondo le loro determinazioni economiche ed ha applicato il suo primo schema
interpretativo agli Stati Uniti. Altri studi hanno preso in considerazione le formazioni economiche
statali, talvolta per studiarvi la diffusione del fordismo, talaltra per seguirvi le peculiarità dello
sviluppo, indipendentemente dal loro inserimento o meno nel circuito economico internazionale.
Il secondo indirizzo si concentra sulle dimensioni economiche internazionali della regolazione. Esso
studia i modi peculiari della regolazione internazionale, nonché la forma e la dimensione delle
complementarità tra diversi modi nazionali della crescita. Vengono così esaminati i temi
dell'inclusione e dell'esclusione delle formazioni statali e regionali dall'ordine economico e le
tendenze alla chiusura autarchica e all'apertura internazionalistica dei vari paesi.
Il terzo indirizzo analizza i modelli complessi delle strutture sociali dell'accumulazione a livello
nazionale. La riproduzione delle società dipende da un insieme di pratiche mediate
istituzionalmente che assicurano almeno una certa corrispondenza tra diverse strutture e un
equilibrio di compromesso fra le forze sociali. Questo indirizzo dedica particolare attenzione alle
categorie di stato e di egemonia che esso considera elementi centrali della regolazione sociale.
Il quarto indirizzo, il meno sviluppato, studia le interdipendenze delle strutture internazionali
emergenti e i tentativi di fondare un ordine globale attraverso istituti internazionali (chiamati
"regimi") destinati a stabilire o ristabilire un ordine internazionale.
Ora, anche da questa sommaria elencazione dei principali temi della scuola regolazionista, risulta
evidente che il baricentro dei suoi interessi sta nell'analisi non tanto dei rapporti sociali di
produzione, quanto piuttosto degli istituti economico-statuali che vi presiedono. In breve, la scuola
regolazionista insiste sulla permanenza delle strutture e deve trascurare i soggetti umani, le loro
metamorfosi, le loro tensioni attorno alla disorganizzazione e alla riorganizzazione dei rapporti
sociali. Il regolazionismo nasce e rimane irrimediabilmente magnetizzato dalla tenuta del
capitalismo statunitense dopo il 1968 e nonostante la sconfitta in Vietnam. Secondo i regolazionisti,
posto che agli Stati Uniti del secondo dopoguerra va imputata "la posizione imperialistica
dominante"[8], occorre capire come e grazie a quali istituzioni le sue strutture e quelle dei paesi
industriali alleati abbiano dimostrato la loro stabilità. In tale ipotesi di lavoro è sotteso l'asserto
secondo cui le istituzioni occidentali restano salde (e saldissime quelle statunitensi), mentre non
soltanto le istituzioni del movimento operaio ma anche la forza-lavoro viva nel suo complesso
appaiono inesorabilmente aggiogati all'inarrestabile marcia dell'accumulazione: in breve, nel medio
e lungo periodo il mestoso incedere del capitalismo sarebbe destinato a continuare, mentre le sue
aporie si dileguerebbero all'orizzonte. Si tratterebbe dunque di studiare le leggi secondo le quali il
capitale occidentale va perpetuandosi. E' in questa temperie che esce il libro di Michel Aglietta[9]
nell'anno successivo al primo shock petrolifero, che è anche quello della sconfitta politica e militare
di Washington nel Vietnam.
Gli incerti contorni del postfordismo regolazionista
Il postfordismo appare ai regolazionisti come una sfera di cristallo nella quale, "a parte le
conseguenze non ancora completamente prevedibili della tecnologia molecolare e genetica", è
possibile leggere qualche segno del futuro. Soprattutto nella nuova informazione, nelle
telecomunicazioni e nelle tecnologie di elaborazione dei dati, che potrebbero diventare la base
dell'"iperindustrializzazione", si intravede il potenziale di rivoluzionamento della produzione.
Trasformando profondamente il lavoro e frammentando "l'operaio massa tayloristico", la
"rivoluzione elettronica" ristratifica la forza-lavoro e la divide in un ristretto livello superiore di
iperqualificati e in un massiccio livello inferiore di esecutori postfordisti. In breve, essa separa la
forza-lavoro gerarchicamente e spazialmente e finisce per rompere il quadro della contrattazione
collettiva[10]. Si intensifica così il ritmo di accumilazione e si apre una prospettiva di lungo periodo
di capitalismo senza opposizione, ovvero di "turbocapitalismo", senza che ne venga intaccata la
stabilità politica. L'operaio postfordista dei regolazionisti appare come un individuo atomizzato,
reso flessibile, tendenzialmente desindacalizzato, tenuto a basso salario e irrimediabilmente
precarizzato nel posto di lavoro. Lo stato non assicura più la copertura dei costi materiali della
riproduzione della forza-lavoro e asseconda la contrazione dei consumi. A giudizio dei
regolazionisti, non potrebbe essere più completo il rovesciamento del cosiddetto consumismo
fordista, grazie al quale la forza-lavoro era asseritamente messa nelle condizioni salariali di
comprare i beni di consumo durevoli che essa creava.
Se poi guardiamo alla discontinuità tra fordismo e postfordismo, essa sembra derivare dal venir
meno di due condizioni essenziali: il modo dell'accumulazione capitalistica e il mancato
aggiustamento del consumo di massa all'aumento della produttività generato dall'intensa
accumulazione[11]. Negli "anni d'oro" successivi alla Seconda guerra mondiale, queste due
condizioni erano soddisfatte: il fordismo mobilitava le capacità industriali ai due estremi dell'alta
qualificazione e della dequalificazione, senza che il sistema venisse destabilizzato da tale
polarizzazione; dai consumi di massa si ricavavano profitti soddisfacenti, che tenevano il passo con
gli investimenti crescenti[12]. A partire dagli anni Settanta, queste due condizioni non si verificano
più perché gli investimenti nel settore che produce merci dei paesi industrializzati sono cresciuti più
della produttività, generando una crisi che il capitale tenta di risolvere per sé cercando sbocchi
produttivi e di mercato nel Terzo Mondo.
Secondo i regolazionisti, le conseguenze sul piano sociale sono vaste. La società si destatalizza; lo
stato snellisce; il preponderante settore dei non privilegiati applica la parsimonia a se stesso per
organizzare la propria sopravvivenza; non si intravedono nuove organizzazioni in grado di
esprimere una solidarietà collettiva sulle ceneri delle vecchie organizzazioni. Ai regolazionisti,
scioperi, campagne e conflitti nel punto della produzione appaiono lungo uno spettro prepolitico che
va dal vivace ornamento (al quale la ricerca universitaria non può dedicare attenzione) sino al
fenomeno residuale.
La variante toyotofila
I sostenitori dell'avvento del postfordismo hanno scoperto il toyotismo come sua variante concreta
verso la fine degli anni 0ttanta[13]. Negli anni Settanta, l'Occidente cominciò tardivamente ad
accorgersi dell'espansione del capitalismo giapponese[14]. Allora esso era stato studiato come
fenomeno che combinava avvedute strategie commerciali con un endemico conformismo e con
politiche sociali insufficienti[15]. A sinistra vi era chi - a ragione e in anticipo sui tempi - ravvisava
nell'espansione nipponica nuove tentazioni egemoniche del Giappone nell'Asia orientale[16].
Alcuni anni dopo, un ammiratore della crescita economica del Giappone ne constatava l'incremento
regolare del livello di vita e l'assorbimento degli shock petroliferi degli anni Settanta[17]. Non
mancava chi metteva in guardia contro l'irregimentazione della società giapponese e contro il suo
incipiente rifiuto delle regole dettate dall'Occidente[18]. Intanto cominciavano a conoscere una
certa fortuna gli autori giapponesi che fornivano agli occidentali dubbie ma facili spiegazioni
dell'ascesa del Giappone sulla base dei suoi modelli culturali e religiosi[19].
Negli anni Ottanta, si aprivano un varco verso il pubblico alcune opere importanti sulla sua struttura
economica, nonostante le crescenti ostilità commerciali occidentali e i conseguenti, facili attacchi
della stampa al sistema industriale giapponese[20]. Tuttavia, sempre negli anni Ottanta, alcuni studi
di economisti e sociologi giapponesi tradotti in inglese passarono pressoché inosservati[21]. Per
parte sua, il libro del massimo ideatore e propagatore del verbo toyotista, Tai'ichi Ohno[22], è stato
tradotto e diffuso in Occidente solo alla vigilia di questo decennio, quando il mondo industriale
giapponese diventava uno dei terreni privilegiati di riflessione sulla produttività industriale.
Nei primi anni Novanta, grazie soprattutto al noto volume di Coriat[23], anche nell'Europa
continentale il dibattito sull'industria giapponese si sposta dalle motivazioni culturali alle strategie
d'impresa, mentre qualche pur meritevole contributo precedente aveva suscitato minore interesse.
Secondo Coriat, l'insegnamento irradiatosi dagli stabilimenti della Toyota introduce un nuovo
paradigma produttivo di importanza paragonabile a quello che furono ai loro tempi il taylorismo e il
fordismo. Si presenta così alla ribalta il toyotismo con la maschera di un postfordismo compiuto e
ormai ineluttabile. Il toyotismo sarebbe l'inveramento di una tendenza alla nuova razionalizzazione
che era sì albeggiata con la categoria del postfordismo, ma che in Occidente era apparsa vaga, non
incarnandosi in una produzione concreta e in uno spazio consolidato. Per contro, apprendiamo da
Coriat che nel toyotismo si realizza il toyotismo non soltanto quale insieme di tentativi di
razionalizzare e di abbattere i costi di produzione, bensì anche quale esperimento su vasta scala di
nuovi e più avanzati rapporti di produzione, addirittura di una nuova socialità che può prefigurare
nuove forme di democrazia industriale. Nel libro di Coriat, l'Occidente rimane sullo sfondo, ma se
dal delicato equilibrio produttivo giapponese ci trasportassimo verso la sua variante europea, la
fabbrica diffusa, troveremmo un toyotismo informale, fondato su accordi individuali. Ad esempio,
nei celebrati distretti industriali italiani il padronato della fabbrica diffusa cerca di instaurare
rapporti individuali per ottenere una contrattazione frantumata.
Secondo poi la vulgata toyotista, il nuovo sistema produttivo è sorto prevalentemente per fattori di
domanda endogena durante e dopo il boom della guerra di Corea (1950-53) come produzione senza
scorte (just in time), e quindi in sostanza come tentativo di ridurre i tempi di attraversamento delle
materie prime, in presenza di una manodopera limitata, anzi a numero chiuso[24].
Le novità del toyotismo sono essenzialmente la produzione senza scorte e di pronta reazione al
mercato, l'imposizione della polivalenza agli operai che vengono addetti a più macchine o
simultaneamente o sequenzialmente, il controllo di qualità in corso d'opera, l'informazione
simultanea sull'andamento della produzione nella fabbrica, informazione tanto capillare e
autoritariamente filtrata da creare imbarazzo sociale e dramma nel caso di eventi nocivi alla
produzione. La produzione può essere interrotta in qualsiasi momento, creando così un caso che
coinvolge la squadra o il reparto o addirittura tutta la fabbrica. L'operaio che dimostra la sua
indifferenza di salariato di fronte agli esiti produttivi dell'azienda e che quindi non si integra nel
gruppo viene stigmatizzato e indotto ad andarsene. Da Coriat veniamo a sapere che nel dilemma
"democrazia/ostracismo", al gruppo può forse toccare la democrazia, mentre allo stigmatizzato
tocca sicuramente l'ostracismo. Nelle descrizione delle mirabilia del toyotismo, per amor di
completezza Coriat[25] dedica una laconica nota a Satochi Kamata, il saggista che nel 1972 andò a
lavorare alla Toyota e ne trasse il libro dal titolo significativo, Toyota, la fabbrica della
disperazione[26].
Il toyotismo offre alcuni vantaggi ai regolazionisti rispetto all'orizzonte manageriale occidentale,
benché il vantaggio produttivo giapponese stia rivelandosi fragile a dispetto dell'alone
propagandistico che l'ha soffuso in Occidente[27]. Innanzitutto esso è un esperimento
geograficamente remoto e commercialmente riuscito, poiché trova una sua via all'accumulazione,
anche se in congiunture prebelliche e belliche, e nient'affatto ireniche come invece i rapsodi del
toyotismo vorrebbero far credere. In secondo luogo, i metodi toyotisti sembrano contraddire il
crescente processo di individualizzazione, al quale viene sovente imputata la resistenza endemica da
parte della forza-lavoro occidentale alla massificazione e all'irregimentazione. In terzo luogo, il
toyotismo è portatore di un programma di terziarizzazione della forza-lavoro, il cosiddetto
sbiancamento dei colletti blu, che riguarda sì una minoranza alquanto ristretta delle maestranze, ma
che converge con quelle previsioni di ristratificazione dualistica della forza-lavoro che i postfordisti
considerano ineluttabile.
Il fordismo presindacale
Qual è la realtà del fordismo dalla parte dei soggetti che l'hanno sperimentato sulla loro pelle? In
sintesi, il fordismo è un sistema autoritario di produzione imposto "oggettivamente" dalla catena di
montaggio, a salario e condizioni di lavoro che la forza-lavoro non può negoziare collettivamente.
Si tratta dunque del fordismo presindacale, che con i ritmi di lavoro tagliati, con le guardie armate,
con l'intimidazione fisica sul luogo di lavoro e con la propaganda esterna negli anni Venti e Trenta
costituisce uno degli elementi essenziali nella lenta costruzione dell'universo concentrazionario che
stava mettendo i suoi primi artigli nell'Urss staliniana e che li avrebbe presto messi anche nella
Germania nazista. Per contro, negli Stati Uniti, anche durante la Grande depressione, permane e si
rafforza un costume democratico di base che punta alla costruzione del sindacato industriale e cinge
d'assedio il fordismo sino a farlo cadere. Nei vent'anni che precedono la sindacalizzazione del 1941,
alla Ford i managers e i guardiani-picchiatori conducono la repressione antioperaia a colpi di
pestaggi, di licenziamenti e di relazioni pubbliche. Forse un giorno si potrà essere più puntuali di
Irving Bernstein, quando, a proposito del maggiore stabilimento Ford, egli scrive: "il River Rouge
... era un grande campo di concentramento basato sulla paura e la violenza fisica"[28]. Sta di fatto
che il delirio fordista di rompere il ritmo dell'agire umano per comprimerlo secondo un piano rigido
su scala planetaria viene sconfitto negli Stati Uniti, ma nel frattempo esso è già trapassato
nell'Europa in fiamme. Si può sostenere che nel ventesimo secolo la catena di montaggio è, insieme
con le macchine totalitarie dello stato e del nazionalismo razzista, una delle strutture originali che
spiegano in ampia misura i misfatti concentrazionari perpetrati su scala industriale. Intendo dire che
nel fordismo presindacale, e nel taylorismo prima, non era già contenuto in potenza il suo
contrario: non la superiorità del lavoro "sul capitale" di Abramo Lincoln, né la costruzione del
sindacato industriale Cio, né la caduta della divisione del lavoro razzista e maschilista, né
tantomeno il diritto di sciopero. Il fascismo e il nazismo non erano ab origine le anime perdenti del
fordismo, ma furono costretti a diventarlo grazie alle lotte sociali e operaie degli anni Trenta negli
Stati Uniti, quelle stesse lotte che avevano già fermato una classe dirigente sulla china di soluzioni
corporative al momento della formazione del primo gabinetto Roosvelt nel 1932-33.
Com'è noto, negli Stati Uniti la catena di montaggio viene da lontano. La produzione in serie di beni
durevoli nel Novecento è un processo che si innesta sull'American System of Manufactures, il
metodo di produzione per parti intercambiabili che era stato incubato dall'industria statunitense già
nell'Ottocento[29]. L'esperimento della fabbrica Ford è un momento cruciale di tale produzione in
serie, poiché esso la applica a un bene durevole, l'automobile, che nei primi anni di questo secolo
appariva generalmente un oggetto di lusso anche negli Stati Uniti. Così facendo, la Ford struttura
una domanda sempre più ampia e pressante, la quale a sua volta legittima presso l'opinione pubblica
le misure autoritarie che sono tipiche degli stabilimenti Ford nel periodo che va dai primi del secolo
alla vigilia della seconda guerra mondiale.
Si è detto: esperimento autoritario da parte di Ford, a suo modo più autoritario e soprattutto più
fattuale della stessa predicazione di Frederick W. Taylor che lo precede di un ventennio. L'operaio
che lavora per la Ford è un individuo che produce lo strumento per la moltiplicazione dei punti di
contatto degli individui[30], ma paradossalmente egli lo produce proprio grazie al suo
imprigionamento a ore nel punto di produzione, là dove è privato del diritto di locomozione in
misura fino ad allora sconosciuta, così come la donna addetta alla sua riproduzione quotidiana è
legata ai ritmi della produzione industriale e nel contempo confinata nella penombra sociale del
lavoro domestico. L'operaio è privato anche del diritto di parola, poiché - e in questo
disciplinamento il fordismo è il potenziatore del taylorismo - egli riceve non tanto ordini verbali
diretti da un superiore quanto una scansione preodinata del ritmo produttivo dal macchinario; la
comunicazione e il contatto con i suoi pari vengono minimizzati e, in ogni caso, egli deve
semplicemente agire per reazione monotona agli impulsi di un sistema produttivo totalitario. Non
ultimi fattori d'isolamento sono le barriere linguistiche che gli operai immigrati portano in dono alla
Ford e che questa mantiene e valorizza a ragion veduta per quattro decenni, fomentando aspre
incomprensioni e divisioni che vengono attenuate soltanto dal tempo, dalla contiguità diuturna,
dalla Grande depressione e dall'opera organizzativa apparentemente sconfitta in partenza e tuttavia
instancabile di una minoranza che si batte per il sindacalismo industriale negli anni Venti e Trenta.
E' noto che fin dalla sua fondazione nel 1903 la Ford non tollera alcuna presenza dei sindacati: non
soltanto dei sindacati di mestiere o industriali, bensì neppure di quelli "gialli" ovvero padronali. I
sindacati rimangono fuori dai cancelli della Ford statunitense fino al 1941. Il salario diventa alto
con i famosi cinque dollari al giorno del gennaio 1914, ma soltanto per gli operai che il
Dipartimento sociologico della Ford approva dopo minuziose ispezioni nelle pieghe della vita
personale e familiare e soltanto nell'alta congiuntura, quando la Ford è stretta dal pressante bisogno
di stabilizzare una forza-lavoro che abbandona le sue fabbriche a causa dei ritmi massacranti[31]. Il
piano di controllo totale degli operai e delle loro famiglie va in crisi dopo l'entrata in guerra degli
Stati Uniti nel 1917, quando la sorveglianza comincia a impiegare più capillarmente gli spioni nei
reparti. Nella recessione successiva alla Prima guerra mondiale, i salari delle altre aziende tendono
ad eguagliare quelli della Ford che smantella le forme di assistenza adottate negli anni Dieci. Nel
febbraio del 1921, più del 30% degli operai Ford vengono licenziati e quelli che rimangono devono
accontentarsi degli inflazionati sei dollari al giorno e dell'ulteriore taglio dei tempi.
La supremazia della Ford nell'auto si incrina alla metà degli anni Venti, quando i manager della
General Motors, in buona parte transfughi della Ford e dai suoi metodi autoritari, le strappano
definitivamente il primato della produzione automobilistica. Contro la produzione indifferenziata
per "le moltitudini", come le chiama Henry Ford, la General Motors vince la battaglia in nome della
distinzione e dell'individuazione, ampliando la gamma produttiva, diversificando e introducendo
annualmente nuovi modelli. Dalla fine degli anni Venti e sino alla sindacalizzazione del 1941, la
Ford è un'azienda notoria per i suoi salari, inferiori persino ai bassi salari del settore dell'auto in
generale[32].
Il sorpasso da parte della Generl Motors e le difficoltà finanziarie non bastano a piegare il fordismo
presindacale negli Stati Uniti: sono prima le rivolte operaie e le occupazioni di fabbrica degli anni
Trenta e poi la sindacalizzazione della grande industria che determinano l'accerchiamento politico
delle altre imprese automobilistiche e infine della Ford, sino alla sua vera e propria capitolazione
allo Uaw, il sindacato dell'auto, a seguito del grande sciopero della primavera del 1941. Il fordismo
presindacale si dissolve quando, a fronte degli attacchi delle guardie armate, i picchetti degli
scioperanti invece di diradarsi si singrossano e le disperdono. E' il momento che si può forse
rammentare con le parole di Emil Mazey, uno dei principali organizzatori dello Uaw: "Era come
veder prendere improvvisamente vita degli uomini che erano stati semimorti"[33].
Con la firma del primo contratto sindacale nel 1941, la Ford non solo si allinea sulle posizioni delle
altre grandi dell'auto, General Motor e Chrysler, ma le supera nelle concessioni allo Uaw e si salva
una seconda volta dal fallimento solo grazie alle commesse belliche del governo. Già nel corso della
Seconda guerra mondiale, essa cerca di rafforzare l'apparato sindacale in fabbrica e di integrarlo
agli obbiettivi dell'impresa. A partire dal 1946, un nuovo management Ford dispone una strategia di
lunga lena per cooptare lo Uaw e renderlo uno strumento di integrazione aziendale. Il fordismo è
così sepolto. Se si intende per fordismo un sistema autoritario di produzione in serie alla catena di
montaggio, a salario e condizioni di lavoro che la forza-lavoro non può negoziare sindacalmente, un
fordismo quale la sociologia del lavoro aveva generalmente inteso negli anni Venti e Trenta, allora
il fordismo si estingue grazie alle lotte per il sindacalismo industriale negli Stati Uniti degli anni
Trenta, coronate dall'imposizione della contrattazione collettiva alla Ford nel 1941. Quanto alle
tendenze a negare totalitariamente la discrezionalità della forza-lavoro nella scansione dei tempi
lavorativi e all'imposizione di ritmi di lavoro incorporati nel macchinario, esse sono ben lontane
dall'essere svanite con la fine del fordismo presindacale; esse sono più cogenti che mai in questo
scorcio di secolo, proprio a fronte del potenziamento delle forze produttive del lavoro e dell'avvento
delle macchine logiche, ma sono ormai lontane dal fordismo presindacale. Possiamo considerare o
meno tali tendenze come un capitolo di un più vasto movimento di razionalizzazione che comincia
con l'American System of Manufactures e che non si è ancora esaurito. In ogni caso, la spinta
complessiva al comando sui tempi di lavoro attraverso l'"oggettività" del macchinario[34] è
incubata da altre grandi imprese prima della Ford, esplode con la diffusione della catena di
montaggio fordista, non si esaurisce affatto con la sua temporanea sconfitta alla fine degli anni
Trenta, e anzi sembra oggi imporsi con rinnovata virulenza anche nei recessi più remoti della
penetrazione capitalistica.
Postfordismo e toyotismo globali
Quanto alla categoria del postfordismo, formulata oscuramente dai regolazionisti, essa ha poi aperto
la strada ad alcune posizioni che sembrano fondarsi su due assiomi indimostrati: il determinismo
tecnologico delle serie discrete degli anni Settanta di questo secolo costituirebbero un momento di
rottura profonda con le grandi serie nella produzione di beni durevoli e la recente scoperta della
produttività della comunicazione tra i cosiddetti produttori all'interno dell'azienda[35].
Il primo assioma deriva dalla constatazione che la produzione materiale in genere e persino quella
meccanica - più discontinua di quella a flusso - procede oggi per serie discrete, poiché, grazie alla
flessibilità delle macchine utensili, a cominciare da quelle a controllo numerico negli anni
Cinquanto, viene facilitata la diversificazione del prodotto, in particolare nella produzione di beni
durevoli. Questa diversificazione permette non soltanto di assecondare i consumatori impegnati
nella ricerca di distinzione, ma anche di plasmare i gusti e generalmente di esaltare i ritocchi e le
personalizzazioni che passano per costose innovazioni. In breve, tale tendenza non è che il
potenziamento della spinta alla diversificazione che la General Motors aveva assecondato e
promosso fin dai primi anni Venti e che le aveva permesso di battere la Ford quando Henry Ford
aveva sentenziato che "il cliente può comprare l'automobile del colore che vuole, purché sia nera".
La produzione di massa aveva solo in apparenza plasmato l'operaio-massa (tremine usato ma anche
abusato al fine di procedere sommariamente per figure storiche). In parecchi reparti del maggiore
stabilimento della Ford, il River Rouge, il silenzio Ford era interrotto dal "bisbiglio Ford", ovvero
"dalla comunicazione gestuale", uno degli elementi della resistenza operaia fino allo scontro
decisivo del 1941[36]. Nonostante il dovere d'indossare l'indifferenziata tuta blu e pur in mancanza
dell'opportuna autorizzazione a pensare, vi era evidentemente nel "produttore" una mente che
aspirava all'individuazione, non al livellamento universale. Andava ormai esaurendosi la battaglia
livellatrice per un'eguaglianza "che possegga la solidità di un pregiudizio popolare"[37]. Verso la
fine degli anni Venti, Henry Ford si trovò una prima volta in serie difficoltà finanziarie per la sua
insistenza sul modello T a un solo colore. Si può ricordare che nelle fabbriche Ford neppure nei bui
anni Trenta mancavano gli operai che rischiavano il licenziamento pur di comprare un'automobile
della General Motors[38]. Dunque, nell'industria automobilistica è la General Motors degli anni
Venti che realizza una produzione flessibile compatibile con i tempi[39]. I suoi veicoli diversificati
vengono prodotti con la messa in comune (commonalisation) delle macchine utensili e della
principale componentistica dell'auto. Le economie di scala sono la base delle economie di gamma.
La varietà produttiva è ben lontana dall'aver aspettato il toyotismo, come era ben consapevole
Charles Wright Mills all'inizio degli anni Cinquanta, quando denunciava l'intreccio manipolato dei
gusti massificati e dei "tocchi personali" sui prodotti correnti[40]
Inoltre, viene dato per scontato che il toyotismo abbia rotto con il "fordismo" sviluppando la sua
flessibilità già negli anni Cinquanta e Sessanta, in quanto la sua produzione automobilistica doveva
far fronte a una domanda alquanto diversificata. Lo stesso massimo esponente del toyotismo[41] lo
afferma, e parecchi studiosi occidentali, tra cui Coriat, ne hanno propagato il mito. In realtà, nel
dopoguerra la Toyota, al pari della Nissan, poteva contare su di una breve esperienza come
produttrice di autoveicoli; aveva cominciato a produrli soltanto nel 1936 e aveva imparato presto a
costruirsi una posizione oligopolistica contribuendo a sloggiare la Ford e la General Motors dal
Giappone appena tre anni dopo. Dopo il 1945, con la famiglia Toyoda ancora al timone
dell'azienda, essa è vissuta a lungo di grandi serie, esportate e poi prodotte anche all'estero. La
continuità non con il fordismo regolazionista bensì con il settore statunitense dell'auto risulta assai
più forte di quanto la vulgata toyotofila voglia ammettere. Infatti, dopo una stentata riconversione
postbellica, la Toyota tenta la via dell'utilitaria (la Toyotapet) e subisce gli scioperi del 1949 e del
1953. Essa si salva grazie soprattutto all'intransigenza della Nissan, che distrugge il sindacato
dell'auto Zenji, ma anche grazie alle commesse statunitensi in occasione della guerra di Corea. In
seguito e per un ventennio, la gamma produttiva della Toyota, come quella delle altre aziende
automibilistiche giapponesi, è ristretta a pochissimi modelli. Sino agli anni Sessanta la qualità
scadente di tali modelli ne rende fallimentari le esportazioni. In seguito a questi insuccessi,
comincia la fase di sperimentazione, fondata sia sull'impiego di squadre polivalenti e mobilitabili
per macchine utensili a moduli variabili, sia sull'attenzione alla qualità in vista
dell'esportazione[42]. E' il successo di un unico modello (l'utilitaria Corolla) negli anni Settanta che
getta le basi della diversificazione produttiva, non viceversa; ed è un successo che la Toyota coglie
all'estero ben più che all'interno, dove il mercato è assai meno dinamico. Fino agli anni Ottanta, la
varietà dei modelli Toyota è prudentemente limitata e soltanto negli anni Ottanta, quando il mercato
interno segna una battuta d'arresto, l'azienda espande la gamma produttiva per conquistare nuove
quote di mercato all'estero. Non è dunque la varietà dei modelli bensì la mobilitazione della forzalavoro dopo una storica sconfitta operaia che spiega la sperimentazione dell'ingegner Ohno alla
Toyota. La novità sostanziale consiste nel fatto che mentre la General Motors degli anni Venti si
accontentava della varietà dei modelli, la Toyota piega la sua squadra, comandabile a piacere, al
lavoro polivalente per la produzione di modelli differenziati lungo la stessa linea.
Quanto alla produzione senza scorte, essa era già stata sperimentata a suo modo dall'industria
dell'auto negli Stati Uniti negli anni Venti e perfino oltre la Depressione. La "messa in libertà" a
salario zero, così frequente negli anni Venti e ancor più durante la Grande Depressione a causa della
stagionalità della domanda, diventò uno dei terreni di scontro decisivi per la nascita del sindacato
dell'auto negli Stati Uniti[43]. Nella partita ai punti del 1936-37 tra lo Uaw e la General Motors, il
sindacato vinse sulla programmazione delle scorte e sull'eliminazione della disoccupazione
stagionale. Forse quanti tessono le lodi del just in time possono staccare una pagina dalle cronache
della Detroit degli anni Trenta, ma anche, ad esempio, dei ricorrenti scioperi europei e statunitensi
da parte degli autotrasportatori "padroncini" del ciclo dell'automobile che in realtà sono l'estrema
appendice delle grandi imprese.
Stando al secondo assioma, i sostenitori del postfordismo affermano che la produzione richiede
ormai e richiederà sempre più gradi elevatissimi di comunicazione tra i soggetti produttivi e che tali
livelli a loro volta rimandano a spazi di discrezionalità dei cosiddetti produttori che sono assai
rilevanti rispetto a un passato di lavoro non-comunicativo, di "silenziosa coazione dei rapporti
economici"[44] del mondo moderno. Tale comunicazione creerebbe una connettività sempre più
intensa tra soggetti, in contrasto con l'isolamento, la separatezza e il mutismo imposti all'operaio
dalla prima e dalla seconda rivoluzione industriale. Mentre è indubbio che i processi di
apprendimento nella produzione (learning by doing) hanno richiesto e richiedono un notevole grado
di interazione anche verbale tra individui, resta il fatto che dal taylorismo in poi il risparmio di
tempo di lavoro passa in larga misura attraverso la minimizzazione del contatto e dell'interazione
informale tra i pianificatori e gli esecutori. Il taylorismo ha cercato con magri risultati di imporre
tale pianificazione al fine di aumentare la produttività, sottraendo ai capi e agli operai la
discrezionalità temporale che essi assumevano negoziando informalmente e verbalmente nei reparti.
Tuttavia, anche nell'epoca del fordismo presindacale, va ricordato che nei periodi di ristrutturazione
di fabbrica, di cambiamento dei modelli e di innovazione tecnologica, il bisbiglio della
ristrutturazione era non solo produttivo ma addirittura essenziale al buon esito dell'operazione.
Dunque, il silenzio imposto d'autorità e il rumore assordante dello sviluppo dominano l'industria
dell'auto sino alla metà degli anni Trenta[45]. Ma il disciplinamento del sillenzio e del bisbiglio
entro gli alvei della comunicazione produttiva di capitale non è forse un tratto costitutivo della
fabbrica moderna? A questo proposito, si può notare che la stessa sociologia industriale come
disciplina è stata costruita sull'occultamento della dimensione comunicativa e sulla ripulsa di
qualsiasi analisi dei processi di interazione verbale nei luoghi di lavoro. Non si tratta di una mera
distrazione. Basterà qui ricordare l'osservazionedi Harold Garfinkel:
"Esiste un ordine prodotto localmente delle cose del lavoro; [...] esse formano un dominio
imponente di fenomeni organizzativi; [...] gli studi classici del lavoro, senza rimedio o alternativa,
dipendono dall'esistenza di questi fenomeni, fanno uso del dominio e lo ignorano"[46]
Quanto alle tendenze a imporre totalitariamente i ritmi di lavoro, esse non sono certo svanite con la
fine del fordismo presindacale; tornano più cogenti che mai in questo scorcio di secolo, proprio a
fronte del potenziamento delle forze produttive del lavoro e anzi hanno assunto alcuni tratti del
fordismo presindacale dei ruggenti anni Venti: precarietà del posto di lavoro, mancanza di
assistenza sanitaria e di sussidio di disoccupazione, decurtazioni non solo dei salari reali, ma anche
dei salari nominali, spostamento di linee produttive lontano dalle regioni industrialmente "mature".
I tempi di lavoro si prolungano, anziché accorciarsi. In tutto l'Occidente come anche in Oriente si
lavora più a lungo di vent'anni fa, e in una dimensione sociale dalla quale il potere regolatore dello
stato si è eclissato. Si lavora più a lungo e più intensamente anche grazie all'obsoleto cronometro
taylorista e alla catena di montaggio fordista "fuori moda". Ironicamente, proprio per la Francia,
dov'è sorta la scuola regolazionista, preziosi dati, altrove inesistenti, mostrano che il lavoro alla
catena e sotto costrizione automatica è in aumento, sia percentualmente che in assoluto: vi erano
sottoposti il 13,2% degli operai nel 1984 e il 16,7% nel 1991 (su, rispettivamente, 6.187.000 e
6.239.000 operai)[47].
Negli anni Cinquanta e Sessanta, ovvero negli "anni d'oro" del fordismo, come li chiama Lipietz,
l'economia internazionale sotto guida statunitense promosse la domanda di investimenti privati, più
ancora dei consumi dei beni-salario. Quello che appariva un sistema stabile cominciò a sfaldarsi
dall'interno, perché alla fine degli anni Sessanta la lotta di classe nelle sue forme variegate ribaltò le
solide certezze del capitale sul terreno del salario, dell'organizzazione del lavoro, del rapporto tra
sviluppo e sottosviluppo, del patriarcato. Se non si comprende la radicalità di tale sfida, non si
possono cogliere gli elementi di crisi e di incertezza che hanno caratterizzato le prospettive di
dominio nel ventennio successivo[48]. La disomogeneità delle reazioni - dalla guerra manovrata
contro i colletti blu nei paesi industrializzati fino alla regionalizzazione in tre grandi aree
capitalistiche (Nafta, Unione Europea e Giappone) e alla spedizione nel Golfo - denotano non il
passaggio a un modello postfordista ma la continua ricombinazione di vecchi e nuovi elementi di
dominio per scomporre politicamente la forza-lavoro attorno a una produzione flessibile.
Conclusioni
Il regolazionismo guarda alle implicazioni dal lato del capitale come centro e motore del
movimento operaio complessivo della società. Hirsch e Roth parlano a nome di molti quando
affermano che "è sempre il capitale stesso e le strutture che esso impone 'oggettivamente' alle spalle
degli attori che mette in moto le condizioni decisive delle lotte di classe e dei processi di crisi"[49].
Non stupisce che le conclusioni che i regolazionisti traggono da tale posizione vadano nell'unica
direzione che non è loro preclusa: il conflitto contro le leggi dello sviluppo capitalistico non ha
futuro, e pertanto è inutile rilevare le crepe nell'edificio del dominio. Parafrasando Mark Twain, si
può dire che se i regolazionisti dispongono soltanto di un martello panfordista non vedranno altro
che chiodi postfordisti da ribadire.
Assumendo tale posizione, i regolazionisti non soltanto si precludono la via dell'analisi dei processi
conflittuali presenti e futuri, ma si autoescludono dal dibattito a più voci che si incentra sui
soggetti[50]. Non altrimenti si può spiegare la riduzione regolazionista della classe operaia negli
Stati Uniti a mero oggetto fordizzato[51], persino nei suoi momenti di maggiore progettualità
antagonistica, come essa ha certamente espresso tra la Grande depressione e il nuovo ordine
nazifascista in Europa. E assumendo tale posizione, il regolazionismo non può comprendere poi
come proprio tale classe operaia abbia contribuito in maniera determinante a porre lo stesso
capitalismo statunitense in rotta di collisione con il nazifascismo. Il fordismo presindacale fu
transeunte, non nel senso banale (ma pur non insignificante) di un Henry Ford che andava
finanziando Hitler sulla via verso il potere e si fregiava delle medaglie naziste fino al 1938, ma
perché a sconvolgere la silenziosa coazione della forza-lavoro fordizzata era la forza-lavoro stessa,
in uno dei movimenti sociali di autoemancipazione che i regolazionisti non sono strutturalmente
attrezzati per comprendere nelle sue vaste implicazioni a livello mondiale e per lunghi anni
avvenire, ben al di là della Seconda guerra mondiale.
Quanto alla condizione odierna, non è in questione l'esame delle novità dopo la caduta delle
certezze oltre che del muro di Berlino, bensì la possibilità o meno di scrollarsi di dosso
l'ineluttabilità del passaggio a un paradigma "postfordista" nel quale la forza-lavoro figuri ancora
una volta come mero oggetto e massa inerte. Come notavano Holloway e Pelaez, l'insistenza con la
quale i regolazionisti invitano il loro pubblico a guardare in faccia il futuro desta qualche
perplessità[52]. Dopotutto, la fede nelle meraviglie della tecnologia da parte delle organizzazioni
del movimento operaio ha condotto a qualche epocale sconfitta nel passato. Non è soltanto in gioco
l'inevitabilità di un sistema, quello capitalistico, che ha troppi connotati di costrizione e di morte per
essere accettabile, bensì persino la possibilità di qualsiasi iniziativa, anche la più cauta, che parta dai
soggetti. In gioco è la prospettiva di combattere una precostituita subordinazione della forza-lavoro
agli inesorabili Tempi Nuovi impastati sì di silicio informatico, ma anche di forti ostilità
intraimperiali, per il momento ammantate di parole d'ordine quali concorrenza e libero mercato.
E' l'indeterminazione dei confini dell'azione conflittuale che il presente ci induce a difendere.
Dovremo dunque riesaminare tempestivamente qualche strumento, al fine di sgombrare il futuro se
non delle eventuali ipoteche, almeno dei belati più lamentosi. Finora la scomposizione e
l'anatomizzazione della forza-lavoro in quanto "macchina umana" hanno di fatto costituito il
processo preparatorio dei vari stadi della meccanizzazione; è un processo che il dominio
capitalistico ha costantemente presentato come necessario. Il punto non è se il postfordismo si
aggiri tra noi, ma se si può arrestare il sacrificio delle "macchine umane" sulle piramidi
dell'accumulazione.
[1] Per una critica tempestiva del termine "produzione immateriale", v. Sergio Bologna,
Problematiche del lavoro autonomo in Italia (I), "Altreragioni" n. 1 (1992), pp. 10-27.
[2] M. Aglietta (1974), Accumulation et régulation du capitalisme en longue période. L'exemple des
Etas-Unis (1870-1970), Paris, Insee, 1974; la seconda edizione francese reca come titolo Régulation
et crises du Capitalisme, Parigi, Calmann-Levy, 1976; tr. inglese, A Theory of Capitalist
Regulation: The US Experience, Londra e New York, Verso, 1979; nel 1987 è seguita una seconda
edizione inglese presso il medesimo editore. Tratto di unione tra la categoria di fordismo e quella di
postfordismo può essere considerato il termine di neo-fordismo, proposta da Christian Palloix due
anni dopo l'uscita della prima edizione del citato libro di Aglietta. V. Christian Palloix, Le procès de
travail. Du fordisme au néofordisme, "La Pensée", n. 185 (febbraio 1976), pp. 37-60, secondo il
quale il neofordismo definisce la nuova pratica capitalisa di arricchimento e ricomposizione delle
mansioni in risposta a nuove esigenze di gestione della forza-lavoro.
[3] Sull'interpretazione regolazionista del fordismo fino al 1991, si veda il fondamentale volume di
Werner Bonefeld e John Holloway (a cura di), Post-Fordism and Social Form: A Marxiste Debate
on the Post-Fordist State, Londra MacMillan, 1991, che contiene le indicazioni bibliografiche del
dibattito. Per la scuola regolazionista si possono vedere, tra gli altri, i seguenti lavori: R. Boyer, La
théorie de la régulation: une analyse critique, Parigi, La Découverte, 1986; R. Boyer (a cura di),
Capitalisme fin de siècle, Parigi, Presses Universitaires de France, 1986; Alain Lipietz, Towards
Global Fordism?, "New Left Review", n. 132 (marzo-aprile 1982), pp. 33-47; Imperialism as the
Beast of the Apocalypse, "Capital and Class", n. 22 (primavera 1984), pp. 81-109; Behind the
Crisis: the Exhaustion of a Regime of Accumulation. A 'Regulation School Perspective' on Some
French Empirical Works, "Review of Radical Political Economy", vol. 18, n. 1-2 (1986), pp. 13-32;
Mirages and Miracles: The Crisis of Global Fordism, Londra, Verso, 1987; Fordism and postFordism, in W. Outhwaite and Tom Bottomore (a cura di), The Blackwell Dictionary of Twentieth
Century Social Thought, Oxford, Blackwell, 1993, pp. 230-231; B. Coriat, Penser à l'envers.
Travail et organisation dans l'entreprise japonaise, Parigi, Christian Bourgois, 1991; Ripensare
l'organizzazione del lavoro. Concetti e prassi del modello giapponese, Bari, Dedalo 1991, con
introduzione e traduzione di Mirella Giannini.
[4] Dico "produttività relativamente elevata", perché la catena di montaggio non sempre ne ha dato
prova. Ad esempio, il fordismo sovietico dei primi due piani quinquennali (1928-32, 1933-37)
venne sperimentato soprattutto alla catena di montaggio dello stabilimento automobilistico di
Gor'kij grazie anche all'apporto dei tecnici della Ford, ma si mantenne a un livello di produttività di
circa il 50% inferiore a quello delle fabbriche statunitensi della Ford. V. in proposito John P. Hardt
e George D. Holliday, Technology Transfert and Change in the Soviet Economic System, in
Frederic J. Fleron jr., Techology and Communis Culture: The Socio-Cultural Impact of Technology
under Socialism, New York e Londra, Praeger, 1977, pp. 183-223.
[5] Nel suo Fordism and post-Fordism, cit., p. 230, Lipietz sostiene erroneamente che il termine
"fordismo" "venne coniato negli anni Trenta dal marxista italiano Antonio Gramsci e dal socialista
belga Henri de Man". Lipietz si riferisce evidentemente ad "Americanismo e fordismo" (1934) in
Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere, vol. 3, a cura di Valentino Gerratana, Torino, Einaudi
1975, pp. 2137-2181, una serie di note in cui Gramsci tiene conto tra l'altro di un libro di de Man
che non discute direttamente di fordismo. La prima edizione dell'opera di de Man comparve in
Germania nel 1926: Hendrik de Man, Zur Psychologie des Sozialismus, Jena, E. Diederichs, 1926 e,
dopo una parziale traduzione francese comparsa a Bruxelles nel 1927, venne pubblicata una
traduzione completa con il titolo Au delà du marxisme, Parigi, Alcan, 1929 sulla seconda edizione
tedesca presso Diederichs (1027). Per le sue note su "Americanismo e fordismo" Gramsci in carcere
disponeve della traduzione italiana dell'edizione francese uscita presso Alcan: Henri de Man, Il
superamento del marxismo, Bari, Laterza, 1929. In Europa, l'uso del termine "fordismo" precede de
Man e Gramsci ed è già affermato nei primi anni Venti; in particolare, Friedrich von GottlOttlilienfeld, Fordismus? Paraphrasen über Verhältnis von Wirtschaft und Technischer Vernunft
bei Henry Ford und Frederick W. Taylor, Jene, Gustav Fischer, 1924; H. Sinzheimer, L'Europa e
l'idea di democrazia economica (1925), "Quaderni di azione sociale", XXXIX, n. 2 (1994), pp. 7174, a cura e nella traduzione di Sandro Mezzadra, che ringrazio per questa segnalazione. Nel suo
articolo citato più sopra, altrettanto erroneamente Lipietz afferma che "negli anni Sessanta, il
termine venne riscoperto da alcuni marxisti italiani (R. Panzieri, M. Tronti, A. Negri)". In Italia la
discussione del fordismo venne affrontata prendendo le distanze da Gramsci nel volume di Romano
Alquati, Sulla Fiat e altri scritti, Milano, Feltrinelli, 1975, che raccoglieva i suoi scritti degli anni
del periodo 1961-67 e nel volume di Sergio Bologna, George P. Rawick, Mauro Gobbini, Antonio
Negri, Luciano Ferrari Bravo, Ferruccio Gambino, Operai e stato: lotte operaie e riforma dello
stato capitalistico tra rivoluzione d'Ottobre e New Deal, Milano, Feltrinelli, 1972, che raccoglieva
gli atti di un convegno tenutosi a Padova nel 1967.
[6] Si vedano in particolare in Werner Bonefeld e John Holloway (eds.) Post-Fordism and Social
Form, cit., il saggio di Joachim Hirsch, Fordism and Post-Fordism: The Present Social Crisis and
its Consequences, pp. 8-34 e i due saggi di Bob Jessop, Regulation Theory, Post-Fordism and the
State: More than a Reply to Werner Bonefeld, pp. 69-91 e Polar Bears and Class Struggle: Much
Less than a Self-Criticism, pp. 145-169, che contengono ulteriori riferimenti bibliografici.
[7]Bob Jessop, Regulation Theory, Post-Fordism and the State, cit., pp. 87-88.
[8] Joachim Hirsch, Fordism and Post-Fordism: The Present Social Crisis and its Consequences,
cit., p. 15.
[9] Michel Aglietta (1974), Accumulation et régulation du capitalisme en longue période. Exemple
des Etas-Unis (1870-1970), Paris, INSEE, 1974.
[10] Joachim Hirsch, Fordism and Post-Fordism: The Present Social Crisis and its Consequences,
cit., pp. 25-26.
[11] Alain Lipietz, Towards Global Fordism, "New Left Review", n. 132 (marzo-aprile 1982), pp.
33-47.
[12] Ibid., pp. 35-36.
[13] Sull'argomento, v. la rassegna di Giuseppe Bonazzi, La scoperta del modello giapponese nelle
società occidentali, "Stato e mercato", n. 39 (dicembre 1993), pp. 437-466 che discute la ricezione
variamente critica del modello giapponese nella sociologia occidentale; più brevemente e in termini
più generali, Pierre-François Souyri, Un nouveau paradigme?, "Annales", vol. 49, n. 3 (maggiogiugno 1994), pp. 503-510.
[14] Robert Guillain, Japon troisième grand, Paris, Seuil, 1969; Herman Kahn, The Emerging
Japanese Superstate, Minneapolis, Minn., Hudson Institute, 1970.
[15] Robert Brochier, Le miracle economique jeponais, Parigi, Calmann-Lévy, 1970.
[16] John Holliday e David McCormack, Japanese Imperialism Today: Co-Prosperity in Greater
East Asia, Harmondsworth, Inghilterra, Penguin, 1973.
[17] Ezra Vogel, Japan as Number One: Lessons for America, Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1979.
[18] Karel Van Wolferen, The Enigma of Japanese Power, New York, N. Y., Knopf, 1989.
[19] Chie Nakane, Japanese Society, Londra, Weinenfeld e Nicholson, 1970, tr. it., La società
giapponese, Milano, Cortina; Michio Morishima, Why Has Japan "Succeeded", Cambridge,
Cambridge University Press, tr. it. Cultura e tecnologia nel successo giapponese, Bologna, Il
Mulino.
[20] Jean-Loup Lesage, Les grandes sociétés de commerce au Japon, les Shosha, Parigi, PUF;
Chalmers Johnson, MITI and Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy, 1925-1975,
Tokyo, Tuttle, 1986.
[21] Masahiko Aoki, The Economic Analysis of the Japanese Firm, Amsterdam, Elsevier, 1984;
Kazuo Koike, Understanding Industrial Relations in Modern Japan, Londra MacMillan, 1988.
[22] Tai'ichi Ohno, Toyota Seisan Hoshiki [Il modo di produzione Toyota], Tokyo, Diamond Sha,
1978; tr. inglese, The Toyota Production System: Beyond Large Scale Production, Productivity
Press, Cambridge, Mass., tr. francese, L'esprit Toyota, Parigi, Masson, 1989; tr. italiana, Lo spirito
Toyota, Torino, Einaudi, 1993.
[23] Benjamin Coriat, Penser à l'envers. Travail et organisation dans lentreprise japonaise, Parigi,
Christian Bourgois, 1991; tr. it., Ripensare l'organizzazione del lavoro. Concetti e prassi del
modello giapponese, Bari, Dedalo, 1991.
[24] Benjamin Coriat,Ripensare l'organizzazione del lavoro. Concetti e prassi del modello
giapponese, cit., pp. 32-33.
[25] Ibid., p. 85.
[26] Satochi Kamata, Toyota, l'usine du désespoir, Parigi, Editions Ouvrières, 1976; tr. inglese,
Japan in the Passing Lane: Insider's Account of Life in a Japanese Auto Factory, New York, N. Y.,
Unwin Hyman, 1984. Dello stesso autore, L'envers du Miracle, Parigi, Maspéro, 1980.
[27] Ray e Cindelyn Eberts, The Myths of Japanese Quality, Upper Saddle, N. J., Prentice Hall,
1994.
[28] Irving Bernstein, Turbulent Years: A History of the American Worker 1933-1941, Boston,
Houghton Mifflin, 1969, p. 737.
[29] David A. Hounshell, From the American System to Mass Production (1800-1932), Baltimora e
Londra, The Johns Hopkins University Press, 1984.
[30] Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica, vol. I, tr. di Enzo
Grillo, Firenze, La Nuova Italia, 1968, p. 242, sulla società, la quale "non consiste di individui,
bensì esprime la somma delle relazioni, dei rapporti in cui questi individui stanno l'uno rispetto
all'altro".
[31] Steohen Meyer III, The Five Dollar Day: Labor Management and Social Control in the Ford
Motor Company, 1908-1821, Albany, N. Y., State Universiti of New York Press, 1981, in
particolare pp. 96-202.
[32] Joyce Shaw Peterson, American Automobile Workers, 1900-1933, Albany, N. Y., State
Universiti of New York Press, 1987. Come scriveva Samuel Romer, The Detroit Strike, "The
Nation", vol. 136, n. 3528, 15 febbraio 1933, pp. 167-168: "L'industria dell'automobile è stagionale.
Tutti gli anni, le fabbriche rallentano la produzione in autunno per preparare i nuovi modelli; e
l'operaio dell'auto deve allungare gli 'alti salari' di otto mesi per tirare avanti per l'intero anno". V.
anche La Faver, M. W (1929), Instability of Employment in the Automobile Industry, "Monthly
Labor Review", vol. XXVIII, pp. 214-217.
[33] Bernstein, Turbulent Years, cit., p. 744.
[34] David Noble, Social Choice in Machine Design, in Andrew Zimbalist, Case Studies on the
Labor Process, New York, Monthly Review Press, 1979, pp. 18-50.
[35] Una sintesi aggiornata di queste posizioni è il saggio di Marco Revelli, Economia e modello
sociale nel passaggio tra fordismo e toyotismo, in Pietro Ingrao e Rossana Rossanda, Appuntamenti
di fine secolo, Roma, Manifestolibri, 1995, pp. 161-224.
[36] Irving Bernstein, Turbolent Years, cit., p. 740.
[37] Karl Marx, Il Capitale, Vol. I, Roma Editori Riuniti, 1964, p. 92.
[38] Irving Bernstein, Turbolent Years, cit., p. 740.
[39] Benché non appartengano alla scuola regolazionista, anche due ammiratori dei distretti
industriali italiani hanno presentato la produzione flessibile come un'innovazione tipica degli anni
Settanta, riferendosi non al Giappone ma all'area orientale della Pianura padana: J. Michael Piore
and Charles F. Sabel (1983), The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, New York,
N. Y., Basic Books; tr. it., Le due vie dello sviluppo industriale. Produzione di massa e produzione
flessibile, Torino, Isedi, 1987.
[40] Charles Wright Mills, Commentary on Our Culture and Our Country, "Partisan Review", vol.
19, n. 4 (luglio-agosto 1952), pp. 446-450 e in particolare p. 447.
[41] Tai'ichi Ohno, Toyota Seisan Hoshiki [Il modo di produzione Toyota], Tokyo, Diamond Sha,
1978; tr. inglese, The Toyota Production System: Beyond Large Scale Production, Productivity
Press, Cambridge, Mass., tr. francese, L'esprit Toyota, Parigi, Masson, 1989; tr. italiana, Lo spirito
Toyota, Torino, Einaudi, 1993.
[42] Marie-Claude Belis Bourguignan et Yannick Lung (1994), Le Mythe de lavariété originelle.
L'internasionalisation dans la trajectoire du modèle productif japonais, "Annales", 49, 2 (maggiogiugno), pp. 541-567.
[43] M. L. La Fever, Instability of Employment in the Automobile Industry, "Monthly Labor
Review", vol. XXVIII (1929), pp. 214-217. V. anche nota 31.
[44] Karl Marx, Il Capitale, cit., Vol. I, p. 800.
[45] Joyce Shaw Peterson, American Automobile Workers, 1900-1933, cit., pp. 54-56; Irving
Bernstein, Turbolent Years, cit., p. 740.
[46] Harold Garfinkel (ed.), Ethnomethodological Studies of Work, Routledge e Kegan Paul, Londra
e New York 1986, p.7.
[47] Anonimo, Alternatives Economiques, maggio 1994, su dati Dares, Enquetes spécifiques
Acemo: Enquetes sur l'activité et les conditions d'emploi de mani-d'oevre; devo questa segnalazione
ad Alain Bihr.
[48] Cfr. L'indispensabile "Intervento su Pietro Ingrao e Rossana Rossanda, Appuntamenti di fine
secolo", di Riccardo Bellofiore, Associazione dei Lavoratori e delle Lavoratrici Torinesi (Allt), 24
novembre 1995 (stampato in proprio).
[49] Joachim Hirsch e Roland Roth, Das neue Gesicht des Kapitalismus, Amburgo, VSA, 1986, p.
37.
[50] Su questo tema, v. la rassegna di Peter Miller e Nikolas Rose, Production, Identity, and
Democracy, "Theory and Society", vol. 24, n. 3 (giugno 1995), pp. 427-467.
[51] Durante i primi due Piani quinquennali staliniani, "fordizzati" (fordirovannye) erano chiamati
dal regime sovietico gli operai della catena di montaggio della fabbrica automobilistica di Gor'kij.
[52] Eloina Pelaez e John Holloway, Learning to Bow: Post-Fordism and Technological
Determinism, in Werner Bonefeld e John Holloway (eds.), Post-Fordism and Social Form, cit., p.
137.