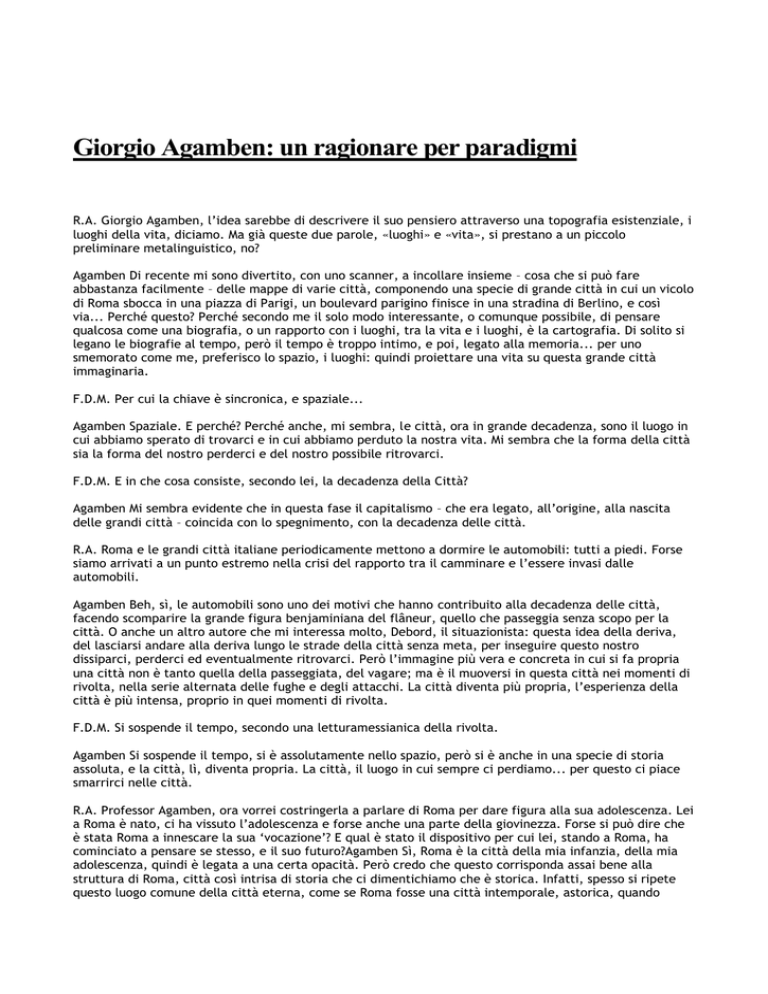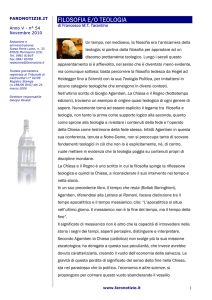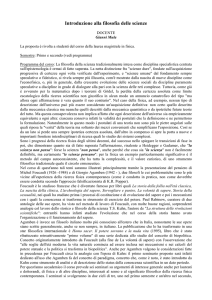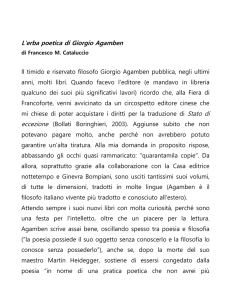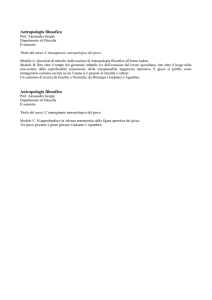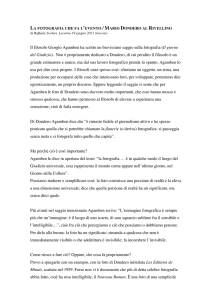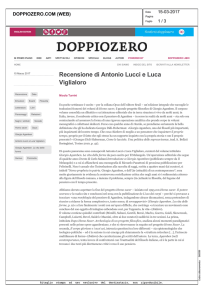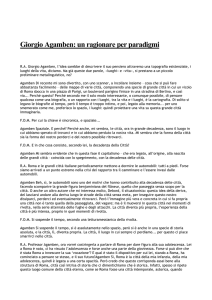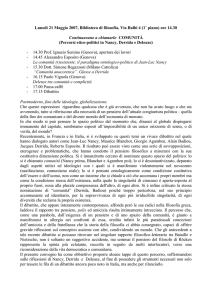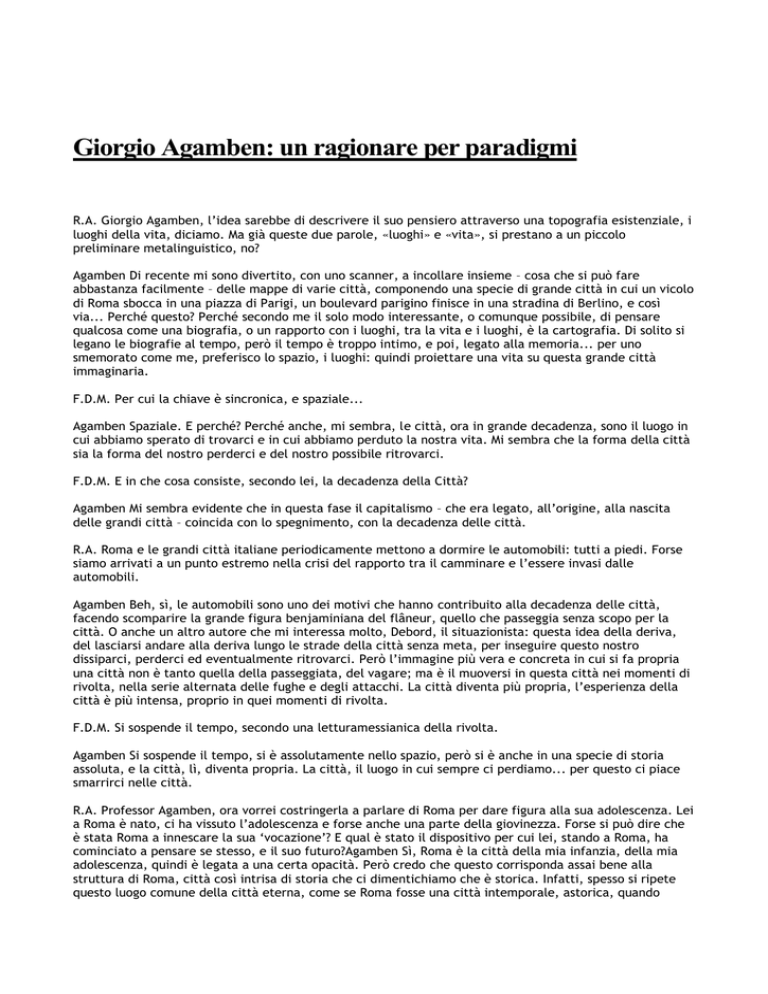
Filosofia letteratura discorsi altri: contaminazioni
Giorgio Agamben: un ragionare per paradigmi
R.A. Giorgio Agamben, l’idea sarebbe di descrivere il suo pensiero attraverso una topografia esistenziale, i
luoghi della vita, diciamo. Ma già queste due parole, «luoghi» e «vita», si prestano a un piccolo
preliminare metalinguistico, no?
Agamben Di recente mi sono divertito, con uno scanner, a incollare insieme – cosa che si può fare
abbastanza facilmente – delle mappe di varie città, componendo una specie di grande città in cui un vicolo
di Roma sbocca in una piazza di Parigi, un boulevard parigino finisce in una stradina di Berlino, e così
via... Perché questo? Perché secondo me il solo modo interessante, o comunque possibile, di pensare
qualcosa come una biografia, o un rapporto con i luoghi, tra la vita e i luoghi, è la cartografia. Di solito si
legano le biografie al tempo, però il tempo è troppo intimo, e poi, legato alla memoria... per uno
smemorato come me, preferisco lo spazio, i luoghi: quindi proiettare una vita su questa grande città
immaginaria.
F.D.M. Per cui la chiave è sincronica, e spaziale...
Agamben Spaziale. E perché? Perché anche, mi sembra, le città, ora in grande decadenza, sono il luogo in
cui abbiamo sperato di trovarci e in cui abbiamo perduto la nostra vita. Mi sembra che la forma della città
sia la forma del nostro perderci e del nostro possibile ritrovarci.
F.D.M. E in che cosa consiste, secondo lei, la decadenza della Città?
Agamben Mi sembra evidente che in questa fase il capitalismo – che era legato, all’origine, alla nascita
delle grandi città – coincida con lo spegnimento, con la decadenza delle città.
R.A. Roma e le grandi città italiane periodicamente mettono a dormire le automobili: tutti a piedi. Forse
siamo arrivati a un punto estremo nella crisi del rapporto tra il camminare e l’essere invasi dalle
automobili.
Agamben Beh, sì, le automobili sono uno dei motivi che hanno contribuito alla decadenza delle città,
facendo scomparire la grande figura benjaminiana del flâneur, quello che passeggia senza scopo per la
città. O anche un altro autore che mi interessa molto, Debord, il situazionista: questa idea della deriva,
del lasciarsi andare alla deriva lungo le strade della città senza meta, per inseguire questo nostro
dissiparci, perderci ed eventualmente ritrovarci. Però l’immagine più vera e concreta in cui si fa propria
una città non è tanto quella della passeggiata, del vagare; ma è il muoversi in questa città nei momenti di
rivolta, nella serie alternata delle fughe e degli attacchi. La città diventa più propria, l’esperienza della
città è più intensa, proprio in quei momenti di rivolta.
F.D.M. Si sospende il tempo, secondo una letturamessianica della rivolta.
Agamben Si sospende il tempo, si è assolutamente nello spazio, però si è anche in una specie di storia
assoluta, e la città, lì, diventa propria. La città, il luogo in cui sempre ci perdiamo... per questo ci piace
smarrirci nelle città.
R.A. Professor Agamben, ora vorrei costringerla a parlare di Roma per dare figura alla sua adolescenza. Lei
a Roma è nato, ci ha vissuto l’adolescenza e forse anche una parte della giovinezza. Forse si può dire che
è stata Roma a innescare la sua ‘vocazione’? E qual è stato il dispositivo per cui lei, stando a Roma, ha
cominciato a pensare se stesso, e il suo futuro?Agamben Sì, Roma è la città della mia infanzia, della mia
adolescenza, quindi è legata a una certa opacità. Però credo che questo corrisponda assai bene alla
struttura di Roma, città così intrisa di storia che ci dimentichiamo che è storica. Infatti, spesso si ripete
questo luogo comune della città eterna, come se Roma fosse una città intemporale, astorica, quando
invece è proprio intrisa e fatta di storia più di qualsiasi altra città. Anzi, direi che la vera immagine
diRomaè quella di una città verticale...
R.A. A strati.
Agamben ...sì, per cui una chiesa barocca ha sotto di sé, accessibile, una chiesa romanica, sotto la chiesa
romanica una basilica paleocristiana, poi si scende ancora e c’è il mitreo romano... Questa è Roma. Però,
invece, apparentemente Roma è appunto atemporale, sembra non offrire nulla; e gli accessi sono segreti,
alla vera realtà di Roma. Quindi corrisponde assai bene allo stadio opaco dell’infanzia e dell’adolescenza,
quando si è in preda a questa cosa strana che è il voler scrivere...
R.A. Cos’è il voler scrivere?
Agamben Se ci pensate, chi vuole scrivere non vuole scrivere questa opera, questo romanzo, vuole
scrivere in generale, che è l’esperienza la più insensata e strana, però credo anche la più profonda. Molti
anni dopo ho visto che nella filosofia medioevale la scrittura è il modello o l’immagine della potenza,
della possibilità: il bambino che impara a scrivere, oppure lo scriba che sa già scrivere, che è padrone
della sua potenza. Io credo che sia questo: nel voler scrivere in realtà c’è una specie di desiderio e di
esperienza della possibilità. Voler scrivere significa volersi rendere la vita possibile.
F.D.M. Dunque il suo voler scrivere, agli inizi, non coincideva con un voler pensare?
Agamben Sì, credo che all’inizio avesse la forma «voler scrivere», dev’essere così un po’ per tutti. Anche
in séguito mi ha sempre più interessato il prima e il dopo dell’opera, che non l’opera stessa. È la
dimensione appunto del prima del voler scrivere, o del tornare, dopo, sulla scrittura.
R.A. Non finirà anche lei, Dio ne guardi!, tra i pensatori che a un certo punto scrivono romanzi, vero
professore?
Agamben No, nel modo più assoluto: no. Comunque, credo che una vera vocazione, proprio perché legata
alla possibilità, a un’esperienza di poter qualcosa, significa innanzitutto una revocazione di una vocazione
precedente: si comincia a scrivere cioè perché si pensa di voler fare il poeta, e poi si dice: ma no,ma non
è questo quello che voglio, io vorrei un’altra cosa, una cosa più importante, più urgente; e si fa un’altra
cosa, e di nuovo questa vocazione viene revocata, interrotta...
R.A. Ma è un’idea un po’ neoplatonica?
Agamben Platone si dice nella tradizione che avesse cominciato col fare il poeta tragico, poi sentì la voce
di Socrate nei mercati e disse: no, no. Bruciò le tragedie e... Mi sembra che la filosofia sia un po’ sempre
la revocazione di una vocazione, il mettere in questione una vocazione.
R.A. No, io lo dicevo in senso plotiniano, di qualcosa che deve essere liberato – come dire? – dagli strati
accumulatisi: un’idea in nuce che bisogna sprigionare.
Agamben Sì, significa anche che il pensiero non può essere una disciplina, un ambito, corrispondente a una
vocazione determinata. La filosofia, il pensiero sono delle ‘intensità’ che possono percorrere qualunque
ambito: la poesia, l’arte, la religione, il diritto, l’economia. Non esiste una specificità della filosofia. Per
questo la vocazione della filosofia ha solo la forma del cambiare, del mettere in questione una vocazione.
F.D.M. E già questa affermazione apre sulla sua esperienza asistematica di metodo, multidisciplinare
anche, cioè la tendenza a integrare nell’esperienza culturale. Una sua scena madre è: Provenza 1966,
dove lei a 24 anni assiste a dei seminari di Martin Heidegger, un pensatore che probabilmente già
conosceva, ma destinato a influire molto sulla sua elaborazione teorica. Andiamoin Provenza.
Agamben Sì, mi costringete a dei ricordi... Sì, l’esperienza di quel soggiorno in Provenza sicuramente per
me è stata abbastanza determinante come incontro con la filosofia. Filosofia che ancora una volta aveva
anche la forma, però, di un luogo, cioè di un paesaggio della Provenza. La presenza anche di René Char, il
poeta francese, che Heidegger era andato a trovare... Quindi di nuovo era una costellazione che si apriva
per me, più che un seminario in cui avrei appreso delle cose. Era più interessante l’esperienza stessa che i
contenuti del seminario, per me.
R.A. Ma Heidegger che ci faceva in Provenza? Era legato appunto a Char?
Agamben Inizialmente era andato a trovare René Char, e siccome sempre lavorava, aveva deciso di fare
questo seminario: eravamo cinque in un piccolo albergo, e il seminario aveva luogo all’aperto, sotto gli
alberi, qualche volta passeggiando in campagna si trovava una capanna, ci sedevamo lì... era
un’esperienza abbastanza straordinaria.
F.D.M. Abbastanza greca...
Agamben Abbastanza greca, sì. Per me poi l’incontro con Heidegger avveniva più o meno negli stessi anni
in cui avevo ‘incontrato’ Walter Benjamin, e credo di poter dire che mi sono serviti uno come
contravveleno dell’altro. Io credo che sempre, quando si ha un rapporto forte con un autore o con
qualcosa che amiamo, ci vuole anche un contravveleno. E gli autori più interessanti sono quelli che
contengono già un contravveleno contro i propri veleni.
R.A. E già la selezione si fa più stretta.
Agamben Sì... è una messa in costellazione di due autori di cui uno era molto critico rispetto all’altro, e
l’altro probabilmente non conosceva nemmeno l’altro (chiesi a Heidegger se aveva mai letto Benjamin e
disse di no): eppure si sono costeggiati a Friburgo negli stessi anni, quando Benjamin era studente.
F.D.M. In che modo Benjamin fu usato come contravveleno di Heidegger?
Agamben Sono in un certo senso l’opposto, con questa esperienza curiosa: che toccano spesso gli stessi
problemi da distanze remote, e qualche volta lo stesso termine. Ci sono dei termini che Benjamin giovane
usa che sono gli stessi del pensiero tardo di Heidegger. Sono due esperienze per me differentissime. In
generale quando lavoro con gli autori che amo, il mio rapporto è un po’ retto da questa legge... una volta
Feuerbach ha detto che in qualsiasi opera – opera di pensiero, di poesia, di arte –l’elemento filosofico è la
capacità che quell’opera ha di essere sviluppata: il germe, il punto non detto che può essere sviluppato,
ripreso. Io ho sempre un po’ seguito questo filo. Con gli autori che amo, più che imitarli, ripeterli, cerco
di trovare il punto in cui possono essere sviluppati, portati a, continuati.
F.D.M. Cosa ricorda della ricezione di Heidegger al tempo dei seminari di Provenza, cioè metà anni
sessanta?
Agamben In quel momento era scarsissima, in Italia quasi inesistente: provai invano a far tradurre le opere
di Heidegger da due degli editori più importanti, Einaudi e Adelphi: entrambi rifiutarono. Il rifiuto
continuò per Einaudi, invece Adelphi, molti, molti anni dopo pubblicò le opere di Heidegger.
R.A. Cinque ‘provenzali’ attorno a Heidegger, dunque – e uno era lei: qual era l’oggetto di queste lezioni,
di questi seminari? di queste conversazioni anche,immagino...
Agamben Ah, no, no, era un vero seminario con un tema preciso, cioè la lettura dei frammenti di Eraclito,
però in modo molto libero, e mi ricordo che c’erano continue interruzioni da parte di Jean Beaufret,
questo simpaticissimo allievo di Heidegger. E alla fine, a un certo punto Heidegger disse: «Mi avete
costantemente impedito di finire il mio seminario...».
F.D.M. E anche la figura di Char giocava a interrompere?
Agamben René Char non eranel seminario, però spesso andavamo a casa sua a trovarlo, Heidegger lesse
dei testi, gli chiese spiegazioni sulla frase di Rimbaud: la poesia non ritmerà più l’azione, sarà avanti
all’azione.
R.A. Sul piano del pensiero, che tracce ha lasciato Heidegger in Agamben? Agamben È difficile rispondere,
perché più che tracce sono presenze: i testi che uno continua a portare con sé... Per me si trattava di
capire cos’è la filosofia, semplicemente.
F.D.M. Com’era Heidegger personalmente?
Agamben Mi fece l’impressione di una specie di dolcissimo contadino. Aveva 76 anni, ma era molto
sveglio, con questi occhi vivissimi... Molti anni dopo, frequentando le Letture bibliche che Levinas faceva
nella sinagoga di Rue Michel-Ange a Parigi, accompagnai Levinas verso casa, e lui, che aveva saputo che io
ero stato ai seminari di Le Thor, mi fece la stessa domanda che mi ha fatto lei: «Ma Heidegger... com’è?».
E io gli diedi la stessa risposta, e Levinas, sorpreso (era stato allievo di Heidegger nel 1934): «Io me lo
ricordo completamente diverso. Era un uomo durissimo». E poi si fermò, e disse: «Ah, però nel frattempo
c’era stata la sconfitta della Germania!».
F.D.M. Ora vorrei tornare al problema della città moderna, ancora attraverso Benjamin, Parigi. Capitale
del XIX secolo: quali sono – di quel libro – le chiavi di lettura più operative oggi?
Agamben Benjamin ha anche scritto, secondo me, le più belle pagine su Napoli.
R.A. Forse dopo Croce.
Agamben No, secondo me più belle. La «città porosa», dice... Il rapporto di Benjamin con l’idea di città
era ovviamente diverso dal nostro. Lui viveva un momento in cui le grandi città europee erano ancora in
piena vita, e poi inseguiva il modello della grande città del diciannovesimo secolo, dove sempre cercava
quello che una volta ha definito «gli stracci della storia»: l’immagine della città che Benjamin inseguiva
era fatta di un’attenzione minuta ai dettagli trascurabili, un po’ secondari, infimi, appunto gli stracci
della storia. E queste esperienze apparentemente secondarie diventavano invece il paradigma per capire
una città, secondo il suo modello, però, di conoscenza storica, che era quello sempre di stabilire... non gli
interessava affatto, ovviamente, il passato come tale, e nemmeno a noi interessa, gli interessava quello
che lui chiamava una «costellazione» tra un momento del passato e il presente, l’ora, l’adesso. Tutto il
suo modo di lavorare è «realizzare» queste costellazioni: però attenzione, non si tratta dell’idea che il
passato debba gettare luce sul presente, o viceversa. No, era qualcosa di più complesso: l’oggetto storico
cioè non sta più né nel passato né nel presente, non sta più su una linea cronologica; sta invece in una
relazione paradossale tra due momenti. E questa è un’idea, mi sembra, molto bella, che ci toglie dai
problemi della cronologia, del passato, del diventare specialisti di un’epoca...
R.A. Resta in piedi, immagino, però, il problema della percezione.
Agamben Sì, perché questo momento, che appunto non è più un oggetto, un punto localizzabile nel
tempo, diventa per Benjamin quello che lui chiama «immagine». Benjamin usa questo strano termine –
Bild, immagine, «immagine dialettica» la chiama, per dire questo che è l’oggetto della conoscenza. Quindi
per esempio i ‘passages’ di Parigi (luogo a cui dedica tante pagine) erano per lui un’immagine dialettica,
cioè un’immagine che aveva la capacità di operare questa costellazione tra passato e presente; però essa
stessa, Benjamin dice, era una «dialettica immobile»: immobilità dell’immagine, che si tratta di
afferrare... Questa immagine dialettica è – dice Benjamin – «carica di tempo». Io credo sia uno sguardo
molto penetrante sulle immagini; anche a me interessano molto le immagini, perché quando sono colte
nella loro verità risultano cariche di tempo e di storia. Questo vale anche per la fotografia più banale,
quella di un volto, quella che per un attimo coglie un passante o una figura o un luogo. Che cosa coglie
una fotografia? Coglie un che di assolutamente temporale, che qualcosa è stato lì, e che ora è qui.
R.A. Questa è l’idea di Barthes, anche.
Agamben ...che è anche l’idea di Barthes, sì. Ma tradotto in termini benjaminiani che cosa significa? che
le immagini hanno a che fare col tempo in maniera fondamentale.
F.D.M. Per Barthes con la morte, invece.
Agamben Quella era la particolare ottica di Barthes, e direi che per Benjamin non ci si dovrebbe
esprimere così, sarebbe più con la vita: se le immagini sono cariche di tempo, sono qualcosa di vivo. C’è
una vita delle immagini. Questo vale per Benjamin, e vale per Warburg, e credo che c’è una corrente
importante di tutto il pensiero, anche dell’arte, del Novecento, che cerca di afferrare la vita delle
immagini.
R.A. Secondo questa idea della dialettica che precipita in una configurazione, quali sono le sue ‘immagini’
di Parigi, città-snodo della sua esperienza intellettuale?
Agamben La Parigi che ho conosciuto nei primi anni, cioè negli anni sessanta, aveva ancora molte di quelle
cose che Benjamin inseguiva, cioè improvvisamente una via laterale conduceva nel diciannovesimo secolo.
Io credo che questa natura temporale delle città sia importantissima. Una volta, mi ricordo, Ingeborg
Bachmann paragona le città a una lingua: anche una lingua ha un suo centro storico, ha un centro più
antico, una periferia più nuova... Voleva dire una cosa ovvia, no?, che la lingua che noi usiamo come se
fosse un che di intemporale è la cosa più storica che esiste. Noi ripetiamo nella nostra bocca suoni e
concetti che rimontano non solo a, eventualmente, la Roma Antica, ma addirittura ai bovari indoeuropei
di quando diecimila anni fa sono arrivati in Europa... Quindi quest’idea che la città e la lingua siano due
esseri temporali usando i quali o stando nei quali ci muoviamo nel tempo... Appunto, nella Parigi che ho
conosciuto c’era ancora, questo: mi ricordo che c’era proprio una via che ‘era’ il diciannovesimo secolo,
intatta; con le boutique, le vetrine, le stesse che aveva fotografato Atget più di un secolo prima.
F.D.M. Sono esperienze di tipo epifanico, in Benjamin: cioè la storia si mostra.
Agamben Sì, la storia appare appunto in un’immagine. E questa immagine può essere un oggetto, un libro,
ma anche un’immagine in senso tecnico, una fotografia. Per la Parigi di ora credo non si possa più dire
questo, dopo le grandi distruzioni del periodo pompidouriano che hanno cancellato Les Halles, a cui hanno
potentemente collaborato gli architetti, che sono dei grandi distruttori: gli architetti sono sempre dei
grandi distruttori...
R.A. Lanciamo un grido di dolore.
Agamben Beaubourg, che tanto piace, ha contribuito alla distruzione del più vivo e bel quartiere di Parigi.
Credo che ora siamolto più difficile, dovunque un po’, però è ovvio che tutto può sempre ancora avvenire.
Ciò che cambia si nasconde in ciò che rimane intatto; ciò che rimane intatto si nasconde in ciò che
cambia.
R.A. E allora, lei che ha studiato le Res gestae di Augusto, che cosa rimane della vecchia Ara Pacis in
questa nuova?
Agamben L’Ara Pacis era un oggetto storico già contenuto in qualcosa, in un involucro di epoca fascista: è
il problema della cosiddetta conservazione del passato – che è abbastanza disastrosa. Oppure l’idea di
riportare in pristino i monumenti del passato: ponte Sisto, che io percorrevo cinque volte al giorno, rimase
chiuso per anni perché questo delizioso ponte, che nella forma di allora era un ponte di inizio Novecento,
fine Ottocento, è stato riportato in pristino senza alcuna ragione. Questo tipo di operazioni sono il
contrario di una costellazione benjaminiana, non c’è più un rapporto vivo tra un momento del passato e
un momento del presente; e un passato come tale è ricostruito, restaurato così com’era. Benjamin critica
sempre l’idea dello storicismo, che si possa accedere a qualcosa così com’era.
F.D.M. La trasformazione della storia in immagini, che opera Benjamin contro lo storicismo e l’idea di
cronologia, come ha plasmato allora il suometodo di lavoro?
Agamben Credo che ci sia un rapporto, anche in questo caso, abbastanza forte. Benjamin, quando doveva
definire se stesso (esiste un carteggio molto duro con Adorno sul problema del metodo), spesso diceva
«filologo». Ed è molto curioso capire che cosa lui volesse intendere con filologo: la filologia per lui è la
rivendicazione di un rapporto quasi materiale con i testi, con gli oggetti. E anch’io... una grande
tentazione che ho avuto era quella di diventare un filologo: per fortuna non lo sono diventato, però nel
mio metodo c’è molto questo rapporto con la materialità di un passato. Però il bello della filologia,
appunto, è che è presa nella contraddizione, comedicevamo, per eccellenza: la filologia, per esempio se
si propone l’edizione di un testo antico, dovrebbe restaurare il testo così com’era,ma per far questo deve
ricorrere a pratiche come la congettura, che sono pratiche quasi divinatorie.
R.A. Sì, infatti si chiama divinatio.
Agamben Per cui il filologo in realtà spesso opera il paradosso di ‘produrre’ il documento del passato che
dovrebbe restaurare. C’è una vicinanza forte, per me, tra questo metodo filologico e un altro metodo,
presente in Benjamin ma anche in Foucault – altro autore con cui anni dopo ho avuto un rapportomolto
forte –, e che credo sia il metodo a cui chiunque voglia lavorare su ricerche di scienze umane, come
facciamo noi, non può fare a meno di riferirsi: ed è lavorare per paradigmi. Paradigma è un termine che
usa Foucault, e che cosa vuole dire? «Paradigma» è il termine greco per «esempio», significa
semplicemente «un esempio ». Prendiamo il panopticon, che è un modello architettonico concreto che si
può datare, in un libro scritto da Bentham nel 1800 e passa: quindi è un fenomeno storico particolare,
singolare...
R.A. Aveva uno scopo giudiziario, no?
Agamben Sì, era il modello delle carceri, era un modello di architettura carceraria in cui un guardiano
poteva vedere una molteplicità di prigionieri...
F.D.M. Un edificio di controllo sociale.
Agamben Di controllo sociale. Perché si può dire che Foucault lavora con i paradigmi? Perché appunto
Foucault non usa il panopticon soltanto come quel tipo singolare da indagare quale fenomeno storico, ma
come paradigma, come esempio per comprendere un insieme molto più ampio, che si costituisce proprio
tramite questo esempio, questo paradigma; e che appunto gli serve, poi, per capire l’evoluzione delle
società di controllo, le società disciplinari. Io credo che tutti gli storici intelligenti lavorano così. Infatti si
può dire questo anche di un libro come quello di Kantorowicz sui due corpi del re. I due corpi del re sono
un fenomeno specifico, che però non è circoscritto in un anno, o può volgere nel tempo...
R.A. ...lui lo applica soprattutto alle monarchie francesi e inglesi.
Agamben ...francesi e inglesi. Se ci pensate, nella nostra cultura accademica – che manca di ogni
riflessione epistemologica sullo statuto delle discipline umane –, quando uno storico vuole essere serio,
diventa specialista di un secolo: «Io sono uno specialista del secolo XVIII!», e non si accorge di dire la cosa
più assurda. Nel senso che nell’espressione «secolo XVIII» il secolo è un’unità di misura, non una realtà; è
una unità di misura molto recente, usata per la prima volta alla fine del Cinquecento dagli storici della
Chiesa, detti per questo centuriatores, «secolarii», che poi solo a partire dalla Rivoluzione francese
prende il significato moderno, prima non c’era mai stato... Quindi essere specialisti di un secolo significa
essere il meno scientifici possibile. Invece i contesti non-cronologici, non-geografici come una metafora,
un oggetto, un paradigma, sono molto più seri e interessanti.
R.A. Anche lo «stato di eccezione» è un paradigma.
Agamben Sì, in quel mio libro si vede appunto come il metodo per esempi e paradigmi che dicevamo
prima, è anche il mio metodo. Lo «stato di eccezione» è un istituto giuridico preciso che nella sua forma
moderna nasce con la Rivoluzione francese, ma io in realtà, anche se faccio una piccola storia dello stato
di eccezione, non sono uno storico e non lo uso, appunto, come un oggetto collocato cronologicamente,
ma come un modello per comprendere la situazione presente. Ed ero partito dalla constatazione ovvia che
quello che in origine era un provvedimento eccezionale, limitato nel tempo e nello spazio (lo «stato di
eccezione», per chi non lo sapesse, è la sospensione della legge per far fronte a una situazione di
emergenza), a partire almeno dalla seconda guerra mondiale, in maniera sempre più forte ed evidente
oggi, sta diventando un paradigma normale di governo negli stati democratici in cui viviamo.
R.A. Per cui non parliamo solo dei regimi fascisti e nazisti, o del «vecchio» stato di guerra.
Agamben Sì, il regime nazista ha potentemente usato lo stato di eccezione applicando l’articolo 48 della
costituzione di Weimar; tutto il regime nazista si è svolto in stato di eccezione, cioè di sospensione delle
garanzie personali, delle libertà civili, ecc., però, appunto, non è affatto una prerogativa degli stati
totalitari, anzi, quando lo vediamo nascere con la rivoluzione francese, curiosamente lo stato di eccezione
è legato alla tradizione democratica, anche se democratico-giacobina. E oggi non si capisce la politica
americana se non si capisce che il governo degli Stati Uniti vuole imporre uno stato di eccezione mondiale,
questa volta non più localizzato specificamente nei confini del proprio territorio, ma ’mobile’, che si
sposta secondo le occasioni. Questo stato di eccezione globale, mondiale, è la risposta a una guerra civile
mondiale, il terrorismo, cioè a dire l’interlocutore ideale dello stato di eccezione.
F.D.M. Il termine cronologico dello stato di eccezione, lei dice, è la fine della seconda guerra mondiale...
Agamben Durante sia la prima che la seconda guerra mondiale, ovviamente quasi tutti gli stati belligeranti
– e curiosamente ho scoperto anche non belligeranti, come la Svizzera –, ricorsero allo stato di eccezione.
Quindi è in queste lunghe guerre che comincia a diventa-re un paradigma ‘normale’. Dalla fine della
Seconda guerra alcuni caratteri dello stato di eccezione, ad esempio per quel che concerne il diritto
internazionale, sono rimasti: da allora nessuna guerra è più dichiarata – né quella di Corea, né quella del
Vietnam lo furono –, quindi non abbiamo più uno stato di guerra secondo il diritto internazionale, dove è
possibile distinguere il momento in cui comincia e finisce una guerra, e distinguere i militari dai civili...
Come voi sapete, dalla fine della Seconda guerra, nessuna guerra è guerra: è guerra civile.
F.D.M. C’è una continuità rispetto alla vita civile.
Agamben Esatto, dal punto di vista del diritto queste guerre non sono guerre, ma sono guerre civili, o
operazioni di polizia.
R.A. Dal punto di vista giuridico teoretico, il fondamentalismo islamico che ruolo interpreta, secondo lei,
nello stato di eccezione globale?
Agamben Innanzitutto non c’è paese più fondamentalista, oggi, degli Stati Uniti, che sono riusciti a
trasformare i concetti della democrazia in strumento di pressione totalitaria... Entrambi questi due, forse,
pseudo-avversari (che secondo la rappresentazione comune si fanno fronte), non rappresentano né l’uno la
tradizione dell’Islam né l’altro la tradizione della democrazia occidentale. La prima cosa che
bisognerebbe sempre non dimenticare è che il terrorismo è la figura ideale che corrisponde a questo
paradigma dell’eccezione: perché il terrorista per definizione è invisibile. Per esempio, voi sapete che
tutta la materia relativa all’inchiesta sulle Torri è stata dichiarata fuori delle competenze giurisdizionali,
e quindi è esclusivo appannaggio dei servizi segreti americani. Voi avreste fiducia in una ricostruzione
fatta solo dai servizi segreti, in cui nessun giudice ha potuto mettere bocca?
F.D.M. Qual è il nesso tra stato di eccezione che diventa forma di governo planetario e globalizzazione
dell’economia?
Agamben A dire il vero nel mio libro questo tema non c’è, perché ho voluto fare un’analisi che
concernesse soltanto il Diritto. Se pensate a Foucault, lui ha lasciato quasi sempre intenzionalmente da
parte l’esame del Diritto: gli interessavano più i modi concreti in cui quelle che lui chiamava le relazioni
di potere si realizzano nei singoli corpi. A me sembra che la ricerca di Foucault va integrata con questo
modello del Diritto, che tra l’altro nel nostro tempo ha uno statuto molto curioso: da una parte, gli unici
concetti che circolano sono di tipo giuridico, non esiste più né un’etica né una politica, sono concetti
giuridici travestiti da concetti etici o da concetti politici; però in realtà del Diritto nessuno ha
competenza, nessuno sa più nulla, è uscito fuori dalla cultura comune. Quindi mi sembrava urgente
occuparmene. Ecco perché nel mio libro l’economia non c’è, e poi se dovessi esser sincero... se ogni libro
– come è stato detto – si scrive per avvicinarsi, o qualche volta per sfuggire, a un centro che rimane
nascosto, nel mio caso questo centro nascosto è una domanda curiosa che concerne proprio l’essenza del
Diritto: se lo stato di eccezione diventa un po’ il paradigma, il centro stesso del Diritto, come mai la
norma, il sistema giuridico dell’Occidente, ha bisogno di avere questo rapporto con una sospensione, con
un vuoto di legge, con uno stato di a-nomia? Come mai il nostro Diritto contiene al suo centro uno spazio
non giuridico, di sospensione?
R.A. Non è un po’ come il folle per le marce della macchina?
Agamben Ah, mi pare una bella immagine! Sì, sembrerebbe che questa macchina che è il sistema giuridico
e politico dell’Occidente funzioni con due poli, che però sono articolati su questa zona indistinta, oscura,
di indifferenza, che è un luogo vuoto: dove però tutto può avvenire, e questo vuoto mette in moto la
macchina, regge la macchina... Quindi la domanda ultima, il centro segreto del libro, era più vasta,
concerneva quasi la natura stessa del nostro sistema politico e giuridico.
R.A. Un altro suo titolo chiave, che ha avuto più edizioni, è Homo Sacer. Sottotitolo, Il potere sovrano
nella nuda vita. Anche qui la cornice è foucaultiana: quand’è che la vita diventa posta in gioco della
politica?
Agamben Sì, il termine è una figura arcaica del Diritto romano, che designava un uomo che era possibile
uccidere senza commettere delitto (quindi impunemente) e che però non era possibile sacrificare,
mettere a morte nelle forme prescritte, rituali. Quindi veramente una figura di indeterminazione assoluta.
(Una specie di figura assoluta si potrebbe dire anche la vita nello stato di eccezione). Ancora una volta
non mi interessava – anche se ho dovuto farlo – indagare storicamente questo complesso problema della
storia del diritto penale arcaico, ma trovare un paradigma per capire la struttura della politica in cui
viviamo. E questo è poi stato il risultato. Lì seguivo l’idea foucaultiana di «biopolitica»: a un certo punto
con la modernità vediamo che la vita, da qualcosa che era fuori dei calcoli e delle mire del potere, la vita
naturale dei cittadini e degli uomini, diventa una delle preoccupazioni maggiori dei calcoli e dei
meccanismi del potere. Noi ormai siamo abituati a che lo Stato si occupi della nostra vita perfino nelle
minuzie, come fumiamo, come abitiamo, come mangiamo, come andiamo in macchina. Questa è una
novità del Moderno... Quello però che mi è avvenuto di scoprire, è che questo che per Foucault è la
biopolitica – cioè la politica dove la vita è in gioco –, è in realtà più antico, in qualche modo è la struttura
stessa del sistema giuridico-politico dell’Occidente. Che sempre, fin dall’inizio, si fonda su questa curiosa
figura del catturare qualcosa: la vita, la vita naturale che nella Grecia classica era qualcosa di fuori, che
doveva restare nei limiti della casa, con gli schiavi, le donne, i bambini, la produzione economica... e
invece catturarla nella forma stessa della sua esclusione. La domanda era: ma come mai la politica
occidentale ha bisogno di escludere da sé qualcosa (all’inizio, la vita) per fondarsi? Quindi questa struttura
di fondazione arretra di molto il problema, e quello che avviene oggi non è che l’emergere in piena luce di
questa struttura nascosta di inclusione della vita umana tramite la sua esclusione.
F.D.M. E questa inclusione forzata della vita nella sfera del politico, lei, nel Novecento, la vede figurata
nel campo di concentramento.
Agamben Naturalmente qui ci sono stati spesso degli equivoci. Il mio non è un giudizio storico, né
sociologico, si tratta ancora una volta di trovare un archetipo filosofico, e il Campo è il luogo
dell’eccezione: coloro che entrano nel Campo, vi entrano soltanto in quanto viventi; l’ebreo che entrava
nel campo di concentramento era spogliato completamente del suo statuto giuridico, anche di quel
residuo di nazionalità che gli avevano lasciato le leggi di Norimberga, di terzo grado. Al momento
dell’entrata era totalmente denazionalizzato, e quindi diventava una pura figura di quella che io chiamo
la «nuda vita», e la relazione fondamentale tra potere e nuda vita emerge alla luce del Campo. Pensiamoa
quello che avviene oggi a Guantanamo... la cosa più curiosa è che i talebani che si trovano lì non sono
accusati di nessun delitto secondo la legge americana, e non sono nemmeno prigionieri di guerra; sono,
secondo la lettera dell’istituzione del comando di Bush che ha istituito Guantanamo, «detenuti».
F.D.M. Per cui sono «nuda vita».
Agamben Non esistono. Non hanno nessuno statuto giuridico, quindi qualunque cosa potrebbe essere
possibile come nei campi tedeschi.
F.D.M. Agamben, in questo ultimo scorcio del suo pensamento lei sta lavorando su Aby Warburg, figura
molto controversa anche come ricezione. Ci vuol spiegare qual è precisamente il «suo» Warburg?
Agamben Sono tornato su Warburg a distanza di tanti anni: ne avevo bisogno, credo, dopo questa
inversione nei problemi di filosofia politica... Il lavoro che faccio più di recente concerne proprio la cosa a
cui Warburg lavorava negli ultimi anni della sua vita, dal ’24 al ’29, cioè questo progetto di atlante per
immagini (cosa chemi affascina molto) che lui chiamava Mnemosyne, «memoria»: un atlante della
memoria occidentale, in apparenza; praticamente, si tratta di una settantina di pannelli, grandi, ricoperti
di tela nera, su cui lui appuntava, spillava una serie di fotografie che potevano essere opere d’arte,ma
anche una fotografia della pubblicità, una fotografia di una contadina per le strade della campagna
toscana, ecc. Che cosa voleva fare Warburg? La domanda che mi sono posto è capire l’enigma di questo
atlante – atlante che abbiamo, non materialmente ma nella sua riproduzione fotografica.
F.D.M. Incompiuto, peraltro.
Agamben Incompiuto sicuramente, però abbiamo settanta tavole con quasi un migliaio di fotografie.
Sicuramente non era quello che poi in realtà è stato ‘raccolto’ dagli storici dell’arte: non era un
repertorio iconografico dell’arte occidentale, a Warburg la storia dell’arte interessava solo come cifra di
qualcos’altro. Queste immagini non sono nemmeno immagini, in un certo senso. Potrebbero anche essere
chiamate gesti, rappresentano ciascuna... che cosa?... un gesto? Warburg dice: «dei cristalli di memoria»,
attraverso cui si trasmette la memoria dell’Occidente.
F.D.M. Può essere raffrontato al concetto di immagine di Benjamin?
Agamben Certo, del resto Benjamin si interessava molto alle prime ricerche, allora, di Warburg. Perché, di
cosa sono fatte queste immagini? Direi, ancora una volta, sono cariche di tempo, di storia, sono dei
cristalli... Qualche volta Warburg usa l’immagine della fisica del suo tempo, della tecnica del suo tempo:
«dinamogramma», sono cariche di energia elettrica... E ricevere queste immagini significa esporsi,
misurarsi con questa carica di energia mnemonica (intendendo lamemoria in un senso molto vasto). E
l’artista, lo studioso, o qualunque uomo che si confronta con queste immagini si espone a un rischio –
mette in gioco se stesso – per rianimare queste immagini, che sono lì come ormai spettri. Warburg
chiamava questo album: «una storia di fantasmi e di spettri per adulti, per veramente adulti».
R.A. L’atlante, come anche la Biblioteca, ha un tasso di lavorazione molto forte dal punto di vista degli
accostamenti sintattici. Destrutturare, e ristrutturare, le liaisons, le contiguità.
Agamben Esatto, sì. Ed è difficilissimo capirle. Prendiamo una delle figure che ossessionava Warburg:
«ninfa fiorentina», figura femminile in movimento che lui identifica la prima volta in un affresco di
Ghirlandaio a Santa Maria Novella – quindi sappiamo cos’è –, però diventa un paradigma, la Ninfa, che
ritrova dall’antichità a una fotografia di pubblicità oggi, a una figura terribile – la tagliatrice di testa,
Giuditta... Questa planche, questa tavola, ce l’abbiamo (una settantina di fotografie...). Se chiediamo:
dov’è la ninfa? come la leggiamo, sintatticamente appunto? Non si può disegnare in realtà un itinerario
cronologico, come ci si muova dentro questa planche è impossibile da capire subito... La sola cosa che si
può dire è che nessuna di queste fotografie è l’originale, l’archetipo, e nessuna è una copia. La Ninfa è
l’insieme di queste immagini, che a questo punto, allora, diventano dei fotogrammi per un film chemanca.
Noi dovremmo essere in grado di mettere in movimento questi settanta fotogrammi, farli muovere, dar
vita alle immagini. Questo era proprio lo scopo letterale di Warburg: dar vita alle immagini. Lì sono delle
immagini morte.
F.D.M. Infine, San Paolo: il libro in questione è Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai romani.
Che cos’è «il tempo che resta»?
Agamben Mi fate tornare indietro sul passato, sui libri del passato, sui libri così come veramente erano...
R.A. Ma San Paolo è ancora seduto qui con noi. F.D.M. Non penso che si possa tornare al passato: a
proposito di San Paolo, poi, proprio no.
Agamben Prima dicevo che mi interessano più il prima e il dopo, dell’opera: bisognerebbe situare
questomio libro tra un prima e un dopo. Mi piace sempre tantissimo quel che diceva Vasari di Leonardo:
«Leonardo per l’intelligenza dell’arte molte opere cominciò e nessuna finì». Il fatto che l’intelligenza
dell’arte impedisca di finire qualcosa...
F.D.M. È un suo modello, immagino.
Agamben Non è un modello, per carità! Però in un certo senso tutte le opere sono non-finite, da questo
punto di vista. Qui, appunto, una prima questione (almeno per me è stato così), è chiedersi, con
Benjamin, se le opere del passato stanno lì a disposizione dei ricercatori, che possono scegliere questa o
quella: no! Invece contengono ciascuna un indice temporale, che esige che esse vengano lette in quel
precisomomento. E quindi l’intelligenza dello studioso sta nel cogliere questo indice: le Lettere di Paolo
oggi esigono di essere lette e rilette (non è un caso che vari autori stanno tornando su questo testo). Forse
una cosa che potrei dire, principale, è stata che Paolo mi ha fatto capire in modo diverso il problema del
tempo storico. Il problema del «messianico», per esempio in Benjamin, l’ho capito solo lavorando su
Paolo. Per Paolo l’evento messianico (che lo interessava, l’arrivo del Messia) non è, come si suole pensare,
semplicemente la fine, il punto finale del tempo, ma, in una formula: «il tempo della fine», il tempo che
comincia a finire e si trasforma qualitativamente. In questo senso si potrebbe dire ancora, con un’altra
immagine, che il tempo messianico, il tempo che resta, l’unico tempo in cui noi viviamo, di cui abbiamo
esperienza reale, è qualcosa come il tempo che il tempo ci mette per finire. Che la fine è sempre in
corso, è una vera esperienza politica del tempo, o comunque storica, reale, umana. Non è quella
cronologica, ma è vivere il tempo sempre come tempo che resta, cioè come questa parte del tempo che il
tempo ci mette per finire, e in cui possiamo afferrare il tempo. E la fine non ha importanza al momento
della fine. La fine finisce tante volte...
R.A. E del resto è un’idea profondamente cristiana... Non a caso c’è questa espressione, «una
ricapitolazione vertiginosa». Forse è questa l’immagine?
Agamben Sì, perché questa porzione di tempo in realtà per Paolo ricapitola in sé, contiene in sé – come
una vera abbreviatura, un vero compendio – tutta la storia. E tutta la storia passata trova in questa nuova
esperienza del tempo il suo unico senso.
R.A. In questo libro su San Paolo c’era anche una sua scoperta filologica. Studiando il manoscritto delle
tesi di Benjamin sulla filosofia della storia, lei trova questa citazione nascosta di San Paolo: «la potenza si
compie nella debolezza», ed è appunto la seconda lettera ai Corinti.
Agamben Sì, per me è stata una scoperta davvero abbastanza emozionante. Avevo letto questo testo
infinite volte, ma non mi ero mai accorto che è una citazione letterale di Paolo, e quindi, quando c’è
all’inizio delle Tesi benjaminiane l’immagine di un omino gobbo, nascosto sotto la scacchiera – che è la
teologia: la teologia piccola e brutta, che però dobbiamo usare nella lotta contro il nemico –, ebbene
questo nano gobbo, questo teologo nascosto, è Paolo. È stata una scoperta abbastanza decisiva, secondo
me, che mi pare anche di aver provato con ragioni filologiche,ma che non è facile far accettare agli
studiosi di Benjamin, perché c’è sempre questa idea che Benjamin è inscritto nella tradizione ebraica, e
Paolo (chissà perché) non apparterrebbe alla tradizione ebraica. Mentre Paolo è l’ebraismo più puro e
genuino che uno possa immaginare. C’è questo gobbo che si muove sotto il testo delle Tesi...