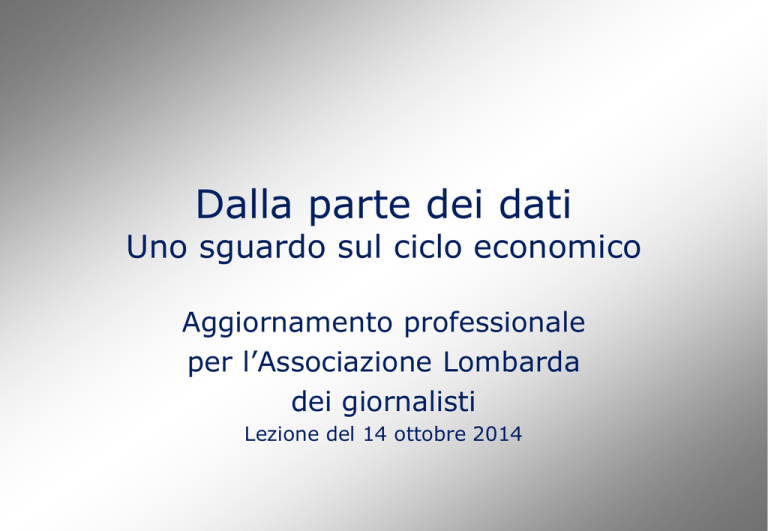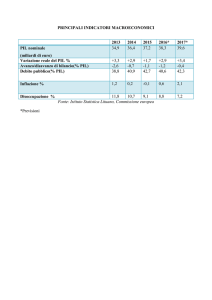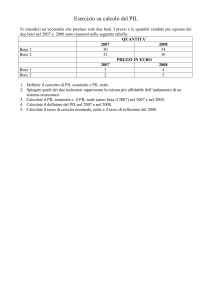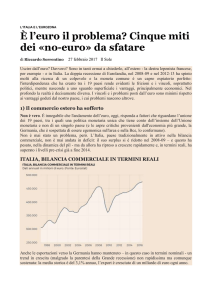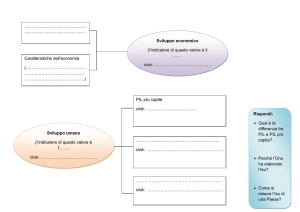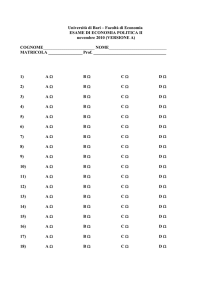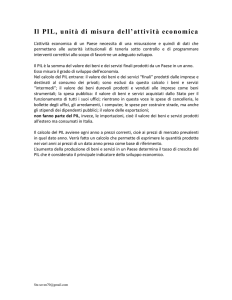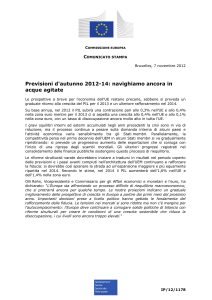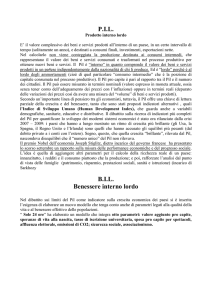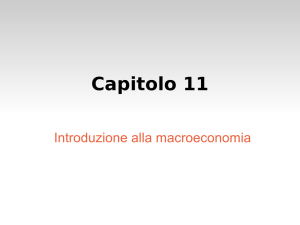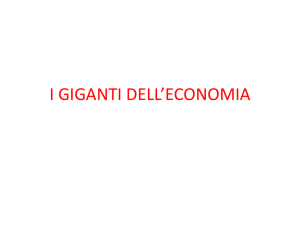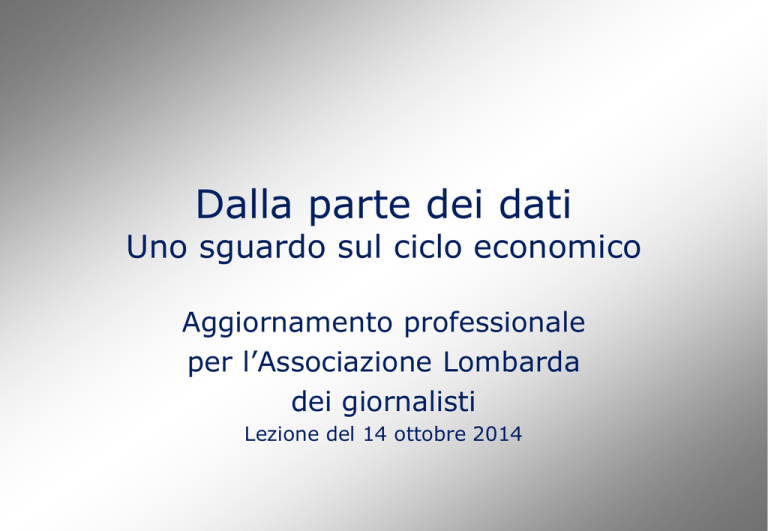
Dalla parte dei dati
Uno sguardo sul ciclo economico
Aggiornamento professionale
per l’Associazione Lombarda
dei giornalisti
Lezione del 14 ottobre 2014
Due approcci al ciclo
economico
Il ciclo economico
Il ciclo economico
Il Pil reale
11,000,000
10,000,000
9,000,000
Gdp reale
8,000,000
Trend Gdp
7,000,000
dic-11
dic-09
dic-07
dic-05
dic-03
dic-01
dic-99
dic-97
dic-95
6,000,000
Il ciclo economico
Le teorie del ciclo
La teoria delle crisi di Karl Marx
Secondo Marx, i capitalisti effettuano investimenti in
innovazione per ridurre il costo del lavoro e
aumentare la produttività e quindi i profitti privati.
L’aumento degli investimenti in capitale a scapito di
quelli sui salari (fonte vera dei profitti) riduce il tasso
di profitto (utili/capitale) mentre l’aumento della
disoccupazione ‘tecnologica’ riduce la domanda di
beni. Teoria subito abbandonata anche da molti
marxisti
Rivitalizzata da Andrew Kliman, che ha così spiegato la
Grande recessione partendo dai dati
Le teorie del ciclo
La teoria keynesiana
• Le decisioni di investimento degli imprenditori
sono sottomesse a un’incertezza radicale e
irrimediabile
• Gli investimenti legati più all’“animal spirit”, al
sentiment che al tasso di interesse
• La crescita o la riduzione della domanda
(soprattutto di investimenti) ha effetti
moltiplicati nel sistema economico
Le teorie del ciclo
Le teorie “mainstream”
Le fluttuazioni sono determinate da fattori
esterni al sistema economico che lo spingono
a ritrovare un nuovo equilibrio
L’equilibrio può essere raggiunto piuttosto
rapidamente e senza intoppi (impostazione
New Classical) o con intoppi e resistenze su
prezzi e salari (impostazione New Keynesian)
Le teorie del ciclo
Le teorie “mainstream”
I fattori esterni:
• Tutto ciò che è compreso nella A della teoria
della crescita (Y = Aƒ(L, K))
• L’innovazione tecnologica, introdotta nel
sistema con gli investimenti
• Il cambiamento delle preferenze
– Il petrolio e la crisi del 2008
Le teorie del ciclo
La teoria di Knut Wicksell
Il tasso di interesse finanziario (o bancario) e
quello “naturale”, che mette in equilibrio
domanda e offerta (risparmio e investimenti)
non coincidono mai. Quando il tasso
finanziario è più basso, in particolare, si
creano le fasi di boom, nel caso contrario
quelle di depressione
Le teorie del ciclo
L’ispirazione di Knut Wicksell
La scuola Austriaca ne deriva che tassi bassi –
spesso determinati dalla politica monetaria –
alterano i prezzi, “segnali” inviati agli
imprenditori: incentivano investimenti
eccessivi e sbagliati (malinvestment)
Le teorie del ciclo
L’ispirazione di Knut Wicksell
Hyman Minski ne deriva l’idea (l’ipotesi) della
instabilità finanziaria: la stabilità finanziaria
incentiva gli attori economici a indebitarsi, fino
a un livello insostenibile: alimenta così la sua
stessa fine
Quando si occupa di politica monetaria, il
“mainstream” ama definirsi new-wicksellian
Le teorie del ciclo
• La recessione da balance sheet
• L’accumularsi di debiti nei bilanci delle
aziende rende difficile i rimborsi.
• Le aziende non chiedono più credito, le
banche – piene di prestiti in sofferenza – non
ne offrono più
• Si riducono gli investimenti e la domanda
Le teorie del ciclo
•
•
•
•
•
Il monetarismo di mercato
Prima scuola economica nata sul web
Ispirazione da Milton Friedman
A favore, in questa crisi, di politiche
ultraespansive
Ogni recessione è un fenomeno monetario
Quindi: le recessioni sono causate dagli errori
delle banche centrali
Il ciclo economico
Il Pil reale
11,000,000
10,000,000
9,000,000
Gdp reale
8,000,000
Trend Gdp
7,000,000
dic-11
dic-09
dic-07
dic-05
dic-03
dic-01
dic-99
dic-97
dic-95
6,000,000
In ogni caso…
Eurolandia: il ciclo economico
Gdp
Investimenti
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
2013Q2
2011Q4
2010Q2
2008Q4
2007Q2
2005Q4
2004Q2
2002Q4
2001Q2
1999Q4
1998Q2
1996Q4
1995Q2
Partire dai dati
Uno sguardo empirico
Vantaggi: legame diretto con la realtà, verifica
della validità delle teorie
Svantaggi: legami statistici non sempre stabili
nel tempo
Due relazioni empiriche
La legge di Okun: all’aumento della crescita (2%
nella formulazione originaria, relativa agli Usa)
corrisponde una diminuzione (-1% nella
formulazione originaria) della disoccupazione
La curva di Phillips: a un aumento dell’inflazione
corrisponde una riduzione della
disoccupazione
La legge di Okun
Crescita disoccupazione
Eurolandia - Legge di Okun
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
Crescita Pil
0,0
0,5
1,0
1,5
La legge di Okun
Crescita disoccupazione
Grande recessione - Legge di Okun
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
Crescita Pil
-0,5
0,0
0,5
1,0
La curva di Phillips
Eurolandia 2008-2009
5,0
Inflazione
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
Disoccupazione
9,5
10,0
10,5
La curva di Phillips
Inflazione
Eurolandia 2008-2013
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Disoccupazione
2008-2009
2010
2011 - 2013
11,0
12,0
La curva di Phillips
Eurolandia - Curva (?) di Phillips
5,0
Disoccupazione
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Inflazione
11,0
12,0
I limiti delle relazioni empiriche
• Le relazioni empiriche, per la loro natura
instabili, non permettono neanche
potenzialmente di fare previsioni attendibili,
(come richiede alle teorie la metodologia di
Milton Friedman)
• Le relazioni empiriche permettono però di fare
diagnosi sullo stato dell’economia (come
prevede la metodologia di Marshall)
• Keynes: l’economista ideale, come un dentista
I dati macroeconomici
• I dati
– Prodotti dagli istituti di statistica (pubblici o privati)
• Occorre valutarne:
– Le modalità di produzione
– Il significato
– L’uso
Base 2010=100
Set-2013
Lug-2013
Mag-2013
Mar-2013
Gen-2013
Nov-2012
Set-2012
Lug-2012
Mag-2012
Mar-2012
Gen-2012
Nov-2011
Set-2011
Lug-2011
Mag-2011
Mar-2011
Gen-2011
Nov-2010
Set-2010
Lug-2010
Mag-2010
Mar-2010
Gen-2010
I dati grezzi
Produzione industriale Italia - dati grezzi
120
110
100
90
80
70
60
50
Base 2010=100
Set-2013
Lug-2013
Mag-2013
Mar-2013
Gen-2013
Nov-2012
Set-2012
Lug-2012
Mag-2012
Mar-2012
Gen-2012
Nov-2011
Set-2011
Lug-2011
Mag-2011
Mar-2011
Gen-2011
Nov-2010
Set-2010
Lug-2010
Mag-2010
Mar-2010
Gen-2010
I dati destagionalizzati
Produzione industriale Italia - dati grezzi e destagionalizzati
120
110
100
90
80
70
60
50
Nov-2013
Set-2013
Lug-2013
Mag-2013
Mar-2013
Gen-2013
Nov-2012
Set-2012
Lug-2012
Mag-2012
Mar-2012
Gen-2012
Nov-2011
Set-2011
Lug-2011
Mag-2011
Mar-2011
Gen-2011
Nov-2010
Set-2010
Lug-2010
Mag-2010
Mar-2010
Gen-2010
I dati destagionalizzati
Produzione industriale Italia - dati destagionalizzati
106
104
102
100
98
96
94
92
90
Due tipi di correzioni
• La destagionalizzazione: se la produzione del
mese di agosto è pari al 60% della media di
tutti i mesi, si divide il dato grezzo per il 60%
• La correzione per giorni lavorati: si correggono
le alterazioni in modo da annullare le
differenze generate da un diverso numero di
giorni di lavoro
Elaborare i dati
Variazione tra due dati X2 rispetto a X1
in percentuale
∆ = (X2/ X1-1)*100
Le unità di misura
• Alcuni dati vengono espressi in euro, o nella
valuta dell’economia a cui si riferiscono.
Anche se sono dati che vogliono esprimere
volumi e non valori
• Altri dati vengono espressi con un indice. In
genere la media di un intero anno viene posta
uguale a 100 (p.es. base 2010 = 100)
Elaborare i dati
• Occorre sempre precisare su quale orizzonte
temporale si effettuano le variazioni (mensile,
trimestrale, annuale)
In Italia si distingue tra:
• variazione congiunturale, a più breve termine
(mese su mese, trimestre su trimestre)
• variazione tendenziale, annua
Da un periodo a n periodi
•
•
•
•
•
•
X (p.es trimestrale)
Si divide per 100
Si aggiunge 1
Si eleva a n (p.es. 4)
Si sottrae 1
Si moltiplica per 100
•
•
•
•
•
•
•
X = 0,3%
= 0,003
= 1,003
= 1,012054
= 0,012054
= 1,2054
Lo 0,3% trimestrale è
pari al’1,2%
annualizzato
Da n periodi a un periodo
•
•
•
•
•
•
X (p.es. annualizzato)
Si divide per 100
Si aggiunge 1
Si eleva a 1/n (p.es. ¼)
Si sottrae 1
Si moltiplica per 100
•
•
•
•
•
•
•
X = 3,2% (pil Usa 4Q)
= 0,032
= 1,032
= 1,007906
= 0,007906
= 0,79
Il 3,2% annualizzato
corrisponde a uno 0,8%
circa trimestrale
Le medie mobili
Italia - Saldo commerciale
4000
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
set-13
mag-13
gen-13
set-12
mag-12
gen-12
set-11
mag-11
gen-11
set-10
mag-10
gen-10
set-09
mag-09
gen-09
set-08
mag-08
gen-08
Dati in milioni di euro
Le medie mobili
Italia - Saldo commerciale
4000
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
set-13
mag-13
Media mobile a tre mesi
gen-13
set-12
mag-12
gen-12
set-11
mag-11
gen-11
set-10
mag-10
gen-10
set-09
mag-09
gen-09
set-08
mag-08
gen-08
Dati in milioni di euro
gen-13
gen-10
gen-07
gen-04
gen-01
gen-98
gen-95
gen-92
gen-89
gen-86
gen-83
gen-80
Il rebasing
Usa: produttività e salari
250
200
150
Produttività
100
Salari
50
0
Il rebasing
• Per confrontare lo sviluppo di due grandezze
nel tempo si pongono i due termini iniziali X0 e
Y0 uguali a 100 e, in proporzione si calcolano
tutti gli altri (A0 e B0).
• An = Xn/X0 * 100, analogamente B0
• Attenzione: i risultati possono cambiare molto
cambiando i termini iniziali
Tre dati fondamentali
• Il prodotto interno lordo – quanto si produce
• L’inflazione – come cambiano i prezzi
• La disoccupazione – quanta gente lavora,
quanta gente cerca lavoro
Wesley Mitchell
• Mitchell, fondatore dell’Nber, ha dato vita
all’analisi empirica del ciclo. La sua
impostazione è considerata «priva di una
teoria»
• Punto di partenza è il movimento parallelo, in
circostanze normali, di prestiti, crescita,
prezzi, e occupazione, in genere in questo
ordine.
• Motore del ciclo sono le aspettative sui profitti
Il prodotto interno lordo
È il dato macroeconomico più importante che, in
un certo senso, racchiude tutti gli altri.
È la somma dei prodotti dei beni “finali” (occorre
evitare la doppia contabilizzazione)
Meglio: è la somma dei valori aggiunti di tutte le
unità produttive
Valore aggiunto: ricavi di vendita meno i costi
per materie prime. Viene poi diviso tra salari,
profitti, rendite, interessi e imposte
Il prodotto interno lordo
• Il pil nominale tiene conto dei prezzi di mercato. Non
distingue tra l’effetto della maggiore produzione e
quello dell’inflazione. È l’elemento di confronto per i
debiti (pagati al nominale)
• Il pil reale tiene conto del “volume” della produzione,
facendo astrazione dall’andamento dei prezzi
• La crescita del pil nominale, è pari all’inflazione più la
crescita del pil reale
• Tutti i dati quantitativi possono essere nominali o
reali
Il prodotto interno lordo
• I dati del prodotto interno lordo – reali e
nominali - sono trimestrali
• Vengono diffusi dopo uno (negli Usa) o un
mese e mezzo (in Eurolandia) dalla fine del
trimestre di riferimento
• Sono previste più release per rendere via via
più preciso, e a volte più ricco, il dato
Il prodotto interno lordo
• La qualità dei dati sul Pil, almeno nella prima
release, varia molto
• Gli Stati Uniti sono in grado di pubblicare, dopo un
mese, 17 pagine di dati, che si arricchiscono nelle
releases successive delle indicazioni sui profitti
• Eurolandia è in grado di pubblicare, un mese e
mezzo dopo, due pagine di dati, che salgono dopo
un mese circa a sei
• L’Italia pubblica poche righe, che salgono dopo un
mese circa a sei pagine
Il prodotto interno lordo
Il Pil è la somma di
• Consumi
• Investimenti in macchinari e costruzioni (e
variazione delle scorte: merci prodotte e non
vendute)
• Consumi e investimenti pubblici
• Esportazioni nette (esportazioni meno
importazioni)
• Y = C + I + G + Ex
Il prodotto interno lordo
Dal prodotto interno lordo si può ricavare
• La domanda totale: C + I + G + Es
• La domanda domestica: C + I + G + Im
• La domanda totale e domestica finale
escludono le scorte
Il prodotto interno lordo
• Il limite del prodotto interno lordo è la sua periodicità
trimestrale e il ritardo con cui vengono conosciuti i
dati
• In Eurolandia non sono ancora noti i dati sul terzo
trimestre 2014, e non lo saranno fino al 14 novembre
• Come conoscere l’andamento del Pil in anticipo?
La produzione industriale
• I dati sono mensili
• Anche molti servizi sono servizi alle aziende e
seguono l’andamento della produzione
industriale
• Nel tempo, però, il peso di produzione e
servizi alle aziende si sta riducendo
• I servizi al consumo, piuttosto volatili,
acquistano intanto un peso sempre maggiore
La produzione industriale
Produzione industriale e Pil Italia base 2010 = 100
106
104
102
100
98
96
94
92
90
Ott-2013
Lug-2013
Apr-2013
Gen-2013
Ott-2012
Lug-2012
Apr-2012
Gen-2012
Ott-2011
Lug-2011
Apr-2011
Gen-2011
Ott-2010
Lug-2010
Apr-2010
Gen-2010
Pil
Il Pil nominale e M1
M1 e Pil nominale di 9 mesi dopo
Pil nominale
trimestrale
2500000
2300000
2100000
1900000
1700000
1500000
1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 5000000 5500000
M1, dati in milioni
M1 e Pil nominale
M1 e Pil nominale di 15 mesi dopo (dal 2009)
Pil nominale
trimestrale
2490000
2440000
2390000
2340000
4500000
4700000
4900000
5100000
M1 - dati in milioni
5300000
5500000
M1 e Pil nominale
Il Pil nominale - proiezioni in base a M1
2.5
2
1.5
1
0.5
0
dic-14
nov-14
ott-14
set-14
ago-14
lug-14
giu-14
mag-14
apr-14
mar-14
feb-14
gen-14
dic-13
nov-13
ott-13
set-13
I risultati effettivi
Gli indici Pmi e il Pil reale
Gli indici Pmi e il Pil reale
Gli indici Pmi e il Pil reale
Gli indici Pmi
• Indicatori qualitativi
• Definiti “di confidence”, ma in realtà “di attività”
• Suddivisi in diversi subcomponenti:
produzione, nuovi ordini (domestici ed esteri),
scorte, prezzi, occupazione
• Realizzati intervistando i manager acquisti ai
quali si chiede se le singole componenti sono
in espansione o in contrazione
Gli indici Pmi
• Un indice Pmi al di sopra di quota 50 indica
espansione
• Un indice Pmi sotto quota 50 indica
contrazione
• Vale la stessa regola anche per le
subcomponenti
• Esistono diversi tipi di Pmi (manifatturiero,
servizi, composito, vendite al dettaglio)
• Disponibili per diversi paesi
Gli indici Pmi
• Sono molto tempestivi: sono pubblicati a inizio
mese per il mese precedente, e in alcuni casi
è previsto un dato “flash” nella seconda metà
dello stesso mese di riferimento
• Sono quindi definiti indicatori coincidenti
• Il rapporto con il Pil è molto stretto, ma
impreciso e variabile
Il leading indicator della Ocse
Il leading indicator della Ocse
Il leading indicator dell’Ocse
Il leading indicator della Ocse
• Il Cli (Composite leading indicator) è un
indicatore anticipatore
• I punti rilevanti sono i punti di svolta, dove la
curva inverte la direzione
• Statisticamente il punto di svolta del Cli
precede di sei mesi circa il punto di svolta
dell’economia
Altri indicatori utili per i singoli paesi
• Indice Ifo, coincidente, per l’economia tedesca
(simile al Pmi)
• Indice Ism, coincidente, per l’economia Usa
(simile al Pmi)
• Indice Zew, coincidente, per l’economia
tedesca (riassume le aspettative degli analisti
finanziari)
• Leading indicator, anticipatore, per l’economia
Usa
Il prodotto interno lordo
• È anche possibile ricostruire le singole voci
del Pil
• Le vendite al dettaglio sono considerata una
buona approssimazione dei consumi, dati
mensili
• Non sempre gli indici di fiducia dei
consumatori permettono davvero di prevedere
o stimare i consumi
Il prodotto interno lordo
• La componente beni capitali della produzione
industriale (mensile) è una buona approssimazione
degli investimenti
• Gli ordini di beni capitali (dato mensile, componente
degli ordini alle imprese) danno un’indicazione
approssimata degli investimenti futuri
• In alcuni paesi (Usa) il dato sugli ordini prevede
anche quello delle consegne, misura approssimata
degli investimenti
Il prodotto interno lordo
• Il dato (mensile) su esportazioni, importazioni
e saldo commerciale sono
un’approssimazione della componente
esportazioni nette del Pil (che riguarda però
solo i valori aggiunti)
• Attenzione:
– un deficit commerciale che si riduce fa aumentare
la crescita del pil, anche se il saldo resta negativo
– un surplus commerciale che si riduce fa calare la
crescita del pil anche se il saldo resta positivo
L’inflazione e il Pil
• La necessità di calcolare il Pil nominale e
quello reale comporta di necessità quello di
valutare l’inflazione
• La differenza tra i due risultati è il deflatore del
Pil
• Calcola la variazione dei prezzi di tutti i beni
prodotti in una economia, indipendentemente
però dalla loro importanza nella spesa delle
famiglie
Gli indici di inflazione
• Per tener conto dei beni acquistati dall’estero
e per dare un peso ai beni in base
all’importanza nel paniere di spesa delle
famiglie si calcolano gli indici di inflazione
• Ogni stato definisce il proprio. In Eurolandia si
usa anche uno armonizzato, Hicp, che segue
molto le variazioni stagionali (i saldi, p. es.)
Gli indici di inflazione
• L’indice di inflazione è, semplificando, una
media ponderata: ogni prezzo preso in
considerazione viene prima moltiplicato per un
peso (la “sua” percentuale sul totale del
paniere) e poi entra nella media.
• Il deflatore del pil è quindi più ampio degli
indici di inflazione ed è legato alla domanda
interna, ma è meno preciso
Deflatore e indice del Pil
Eurolandia - Deflatore e indice del Pil
Deflatore del Pil
Inflazione Hicp
giu-13
giu-12
giu-11
giu-10
giu-09
giu-08
giu-07
giu-06
giu-05
giu-04
giu-03
giu-02
giu-01
giu-00
giu-99
giu-98
giu-97
giu-96
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
Gli indici di inflazione
• Dall’indice complessivo, si distingue quello
relativo all’inflazione “di fondo” o “core” che
esclude i beni energetici e quelli di alimentari,
che non è possibile gestire con la politica
monetaria
• Energia e alimenti rispondono poco alle
variazioni dei prezzi che, soprattutto nel caso
del petrolio, vengono definito a livello
internazionale
Gli indici di inflazione
• I prezzi dell’energia sono in grado di trascinare
in alto o in basso tutto l’indice di inflazione,
anche se non c’è un aumento generalizzato di
tutti i prezzi (ma potrebbe esserci in futuro)
• La distanza tra inflazione totale e inflazione
core permette di distinguere l’inflazione dalla
variazione di prezzi relativi (quanto varia il
prezzo di un bene, p.es. il petrolio, rispetto agli
altri. Due fenomeni molto diversi
Gli indici di inflazione
• Negli Stati Uniti, l’inflazione core permette di
prevedere l’andamento dell’inflazione
complessiva futura: i due dati tendono a
convergere: la Fed usa molto questo dato
• In Eurolandia non si assiste a questo
fenomeno: la Bce non usa molto questo dato
Inflazione totale e core
Eurolandia - Inflazione totale e core
Inflazione totale
Inflazione core
gen-14
gen-13
gen-12
gen-11
gen-10
gen-09
gen-08
gen-07
gen-06
gen-05
gen-04
gen-03
gen-02
gen-01
gen-00
gen-99
gen-98
gen-97
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
La moneta e i prezzi
• Non sempre è possibile individuare un nesso
tra l’aumento della quantità di moneta e
l’aumento generalizzato dei prezzi
• Questo non significa che l’aumento della
quantità di moneta non abbia una sua
influenza sui prezzi
• In genere avviene in modo sequenziale: alcuni
prezzi rispondono subito (assets, immobili, a
volte le materie prime), altri dopo
Quando la moneta è troppa
• Si considera che quando la moneta è più
veloce del pil nominale, la parte eccedente
vada a “gonfiare” i prezzi degli assets e degli
immobili
• Il “k marshalliano” = M/Pil nominale è la
misura della liquidità in eccesso
• Come M si considera spesso M2: banconote,
conti correnti, depositi bancari e postali
dic-12
dic-11
dic-10
dic-09
dic-08
dic-07
dic-06
dic-05
dic-04
dic-03
dic-02
dic-01
dic-00
dic-99
dic-98
dic-97
dic-96
dic-95
Il k marshalliano
Eurolandia - Il k marshalliano
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
Le persone e l’economia
• Il prodotto interno lordo può anche essere visto
come la somma dei redditi domestici degli attori
economici
• Pil = salari + profitti + profitti da imprese individuali +
interessi + rendite + altri redditi (profitti non distribuiti,
dividendi) + tasse – sussidi all’export
• Mancano i redditi generati all’estero (e sono
compresi quelli versati all’estero), di cui si tiene
conto nel Reddito interno lordo
Le persone e l’economia
• Il dato sul reddito disponibile e sul risparmio
dà una misura più precisa delle risorse
destinate al consumo o all’aumento della
ricchezza delle famiglie
• Dati mensili in Usa, trimestrali in molti paesi,
annuali in Eurolandia e in Italia
Le persone e l’economia
•
•
Il mercato del lavoro
Il tasso di occupazione è la percentuale degli
occupati sul totale della popolazione abile al
lavoro
Il tasso di disoccupazione è la percentuale
dei senza lavoro in cerca di occupazione sul
totale della popolazione abile al lavoro
Le persone e l’economia
Il mercato del lavoro
• I senza lavoro che abbandonano la ricerca
diventano scoraggiati ed escono dal mercato
• A causa di questa uscita dal mercato del
lavoro può capitare che il tasso di
disoccupazione cali anche se l’occupazione
non aumenta o, addirittura, scende
Le persone e l’economia
Il mercato del lavoro
• La definizione di “persona in cerca di lavoro”
può cambiare molto da paese a paese: in
Italia sono contati coloro che vanno negli uffici
Inps a prelevare alcuni sussidi – e sono quindi
sottostimati - altrove (p.es. Spagna) coloro che
rispondono affermativamente a un sondaggio
Le persone e l’economia
• Da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, si
assiste a una compresenza di posti di lavoro
vacanti e di persone in cerca di lavoro
• Tra le cause, la più importante è il
disallineamento (mismatch) delle competenze:
i lavoratori offrono competenze ma le aziende
ne richiedono altre
La curva di Beveridge
La curva di Beveridge
• Non è calcolabile per tutte le economie (i dati
Eurostat iniziano dal 2009)
• Uno spostamento verso destra della curva,
per cui allo stesso vacancy rate corrisponde
un più alto tasso di disoccupazione, segnala
un peggioramento del mismatch tra
competenze o luoghi di lavoro
La produttività
• La produttività è il rapporto tra la produzione e gli
input. È una misura di efficienza
• Gli input rilevanti sono capitale e lavoro
• Il dato è di difficile calcolo, esistono diversi indicatori,
alcuni dei quali prodotti dagli stessi istituti di statistica
• Una misura semplice ed efficace della produttività
del lavoro è il rapporto tra pil e numero degli
occupati, o il numero delle ore lavorate
La produttività
Italia - Produttività reale (dati in euro)
95000
90000
85000
80000
75000
70000
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
I segnali di vulnerabilità
• Per i paesi emergenti (ma non solo) sono stati
individuati alcuni segnali di vulnerabilità
• Si tratta di indicatori statistici che sottolineano
quanto l’economia dipenda dall’estero e se
sono sufficienti i “cuscinetti” messi in evidenza
dalle autorità
I segnali di vulnerabilità
• Il livello di debito pubblico, di per sé non è un
segnale di vulnerabilità anche se un debito
elevato crea problemi e, soprattutto,
impedisce le politiche anticicliche in periodi di
recessione
• Più rilevante è il debito con l’estero: misura di
quanto sia dipendente un paese dagli
investitori stranieri.
I segnali di vulnerabilità
• Tra i debiti esteri, quelli rappresentati da titoli
di portafoglio – facilmente vendibili sul
mercato – e quelli a breve termine – che
potrebbero non essere rinnovati sono i più
rilevanti.
• Una regola pratica, detta di GuidottiGreenspan, ritiene sufficienti riserve valutarie
presso la banca centrale pari ai debiti a breve
termine
I segnali di vulnerabilità
• Anche le esportazioni, spesso essenziali, richiedono
di essere finanziate: un altro segnali di vulnerabilità è
il calo delle riserve valutarie, soprattutto nei paesi
con cambio fisso, al di sotto del valore medio delle
esportazioni trimestrali
• Più in generale, il livello del deficit corrente
(esportazioni meno importazioni) in rapporto al Pil è
considerato un segnale importante di sostenibilità.
Livelli superiori al 3% sono già considerati a rischio
dagli investitori, ma conta molto la dinamica
I segnali di vulnerabilità
• A maggior ragione, l’esistenza di due deficit
(twin deficits o deficit gemelli) segnala un
“doppio” bisogno di rifinanziamento