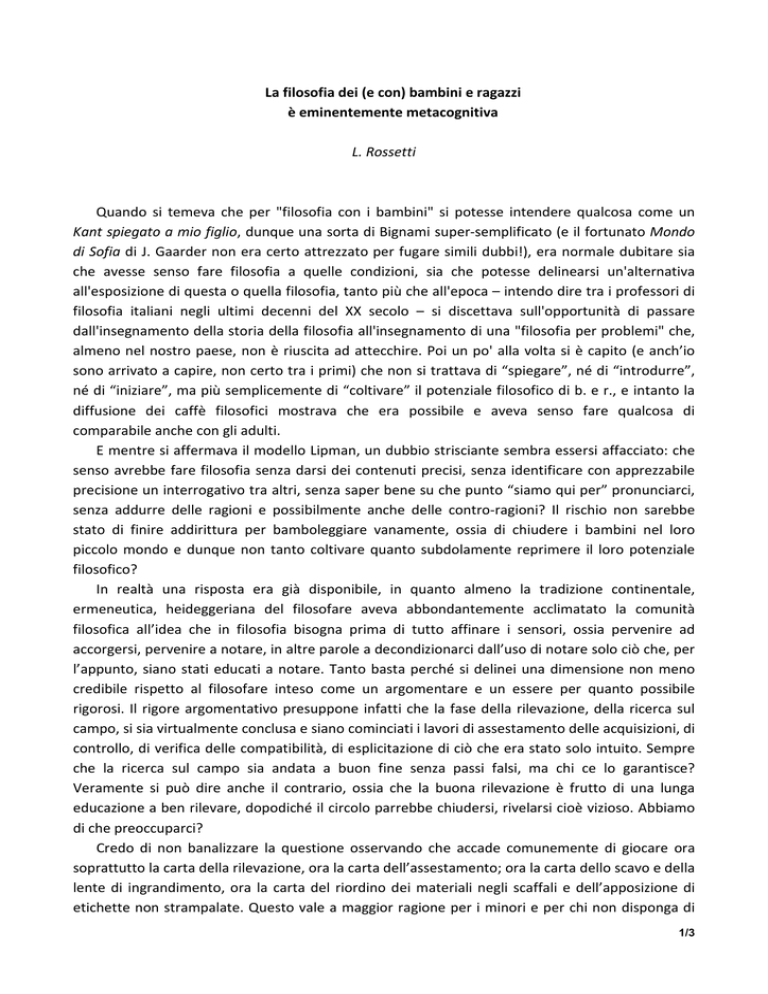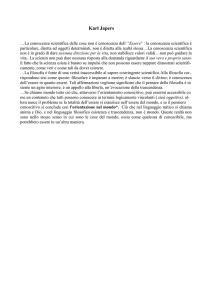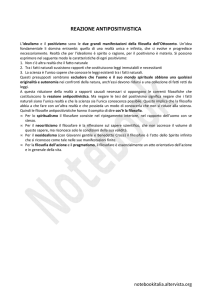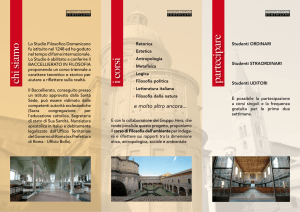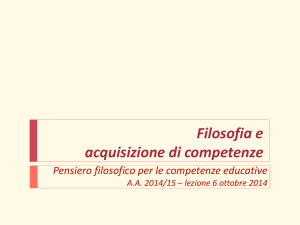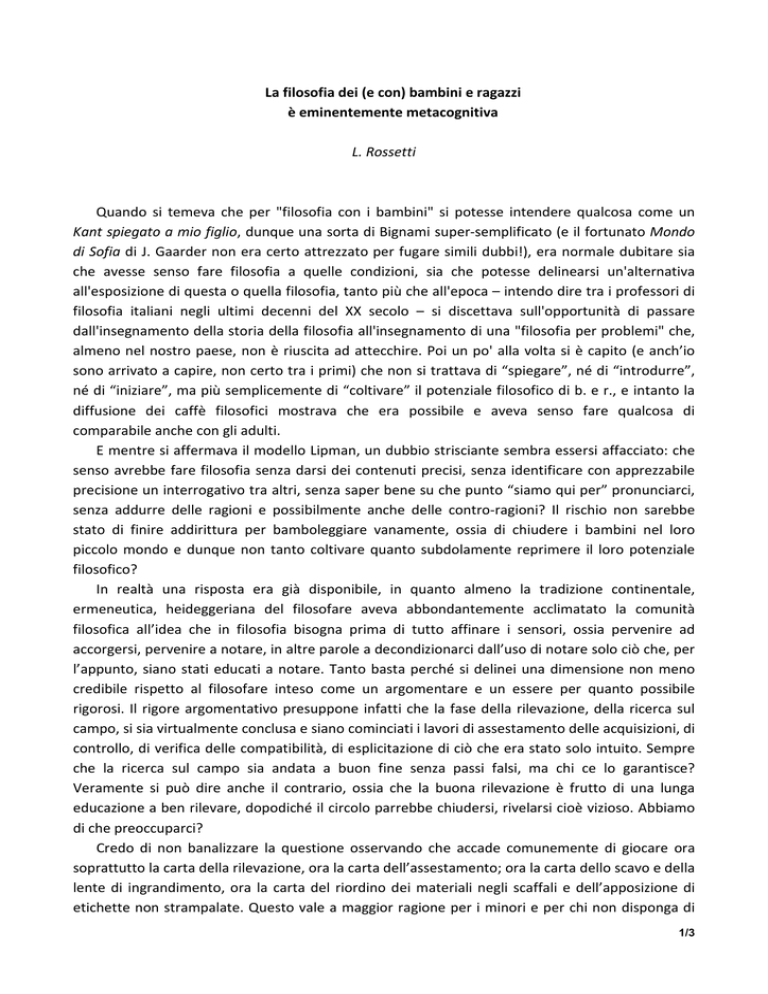
La filosofia dei (e con) bambini e ragazzi
è eminentemente metacognitiva
L. Rossetti
Quando si temeva che per "filosofia con i bambini" si potesse intendere qualcosa come un
Kant spiegato a mio figlio, dunque una sorta di Bignami super-semplificato (e il fortunato Mondo
di Sofia di J. Gaarder non era certo attrezzato per fugare simili dubbi!), era normale dubitare sia
che avesse senso fare filosofia a quelle condizioni, sia che potesse delinearsi un'alternativa
all'esposizione di questa o quella filosofia, tanto più che all'epoca – intendo dire tra i professori di
filosofia italiani negli ultimi decenni del XX secolo – si discettava sull'opportunità di passare
dall'insegnamento della storia della filosofia all'insegnamento di una "filosofia per problemi" che,
almeno nel nostro paese, non è riuscita ad attecchire. Poi un po' alla volta si è capito (e anch’io
sono arrivato a capire, non certo tra i primi) che non si trattava di “spiegare”, né di “introdurre”,
né di “iniziare”, ma più semplicemente di “coltivare” il potenziale filosofico di b. e r., e intanto la
diffusione dei caffè filosofici mostrava che era possibile e aveva senso fare qualcosa di
comparabile anche con gli adulti.
E mentre si affermava il modello Lipman, un dubbio strisciante sembra essersi affacciato: che
senso avrebbe fare filosofia senza darsi dei contenuti precisi, senza identificare con apprezzabile
precisione un interrogativo tra altri, senza saper bene su che punto “siamo qui per” pronunciarci,
senza addurre delle ragioni e possibilmente anche delle contro-ragioni? Il rischio non sarebbe
stato di finire addirittura per bamboleggiare vanamente, ossia di chiudere i bambini nel loro
piccolo mondo e dunque non tanto coltivare quanto subdolamente reprimere il loro potenziale
filosofico?
In realtà una risposta era già disponibile, in quanto almeno la tradizione continentale,
ermeneutica, heideggeriana del filosofare aveva abbondantemente acclimatato la comunità
filosofica all’idea che in filosofia bisogna prima di tutto affinare i sensori, ossia pervenire ad
accorgersi, pervenire a notare, in altre parole a decondizionarci dall’uso di notare solo ciò che, per
l’appunto, siano stati educati a notare. Tanto basta perché si delinei una dimensione non meno
credibile rispetto al filosofare inteso come un argomentare e un essere per quanto possibile
rigorosi. Il rigore argomentativo presuppone infatti che la fase della rilevazione, della ricerca sul
campo, si sia virtualmente conclusa e siano cominciati i lavori di assestamento delle acquisizioni, di
controllo, di verifica delle compatibilità, di esplicitazione di ciò che era stato solo intuito. Sempre
che la ricerca sul campo sia andata a buon fine senza passi falsi, ma chi ce lo garantisce?
Veramente si può dire anche il contrario, ossia che la buona rilevazione è frutto di una lunga
educazione a ben rilevare, dopodiché il circolo parrebbe chiudersi, rivelarsi cioè vizioso. Abbiamo
di che preoccuparci?
Credo di non banalizzare la questione osservando che accade comunemente di giocare ora
soprattutto la carta della rilevazione, ora la carta dell’assestamento; ora la carta dello scavo e della
lente di ingrandimento, ora la carta del riordino dei materiali negli scaffali e dell’apposizione di
etichette non strampalate. Questo vale a maggior ragione per i minori e per chi non disponga di
1/3
una preparazione specifica. Nel momento in cui ci avviciniamo per la prima volta (o quasi per la
prima volta) alle molte facce di un certo problema, troviamo naturale girare attorno all’oggetto
poliedrico e notare ora l’una ora l’altra faccia, sorprenderci di scoprire che ce ‘è anche una quinta,
una sesta, una sedicesima e continuare a lungo senza provare stanchezza o fastidio. Ma proprio la
quantità di rilevazioni accumulate – quasi grandi foglie di vite o di fico che cadano in disordine per
terra, talvolta sovrapponendosi, talvolta lasciando zone scoperte – alimenta il bisogno di mettere
le cose in ordine e dunque di assestare, istituire classi e sottoclassi, disporre, eliminare i doppioni,
rimuovere eventuali contraddizioni.
Di nuovo, si potrebbe obiettare che, siccome tutti abbiamo un’esperienza di vita su cui
contare, e quindi anche l’esperienza di cumuli più o meno disordinati di unità informative, in ogni
età si dovrebbe registrare la prevalenza del bisogno di assestare un po’ meglio ciò che è già
disponibile. Questo è parzialmente falso, perché ci sono, in effetti, età in cui il bisogno di mettere
ordine è poco sentito ed età in cui, al contrario, quel bisogno campeggia. A dieci anni specialmente
i maschietti collezionano di tutto ma non per nulla, a distanza di qualche tempo, quelle raccolte
vengono per lo più buttate.
Traduzione: in filosofia trovano posto il piacere di provare a dire (di guardare nella penombra e
provare a dare un nome a ciò che si intravede appena) così come il piacere di avventurarsi nella
costruzione di edifici argomentativi anche improbabili, il riordino rassicurante (ma spesso un po’
troppo conformista) delle idee già familiari e le avventure della mente. E fin qui sembra difficile
istituire una differenza tra il modo di fare filosofia quando si è bambini o ragazzi e il modo di fare
filosofia quando si è adulti e magari si dispone di una laurea specifica, di un dottorato di ricerca
eccetera. Fortunatamente, a sbloccare la situazione provvede, se non erro, la distinzione tra
dimensione cognitiva e dimensione meta cognitiva del filosofare. Se per dimensione cognitiva si
intende il sapere filosofico, dunque ciò che i filosofi presumono di aver capito e correttamente
denominato, il sapere che ha dato luogo a concrezioni, scuole di pensiero, libroni, paroloni e
quant’altro, diventa evidente che solo se sei più o meno informato su tutta questa tradizione puoi
‘maneggiare’ il sapere filosofico e trarne beneficio, perché altrimenti ti troveresti a usare
malamente congegni di cui non ti sfuggono soltanto svariati componenti ma addirittura la logica
che li fa esistere e costituisce la ragion d’essere, il fattore identificante di ognuno.
D’altra parte la dimensione metacognitiva della filosofia si manifesta in modo eminente in
quelle forme di presa di coscienza della complessità che non danno luogo a un sapere particolare.
Esempio tipico è l’universo delle competenze. Se sono bravi, il meccanico alle prese con l’auto che
non va più bene, l’arredatore cui chiedo di inventarsi qualcosa per casa nostra, la sarta da cui vado
per farmi un bel vestitino, il chirurgo cui affido il mio addome sanno infinite cose ognuno nel suo
settore, sono proprio maestri, eppure non sanno che cosa sarà il caso di fare nel caso particolare.
Noi ci affidiamo a loro sapendo che non sanno ancora precisamente che cosa sarà il caso di fare.
La loro è una competenza diffusa, preziosa ma, almeno per quanto riguarda il da farsi,
cognitivamente povera, molto povera, necessariamente povera. Povera ma preziosa.
Ora i filosofi non si occupano solo di ciò che si presume sia ormai noto, ben noto, ma anche (se
non soprattutto) del quadro di riferimento, delle terre di nessuno, e preferibilmente di ciò che non
è ancora diventato o non riesce a diventare un sapere specialistico. Infatti, se in un determinato
campo si è venuto costruendo un sapere, quell’ambito tenderà a costituirsi in un campo di
2/3
specializzazione a sé, da tenere accuratamente distinto dalla filosofia. Ne deduco che la funzione
di attenzione per ciò che rischia di passare inosservato o di risultare inafferrabile, la funzione di
primo orientamento in un contesto che si presume sia piuttosto refrattario all’assestamento
cognitivo, costituisca una componente non esclusiva ma pur sempre elettiva del filosofare. Di cui
di tanto in tanto ci si è dimenticati.
Ed è proprio questa, io credo, la funzione peculiare del filosofare che si addice a bambini e
ragazzi che provano a filosofare sapendo di brancolare nel buio e che solo in momenti successivi si
adopereranno per fare un po’ d’ordine nella loro testa. Non avrebbe senso portarli a prendere
confidenza con nozioni già disponibili ‘sul mercato’. Molto meglio creare le condizioni perché
provino a dire, si tuffino nell’esercizio del denominare ciò che hanno solo intravisto e accumulino
idee su come orientarsi in un simile oceano di realtà inafferrabili. Trovo che sia un valore, in
particolare, il tentativo di dar voce alla varietà dei punti di vista, la cura nel non chiudere discorsi o
modi di inquadrare le esperienze (chiudere equivarrebbe a precludere prematuramente e magari
a torto delle piste appena accennate, che non sappiamo dove possano portare).
In questo senso – e qui deluderò o impensierirò più d’uno – il nostro metterci a filosofare con i
minori non ha molto di socratico perché, tolte alcune apparenze, Socrate è notevolmente
aggressivo e direttivo. Come ho cominciato a far presente in Quale dialogo? (online nel sito web di
Amica Sofia) e come spero di poter argomentare più diffusamente altrove in un prossimo futuro, il
grande filosofo si è dedicato, in prevalenza, a scompaginare le certezze altrui, a generare un
iniziale disorientamento. Orbene, almeno con i più piccini sarebbe del tutto fuor di luogo giocare
una simile carta. D’altronde, non è certo un caso che Socrate operasse esclusivamente con adulti,
dunque con menti dove le concrezioni e le sedimentazioni possono essere più un limite che una
risorsa.
Perugia, estate 2008
3/3