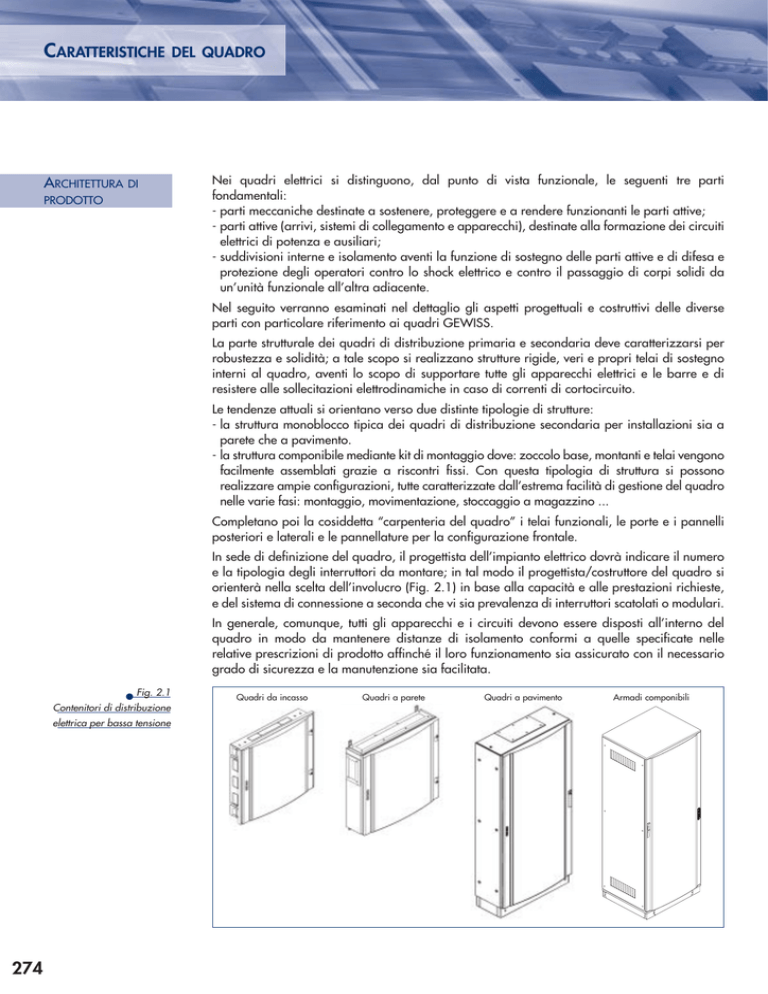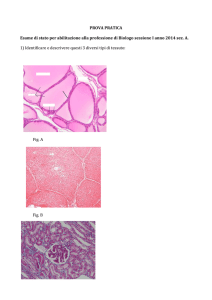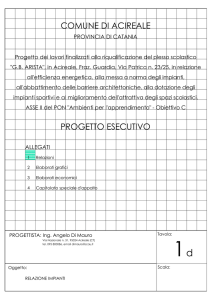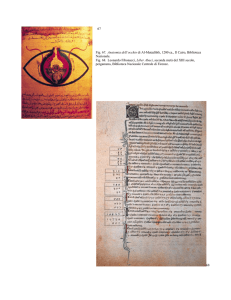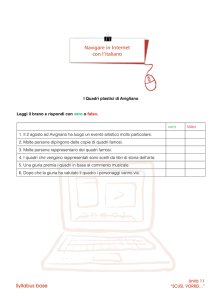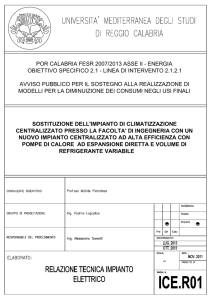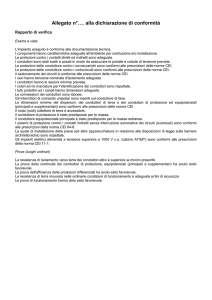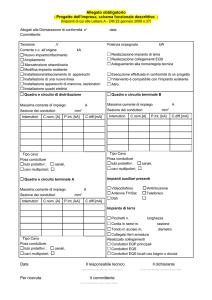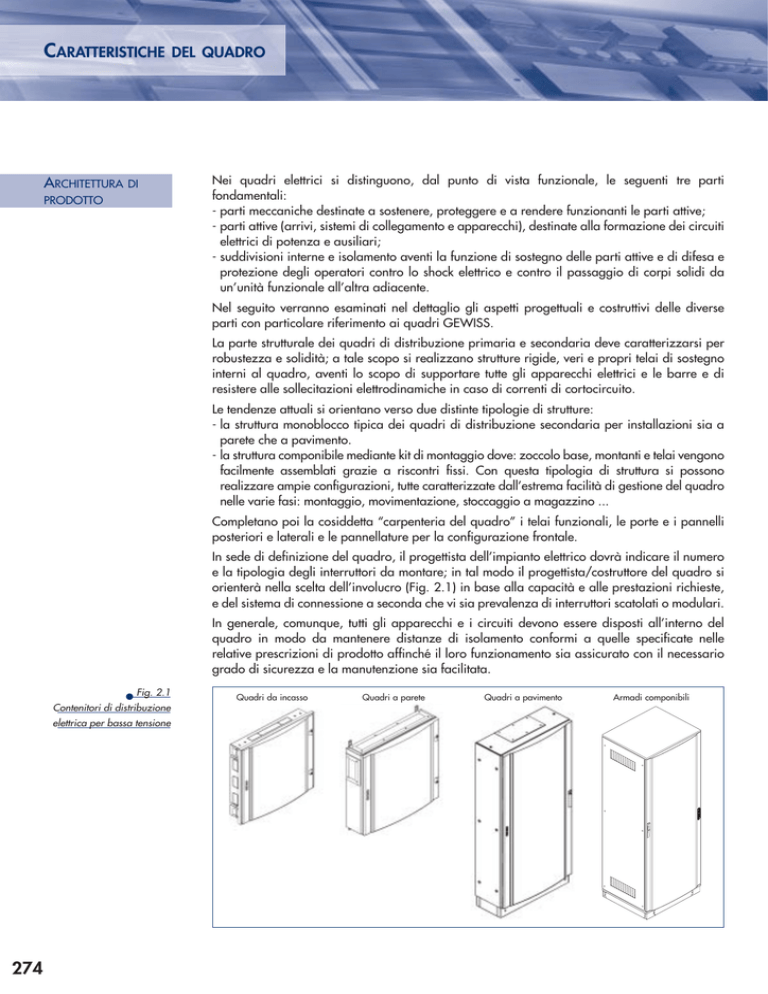
CARATTERISTICHE
ARCHITETTURA DI
PRODOTTO
DEL QUADRO
Nei quadri elettrici si distinguono, dal punto di vista funzionale, le seguenti tre parti
fondamentali:
- parti meccaniche destinate a sostenere, proteggere e a rendere funzionanti le parti attive;
- parti attive (arrivi, sistemi di collegamento e apparecchi), destinate alla formazione dei circuiti
elettrici di potenza e ausiliari;
- suddivisioni interne e isolamento aventi la funzione di sostegno delle parti attive e di difesa e
protezione degli operatori contro lo shock elettrico e contro il passaggio di corpi solidi da
un’unità funzionale all’altra adiacente.
Nel seguito verranno esaminati nel dettaglio gli aspetti progettuali e costruttivi delle diverse
parti con particolare riferimento ai quadri GEWISS.
La parte strutturale dei quadri di distribuzione primaria e secondaria deve caratterizzarsi per
robustezza e solidità; a tale scopo si realizzano strutture rigide, veri e propri telai di sostegno
interni al quadro, aventi lo scopo di supportare tutte gli apparecchi elettrici e le barre e di
resistere alle sollecitazioni elettrodinamiche in caso di correnti di cortocircuito.
Le tendenze attuali si orientano verso due distinte tipologie di strutture:
- la struttura monoblocco tipica dei quadri di distribuzione secondaria per installazioni sia a
parete che a pavimento.
- la struttura componibile mediante kit di montaggio dove: zoccolo base, montanti e telai vengono
facilmente assemblati grazie a riscontri fissi. Con questa tipologia di struttura si possono
realizzare ampie configurazioni, tutte caratterizzate dall’estrema facilità di gestione del quadro
nelle varie fasi: montaggio, movimentazione, stoccaggio a magazzino ...
Completano poi la cosiddetta “carpenteria del quadro” i telai funzionali, le porte e i pannelli
posteriori e laterali e le pannellature per la configurazione frontale.
In sede di definizione del quadro, il progettista dell’impianto elettrico dovrà indicare il numero
e la tipologia degli interruttori da montare; in tal modo il progettista/costruttore del quadro si
orienterà nella scelta dell’involucro (Fig. 2.1) in base alla capacità e alle prestazioni richieste,
e del sistema di connessione a seconda che vi sia prevalenza di interruttori scatolati o modulari.
In generale, comunque, tutti gli apparecchi e i circuiti devono essere disposti all’interno del
quadro in modo da mantenere distanze di isolamento conformi a quelle specificate nelle
relative prescrizioni di prodotto affinché il loro funzionamento sia assicurato con il necessario
grado di sicurezza e la manutenzione sia facilitata.
● Fig. 2.1
Contenitori di distribuzione
elettrica per bassa tensione
274
Quadri da incasso
Quadri a parete
Quadri a pavimento
Armadi componibili
PARTI MECCANICHE
Un elemento importante del “sistema costruttivo prestabilito“ è l’assemblaggio delle parti
meccaniche che compongono gli involucri adatti alla realizzazione di quadri elettrici.
La gamma dei contenitori della serie 47 CVX permette di costruire quadri elettrici con
prestazioni ai massimi livelli perché soddisfano l’esigenza di resistenza meccanica, elettrica e
termica richieste dalle tipologie d’impianto attuale.
Grazie alle moderne tecnologie di produzione (presso-piegatura, saldatura laser, verniciatura
con polveri epossi-poliestere, guarnizioni di tenuta in colata continua, ...) gli involucri della
serie 47 CVX permettono di soddisfare le esigenze tecniche ed ambientali più elevate.
Inoltre i contenitori sono adatti, con semplici montaggi, ad essere equipaggiati con gli
interruttori modulari della serie 90 fino a 125 A e con interrutori scatolati fino a 1600 A nelle
esecuzioni fisse, rimovibili ed estraibili, garantendo i massimi valori delle prestazioni.
Struttura
La gamma 47 CVX comprende contenitori con varie soluzioni per permettere agli installatori e
ai quadristi di scegliere la più rispondente alle proprie esigenze, come esemplificato in Fig. 2.2.
Nelle pagine successive sono presentate le serie principali di prodotti per l’installazione in
ambienti interni e la realizzazione di impianti di distribuzione elettrica in bassa tensione.
Questa gamma lascia ampio margine ai quadristi, i quali seguendo le istruzioni di montaggio
realizzano quadri elettrici secondo la normativa vigente e rispettando le prestazioni nominali.
● Fig. 2.2
Tipologie di contenitori
GEWISS ed
esempi di installazione
QUADRI
DA INCASSO
CVX 160i
Contenitori con involucro da incasso per luoghi ristretti
QUADRI
DA PARETE
CVX 160
E
CVX 250
Contenitori monoblocco per un rapido cablaggio ed una veloce
installazione per ambienti del terziario e dell’industria
QUADRI
DA PAVIMENTO
CVX 630
Strutture monoblocco di tipo aperto, affiancabili, per impianti di
media potenza
ARMADI
COMPONIBILI
CVX 1600
Sistemi componibili e affiancabili con segregazioni interne per
impianti industriali
275
CARATTERISTICHE
Quadri da incasso
CVX 160i
DEL QUADRO
Sono contenitori in metallo zincato di ridotta profondità (105 mm), adatti per l’incasso in pareti
in muratura o in cartongesso, equipaggiabili con una porta trasparente o piena. Il prodotto è
già preconfigurato negli accessori di installazione interna e di configurazione frontale.
Il sistema funzionale interno è costituito da un telaio estraibile, che può essere indifferentemente
cablato a banco oppure dopo averlo fissato nella cassa murata. Tutti i componenti sono in
materiale zincato per garantire l’equipotenzialità di tutti gli elementi installati. I profili del telaio
sono tali da presentare la medesima interfaccia del quadro da parete per l’aggancio di
accessori e di staffe di supporto dei profili EN 50022 (DIN35) ed EN 50035 (G32).
Le particolarità delle soluzioni permettono le regolazioni delle perpendicolarità nelle varie
direzioni (orizzontali e verticali) recuperando così eventuali non allineamenti durante la fase di
muratura del contenitore.
Le numerose prerotture eseguite nella parte da incasso facilitano le soluzioni per l’entrata ed
uscita dei conduttori.
● Fig. 2.3
CVX 160i
Struttura del quadro
da incasso CVX 160i
Telaio funzionale
Cornice
Pannellatura frontale
Porta trasparente
276
Contenitore da incasso
Quadri da parete
CVX 160 e CVX 250
Sono contenitori da installare a parete, realizzati con struttura monoblocco di lamiera
verniciata con polvere epossi-poliestere di colore RAL 7035, e disponibili in due profondità
(170 e 255 mm), tipicamente usate per la realizzazione di quadri di distribuzione secondaria.
I kit standard di installazione consentono infatti il montaggio di apparecchi modulari e scatolati
su guida DIN ad interasse 150/200 mm, di interruttori scatolati con piastre e pannelli
appositamente predisposti e di altri dispositivi montati su piastra regolabile in profondità.
Sono predisposte piastre passacavi per facilitare sia l’ingresso che l’uscita dei conduttori che
può avvenire con tubi o canali/passerelle.
Si possono realizzare quadri con grado di protezione IP 30-40-55-65 e soluzioni sia con porta
trasparente (vetro curvo temprato di sicurezza) sia con porta piena.
Il sistema funzionale per il montaggio dei supporti delle apparecchiature e per il fissaggio dei
pannelli frontali è già predisposto nella cassa.
● Fig. 2.4
Struttura del quadro da
parete CVX 160 e CVX 250
CVX 160
CVX 250
Piastre passacavi
Piastre passacavi
Cassa
da parete
Porta trasparente
Porta trasparente
Cassa
da parete
277
CARATTERISTICHE
Quadri a pavimento
CVX 630
DEL QUADRO
Con questa struttura monoblocco in lamiera di acciaio, la serie 47 CVX è la risposta per gli
impianti di tipo terziario, caratterizzati da elevato numero di circuiti controllati.
La struttura permette l’affiancabilità e l’ispezionabilità dello zoccolo. È possibile installare
interruttori modulari serie 90, interruttori scatolati fino a MTS/E 630, nonché un sistema a barre
piatte o sagomate. Disponibile in due altezze (1400, 1800 mm) e due larghezze (600, 850
mm) con grado di protezione IP 30/55 è completato con porte anteriore in vetro curvo
temprato di sicurezza o porta piena in lamiera, con apertura reversibile destra/sinistra.
I pannelli frontali realizzati in lamiera d’acciaio e verniciati sono disponibili in diverse altezze
per permettere la massima razionalità dello spazio. I pannelli laterali permettono soluzioni con
aerazione e con ventilazione forzata. La presenza delle piastre passacavi facilita il passaggio
dei conduttori sia dal tetto (canali/passerelle) che dal pavimento (cavidotti).
● Fig. 2.5
Struttura del quadro
a pavimento CVX 630
CVX 630
Piastra passacavi
Pannello laterale
Struttura monoblocco
con zoccolo
Porta trasparente
278
Il sistema degli armadi è realizzato con il montaggio di componenti che permettano di costruire
strutture con differenti dimensioni per adeguarsi alle richieste tecniche e normative.
Armadi
CVX 1600
Le elevate prestazioni strutturali, unitamente all’ampia accessoriabilità e flessibilità di
configurazione, rendono idoneo l’armadio GEWISS a realizzare soluzioni impiantistiche di
elevate prestazioni fino a 3200 A, utilizzando gli interruttori scatolati della serie MTS, nella
totalità delle esecuzioni (fissa - rimovibile - estraibili), i sistemi di collegamento e segregazione
(fino alla Forma 4). L’ampia gamma offre 2 opzioni in altezza (1800, 2000 mm), 3 dimensioni in
larghezza (400, 600, 850 mm, equivalenti a 12/24/36 moduli) e 3 dimensioni in profondità
(400, 600, 800 mm).
Le soluzioni adottate permettono la realizzazione di armadi, con grado di protezione IP
31/41/65, con porte frontali trasparenti con vetro curvo temprato di sicurezza o piene e con
coperture frontali (pannelli) ad interasse 100 mm.
● Fig. 2.6
Struttura dell’armadio
CVX 1600
CVX 1600
Pannello posteriore
Telaio funzionale
Testata
Porta/pannello
laterale
Montanti
Base preassemblata
con zoccolo
Porta trasparente/piena
279
CARATTERISTICHE
Grado di protezione
(codice IP)
DEL QUADRO
Il grado di protezione di un quadro elettrico riflette la necessità di impedire o di limitare i
contatti con le parti attive (in tensione) e la penetrazione di corpi solidi all’interno del quadro
stesso. In accordo con la Norma CEI EN 60529 questi valori sono identificati dalla sigla
internazionale IP seguita da numeri e lettere che identificano i livelli di sicurezza, la cui struttura
è riportata nella Fig. 2.7.
● Fig. 2.7
Struttura del codice IP
IP
2
3
C
H
Lettere caratteristiche (Protezione Internazionale)
Prima cifra caratteristica (cifra da 0 a 6, o lettera X)
Seconda cifra caratteristica (cifra da 0 a 8, o lettera X)
Lettera addizionale (lettere A, B, C, D)
Lettera supplementare (lettere H, M, S, W)
Note:
- quando non è richiesta una cifra caratteristica, quest’ultima deve essere sostituita dalla lettera “X” (“XX” se sono omesse entrambe le cifre)
- le lettere addizionali e/o supplementari possono essere omesse senza essere sostituite
- nel caso di più lettere supplementari, si deve applicare l’ordine alfabetico
- se un involucro fornisce diversi gradi di protezione per differenti sistemi di montaggio, il costruttore deve indicare nelle istruzioni i gradi di
protezione corrispondenti ai differenti sistemi di montaggio.
Per un maggior approfondimento si rimanda alle Tab. 2.2, 2.3 e 2.4.
Ad eccezione di casi specifici (ambienti pericolosi), non esiste correlazione per i quadri
destinati all’installazione in ambiente interno tra il grado di protezione e la tipologia
dell’impianto, salvo che il grado minimo debba essere uguale a IP 2X.
In generale, se non diversamente specificato, il grado di protezione indicato vale per l’intero
quadro (struttura affiancata), purché lo stesso venga installato in accordo con le istruzioni del
costruttore. Qualora il quadro richieda l’intervento di personale autorizzato ad accedere a
parti in tensione, deve essere dichiarato il grado di protezione delle parti interne (ad es.
segregazioni).
Nei casi in cui viene realizzato un quadro ANS, per assegnare il grado di protezione IP è
necessario eseguire idonee prove di tipo o, in alternativa, utilizzare involucri standardizzati
preventivamente provati e certificati.
Come indicato in Tab. 2.1, il grado di protezione dei quadri GEWISS può variare da IP30 a
IP65 in modo da soddisfare tutte le esigenze applicative. In particolare le due versioni
monoblocco e componibile consentono di mantenere il grado di protezione più adatto al tipo
di installazione: IP31/41 (senza porta frontale), IP40/41 (con una porta frontale e aerazioni
laterali) o IP55/65, sempre utilizzando un’unica serie di carpenteria.
● Tab. 2.1
Caratteristiche IP dei quadri
GEWISS
280
SERIE
IP31/41
IP40/41
IP55
IP65
■
■
Quadri da parete
■
■
Quadri da incasso
■
■
Quadri da pavimento
■
Armadi
■
■
■
■
TAB. 2.2 - 1
1° CIFRA
0
CARATTERISTICA
Protezione
contro
l’ingresso dei
corpi solidi
A
CIFRA CARATTERISTICA: PROTEZIONE CONTRO L’INGRESSO DI CORPI SOLIDI.
1
2
Corpi solidi
Corpi solidi
con dimensione
con dimensione
minima
minima
superiore a 50 mm superiore a 12,5 mm
Nessuna
Corpi filiformi
con diametro
superiore
a 2,5 mm
0
Protezione
contro
la penetrazione
di acqua
Stagno alla
polvere
ø1mm
Filo rigido Ø 2,5 mm
Filo rigido Ø 1 mm
Camera a
circolazione di talco
Camera a
circolazione di talco
Luoghi chiusi
(accessibili
solo a persone
autorizzate
ed addestrate)
Luoghi ordinari
con presenza solo di
oggetti grossolani
posa su
pareti verticali
Luoghi ordinari
posa su parti
verticali o su
piani orizzontali
inaccessibili
Luoghi ordinari
posa anche
su ripiani
orizzontali
inaccessibili
Luoghi
occasionalmente
polverosi
Luoghi
permanentemente
polverosi
A
CIFRA CARATTERISTICA: PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DELL’ACQUA.
1
2
3
Di condensa
Di condensa
(caduta di
(caduta di gocce
gocce verticali)
con angolo
fino a 15°)
Nessuna
Protetto contro
la polvere
Sfera Ø 12,5 mm
+ dito di prova
TAB. 2.3 - 2
CARATTERISTICA
Corpi filiformi
con diametro
superiore
a 1 mm
6
Sfera Ø 50 mm
In involucri
2° CIFRA
5
ø2,5mm
Nessuno
Impiego
consentito
4
ø12,5mm
ø50mm
Mezzo
di prova
3
4
A pioggia
con angolo
fino a 60°
dalla verticale
5
A spruzzo
da tutte
le direzioni
Getti da tutte
le direzioni
6
7
8
Protezioni
d’acqua
mareggiate
Immersione
temporanea
Immersione
permanente
15°
60°
1m
Mezzo
di prova
Nessuno
0.15m
Vasca di
gocciolamento
Impiego
consentito
In ambienti
asciutti
Vasca di
gocciolamento
In ambienti
umidi con
componente
in posizione
verticale
predeterminata
Spruzzatore
dall’alto
In ambienti
umidi con
Luoghi esposti
componente in alla pioggia ma
posizione non non agli spruzzi
perfettamente
dal basso
verticale
TAB. 2.4 - LETTERA
3° LETTERA
ADDIZIONALE
Protezione delle persone
al contatto con
Impiego consentito
Ugello Ø 6,3 mm Ugello Ø 12,5 mm In vasca con 1 m
portata 12,5 l/min portata 100 l/min di battente d’acqua
Luoghi esposti
alla pioggia Luoghi soggetti
e agli spruzzi a lavaggio con
(es.: stazione getti d’acqua di
con passaggio media potenza
di veicoli)
Luoghi
Luoghi soggetti
soggetti a
a inondazione
lavaggio
temporanea o a
energico e
sommersione
a mareggiate sotto la neve per
(moli)
lunghi periodi
LETTERA
ADDIZIONALE
A
B
C
D
Il dorso della mano
Le dita
Attrezzi piccoli
Fili, aghi, chiodi
ø50mm
Calibro di prova
Spruzzatore
rotante a 360°
100mm
Secondo accordi
cliente-costruttore
ø12mm
ø2.5mm
ø35mm
ø1mm
ø35mm
80mm
100mm
100mm
100mm
100mm
Sfera Ø 50 mm
Dito di prova Ø 12 mm
Filo rigido Ø 2,5 mm.
con superficie d’arresto
Filo rigido Ø 1 mm.
con superficie d’arresto
Luoghi chiusi
(accessibili solo
a persone autorizzate)
Luoghi accessibili
anche a persone
non addestrate
Luoghi dove
si usano piccoli utensili
(cacciaviti)
Luoghi dove
si usano oggetti
filiformi
Funzionalità
subacquea
SUPPLEMENTARE
H
Apparecchiatura
ad alta
tensione
M
Provato in moto
contro l’ingresso
d’acqua
S
Provato da fermo
contro l’ingresso
d’acqua
W
Con misure di
protezione addizionali
da specificare
281
CARATTERISTICHE
Grado di protezione
contro impatti
meccanici (codice IK)
DEL QUADRO
Un’altra grandezza che definisce la protezione di un quadro è la sua capacità di resistere agli
impatti meccanici esterni. Questa viene identificata dalla lettera IK seguita da due numeri in
funzione dei vari valori di impatto (Joule).
In base alla norma CEI EN 50102, il grado IK rappresenta la resistenza, a temperatura
ambiente, all’energia d’urto (Tab. 2.5) misurata in joule (J); infatti 1 joule è dal punto di vista
energetico l’energia d’urto di un martello del peso di un etto che cade dall’altezza di un metro.
● Tab. 2.5
Protezione degli involucri
contro gli impatti meccanici
CODICE
IK 00
IK 01
IK 02
IK 03
IK 04
IK 05
IK 06
IK 07
IK 08
IK 09
IK 10
- (1)
0,15
0,20
0,35
0,50
0,70
1
2
5
10
20
ENERGIA (J)
(1) Nessuna protezione
La norma CEI EN 60439-1 non dà nessun riferimento a questi valori, quindi il costruttore del
sistema prestabilito deve eseguire le prove indicate dalla norma CEI EN 50102. Questa norma
identifica il metodo di prova la classifica dei valori di impatto (11 gradi da IK 00 a IK 10) e le
attrezzature di prova che possono essere:
- martello a molla: per valori dai IK 01 a IK 07
- martello a pendolo: per valori dai IK 01 a IK 10
- martello a caduta libera: per valori dai IK 07 a IK 10.
Se parti diverse dal quadro elettrico hanno differenti gradi di protezione, quest’ultimi devono
essere indicati separatamente.
Il grado di resistenza dei quadri CVX, testato nel laboratorio GEWISS, è riportato in Tab. 2.6.
● Tab. 2.6
Caratteristiche IP dei quadri
GEWISS
282
SERIE
COMPONENTI
IN PLASTICA
COMPONENTI
IN METALLO
VETRO
Quadri da parete
IK 09
IK 10
IK 07
Quadri da incasso
IK 09
IK 10
IK 07
Quadri da pavimento
-
IK 10
IK 07
Armadi
-
IK 10
IK 07
PARTI ATTIVE E CIRCUITI
DI PROTEZIONE
Si considera parte attiva un conduttore o una parte conduttrice destinata ad essere in tensione
in condizioni normali di esercizio, compreso il conduttore di neutro (N) ma non, per
convenzione, il conduttore PEN, cioè il conduttore messo a terra che assicura sia le funzioni di
conduttore di protezione che di neutro.
Con questa definizione è evidente che tutti i sistemi di connessione sono da considerare parti
attive, compresi i terminali di allacciamento dei conduttori alle apparecchiature. Il grado di
protezione minimo previsto è IP 2X.
Gli involucri della serie 47 CVX garantiscono un range di prestazioni da IP 30 a IP 65. Nel caso
di minore grado di protezione (quadro senza porta) l’accesso alle parti attive in tensione
avviene con l’uso di un attrezzo. Altre misure per la protezione contro i contatti diretti deve
essere oggetto di un accordo tra il costruttore del quadro installato e l’utilizzatore.
Le barre interconnettono i diversi montanti tra loro e assicurano al quadro la possibilità di
distribuire la corrente elettrica dagli alimentatori alle utenze secondo le esigenze di esercizio e
d’impianto.
Sistemi di
collegamento
Le barre sono dimensionate di solito in modo uniforme per tutto il quadro e sono costituite da
conduttori di rame o di alluminio. In generale i conduttori di ogni fase sono realizzati con un
profilato sagomato a profilo continuo oppure a sezione rettangolare.
Particolarmente innovativo è il sistema di barre sagomate a profilo continuo predisposto per i
quadri GEWISS che presenta, a parità di sezione trasversale una superficie maggiore rispetto
alle sezioni rettangolari, per cui a parità di portata è maggiore lo scambio termico e, di
conseguenza, è facilitato il raffreddamento. La varie fasi di montaggio (posizionamento dei
portabarre sulle rispettive traverse, posizionamento delle basette di appoggio sui portabarre
terminali, inserimento a scatto delle barre) possono essere eseguite da un unico addetto senza
la necessità di serrare viti; operazione quest’ultima che deve essere effettuata solo a conclusione
del montaggio, per garantire la resistenza agli sforzi elettrodinamici.
Il profilo delle barre sagomate varia in funzione della portata e possono essere posizionate in
posizione orizzontale, verticale, con giunzioni a T o a L grazie a un giunto universale,
appositamente studiato per ridurre al minimo la resistenza di contatto. Anche i portabarre in
materiale isolante, sono tali da garantire la massima tenuta agli sforzi elettrodinamici nei casi
più gravosi di cortocircuito (Fig. 2.8).
● Fig. 2.8
Esecuzione di un sistema
di collegamento con barre
sagomate a profilo continuo
283
CARATTERISTICHE
DEL QUADRO
Circuito di protezione
Per la protezione contro i contatti indiretti si utilizzano due sistemi nella costruzione dei quadri
elettrici:
- conduttore di protezione separato
- parti conduttrici delle strutture.
La serie 47 CVX per il suo particolare sistema costruttivo permette di risolvere il problema con
entrambe le soluzioni. Infatti tutte le masse sono assiemate con un contatto tra loro e con il
circuito di protezione, ad esempio una barra di terra, come in Fig. 2.9. Questa viene montata
direttamente sulla carpenteria e permette di collegare sia il conduttore di protezione in entrata
sia i vari singoli collegamenti connessi con le utenze.
Non è necessario collegare al circuito di protezione le
masse che sono tali da non costituire pericolo per
dimensione o per difficoltà di essere toccate.
● Fig. 2.9
Applicazione di un
conduttore di protezione
Per coperchi, pannelli, porte e piastre, i normali sistemi
di montaggio con viti e cerniere metalliche sono ritenuti
sufficienti ai fini della continuità elettrica, purché su
questi elementi non siano montati apparecchi elettrici.
In questo caso si raccomanda che queste parti siano
collegate con un conduttore di protezione.
La sezione del conduttore di protezione può essere determinata con uno dei seguenti metodi:
- tabella 3 della norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), in funzione della sezione dei conduttori
di fase (Tab. 2.7)
Conduttore PE
● Tab. 2.7
Sezione minima dei
SEZIONE
(mm2)
conduttori di protezione
I valori sono validi soltanto nel caso
MINIMA DEL CORRISPONDENTE
CONDUTTORI DI PROTEZIONE
S ≤ 16
S
16 < S ≤ 35
16
35 < S ≤ 400
S/2
400 < S ≤ 800
200
S > 800
S/4
(PE, PEN)
Nota
SEZIONE
DEI CONDUTTORI DI FASE
che il materiale del conduttore sia lo
stesso del conduttore di fase.
- calcolo in base alla formula: SPE (mm2) =
(mm2)
i2t
k
La formula determina il valore minimo della sezione del conduttore di protezione necessaria per
sopportare le sollecitazioni termiche causate dalle correnti di guasto. L’espressione i2t non è che
la caratteristica di limitazione del dispositivo posto all’ingresso del quadro (A2s); k è un fattore
che dipende dal materiale conduttore, dal materiale isolante e dalle temperature iniziale e
finale (vedere Tab. 2.8).
● Tab. 2.8
ISOLANTE
DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE O DEI RIVESTIMENTI DEI CAVI
Valori del fattore k per
PVC
XLPE, EPR,
CONDUTTORI NUDI
160 °C
250 °C
220 °C
Rame
143
176
166
Alluminio
95
116
110
Acciaio
52
64
60
conduttori di protezione
unipolari
TEMPERATURA
FINALE
GOMMA
BUTILICA
Materiale del conduttore
Nota
I valori in tabella si riferiscono ad
una temperatura iniziale dei
conduttori pari a 30 °C.
284
Esempio 1
Si consideri un interruttore generale MTS 160 installato in un quadro a parete, con corrente di
cortocircuito nel punto di installazione del quadro di 15 kA. Dalla curva di limitazione
dell’interruttore, si ricava A2s = 800.000 (15 kA/400 V), e, applicando la formula, si avrà:
SPE =
i2t
k
=
800000
176
= 5,08 mm2
dove si è considerato come conduttore il materiale rame nudo (k = 176).
Il quadro da parete della serie 47 CVX prevede una barra di terra (GW 47193) di rame di
dimensioni 20x5 mm (100 mm2), di sezione notevolmente superiore e quindi adatta allo scopo.
Esempio 2
Si consideri un interruttore generale con corrente nominale pari a 1250 A, installato in un
armadio, con corrente di cortocircuito nel punto di installazione del quadro di 50 kA. Dalla
curva di limitazione dell’interruttore MTSE 1600 (1250 A), si ricava A2s = 7•107 (50 kA/400
V), e, applicando la formula, si avrà:
SPE =
i2t
k
=
7•107
176
= 47,54 mm2
dove si è considerato come conduttore il materiale rame nudo (k = 176).
In questo caso si adotterà una barra di rame di sezione 20x5 mm (100 mm2) per ottenere anche
una buona resistenza meccanica.
Conduttore PEN
In un sistema di distribuzione di tipo TN (Fig. 2.10), nel caso che un conduttore assicuri sia le
funzioni di conduttore di protezione (PE) che quelle di neutro (N), deve essere identificato con PEN.
Il suo dimensionamento dovrà essere quello del conduttore di neutro con una sezione minima
di 10 mm2 per conduttori di rame e non necessita di essere isolato all’interno del quadro
elettrico. Le parti che costituiscono la struttura del quadro non devono essere utilizzate come
conduttore PEN.
● Fig. 2.10
Sistema TN
285
CARATTERISTICHE
DEL QUADRO
Principali componenti
All’interno dei contenitori della serie 47 CVX si possono installare dispositivi di manovra,
protezione, comando e regolazione inseriti nel catalogo EURODIN. In particolare, la gamma
degli interruttori GEWISS comprende interruttori automatici modulari da 1 A a 125 A (Fig. 2.11)
e la nuova Serie MTS (Fig. 2.12) di interruttori scatolati con correnti nominali fino a 1600 A.
Tutti gli interruttori, siano essi modulari o scatolati, sono corredati di accessori e dispositivi
studiati per soddisfare ogni esigenza d’impianto e, in particolare, per garantire la sicurezza
degli operatori.
Interruttori modulari
Gli interruttori automatici modulari rispondono ai requisiti delle norme CEI EN 60898 e CEI EN
60947-2.
La norma CEI EN 60898 si applica per interruttori per uso domestico e similare. Tali apparecchi
sono caratterizzati dall’ampia gamma di prestazioni sia per quanto riguarda il potere di
interruzione (da 4,5 a 25 kA) che per le curve di intervento (B, C, D).
La scelta degli interruttori automatici modulari deve avvenire in base alle caratteristiche tecniche
richieste dall’impianto.
La protezione contro i guasti, dovuti al fluire di una corrente verso terra per perdita di
isolamento di un conduttore, per contatto diretto di una persona con una parte in tensione del
circuito o per contatto indiretto, è garantita da interruttori corredati di sganciatori che
intervengono in presenza di una corrente differenziale.
Gli interruttori differenziali sono classificati in base a:
- presenza o meno delle protezioni contro le sovracorrenti
- potere di interruzione intrinseco o condizionato
- tempo di intervento (rapidi o selettivi)
- sensibilità differenziale
- forme d’onda rilevabili.
● Fig. 2.11
Serie 90
Interruttori modulari e
differenziali
Interruttori scatolati
Per impianti terziari ed industriali l’utilizzo dei principali componenti riguarda gli interruttori
automatici scatolati, che costituiscono la soluzione ottimale per soddisfare le esigenze tecniche
in quanto offrono ampie disponibilità di scelta per:
- corrente nominale (da 160 A a 1600 A)
- potere di interruzione (B, N, S, H, L)
- tipo di sganciatore (MTS o MTSE)
- esecuzione (fissa, rimovibile o estraibile).
L’interruttore in esecuzione fissa con attacchi anteriori consente di utilizzare quadri di
profondità ridotta rispetto agli interruttori in esecuzione rimovibile ed estraibile. L’impiego di
questa tipologia è indicata per gli impianti che possono tollerare interruzioni del servizio in
caso di guasti o manutenzione programmata.
286
● Fig. 2.12
Serie MTS
Interruttori scatolati
fino a 1600A
L’utilizzo di interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile (Fig. 2.13), scelta in funzione della
tipologia dell’impianto e degli utilizzatori, è limitata agli armadi. In presenza di segregazioni è
necessario scegliere la soluzione con attacchi posteriori.
L’interruttore in esecuzione rimovibile si compone di:
- parte fissa da installare direttamente sulla piastra di fondo del cubicolo del quadro;
- parte mobile ottenuta dall’interruttore fisso con l’aggiunta dei contatti di sezionamento in
corrispondenza dei terminali di connessione, del telaio posteriore per il fissaggio alla parte
fissa e dei copriterminali.
La rimozione dell’interruttore avviene svitando le viti di fissaggio superiori e inferiori. Un
apposito blocco impedisce l’inserzione e la rimozione dell’interruttore con i contatti in posizione
di chiuso.
Nell’esecuzione estraibile l’interruttore è costituito da:
- parte fissa, da installare direttamente sulla piastra di fondo del cubicolo del quadro oppure su
profilato;
- parte mobile ottenuta dall’interruttore fisso con l’aggiunta dei contatti di sezionamento in
corrispondenza dei terminali di connessione, del telaio posteriore;
- accessorio da applicare sul fronte dell’interruttore (comando a leva, comando a motore e
comando a maniglia rotante).
Nell’esecuzione estraibile, a differenza della rimovibile, tutte le posizioni di interruttore inserito,
sezionato in prova e sezionato, vengono raggiunte semplicemente agendo su dispositivi e
cinematismi propri dell’interruttore, senza l’ausilio di alcun attrezzo.
In tutte le posizioni sopra descritte la parte mobile rimane in prossimità della parte fissa dalla
quale viene allontanata solo per raggiungere la posizione di estratto.
● Fig. 2.13
Esecuzione fissa, rimovibile o
estraibile degli interruttori
della serie MTS
Fisso
Rimovibile
Estraibile
287
CARATTERISTICHE
DEL QUADRO
L’inserzione/estrazione della parte mobile può essere agevolmente eseguita tramite l’apposita
leva di manovra fornita con il kit di trasformazione dell’interruttore da fisso a estraibile. Il
meccanismo consente di porre l’interruttore nella posizione di sezionato (con circuiti di potenza
e ausiliari scollegati) e con la porta della cella chiusa, a tutto vantaggio per la sicurezza
dell’operatore.
La manovella può essere inserita solo ad interruttore aperto. Una volta rimosso o estratto
l’interruttore può essere manovrato in aperto/chiuso e, tramite le apposite prolunghe di
connessione, possono essere realizzate le prove in bianco di funzionalità dei circuiti di
comando ausiliari.
Altri componenti
Nella realizzazione di quadri elettrici di distribuzione spesso si fa uso di pulsanti ed indicatori
luminosi, il cui montaggio deve essere realizzato secondo normativa e per la loro scelta si
possono adottare le indicazioni fornite di seguito.
Per una più efficace interfaccia tra il quadro e l’utilizzatore, tutti i conduttori devono essere
siglati secondo le indicazioni normative e lo schema funzionale del quadro stesso.
Altre informazioni sono trasmesse da avvisi e ammonizioni per l’intervento posti all’interno del
quadro su cartelli monitori.
Pulsanti
In aggiunta alle indicazioni funzionali si raccomanda che i pulsanti siano marcati con segni
grafici, vicino o preferibilmente sugli attuatori.
Quando viene utilizzato un mezzo supplementare di codifica (per es. struttura, forma,
posizione) per l’identificazione degli attuatori a pulsante, lo stesso colore bianco, grigio o nero
può essere utilizzato per varie funzioni (per es. bianco per attuatori di avvio e arresto).
● Tab. 2.9
Segni grafici per
i pulsanti
Avviamento o inserzione
● Tab. 2.10
COLORE
Codice-colori per i
pulsanti e loro significato
288
Arresto o disinserzione
SIGNIFICATO
Pulsanti che provocano
alternativamente avviamento
e arresto o inserzione e
disinserzione
SPIEGAZIONE
Rosso
Emergenza
Azionare in caso di condizione pericolosa
o emergenza
Giallo
Anormale
Azionare in caso di condizione anormale
Verde
Sicurezza
Blu
Obbligatorio
Bianco
Grigio
Nero
Nessun significato
specifico
Azionare in caso di condizione di
sicurezza o per preparare una condizione
normale
Azionare in caso di condizione che
richiede un’azione obbligatoria
Per l’avvio generale delle funzioni ad
eccezione dell’arresto di emergenza
Pulsanti che provocano un
movimento quando sono
premuti e un arresto quando
sono rilasciati
ESEMPI
DI APPLICAZIONE
Arresto di emergenza
Inizio della funzione di emergenza
Intervento per sopprimere una
condizione anormale o per riavviare
un ciclo automatico interrotto
Funzionamento normale
Funzione di ripristino
Avvio (preferenziale) / Arresto
Avvio / Arresto
Avvio / Arresto (preferenziale)
Segnalatori - attuatori
● Tab. 2.11
Colori degli indicatori
Gli attuatori dei pulsanti luminosi devono essere colorati conformemente al codice della Tab. 2.11.
Quando risulta difficile assegnare un colore appropriato, deve essere usato il bianco. Il colore
rosso per l’attuatore di arresto di emergenza non deve dipendere della sua fonte di luce.
COLORE
SIGNIFICATO
SPIEGAZIONE
luminosi e loro significato
DELL’OPERATORE
Rosso
Emergenza
Condizioni pericolose
Azione immediata per
trattare una condizione
pericolosa (per es.
azionando l’arresto di
emergenza)
Giallo
Anormale
Condizione anormale
Condizione critica
imminente
Controllo e/o intervento
(per es. ristabilendo la
funzione desiderata)
Verde
Normale
Condizione normale
Facoltativa
Blu
Obbligatorio
Bianco
Neutro
rispetto alle condizioni
della macchina
AZIONE
Indicazione della
condizione che richiede
un’azione dell’operatore
Altre condizioni: può
essere usato ogni volta che
si ha un dubbio
sull’impiego dei colori
rosso, giallo, verde e blu
ESEMPI
DI APPLICAZIONE
Pressione/temperatura
fuori dai limiti di sicurezza.
Caduta di tensione
Interruzione
Oltrecorsa oltre la
posizione di arresto
Pressione/temperatura
superiore ai limiti normali
Sganciamento del
dispositivo di protezione
Pressione/temperatura
entro i limiti normali
Autorizzazione a
procedere
Azione obbligatoria
Istruzione per inserire
valori preselezionati
Controllo
Informazione generale
Per ulteriori distinzioni o informazioni e specialmente per dare maggiore evidenza al segnale
si possono usare luci intermittenti nei seguenti casi:
- per attirare l’attenzione;
- per richiedere un’azione immediata;
- per indicare una discordanza tra il comando dato e lo stato reale dell’apparecchiatura;
- per indicare un cambiamento in corso (intermittenza durante il periodo di transizione).
● Fig. 2.14
Esempi di disposizione
O
arresto
II
alta velocità
salita
I
bassa velocità
O
arresto
arresto
discesa
O
O
I
arresto
marcia
➔
O
marcia
➔
I
➔
luminosi
➔
di pulsanti e di pulsanti
sinistra
destra
arresto
289
CARATTERISTICHE
Senso di manovra
degli attuatori di
comando
● Tab. 2.12
Classificazione delle azioni
DEL QUADRO
Per una chiara identificazione della posizione dei contatti principali rispetto ai suoi circuiti
elettrici si raccomanda di realizzare il senso di manovra in funzione dell’azione corrispondente.
NATURA
DELL’ATTUATORE
NATURA
VOLANTI,
MANOPOLE,
MANOVELLE ECC.
Rotazione
Moto verticale
LEVE,
Moto
orizzontale
IMPUGNATURE ECC. CON
MOTO ESSENZIALMENTE LINEARE
INSIEME
DI
IMPUGNATURE,
PULSANTI, ASTE,
CORDONI DI
TRAZIONE ECC.
CON EFFETTI
OPPOSTI
● Tab. 2.13
UNO
SOPRA
L’ALTRO
UNO
DI
FIANCO
ALL’ALTRO
NATURA
Classificazione degli effetti
DELL’AZIONE
Destra-sinistra
Avanti-indietro
Identificazione dei
conduttori
Orario
Verso l’alto
Verso destra
Si allontana
dall’operatore (pressione)
GRUPPO 2
Antiorario
Verso il basso
Verso sinistra
Si avvicina all’operatore
(trazione)
Azione sul dispositivo
superiore
Azione sul dispositivo
inferiore
Azione del dispositivo
di destra
Azione del dispositivo
di sinistra
EFFETTO
DELL’EFFETTO
DI CONDIZIONE
MOTO DELL’OGGETTO O DEL VEICOLO CONTROLLATO
IN RELAZIONE AI SUOI ASSI PRINCIPALI
MOTO
DELL’AZIONE
Pressione, trazione ecc.
MODIFICAZIONE DI UNA QUANTITÀ FISICA (TENSIONE,
CORRENTE, POTENZA, VELOCITÀ, FREQUENZA,
INTENSITÀ LUMINOSA, TEMPERATURA ECC.)
CAMBIO
SENSO
GRUPPO 1
IN RELAZIONE ALL’OPERATORE
GRUPPO 1
RISULTANTE
GRUPPO 2
Aumento
Diminuzione
Messa in servizio
Avviamento
Accelerazione
Chiusura di un circuito elettrico
Accensione
Messa in moto del fluido
Verso l’alto
Verso destra
Avanti
Si allontana dall’operatore
Messa fuori servizio
Arresto
Frenata
Apertura di un circuito elettrico
Spegnimento
Arresto del fluido
Verso il basso
Verso sinistra
Indietro
Si avvicina all’operatore
Le connessioni tra parti percorse da corrente devono essere realizzate con mezzi che assicurino
una pressione di contatto sufficiente e stabile nel tempo e non devono subire alterazioni
inammissibili a causa di sovratemperature, invecchiamento dei materiali isolanti, vibrazioni,
dilatazioni termiche ecc.
La scelta delle sezioni dei conduttori all’interno del quadro rientra tra i compiti del
progettista/costruttore del quadro e dipende, oltre che dall’entità della corrente, dalle
sollecitazioni meccaniche cui il quadro è sottoposto, dalla sistemazione dei conduttori, dal tipo
di isolamento.
La Tab. 2.14 fornisce utili suggerimenti per la identificazione dei cavi e dei morsetti con sigle
alfanumeriche o con colore. Si consiglia di realizzare i cablaggi di quadri e centralini
attenendosi a queste indicazioni, tratte dalla norma CEI 16-2.
290
● Tab. 2.14
Siglatura e colorazione
dei conduttori
IDENTIFICAZIONE
DESIGNAZIONE
DEI CONDUTTORI
fase 1
fase 2
fase 3
neutro
positivo
negativo
mediano
Sistema in a.c.
Sistema in d.c.
Conduttore di
protezione
Circuiti ausiliari con
alimentazione interna
Circuiti ausiliari con
alimentazione esterna
Cartelli monitori
IDENTIFICAZIONE
COLORE
ALFANUMERICA
ISOLANTE
L1
L2
L3
N
L+
L–
M
nero
nero
nero
blu chiaro
nero
nero
blu chiaro
PE
giallo-verde
numerazione
come da schema –
numerazione
–
come da schema
IDENTIFICAZIONE
CAVI
MORSETTI
IDENTIFICAZIONE IDENTIFICAZIONE IDENTIFICAZIONE
CON COLORE
CON COLORE
ALFANUMERICA
marrone
grigio
nero
blu chiaro
non specificato
non specificato
blu chiaro
marrone
grigio
nero
blu chiaro
–
–
blu chiaro
U
V
W
N
C
D
M
giallo-verde
giallo-verde
numerazione
come da schema
numerazione
come da schema
PE
numerazione
come da schema
numerazione
come da schema
–
–
Come indicato dalla norma CEI EN 60439-1, ogni quadro deve essere identificato con una
targa visibile dopo l’installazione dove devono essere riportati:
- nome, marchio del costruttore del quadro finito
- tipo e numero di identificazione
- norme di riferimento.
Altre informazioni richieste dalla norma possono essere riportate anche su altri tipi di
documenti (schemi, cataloghi, ecc…).
In ogni quadro/armadio deve essere garantita la presenza di cartelli monitori, scritti in maniera
indelebile e visibili quando l’apparecchiatura è installata. La forma ed i colori devono rispettare
le indicazioni riportati nella Tab. 2.15, cui seguono esempi di realizzazione dei cartelli monitori.
Le scritte e i segni grafici devono essere bianchi sui segnali rettangolari, quadrati e su quelli con
sfondo blu; neri sui segnali circolari di divieto e su quelli triangolari di pericolo. Un esempio è
riportato in Fig. 2.15.
● Tab. 2.15
Codificazione delle forme
e dei colori nella
segnaletica generale,
FORME
COLORI
Rosso
Giallo
Verde
Blu
divieto
equipaggiamenti del sistema antincendio
pericolo (attenzione)
obbligo
segnali di sicurezza e di pronto soccorso
informazioni
● Fig. 2.15
Esempi di cartelli
antinfortunistici
IMPIANTI ELETTRICI
SOTTO TENSIONE
E' VIETATO
Eseguire lavori su impianti sotto tensione
Toccare gli impianti se non si è autorizzati
Togliere i ripari e le custodie di sicurezza
prima di aver tolto tensione
E' OBBLIGATORIO
Aprire gli interruttori di alimentazione
del circuito, prima di effettuare interventi
Assicurarsi del collegamento a terra prima di iniziare i lavori
Tenersi ben isolati da terra, con mani e piedi
asciutti, o usando pedane e guanti isolanti
Tenere lontani dagli impianti materiali estranei
ATTENZIONE
PERICOLO
NON USARE ESTINTORI
IDRICI O A SCHIUMA
SU APPARECCHIATURE
ELETTRICHE IN TENSIONE
291
CARATTERISTICHE
DEL QUADRO
SUDDIVISIONI INTERNE
E ISOLAMENTO
Per la progettazione di un quadro, particolare attenzione va rivolta alla possibilità di
suddividerlo in celle o scomparti soprattutto per impianti che richiedono un’elevata continuità di
servizio.
Le segregazioni consentono di intervenire in sicurezza su una parte del quadro mantenendo in
tensione le parti adiacenti, rendono flessibile, sicuro e tempestivo l’intervento su un determinato
circuito elettrico, proteggono da eventuali archi interni dovuti a cedimento dell’isolante.
Infatti, per intervenire in un quadro elettrico sotto tensione bisogna comunque rispettare alcuni
principi di sicurezza:
- per accedere alle singole unità funzionali è opportuno sezionare o segregare le altre unità e
le barre di distribuzione
- per accedere ai terminali per i collegamenti esterni si devono sezionare o segregare gli altri
terminali.
È evidente che per rendere più efficace l’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria
è opportuno che gli interruttori montati all’interno delle singole unità funzionali siano in
esecuzione rimovibile od estraibile.
Questi tipi di interventi devono essere sempre eseguiti da persona istruita o addestrata.
Questa problematica è strettamente connessa alle proprietà dielettriche e alle distanze in aria e
superficiali delle parti attive dall’involucro.
Segregazioni
Il quadro può essere internamente suddiviso mediante barriere o diaframmi (generalmente in
materiale metallico) in celle separate le une dalle altre o in frazioni di scomparto. Il livello di
compartimentazione e suddivisione interna è oggetto di accordo tra costruttore e committente
che può scegliere tra una delle sette diverse tipologie di segregazione previste dalla norma CEI
EN 60439-1 e rappresentate in Fig. 2.16.
In generale è opportuno osservare che un elevato grado di segregazione è a favore della
sicurezza perché confina gli effetti di un eventuale guasto in una singola cella; per contro, oltre
a un sensibile aumento del costo del quadro, una eccessiva segregazione, laddove non richiesta
da esigenze impiantistiche, comporta maggiori problemi di smaltimento del calore e di accesso
per le operazioni di straordinaria manutenzione.
Le diverse forme di segregazione sono classificate secondo un criterio principale (forma 1, 2,
3, 4) e secondo un criterio secondario (soluzione a, b), indicate in Tab. 2.16.
● Tab. 2.16
Classificazione delle forme
di segregazione secondo la
CEI EN 60439-1
CRITERIO
PRINCIPALE
SECONDARIO
Nessuna separazione
Segregazione delle sbarre dalle unità funzionali
Segregazione delle sbarre dalle unità funzionali
Segregazione di tutte le unità funzionali l’una
dall’altra
Segregazione dei terminali per i conduttori esterni
dalle unità funzionali, ma non l’uno dall’altro
Segregazione delle sbarre dalle unità funzionali e
segregazione di tutte le unità funzionali l’una
dall’altra, compresi i terminali per i conduttori esterni,
che sono parte integrante dell’unità funzionale
292
CRITERIO
FORMA
Forma 1
Terminali per i conduttori esterni non separati dalle
sbarre
Terminali per i conduttori esterni separati dalle sbarre
Forma 2a
Forma 2b
Terminali per i conduttori esterni non separati dalle
sbarre
Forma 3a
Terminali per i conduttori esterni separati dalle sbarre
Forma 3b
Terminali per i conduttori esterni nella stessa cella
come le unità funzionali associate
Terminali per i conduttori esterni non nella stessa cella
come le unità funzionali associate ma in singoli spazi
separati e racchiusi o in celle
Forma 4a
Forma 4b
● Fig. 2.16
Forme di segregazione
FORMA 1
(nessuna segregazione interna)
FORMA 2
(segregazione delle sbarre delle unità funzionali)
Forma 2a
Terminali non separati dalle sbarre
Forma 2b
Terminali separati dalle sbarre
FORMA 3
(separazione delle sbarre dalle unità funzionali +
separazione delle unità funzionali tra loro)
Forma 3a
Terminali non separati dalle sbarre
Forma 3b
Terminali separati dalle sbarre
FORMA 4
(separazione delle sbarre dalle unità funzionali +
separazione delle unità funzionali tra loro +
separazione dei terminali tra loro)
Forma 4a
Terminali nella stessa cella come
unità funzionale associata
Forma 4b
Terminali non nella stessa cella come
unità funzionale associata
293
CARATTERISTICHE
Proprietà dielettriche
DEL QUADRO
Le parti attive all’interno di un quadro elettrico devono essere isolate dalla struttura meccanica
del quadro stesso. Nella maggior parte dei casi l’isolante principale è l’aria; le distanze
d’isolamento delle parti in tensione fra loro e verso massa sono progettate in modo che nelle
condizioni più gravose d’esercizio esista un margine di sicurezza tale da evitare scariche o
danneggiamenti.
I supporti meccanici delle parti attive devono essere assicurati da corpi isolanti solidi,
intervallati a distanza sufficiente, lungo le parti attive stesse; tali supporti assumono la forma e
le caratteristiche più varie a seconda del tipo di quadro elettrico e possono essere realizzati sia
con materiali inorganici tradizionali (porcellana, vetro, materiali ceramici in genere) sia con
materiali isolanti a base organica. Questi ultimi si suddividono in:
- resine termoplastiche: sono resine che conservano un buon grado di solubilità a contatto con i
solventi e di fusibilità al calore; in generale, per altro, quando la temperatura non raggiunge i
limiti di danneggiamento del materiale, le resine termoplastiche (resine acriliche e viniliche)
ritornano nelle condizioni iniziali all’abbassarsi della temperatura
- resine termoindurenti: sono sostanze che, portate a temperature crescenti, dopo un iniziale
rammollimento, iniziano un processo di trasformazione o di polverizzazione che le trasforma
in modo irreversibile.
Distanze di isolamento
in aria e superficiali
Quando si eseguono i montaggi delle apparecchiature ed i collegamenti elettrici all’interno dei
quadri è necessario mantenere le distanze di isolamento tra le parti attive e le parti metalliche
e queste distanze devono rimanere inalterate nelle condizioni di servizio.
● Fig. 2.17
Distanza in aria e
superficiale
conduttori attivi
materiale isolante
distanza in aria
distanza superficiale
Con riferimento alla Fig. 2.17, la distanza
di isolamento in aria è il tratto più breve tra
due conduttori attivi o tra conduttori attivi e
la massa, mentre la distanza superficiale di
isolamento è il percorso più breve
attraverso la superficie di un materiale
isolante tra due conduttori attivi o tra
conduttori attivi e la massa.
I componenti dei kit di montaggio degli
interruttori modulari della serie 90 e degli
interruttori scatolati della serie MTS permettono di soddisfare questo aspetto normativo, essendo
già stati verificato il rispetto dei valori nominali dichiarati con le prove di tipo previste dalla
norma CEI 60439-1.
Il rispetto delle distanze superficiali è garantito dal giusto montaggio degli isolatori portabarre,
dal corretto posizionamento delle barre e dal rispetto delle indicazioni per il cablaggio dei
componenti elettrici, contenuti nei manuali di installazione.
I valori che caratterizzano queste proprietà dielettriche sono:
- tensione di tenuta a impulso del circuito principale (valore espresso in kV con forma d’onda
1,2/50 µs, come indicato in Fig. 2.18)
- tensione di isolamento a frequenza industriale (valore espresso in V con forma sinusoidale a 50 Hz).
● Tab. 2.17
Dati della serie 47 CVX
TIPOLOGIA
Quadro a parete
Quadro da incasso
Quadro da pavimento
Armadio
294
TENSIONE
DI TENUTA A
PROVA
DIELETTRICA
IMPULSO (KV)
(V)
6
6
8
8
2500
2500
3500
3500
● Fig. 2.18
Forma d’onda 1,2/50 µs
T1 = 1,2 µs ± 30% (tempo di fronte d’onda)
T2 = 50 µs ± 20% (tempo di coda d’onda)
T1 = 1,67 T (rapporto tra T1 e T)
U
1.0
0.9
0.5
0.3
t
0
T
T1
T2
È evidente che se all’interno del quadro esiste un’apparecchiatura con valore di proprietà
dielettriche inferiori ai valori nominali, questa condiziona i valori nominali del quadro stesso.
Per i conduttori attivi nudi e per le connessioni (per esempio le barre, le connessioni tra
apparecchi, i capicorda), le distanze in aria e superficiali o la tensione di tenuta a impulso
devono almeno rispondere alle stesse regole specificate per gli apparecchi ai quali sono
direttamente collegati. Inoltre condizioni anormali, come un cortocircuito, non devono ridurre
in modo permanente le distanze in aria o la rigidità dielettrica tra le sbarre e/o le connessioni,
al di sotto dei valori specificati per gli apparecchi ai quali esse sono direttamente associate.
Affinché non si verifichi un arco elettrico in aria, la norma CEI EN 60439-1 fornisce le distanze
minime d’isolamento in funzione di:
- tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
- tipo di campo elettrico
- grado di inquinamento (normalmente per ambienti industriali tipo 3).
Le minime distanze d’isolamento in aria, dedotte dalla norma, sono riportate in Tab. 2.18.
● Tab. 2.18
Distanze minime
TENSIONE
NOMINALE
DISTANZE
DI TENUTA A IMPULSO
di isolamento in aria
CAMPO
UIMP
(KV)
1
0,33
0,5
0,8
1,5
2,5
4
6
8
12
0,01
0,04
0,1
0,3
0,6
1,2
2
3
4,5
MINIME DI ISOLAMENTO IN ARIA
CAMPO
ELETTRICO UNIFORME
GRADO DI
2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,6
1,2
2
3
4,5
INQUINAMENTO
3
4
1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,2
2
3
4,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2
3
4,5
0,01
0,04
0,1
0,5
1,5
3
5,5
8
14
(mm)
ELETTRICO NON UNIFORME
GRADO DI
2
0,2
0,2
0,2
0,5
1,5
3
5,5
8
14
INQUINAMENTO
3
4
0,8
0,8
0,8
0,8
1,5
3
5,5
8
14
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
3
5,5
8
14
295
CARATTERISTICHE
DEL QUADRO
Analogamente, in Tab. 2.19 sono indicate le minime distanze di isolamento superficiale in
funzione di
- tensione nominale di isolamento Ui
- grado di inquinamento (normalmente per ambienti industriali tipo 3)
- gruppo del materiale isolante.
● Tab. 2.19
TENSIONE
Distanze di isolamento
NOMINALE
superficiali
MINIME
DISTANZE DI ISOLAMENTO SUPERFICIALE
GRADO
1
(1)
Ui
(V)
10
12,5
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
400
500
630
800
1000
GRUPPO
2
(1)
1
DEL MATERIALE
DI INQUINAMENTO
2
GRUPPO
3
DEL MATERIALE
GRUPPO
4
DEL MATERIALE
(2)
GRUPPO
DEL MATERIALE
I, II, III I, II, IIIa I, II, III
I
II
III
I
II
IIIa
IIIb
I
II
IIIa
0,025 0,04 0,08
0,025 0,04 0,09
0,025 0,04
0,1
0,025 0,04 0,11
0,025 0,04 0,125
0,025 0,04 0,14
0,025 0,04 0,16
0,025 0,04 0,18
0,04 0,063 0,2
0,063 0,1
0,22
0,1
0,16 0,25
0,16 0,25 0,28
0,25
0,4
0,32
0,4
0,63 0,42
0,56
1
0,56
0,75
1,6
0,75
1
2
1
1,3
2,5
1,3
1,8
3,2
1,8
2,4
4
2,4
3,2
5
3,2
0,4
0,42
0,45
0,48
0,5
0,53
0,56
0,6
0,63
0,67
0,71
0,75
0,8
1
1,25
1,6
2
2,5
3,2
4
5
0,4
0,42
0,45
0,48
0,5
0,53
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05
1,1
1,4
1,8
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
0,4
0,42
0,45
0,48
0,5
0,53
1,1
1,2
1,25
1,3
1,4
1,5
1,6
2
2,5
3,2
4
5
6,3
8
10
1
1,05
1,1
1,2
1,25
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,5
3,2
4
5
6,3
8
10
12,5
1
1,05
1,1
1,2
1,25
1,3
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
9
11
14
1
1,05
1,1
1,2
1,25
1,3
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,4
2,5
3,2
4
5
6,3
8
10
12,5
16
1
1,05
1,1
1,2
1,25
1,3
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,4
2,5
3,2
4
5
6,3
8
10
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,4
2,5
3,2
4
5
6,3
8
10
12,5
16
20
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,8
2,4
2,5
2,6
2,8
3,0
3,2
4
5
6,3
8
10
12,5
16
20
25
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,8
3
3,2
3,4
3,6
3,8
4
5
6,3
8
10
12,5
16
20
25
32
Nota
(1) I valori indicati si applicano alle distanze superficiali dei materiali per circuiti stampati.
(2) La classificazione del materiale è in funzione della resistenza alle correnti superficiali (CTI).
Per una più ampia consultazione si rimanda alla Tab. 16 della Norma CEI EN 60439-1.
296
(mm)
DI ISOLAMENTO
DISSIPAZIONE TERMICA
E TENUTA AL
CORTOCIRCUITO
La dissipazione termica e il comportamento in cortocircuito sono tra le problematiche più
importanti che un progettista o un quadrista deve affrontare per la costruzione dei quadri
elettrici. Questo perché le tipologie di quadri elettrici sono abbastanza diseguali e devono
soddisfare le più svariate situazioni impiantistiche.
Per la verifica delle soluzioni adottate, la norma CEI EN 60439-1 mette a disposizione due
percorsi:
- prova di tipo
- metodo per estrapolazione.
La prima soluzione permette di verificare direttamente l’oggetto in esame e determinare i valori
nominali per determinate configurazioni. A titolo esemplificativo si faccia riferimento alle prove
eseguite da GEWISS sui contenitori della serie 47 CVX nelle condizioni e nelle configurazioni
più critiche, riportate nella IV sezione di questa guida.
Le seconda permette di verificare attraverso i calcoli che le soluzioni adottate siano riconducibili
ai valori determinati dal costruttore del sistema costruttivo prestabilito.
Questi metodi sono indicati dalla norma CEI EN 60439-1, che rimanda alla norma CEI 17-43
per la determinazione della sovratemperatura e alla norma CEI 17-52 per la verifica delle
sollecitazioni dovute al cortocircuito.
Sovratemperatura
Quando all’interno di un quadro elettrico poniamo una serie di componenti percorsi da
corrente, per effetto Joule si produce calore che si distribuisce all’interno del quadro in modo
verticale e condizionato dalla superficie di scambio dell’involucro con l’ambiente esterno.
A causa di questo fenomeno risulta necessario conoscere quanta potenza termica è possibile
installare all’interno dell’involucro senza raggiungere valori di sovratemperatura superiori ai
limiti stabiliti dalla norma. Questi valori devono essere calcolati (si veda esempio riportato a
pag. 50) e, nel caso si utilizzi il sistema costruttivo prestabilito GEWISS (quadro AS),
successivamente verificati con i limiti stabiliti dal produttore del sistema costruttivo. Nel caso
contrario (quadro ANS), la verifica della sovratemperatura si può effettuare con il metodo
indicato dalla Norma CEI 17-43 (si veda esempio riportato a pag. 51).
Per calcolare la potenza dissipata installata è necessario anzitutto conoscere i componenti che
sono installati all’interno del quadro, quali, ad esempio, interruttori, fusibili, conduttori, sistemi
di cablaggio, ausiliari.
Per ogni componente si rileva dai dati nominali la potenza dissipata per polo, che dovrà essere
ricalcolata per il massimo dell’effettiva corrente che lo attraversa ad un dato istante oppure, se
non sono note le correnti effettive, moltiplicata per il valore del fattore di contemporaneità, che
se non specificato altrimenti, la norma stabilisce nei valori di Tab 2.20.
● Tab. 2.20
Fattori di contemporaneità
convenzionali
NUMERO
DEI CIRCUITI
FATTORE
DI
PRINCIPALI
CONTEMPORANEITÀ
2-3
4-5
6-9
≥ 10
0,9
0,8
0,7
0,6
Il risultato finale (cioè la somma delle vere potenze dissipate dai componenti) dovrà essere
inferiore o uguale a quella che il produttore del sistema costruttivo ha già verificato per quella
tipologia dell’involucro nella posa d’installazione scelta (AS) o utilizzato per il metodo di
calcolo previsto dalla Norma CEI 17-43 (ANS).
297
CARATTERISTICHE
DEL QUADRO
Nella sezione IV di questa guida sono riportate le massime potenze dissipabili dalla serie CVX
nelle varie tipologie di installazione e le potenze dissipate dagli interruttori della serie 90 e della
serie MTS.
Esempio di calcolo
della potenza dissipata
● Tab. 2.21
Configurazione del quadro
Si consideri un quadro a pavimento in versione IP 30 di dimensioni interne BxH = 600x1800
addossato ad una parete, in cui sono installati un interruttore generale MTS 250 ed interruttori
modulari derivati della serie MT. Il sistema di distribuzione è costituito da un ripartitore a barre
orizzontale, cui sono connessi i circuiti derivati con le sezione dei collegamenti riportate in
Tab. 2.21. La strumentazione è composta da un voltmetro e da 3 amperometri.
TIPO
INTERRUTTORE
MTS 250 (4P)
MT 250 (4P)
MT 250 (4P)
MT 250 (4P)
MT 250 (4P)
MT 250+BD (4P)
MT 250 (4P)
CORRENTE
(A)
NOMINALE
INTERRUTTORI
NR.
COLLEGAMENTI
(mm2)
1
3
4
6
1
2
1
120
2,5
4
4
6,3
6,3
10
250
10
16
20
25
25
32
Strumentazione
Interuttore generale
Ripartitore
Interruttori derivati
Morsettiere
Le correnti effettive che passano nei poli degli interruttori derivati sono indicate in Tab. 2.22 (si
considerano trascurabili per il polo neutro). Si noti che la sommatoria delle correnti in uscita è
pari a 225 A, inferiore alla corrente nominale dell’interruttore generale.
● Tab. 2.22
Correnti effettive nei circuiti
derivati
TIPO
INTERRUTTORE
MT 250
MT 250
MT 250
MT 250
MT 250+BD
MT 250
CORRENTE
(A)
NOMINALE
NR.
INTERRUTTORI
10
16
20
25
25
32
3
4
6
1
2
1
CORRENTE
(A)
EFFETTIVA
6,7
11
14
18
18
23
Totale
CORRENTE
EFFETTIVA
CIRCUITI DERIVATI
(A)
20
44
84
18
36
23
225
Utilizzando la condizione di massimo utilizzo in un dato istante e conoscendo la potenza
dissipata per polo da ciascun apparecchio, indicata in Tab, 2.23, si ricava facilmente la
potenza effettiva dissipata dagli apparecchi con il seguente calcolo:
Pa = 50 x (225/250)2 + (9x2,13) x (6,7/10)2 + (12x2,8) x (11/16)2 + ... = 110,8 W.
● Tab. 2.23
Potenze dissipate dagli
apparecchi
298
TIPO
INTERRUTTORE
MTS 250
MT 250
MT 250
MT 250
MT 250
MT 250+BD
MT 250
CORRENTE
(A)
NOMINALE
250
10
16
20
25
25
32
N.
POLI
3
9
12
18
3
6
3
CORRENTE
(A)
POTENZA DISSIPATA
(W/POLO)
225
6,7
11
14
18
18
23
50 (tot. apparecchio)
2,13
2,80
2,56
3,10
4,40
3,00
Totale
EFFETTIVA
POTENZA
DISSIPATA
TOTALE
(W)
40,5
8,6
15,9
22,6
4,8
13,7
4,6
110,8
Sommando la potenza dissipata dal ripartitore (Pr), dalla strumentazione (Ps), dai collegamenti
(Pc) e dalla morsettiera (Pm) si ricava il valore della potenza dissipabile totale:
Ptot = Pa + Pr + Ps + Pc + Pm = 110,8 + 15 + 10 + 65 + 36 = 236,8 W.
I valori delle potenze dissipate Pr, Pc, Pm sono stati calcolati in riferimento alle correnti effettive
passanti (P = Ri2).
Dalla tabella delle potenze dissipabili per i quadri a pavimento IP 30 (H = 1800 mm), con
installazione addossata a parete, risulta che la sovratemperatura che si avrà nella parte superiore
del quadro è pari a circa 27 K. Considerando una temperatura ambiente di 35 °C, la temperatura
assoluta all’interno del quadro risulta pari a 62 °C, nei limiti stabiliti dalla norma (Tab. 1.4).
Esempio di calcolo e
verifica della
sovratemperatura
(CEI 17-43)
Si desidera verificare la sovratemperatura, in base al metodo descritto nella Norma CEI 17-43,
all’interno di un armadio della serie 47 CVX con le dimensioni indicate in Fig. 2.19, addossato
a parete, senza aperture di ventilazione e senza diaframmi interni orizzontali. La potenza
effettiva dissipata dagli apparecchi installati nell’involucro si ipotizza pari a 400 W.
● Fig. 2.19
637 mm
(600 mm)
Dimensioni effettive
dell’armadio
2131 mm
(2000 mm)
Nota
In figura sono indicate le
dimensione esterne dell’involucro;
tra parentesi le dimensioni interne
funzionali)
748 mm
(600 mm)
Di seguito sono riportati i dati e le procedure di calcolo per la determinazione della
sovratemperatura del quadro.
Determinazione della superficie effettiva di raffreddamento
La superficie effettiva di raffreddamento Ae di un involucro è la somma delle superfici
individuali A0 (superfici dei lati esterni dell’involucro) moltiplicate per il fattore di superficie b.
Questo fattore tiene conto della dissipazione di calore delle superfici individuali a seconda del
tipo di installazione dell’involucro e può essere ricavato dalla Tab. 2.24.
● Tab. 2.24
Fattore di superficie
in funzione del tipo di
installazione
TIPO DI INSTALLAZIONE
Superficie superiore esposta
Superficie superiore coperta, es. involucri a incasso
Parti laterali esposte, es. parete anteriore, posteriore e pareti laterali
Parti laterali coperte, es. lato posteriore dell’involucro per montaggi a parete
Parti laterali di involucri centrali
Superficie di fondo
FATTORE
b
1,4
0,7
0,9
0,5
0,5
non presa in considerazione
DI SUPERFICIE
299
CARATTERISTICHE
DEL QUADRO
Pertanto:
Ae = ∑ (A0 . b) = (0,476 . 1,4) + (2,714 . 0,9) + (1,593 . 0,9) + (1,593 . 0,5) = 5,33 m2.
Determinazione della sovratemperatura ∆t 0,5 dell’aria interna a metà altezza dell’involucro
di raffreddamento
Il calcolo viene eseguito applicando la formula:
∆t 0,5 = k . d . Px
dove:
- k è la costante dell’involucro che tiene conto della dimensione della superficie di
raffreddamento. Per involucri senza apertura di ventilazione e aventi una superficie Ae pari a
quella calcolata, la Norma CEI 17-13 fornisce il valore di k = 0,16
- d è il fattore di sovratemperatura, ricavabile dalla Tab. 2.25 in funzione del numero di
diaframmi interni
- P è la effettiva potenza dissipata dalle apparecchiature installate internamente all’involucro
- x è un esponente che vale 0,804 per involucri senza aperture e 0,715 per involucri con
aperture.
● Tab. 2.25
Fattore d in funzione del
numero di diaframmi
NUMERO
DI DIAFRAMMI ORIZZONTALI
n
FATTORE d
0
1
2
3
1,00
1,05
1,15
1,30
Nota:
I valori in tabella si riferiscono ad involucri senza apertura di ventilazione e con superficie di raffreddamento effettiva Ae > 1,25 m2.
Pertanto:
∆t 0,5 = k . d . Px = 0,16 . 1 . 4000,804 = 19,7 K
Determinazione della sovratemperatura ∆t 1,0 dell’aria interna nella parte superiore
dell’involucro
Il calcolo è eseguito mediante la formula:
∆t 1,0 = c . ∆t 0,5
Il fattore c tiene conto della distribuzione della temperatura all’interno dell’involucro e dipende
dalla presenza o meno di aperture di ventilazione, dal progetto del quadro e dall’installazione
dell’apparecchiatura assiemata nel suo complesso.
Per quadri con superficie effettiva di raffreddamento Ae, maggiore di 1,5 m2, il fattore c può
essere ricavato dal grafico di Fig. 2.20 dove in ascissa la grandezza indicata con la lettera f è
pari al seguente rapporto:
h1,35
f=
Ab
dove:
h = altezza del quadro
Ab = superficie della base del quadro.
300
● Fig. 2.20
Fattore di distribuzione
a
della temperatura c per
involucri senza apertura
di ventilazione e con
raffreddamento effettivo
2
Ae > 1,25 m
1,5
fattore C
superficie di
b
c
d
e
1,6
1,4
1,3
1,2
1,1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
fattore f
c
a
c
b
b
d
e
d
Poiché nel caso in esame risulta:
h1,35
f=
2,1311,35
=
Ab
= 5,834
0,476
ed il quadro risulta appoggiato al muro, la lettura della curva 3 porta al valore: c = 1,4.
In ultima analisi, alla sovratemperatura nella parte superiore del quadro:
∆t1,0 = c . ∆t0,5 = 1,4 x 19,7 = 27,6 K
301
CARATTERISTICHE
DEL QUADRO
Curva caratteristica della sovratemperatura dell’aria all’interno dell’involucro.
La curva caratteristica della sovratemperatura dell’aria per involucri aventi una superficie
effettiva di raffreddamento Ae > 1,25 m2 è definita mediante una linea retta che unisce i punti
∆t 1 e ∆t 0,5 (Fig. 2.21).
● Fig. 2.21
Curva caratteristica della
sovratemperatura
Multipli dell’altezza dell’involucro
La sovratemperatura dell’aria interna alla base dell’involucro è prossima a zero, cioè la curva
caratteristica tende in maniera asintotica a zero.
∆t 1.0
1.0
Estremità superiore
∆t0.5
0.5
Metà altezza
Sovratemperatura dell’aria all’interno dell’involucro ∆t
Validità del progetto
Il progettista del quadro dovrà verificare che i valori di sovratemperatura finali ottenuti, e cioè
circa 19,7 K (pari a 19,7 °C) a metà quadro e 27,6 K alla sommità del quadro, siano
compatibili con le apparecchiature installate. In caso contrario, si devono modificare i
parametri e di conseguenza il calcolo va ripetuto. Se, nel caso in esame, si aggiunge a 27,6 °C
la temperatura media esterna, che può essere, ad esempio, di 30 °C, si ricava un valore
assoluto in cima al quadro di 57,6 °C; questa temperatura è accettabile per le apparecchiature
contenute.
L’intera verifica ed i calcoli ad essa associati, possono essere utilmente raccolti in un unico
modulo di calcolo la cui struttura è suggerita dalla stessa norma CEI 17-43 (Fig. 2.23).
● Fig. 2.22
sovratemperatura
Multiplo dell’altezza dell’involucro
Verifica finale della
1.0
27,6
0.75
0.5
19,7
Sovratemperatura dell’aria all’interno dell’involucro ∆t
302
Cliente/impianto
Elettroquadri s.r.l.
Singolo
Tipo di involucro
Dimensioni
significative per
la sovratemperatura
Altezza
mm
Larghezza
mm
Profondità
mm
Tipo di installazione:
2131
748
637
a parete
Apertura di ventilazione:
SI/NO
Numero di diaframmi orizzontali:
0
Ao x b
Dimensioni
Ao
Fattore
(Colonna 3) x
di superficie b
(Colonna 4)
mxm
m2
secondo la Tab. 3
m2
Colonna 2
Colonna 3
Colonna 4
Colonna 5
0,748 x 0,637
0,748 x 2,131
0,748 x 2,131
0,637 x 2,131
0,637 x 2,131
0,476
1,593
1,593
1,357
1,357
1,4
0,9
0,5
0,9
0,9
0,666
1,434
0,796
1,221
1,221
5,33
2,131
compilato
Calcolo della sovratemperatura dell’aria all’interno dell’involucro
Superficie di raffreddamento effettiva
● Fig. 2.23
Esempio di modulo
0,748 0,637
Parte superiore
Parte anteriore
Parte posteriore
Lato sinistro
Lato destro
Ae = Σ (Ao x b) = Totale
Con superficie di raffreddamento effettiva Ae
Superiore a 1,25 m2
f=
h1,35
Ab
Inferiore o uguale a 1,25 m2
g=
(5.2.3)
h
w
(5.2.3)
1,35
2,131
0,476
=
=
=
5,834
Aperture d’entrata aria
cm2
Costante d’involucro k
Fattore d
Potenza dissipata effettiva P
x
P =P
W
0,804
...
∆t0,5 = k • d • Px
K
Fattore di distribuzione della temperatura c
∆t0,1 = c • ∆t0,5
K
=
0
0,16
1,00
400
123,6
19,7 K
1,4
27,6
303
CARATTERISTICHE
Calcolo degli sforzi
elettrodinamici nei
sistemi barre
DEL QUADRO
La tenuta complessiva al cortocircuito di un quadro elettrico può essere accertata mediante la
prova di tipo descritta alla sezione 8 della Norma CEI 17-13/1.
Nel caso si utilizzi il sistema costruttivo prestabilito GEWISS (quadro AS), questa prova è già
stata effettuata dal produttore (Tab. 3.17, Tab. 3.19 per barre piatte e Tab. 3.23, Tab. 3.25 per
barre sagomate) e quindi, se i dati del quadro rientrano nei limiti indicati da GEWISS non è
richiesta alcuna verifica aggiuntiva.
Invece nei quadri ANS la verifica della tenuta al cortocircuito deve essere eseguita tramite:
- prove effettuate secondo la Norma CEI EN 60439-1
- verifica per estrapolazione da sistemazioni similari che abbiano superato le prove di tipo,
secondo quanto indicato nella Norma CEI 17-52.
Risulta pertanto decisivo, per i quadri ANS, che i sistemi sbarre e gli altri componenti interessati
al cortocircuito siano derivati da quadri che hanno superato le prove di tipo e che le modifiche
introdotte siano tali da non comportare sollecitazioni superiori a quelle relative al quadro (e/o
ai componenti del quadro) che ha superato la prova di tipo.
Il metodo previsto attualmente dalla normativa è quello di verifica dei sistemi di sbarre, il cui
procedimento è indicato nella norma CEI 17-52 che, a sua volta, rimanda alla Pubblicazione
IEC 865 (CEI 11-26).
Nel seguito verranno esaminate alcune tra le situazioni più ricorrenti nelle quali l’applicazione
delle suddette norme (CEI 17-52 e CEI 11-26) consente di estrapolare per i quadri ANS (ma
sempre con riferimento a situazioni provate) la verifica al cortocircuito di sistemi sbarre nelle
configurazioni usualmente impiegate.
Le principali condizioni di applicabilità del metodo sono:
- la corrente di picco di cortocircuito deve essere inferiore a quella della prova eseguita sul
prototipo di riferimento;
- non vi devono essere stati cambiamenti nella geometria o nel materiale dei supporti del
prototipo di riferimento;
- le barre che realizzano percorsi angolari devono essere riconducibili a composizioni di barre
rettilinee, supportate ad ogni angolo;
- la sovratemperatura calcolata secondo la Norma IEC 865 per un sistema SNS non deve essere
superiore a quella del sistema SAS;
- il tipo di connessione delle barre e dell’apparecchiatura deve essere stato sottoposto a prova
di tipo.
Da ultimo si ribadisce che per i quadri che hanno una corrente presunta di cortocircuito
nominale fino a 10 kA non è richiesta la prova di tipo; la prova non è altresì richiesta nei casi
in cui il quadro è protetto da un dispositivo limitatore di corrente, fusibile o interruttore
limitatore, tale per cui il valore di picco della corrente limitata, in corrispondenza della corrente
di cortocircuito presunta nominale del quadro, non superi 17 kA e quindi, in questi casi, la
distinzione tra quadri AS e ANS, per quanto riguarda il cortocircuito, non si pone.
In particolare la Norma CEI 17-52 introduce due strutture tipo di sistemi di sbarre (Fig. 2.24),
denominati rispettivamente:
- sbarre di serie (SAS)
- sbarre non di serie (SNS).
304
● Fig. 2.24
Sistemi di sbarre SAS e
SNS
Legenda:
barre
portabarre
connessione delle barre o dell’apparecchiatura
apparecchiatura
vista di lato
vista di lato
Struttura di sistema di barre di serie (SAS)
Struttura di sistema di barre non di serie (SNS)
Nel primo caso sia i materiali, sia la struttura che la sua sistemazione sono oggetto di
documentazione risultante da certificati di prova; nel secondo caso la tenuta al cortocircuito
della struttura deve avvenire per estrapolazione.
La Norma CEI 17-52 consente di estrapolare per i quadri ANS (ma sempre con riferimento a
situazioni provate) la verifica al cortocircuito di un sistema sbarre.
Ad esempio, conoscendo:
- le dimensioni e le sezioni delle sbarre in rame
- la corrente di cortocircuito
- l’interasse (a) tra le fasi
- la disposizione delle barre e il tipo di vincolo
è possibile determinare:
- la forza (Fd) che agisce sui portabarre
- la distanza ( ) a cui vanno disposti i supporti per le barre.
l
La disposizione tipica delle sbarre a cui si fa riferimento per la verifica è quella indicata nella
Fig. 2.25.
● Fig. 2.25
Esempio di disposizione
di un sistema a barre in
a
rame con una sola
a
s
barra per fase
Fd
h
b
305