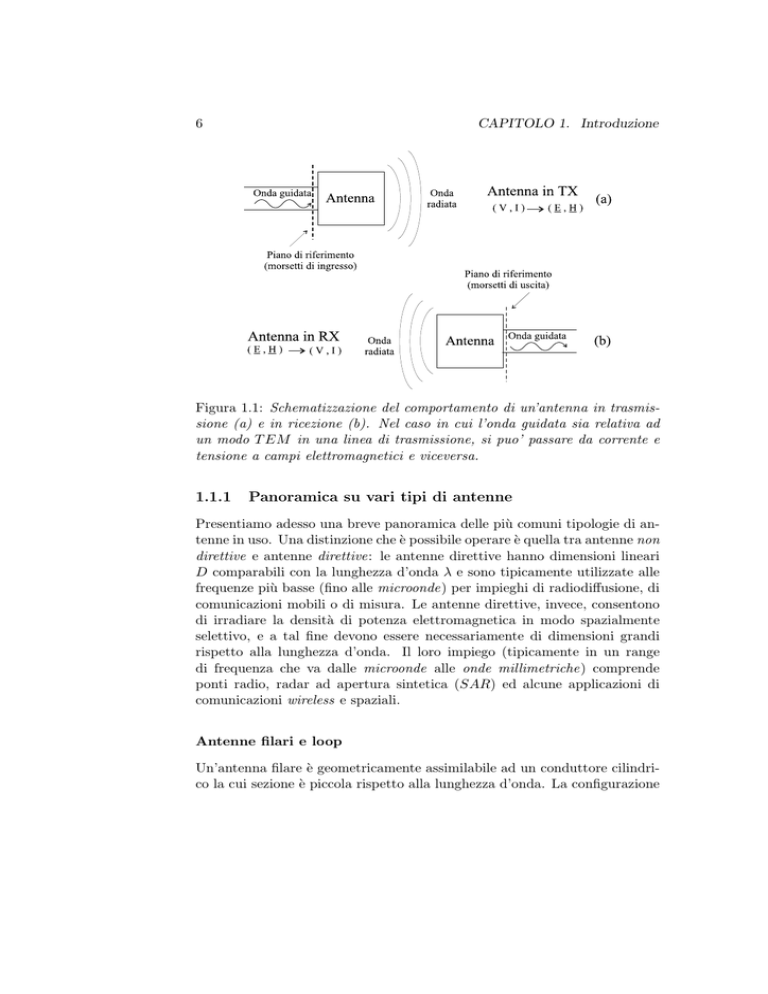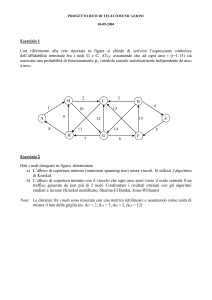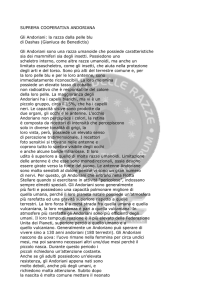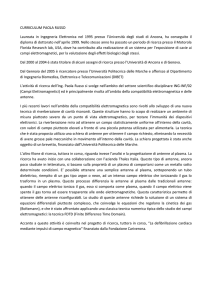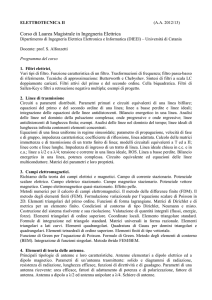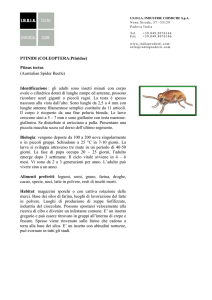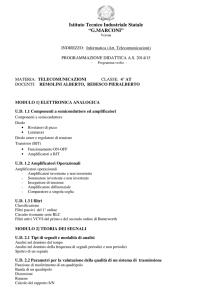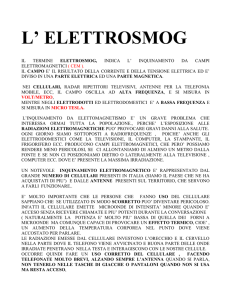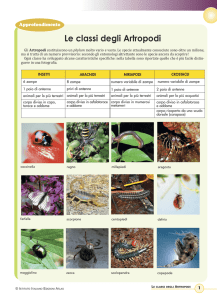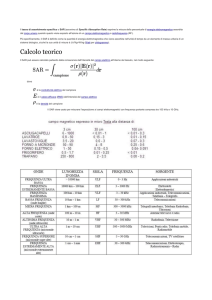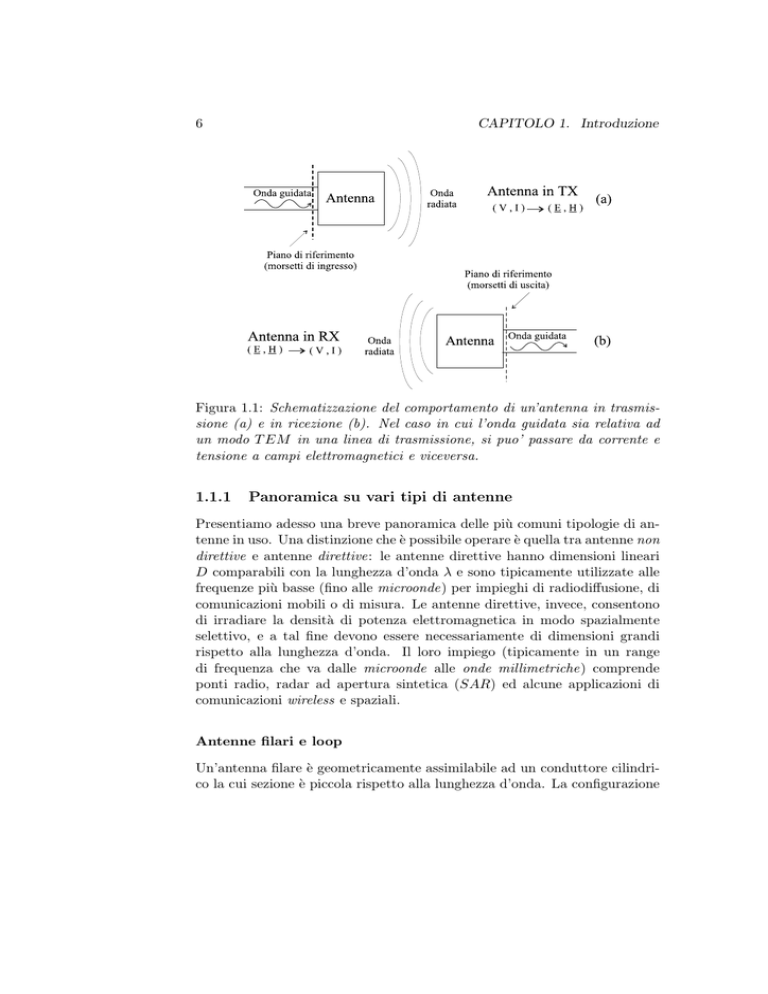
6
CAPITOLO 1. Introduzione
Figura 1.1: Schematizzazione del comportamento di un’antenna in trasmissione (a) e in ricezione (b). Nel caso in cui l’onda guidata sia relativa ad
un modo T EM in una linea di trasmissione, si puo’ passare da corrente e
tensione a campi elettromagnetici e viceversa.
1.1.1
Panoramica su vari tipi di antenne
Presentiamo adesso una breve panoramica delle più comuni tipologie di antenne in uso. Una distinzione che è possibile operare è quella tra antenne non
direttive e antenne direttive: le antenne direttive hanno dimensioni lineari
D comparabili con la lunghezza d’onda λ e sono tipicamente utilizzate alle
frequenze più basse (fino alle microonde) per impieghi di radiodiffusione, di
comunicazioni mobili o di misura. Le antenne direttive, invece, consentono
di irradiare la densità di potenza elettromagnetica in modo spazialmente
selettivo, e a tal fine devono essere necessariamente di dimensioni grandi
rispetto alla lunghezza d’onda. Il loro impiego (tipicamente in un range
di frequenza che va dalle microonde alle onde millimetriche) comprende
ponti radio, radar ad apertura sintetica (SAR) ed alcune applicazioni di
comunicazioni wireless e spaziali.
Antenne filari e loop
Un’antenna filare è geometricamente assimilabile ad un conduttore cilindrico la cui sezione è piccola rispetto alla lunghezza d’onda. La configurazione
1.1. Concetti di base
7
più nota è quella del dipolo elettrico, di dimensioni pari a mezza lunghezza d’onda, alimentato da una tensione � − gap (Fig.1.2). Una variante al
Figura 1.2: Antenna filare alimentata a ∆ − gap.
dipolo è il monopolo (Fig.1.3), ovvero un’antenna costituita da un cilindro
metallico sottile, di lunghezza λ/4, posto su un piano di massa. Tale antenna viene anche detta antenna marconiana e viene alimentata attraverso un
cavo coassiale il cui conduttore esterno è collegata al piano di massa e la cui
anima interna è collegata al cilindro metallico. Il vantaggio del monopolo
rispetto al dipolo è che il primo può essere alimentato con un generatore
sbilanciato, mentre il secondo, poiché deve possedere correnti uguali sui due
rami, necessita di una alimentazione bilanciata tipicamente più complicata,
costosa e limitata in banda.
Componendo antenne a dipolo è possibile modificare le caratteristiche radiative, generando una direttività più spinta in una prefissata direzione. È
il caso delle antenne Yagi-Uda, tipicamente impiegate per la ricezione televisiva (vedi Fig.1.4).
Altri tipi di antenne tipicamente impiegate a bassa frequenza quali ad esempio l’antenna a loop (Fig.1.5), costituita da un conduttore ripiegato in
circolo alimentato in modo sbilanciato.
Salendo in frequenza, le antenne costituzionalmente risonanti (lunghe ap-
8
CAPITOLO 1. Introduzione
Figura 1.3: Antenna marconiana alimentata in coassiale.
Figura 1.4: Antenna Yagi-Uda.
9
1.1. Concetti di base
Figura 1.5: Loop.
prossimativamente λ/2), hanno dimensioni fisiche sempre più piccole, e ciò
comporta problemi di limitazione di potenza gestibile in T X. Per chiarire
questo punto supponiamo di avere un’antenna filare risonante trasmittente
alla frequenza di 10 GHz, cioè di lunghezza circa pari a λ/2 = 1, 5 cm e
spessore di una frazione di millimetro: è intuitivo pensare che un’antenna
cosı̀ sottile e corta rischierebbe di fondere se alimentata da una potenza eccessiva, a causa della conducibilità finita del conduttore e alla impossibilità
di smaltire il calore per la scarsa superficie. Per questo motivo, entrando
nel campo delle microonde, è necessario cambiare tecnologia di costruzione,
soprattutto per le antenne in T X; per quanto riguarda invece la ricezione,
è consentito l’uso di antenne strutturalmente più piccole poiché le potenze
in gioco sono di entità limitata.
Antenne a larga banda
Le antenne a larga banda sono costruite in modo da avere caratteristiche
radiative e di impedenza uniformi su un range di frequenza di una ottava.
Tra queste sono da menzionare le antenne Log-periodiche ad array di dipoli
(Fig.1.6), le antenne ad elica (Fig.1.7), a spirale planare (Fig.1.8) e a spirale
conica (Fig.1.9). I concetti di base delle antenne a larga banda saranno
discussi successivamente.
10
CAPITOLO 1. Introduzione
Figura 1.6: Antenna logperiodica.
Figura 1.7: Array di antenne ad elica.
11
1.1. Concetti di base
Figura 1.8: Antenna a spirale.
Figura 1.9: Antenna a spirale conica logaritmica.
12
CAPITOLO 1. Introduzione
Antenne ad apertura
Le antenne ad apertura sono una classe di antenne definibili tramite una
distribuzione di campo elettromagnetico su di una superficie planare detta
apertura. Questa può essere corrispondente all’interfaccia di guide d’onda
rastremate aperte in spazio libero o sul piano ideale passante per il bordo di
riflettori parabolici. Questo tipo di antenna è oggi molto diffuso a causa della
crescente domanda di antenne per frequenze superiori al GHz (gamma delle
microonde). In aggiunta, l’apertura radiante può essere protetta dall’interazione con l’ambiente esterno da speciali coperture dielettriche (radomes).
Come anticipato, gli esempi più tipici di antenne ad apertura sono i
trombini (horn) (cfr.Fig.1.11, e i riflettori parabolici (Fig.1.13, Fig.1.14).
Figura 1.10: Antenna a horn.
L’horn non è altro che una guida d’onda che viene rastremata con continuità individuando una sezione piramidale troncata (o a tronco di cono,
se la guida di partenza è a sezione circolare, come in Fig.1.12). La guida
d’onda permette la propagazione di un campo modale che gradualmente si
trasforma nellospazio rastremato fino ad essere lanciato nello spazio libero
attraverso l’apertura.
L’antenna a riflettore parabolico è composta essenzialmente da un riflettore metallico sagomato a forma di paraboloide di rotazione e alimentato nel
fuoco da una antenna non molto direttiva (spesso un horn) o mediante un
subriflettore iperbolico a sua volta eccitato da sorgente focale (si parla in tal
caso di configurazioni Cassegrain, cfr.Fig.1.14); tali antenne si usano nella
gamma di frequenza 5 − 100GHz. Tra i vari impieghi dei riflettori parabolici sono da menzionare quelli relativi alle applicazioni radioastronomiche. I
1.1. Concetti di base
Figura 1.11: Trombini rettangolari.
Figura 1.12: Trombino circolare corrugato.
13
14
CAPITOLO 1. Introduzione
Figura 1.13: Antenna a riflettore.
radio-telescopi usano le antenne di dimensioni più grandi che esistano poiché
necessitano di direttività eccezionali, angoli di fascio estremamente stretti e
una vasta gamma di frequenze operative simultaneamente operanti con lo
stesso riflettore.
Nelle Fig.1.15-1.18, sono mostrati in sequenza l’osservatorio radio astronomico di Green Bank (West Virginia), quello di Medicina (BO), l’interferometro di Socorro (New Mexico) e il radio telescopio di Arecibo (Portorico).
Antenne stampate
Sono antenne di sviluppo relativamente recente, introdotte negli anni � 70 e
ampiamente impiegate solo negli ultimi 15 anni. Sono caratterizzate da una
struttura metallica radiante (patch) stampata su di un substrato dielettrico
posto su un piano di massa (Fig.1.19). I vantaggi di basso peso e costo e di
integrabilità con reti di alimentazione stampate, rendono queste antenne estremamente appetibili su una vasta gamma di applicazioni nelle microonde.
La forma del patch varia a seconda delle applicazioni; tra le forme più comuni vi è quella quadrata o rettangolare, ma si incontrano anche elementi
circolari, anulari, a croce etc....
1.1. Concetti di base
Figura 1.14: Antenna a riflettore con illuminatore Cassegrain.
15
16
CAPITOLO 1. Introduzione
Figura 1.15: National Radio Astronomy Observatory - Green Bank, West
Virginia.
1.1. Concetti di base
Figura 1.16: Osservatorio radioastronomico di Medicina.
17
18
CAPITOLO 1. Introduzione
Figura 1.17: Osservatorio radioastronomico di Arecibo - Portorico.
Figura 1.18: Very large telescope interferometer - Socorro, New Mexico.
1.1. Concetti di base
19
Figura 1.19: Patch rettangolare.
Antenne a schiera - (ARRAY)
Si definisce schiera (array) un insieme di radiatori disposti nello spazio con
un certo ordine, al fine di avere un sistema radiante con elevata direttività
e altre caratteristiche di fascio. Si possono avere schiere a una, due o (più
raramente) tre dimensioni a seconda che i radiatori siano disposti lungo una
linea, su una superficie, o in un volume.
Alcuni tipi di antenne ad array sono mostrate nelle Fig.1.20-1.24.
20
CAPITOLO 1. Introduzione
Figura 1.20: Antenne a patch stampate in configurazione ad array.
Figura 1.21: Array di fessure su guida d’onda rettangolare.
Figura 1.22: Array di fessure in guida - particolare.
21
1.1. Concetti di base
Figura 1.23: Array di slot.
Figura 1.24: Array di horn.