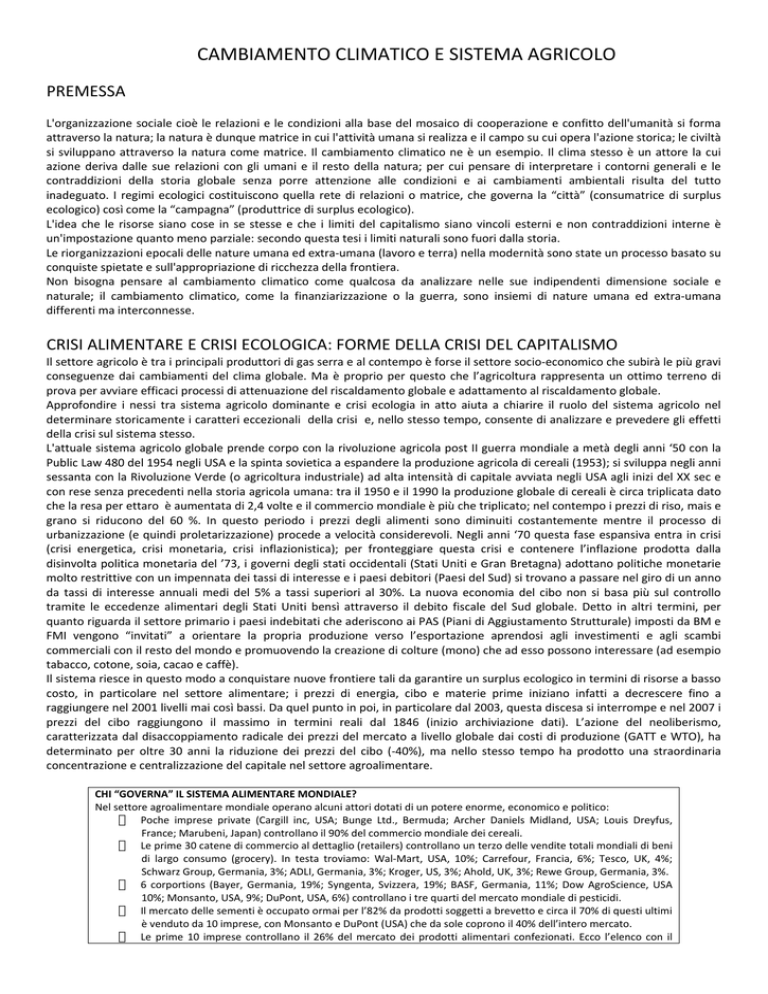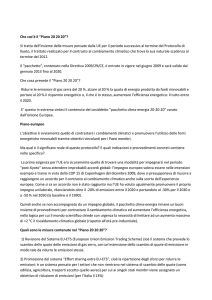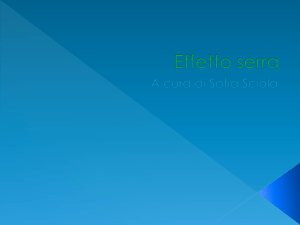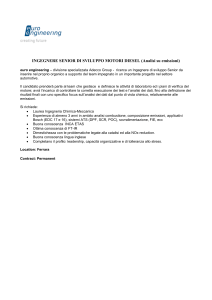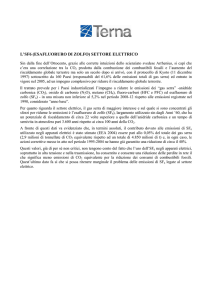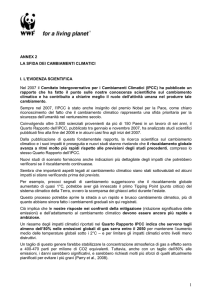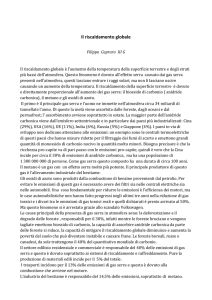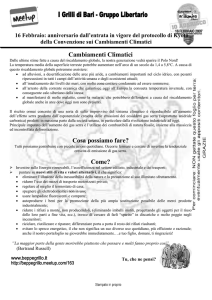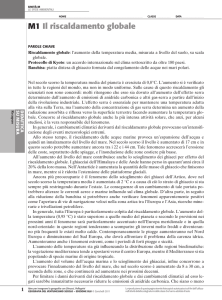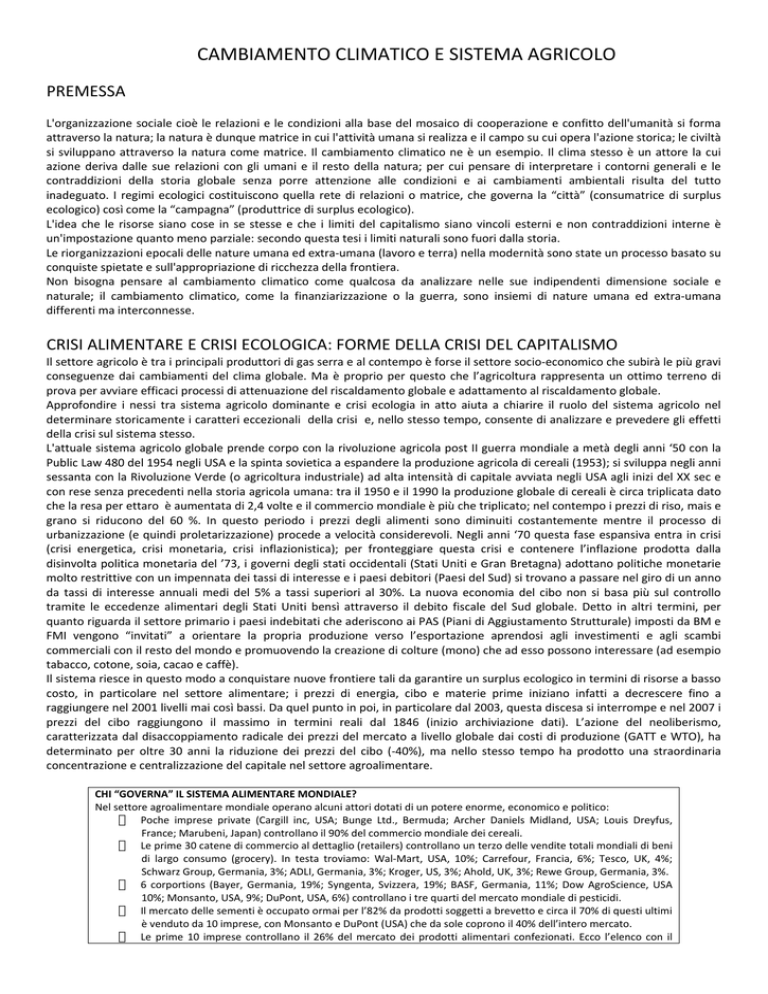
CAMBIAMENTO CLIMATICO E SISTEMA AGRICOLO
PREMESSA
L'organizzazione sociale cioè le relazioni e le condizioni alla base del mosaico di cooperazione e confitto dell'umanità si forma
attraverso la natura; la natura è dunque matrice in cui l'attività umana si realizza e il campo su cui opera l'azione storica; le civiltà
si sviluppano attraverso la natura come matrice. Il cambiamento climatico ne è un esempio. Il clima stesso è un attore la cui
azione deriva dalle sue relazioni con gli umani e il resto della natura; per cui pensare di interpretare i contorni generali e le
contraddizioni della storia globale senza porre attenzione alle condizioni e ai cambiamenti ambientali risulta del tutto
inadeguato. I regimi ecologici costituiscono quella rete di relazioni o matrice, che governa la “città” (consumatrice di surplus
ecologico) così come la “campagna” (produttrice di surplus ecologico).
L'idea che le risorse siano cose in se stesse e che i limiti del capitalismo siano vincoli esterni e non contraddizioni interne è
un'impostazione quanto meno parziale: secondo questa tesi i limiti naturali sono fuori dalla storia.
Le riorganizzazioni epocali delle nature umana ed extra-umana (lavoro e terra) nella modernità sono state un processo basato su
conquiste spietate e sull'appropriazione di ricchezza della frontiera.
Non bisogna pensare al cambiamento climatico come qualcosa da analizzare nelle sue indipendenti dimensione sociale e
naturale; il cambiamento climatico, come la finanziarizzazione o la guerra, sono insiemi di nature umana ed extra-umana
differenti ma interconnesse.
CRISI ALIMENTARE E CRISI ECOLOGICA: FORME DELLA CRISI DEL CAPITALISMO
Il settore agricolo è tra i principali produttori di gas serra e al contempo è forse il settore socio-economico che subirà le più gravi
conseguenze dai cambiamenti del clima globale. Ma è proprio per questo che l’agricoltura rappresenta un ottimo terreno di
prova per avviare efficaci processi di attenuazione del riscaldamento globale e adattamento al riscaldamento globale.
Approfondire i nessi tra sistema agricolo dominante e crisi ecologia in atto aiuta a chiarire il ruolo del sistema agricolo nel
determinare storicamente i caratteri eccezionali della crisi e, nello stesso tempo, consente di analizzare e prevedere gli effetti
della crisi sul sistema stesso.
L'attuale sistema agricolo globale prende corpo con la rivoluzione agricola post II guerra mondiale a metà degli anni ‘50 con la
Public Law 480 del 1954 negli USA e la spinta sovietica a espandere la produzione agricola di cereali (1953); si sviluppa negli anni
sessanta con la Rivoluzione Verde (o agricoltura industriale) ad alta intensità di capitale avviata negli USA agli inizi del XX sec e
con rese senza precedenti nella storia agricola umana: tra il 1950 e il 1990 la produzione globale di cereali è circa triplicata dato
che la resa per ettaro è aumentata di 2,4 volte e il commercio mondiale è più che triplicato; nel contempo i prezzi di riso, mais e
grano si riducono del 60 %. In questo periodo i prezzi degli alimenti sono diminuiti costantemente mentre il processo di
urbanizzazione (e quindi proletarizzazione) procede a velocità considerevoli. Negli anni ‘70 questa fase espansiva entra in crisi
(crisi energetica, crisi monetaria, crisi inflazionistica); per fronteggiare questa crisi e contenere l’inflazione prodotta dalla
disinvolta politica monetaria del ’73, i governi degli stati occidentali (Stati Uniti e Gran Bretagna) adottano politiche monetarie
molto restrittive con un impennata dei tassi di interesse e i paesi debitori (Paesi del Sud) si trovano a passare nel giro di un anno
da tassi di interesse annuali medi del 5% a tassi superiori al 30%. La nuova economia del cibo non si basa più sul controllo
tramite le eccedenze alimentari degli Stati Uniti bensì attraverso il debito fiscale del Sud globale. Detto in altri termini, per
quanto riguarda il settore primario i paesi indebitati che aderiscono ai PAS (Piani di Aggiustamento Strutturale) imposti da BM e
FMI vengono “invitati” a orientare la propria produzione verso l’esportazione aprendosi agli investimenti e agli scambi
commerciali con il resto del mondo e promuovendo la creazione di colture (mono) che ad esso possono interessare (ad esempio
tabacco, cotone, soia, cacao e caffè).
Il sistema riesce in questo modo a conquistare nuove frontiere tali da garantire un surplus ecologico in termini di risorse a basso
costo, in particolare nel settore alimentare; i prezzi di energia, cibo e materie prime iniziano infatti a decrescere fino a
raggiungere nel 2001 livelli mai così bassi. Da quel punto in poi, in particolare dal 2003, questa discesa si interrompe e nel 2007 i
prezzi del cibo raggiungono il massimo in termini reali dal 1846 (inizio archiviazione dati). L’azione del neoliberismo,
caratterizzata dal disaccoppiamento radicale dei prezzi del mercato a livello globale dai costi di produzione (GATT e WTO), ha
determinato per oltre 30 anni la riduzione dei prezzi del cibo (-40%), ma nello stesso tempo ha prodotto una straordinaria
concentrazione e centralizzazione del capitale nel settore agroalimentare.
CHI “GOVERNA” IL SISTEMA ALIMENTARE MONDIALE?
Nel settore agroalimentare mondiale operano alcuni attori dotati di un potere enorme, economico e politico:
Poche imprese private (Cargill inc, USA; Bunge Ltd., Bermuda; Archer Daniels Midland, USA; Louis Dreyfus,
France; Marubeni, Japan) controllano il 90% del commercio mondiale dei cereali.
Le prime 30 catene di commercio al dettaglio (retailers) controllano un terzo delle vendite totali mondiali di beni
di largo consumo (grocery). In testa troviamo: Wal-Mart, USA, 10%; Carrefour, Francia, 6%; Tesco, UK, 4%;
Schwarz Group, Germania, 3%; ADLI, Germania, 3%; Kroger, US, 3%; Ahold, UK, 3%; Rewe Group, Germania, 3%.
6 corportions (Bayer, Germania, 19%; Syngenta, Svizzera, 19%; BASF, Germania, 11%; Dow AgroScience, USA
10%; Monsanto, USA, 9%; DuPont, USA, 6%) controllano i tre quarti del mercato mondiale di pesticidi.
Il mercato delle sementi è occupato ormai per l’82% da prodotti soggetti a brevetto e circa il 70% di questi ultimi
è venduto da 10 imprese, con Monsanto e DuPont (USA) che da sole coprono il 40% dell’intero mercato.
Le prime 10 imprese controllano il 26% del mercato dei prodotti alimentari confezionati. Ecco l’elenco con il
valore delle vendite in milioni di dollari per il 2007: Nestle (Sviz.) 83600; Pepsi.co Inc. (US) 39474; Kraft Foods
(US) 37241; The Coca-Cola Company (US) 28857; Unilever (The Netherlands) 26985; Tyson Foods (US) 26900;
Cargill (US) 26500; Mars (US) 25000; Archer Daniels Midland Company (USA) 24219; Danone (Francia) 19975.
Tabella da “LA CRISI ALIMENTARE DEL 2008 “ di Valeria Sodano
All’inizio del secolo in corso il mercato globale dominato da questi pochi soggetti è conquistato e disciplinato dalla finanza
globale (processo di dipendenza dal credito finanziario), che inizia a estrarre plusvalore direttamente e indirettamente
(l’ammontare di danaro affluito sul mercato dei futures delle commodities per fini speculativi è passato dai 5 miliardi di dollari
del 2000 ai 175 miliardi di dollari del 2007, una dinamica che a Wall Street è stata denominata ‘commodities super-cycle’).
L’obiettivo dell’agroindustria mondiale è quello di garantire il valore per i grandi azionisti; l’egemonia neoliberista del capitale
finanziario sul processo di accumulazione a livello mondiale gioca pertanto un ruolo fondamentale nel determinare l’inversione
relativa ai prezzi di cibo, energia e materie prime, che non deve essere attribuita soltanto all’esaurimento delle risorse: il capitale
si è diretto a estrarre quanta più ricchezza possibile e quanto più velocemente possibile dal contenitore esistente; la
finanziarizzazione ha rappresentato una rapida e poco costosa strategia estrattiva, che ha scoraggiato investimenti industriali a
lungo termine, privilegiando invece nuove aree di saccheggio: fondi pensione, privatizzazione aziende pubbliche, privatizzazione
beni e servizi. Se l'appropriazione della frontiera del lavoro e della terra è stata la condizione indispensabile per le grandi ondate
dell'accumulazione capitalistica, dall'egemonia olandese nel XVII sec all'ascesa del neoliberismo negli anni 70-80 del novecento,
di fatto la spinta inflazionistica senza precedenti su cibo, energia e materie prime in atto dal 2003 sta indebolendo le condizioni
per un nuovo boom capitalistico (alta produttività e bassi costi delle materie prime). Innovazioni tecnologiche (biotecnologie
agrarie), nuovi progetti di accumulazione per espropriazione (land grabbing, privatizzazioni, accordi transnazionali, ecc) e
finanziarizzazione hanno momentaneamente arrestato il declino delle rese, ma non sono riuscite a creare le condizioni per una
nuova lunga fase espansiva di accumulazione basata su elevata produttività e costi bassi.
La natura è finita oggettivamente mentre il capitale si basa sull'infinito ed è alla ricerca continua di nuove frontiere, fatte di
energia, cibo e risorse a buon mercato; modalità di appropriazione con la quale far pagare agli altri all'esterno del circuito del
capitale ma nell'ambito della portata del potere capitalistico il conto per l'accumulazione continua del capitale. La grande
frontiera di non pagare I conti oggi è in crisi e la fine della natura a buon mercato rappresenta la fine dell'opportunismo. Non
è la crisi della natura quella di cui stiamo parlando ma la crisi sistemica del capitalismo che assume tante forme: quella
sociale, quella democratica, quella alimentare e quindi ecologica deteriorando in modo drammatico le relazioni tra umanità e
natura di cui fa parte.
Grafici dal Rapporto sull'andamento dei prezzi delle commodities agricole (1972 – 2011)
Non solo cibo, energia e materie prime a buon mercato ma anche la possibilità di non pagare il costo dei rifiuti e
dell’inquinamento rappresenta una condizione necessaria al processo di accumulazione; anche in questo senso l’attuale crisi
pone dei limiti forti a una possibile nuova fase espansiva.
In questo senso il cambiamento climatico, come effetto della discarica globale del sistema di produzione capitalistico,
rappresenta un ulteriore elemento di debolezza (scarsità di nuove frontiere) consolidando una caratteristica del nostro
tempo: la fine dell'energia e del cibo a buon mercato.
Cambiamento climatico significa infatti: riduzione terreni coltivabili (8-20% al 2050), scarsità di risorse idriche, proliferazione di
specie invasive, crescente resistenza biologica a pesticidi ed erbicidi, prezzi crescenti fertilizzanti ed effetti depressivi sui raccolti,
la competizione per la terra coltivabile da parte degli agro carburanti e soprattutto un declino delle aree agricole produttive
attorno al 12%; ma significa anche mutate e mutanti condizioni operative rispetto alle quali sono richiesti costi aggiuntivi di
investimento (capitalizzazione) che riducono i margini di profitto, mettendo in crisi l’essenza stessa del capitale; due esempi
possono aiutare a capire:
- il caso delle “supererbacce” come le definisce moore nel suo libro “ecologia-mondo e crisi del capitalismo. la fine della
natura a buon mercato” effetto collaterale e incontrollabile dell’erbicida “roundup” (contenete l’elemento attivo
glifosato) della monsanto venduto in unico pacchetto con la soia gm roundup ready (rr) ad esso resistente; le
supererbacce frutto dell’adattamento all’erbicida oggi invadono le stesse monocolture di soia riducendo fino a 1/5 la
capacità produttiva della stessa
- è di questi giorni un nuovo allarme dagli scienziati americani per cui nel 2100 la temperatura alcune aree del golfo
persico potrebbero raggiungere temperature di 77°C; ciò oltre a colpire le persone più povere che non possono
permettersi sistemi di condizionamento e di raffreddamento, oltre a costituire ulteriore causa di insicurezza alimentare,
provocherà effetti negativi su tutte le attività produttive nelle aree, tra queste non ultima le attività estrattive di
petrolio con conseguenze facilmente immaginabili sul costo finale del combustibile.
Sono esempi che mettono in luce il corto-circuito prodotto dall’attuale sistema di produzione e le contraddizioni strutturali che
caratterizzano questa crisi.
CAMBIAMENTO CLIMATICO
COS'E' Le emissioni di CO2 di origine umana sono molto più piccole di quelle naturali. L’assorbimento da parte della vegetazione
e dei microbi assomma a circa 220 Gt per anno, la respirazione del mondo vegetale provoca una emissione egualmente attorno
a 220 Gt/anno. Gli oceani rilasciano circa 332 Gt/anno. Mettendo assieme l’uso dei combustibili fossili, ed i cambiamenti di uso
del terreno, l’uomo è responsabile di circa 29 Gt/anno. Dobbiamo comunque tenere presente che le emissioni naturali ( da parte
degli oceani e dalla vegetazione) sono controbilanciate da assorbimento naturale (sempre da oceani e vegetazione). Le piante
assorbono circa 450 Gt/anno e l’oceano 338 Gt/anno. Ciò fa sì che il bilancio della CO2 atmosferica è pressoché in equilibrio. Le
emissioni di CO2 da parte dell’Uomo alterano l’equilibrio naturale.
Il 40% circa delle emissioni umane di CO2 vengono assorbite prevalentemente da vegetazione ed oceani. Ciò che resta rimane in
atmosfera. La conseguenza è che la CO2 atmosferica è attualmente al livello più alto mai raggiunto negli ultimi 15-20 milioni di
anni. Cambiamenti naturali dell’ordine di 100 ppm normalmente avvengono in 5000-20000 anni.
L’attuale aumento (circa 100 ppm) ha avuto luogo in appena 120 anni.
LE RESPONSABILITÀ Il Quinto Rapporto di Valutazione dell’IPCC, secondo Sergio Castellari, responsabile del Focal Point IPCC che
a Stoccolma ha seguito dal vivo le fasi di approvazione del rapporto degli scienziati selezionati dall’ONU, rafforza e conferma i
dati sui cambiamenti climatici frutto di una vasta serie di osservazioni e modelli di nuova generazione. Con estrema probabilità,
sostiene la comunità scientifica internazionale, la causa dominante del riscaldamento osservato fin dalla metà del XX secolo è
costituita da attività umane. Il riscaldamento è in marcia; esso è dovuto principalmente alla combustione dei combustibili fossili
e gli effetti negativi sono chiaramente più importanti degli effetti positivi; il rapporto GIEC chiarisce: “le emissioni di CO2
provenienti dalla combustione di combustibili fossili e dei processi industriali hanno contribuito per il 78% sul totale delle
emissioni di gas a effetto serra dal 1970 al 2010, con un contributo simile in percentuale dal 2000 al 2010”. Un grafico sul
contributo dei diversi gas tra il 1970 e il 2010 conferma che il problema essenziale è là: l’utilizzazione del carbone, del petrolio e
del gas naturale come fonte di energia (vedere qui di seguito, fonte IPCC):
Le principali fonti di gas a effetto serra generati dall'uomo sono:
- la combustione di carburanti fossili (carbone, petrolio e gas) nella produzione di energia, nel trasporto, nell'industria e nell'uso
domestico (CO2);
- l'agricoltura (CH4 e N2O) e le modifiche della destinazione dei suoli come la deforestazione (CO2);
- la messa a discarica dei rifiuti (CH4);
- l'utilizzo dei gas fluorurati di origine industriale.
Anidride carbonica
E' responsabile per oltre il 60% dell'aumento dell'effetto serra. Questo gas si trova naturalmente nell'atmosfera. La combustione
di carbone, petrolio, gas naturali sta rilasciando in atmosfera una grande quantità di questo gas. Anche la deforestazione libera il
carbonio fissato nelle piante. Ogni anno vengono rilasciate 7 miliardi di tonnellate di carbonio, quasi l'1% della massa totale di
anidride carbonica presente nell'atmosfera.
Metano
Contribuisce per il 15-20% al riscaldamento climatico. La produzione di gas naturale, l'approvvigionamento di combustibili fossili,
le attività agricole, in particolare l'allevamento e la produzione di riso, le discariche sono le principali fonti di emissione.
Clorofluorocarburi
Sono impiegati negli impianti frigoriferi, per la produzione di spray, di schiume e sostanze antincendio,sono responsabili per
circa il 7% all'aumento dell'effetto serra. Sono anche responsabili del cosiddetto "buco dell'ozono".
Protossido di azoto
E' associato all'uso di fertilizzanti, combustibili fossili e alla distruzione delle foreste. Contribuisce per circa il 6% all'effetto serra.
Ozono
L'ozono a bassa altitudine è creato dall'azione del sole sugli agenti inquinanti presenti nell'atmosfera, come le emissioni delle
industrie e dei veicoli a motore.. Contribuisce per circa il 7% all'effetto serra.
Altri inquinanti
Esafluoruro di zolfo (utilizzato come isolante dall'industria elettrica e emesso dalle fonderie di magnesio), idrofluorocarburi
(HCFC) eperfluorocarburi (PFC) impiegati come sostituti dei CFC.
I Paesi che inquinano di più
Come hanno scritto i ricercatori del World Resource Institute pochi Paesi sono responsabili della stragrande maggioranza delle
emissioni. I 10 Paesi che emettono più gas serra contribuiscono al 72% delle emissioni dell'intero pianeta. I 100 Paesi che ne
emettono meno sono responsabili del 3% delle emissioni.
I 10 Paesi che emettono più gas serra al mondo (World Resource Institute) sono: la Cina è il Paese che emette più gas serra, circa
il 25% delle emissioni totali, poi gli Stati Uniti e i 28 Paesi dell'Unione europea insieme. Sei Paesi a rapido sviluppo – India,
Indonesia, Brasile, Messico e Iran, sono tra i primi 10 responsabili di emissioni. Tuttavia se si guardano i dati pro capite lo
scenario cambia sostanzialmente: al primo posto si trova per esempio il Canada, seguito da Stati Uniti e Russia, Giappone e
Unione europea. La Cina è settima dietro all'Indonesia. E Messico e India, tra i maggiori produttori in termini assoluti, sono sotto
la media mondiale.
GLI EFFETTI Probabilmente è ancora possibile evitare che la temperatura media si elevi oltre i 2°C in rapporto al periodo
preindustriale, ma le misure prese nel corso degli ultimi 20 anni ci portano dritti verso un riscaldamento dai 3,7 ai 4,8 °C ( da 2,5
a 7,8 tenendo conto dell’incertezza climatica) che porterebbe a “rischi, da elevati a molto elevati, di impatti severi, largamente
diffusi e irreversibili”.
- innalzamento del livello dei mari.
INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEI MARI
Le conseguenze sociali dell’aumento del livello degli oceani di una tale ampiezza non possono sfuggire a nessuno. Basta
ricordare che 10 milioni di egiziani vivono ad un'altitudine inferiore al metro slm - così come 15 milioni di bengalesi, una
trentina di milioni di cinesi e indiani, venti milioni di vietnamiti… senza contare tutte le grandi città costruite nelle zone
costiere :Londra, New York, San Francisco…
Lo scioglimento della calotta antartica è una delle quattro cause di aumento del livello degli oceani; le altre tre sono: la
dilatazione termica delle masse di acqua, lo scioglimento dei ghiacciai de montagna e quello della calotta della
Groenlandia. Se la quantità di ghiaccio accumulato sulle terre sommerse dovesse sciogliersi totalmente, ne seguirebbe un
aumento del livello del mare di più di 90 metri.
Uno degli autori responsabili del capitolo "innalzamento del livello del mare" del rapporto GIEC, Anders Leverman, ha
tentato di unificare le proiezioni di aumento che i modelli imputano a queste quattro cause. La sua conclusione è
inquietante: a ogni grado centigrado di aumento della temperatura media della superficie rispetto alla fine del 18°secolo
corrisponderebbe un aumento del livello degli oceani di 1,3 metri, al punto d’equilibrio. La differenza di temperatura
rispetto al periodo di riferimento è attualmente di + 0,84°C. Se Levermann ha ragione, un aumento di 1,84 m al punto di
equilibrio è fin d’ora già inevitabile.
Fatih Birol, “capo economista” in seno all’Agenzia Internazionale dell’Energia ha ammesso recentemente che la tendenza
attuale in materia di emissioni di gas a effetto serra è perfettamente coerente con un riscaldamento di 6°C da qui alla fine
del secolo, potendo arrivare fino a 11°C.
Nell’ipotesi in cui le conclusioni di Leverman fossero esatte, noi staremmo per creare le condizioni di un aumento del
livello dei mari di 13,8 m o più. Questa è una delle ragioni per le quali nessun adattamento ad un riscaldamento di questa
ampiezza è possibile in un mondo di 9 miliardi di abitanti.
In queste proiezioni, l’espressione “al punto d’equilibrio” significa questo: il momento in cui un nuovo punto di equilibrio
sarà raggiunto tra la temperatura media di superficie e la quantità di ghiaccio presente sul globo; concretamente, questo
ritorno all’equilibrio energetico del sistema Terra dovrebbe compiersi tra i mille e i duemila anni circa.
Da mille a 2 mila anni, è un tempo lungo.
Ma il punto importante è che il processo, una volta avviato, non può essere fermato: a una concentrazione atmosferica X
di gas affetto serra corrisponderà inevitabilmente un aumento Y della temperatura, la quale porterà inevitabilmente una
dilatazione Z delle masse di acqua e la fusione di una quantità Z' di ghiaccio che, trasformato in acqua, ingrosserà i mari.
- la diminuzione della produzione agricola
- la distruzione dei suoli e la perdita delle terre arabili
- gli eventi meteorologici estremi
- le conseguenze sulla salute, aumento morbosità, epidemie
- l’acidificazione degli oceani
- il declino della biodiversità
- lo sconvolgimento dei cicli dell’azoto e del fosforo
- la distruzione dello strato di ozono stratosferico
- il degrado e il supersfruttamento delle riserve di acqua
- l’avvelenamento chimico della biosfera
Tutti questi fenomeni sono interconnessi: l’acidificazione degli oceani, per esempio, comporta concentrazioni atmosferiche
crescenti in biossido di carbonio, che nello stesso tempo è il principale gas a effetto serra. Il declino delle biodiversità è
ugualmente dovuto in parte al riscaldamento, ed e talmente rapido che alcune specie non riescono a salvarsi con la migrazione.
Soprattutto, tutti questi fenomeni hanno in comune che la loro rappresentazione grafica è data da curve simili, di tipo
esponenziale – con , in tutti i casi, un’accelerazione netta dopo i “ trenta gloriosi" (anni 50-60-70 del XX sec).
I Paesi che subiscono di più. Ogni nazione subirà un cambiamento più o meno profondo, la cui misura dipenderà dalle decisioni
assunte dai leader del mondo. Per misurare la capacità di reagire al cambiamento c’è il ND-GAIN Index, l’indice globale di
adattamento compilato dall’università di Notre Dame che valuta la vulnerabilità di un paese al cambiamento climatico e altre
sfide globali rapportandole alla capacità di migliorare la sua resilienza. Lo scopo è quello di aiutare le imprese e il settore
pubblico a rendere prioritari gli investimenti necessari per una risposta il più efficace possibile alle sfide globali.
I paesi più a rischio, a guardare la mappa che viene fuori, sono quelli più poveri. Il ND-GAIN Index parla chiaro: a rischiare di più è
il Ciad, seguito da Eritrea, Burundi, la Repubblica democratica del Congo, l’Africa Centrale Democratica, il Sudan, la Nigeria,
Haiti, Afghanistan, la Guinea Bissau.
Sono questi i dieci paesi dove il cambiamento climatico rischia di avere i suoi effetti più devastanti. In sostanza, le nazioni più in
pericolo sono le stesse che già soffrono per gravi siccità, mancanza di infrastrutture e instabilità politica ed energetica, mentre
all’altro versante troviamo i paesi che hanno le maggiori possibilità di sopravvivere: al primo posto c’è la Norvegia, seguita
da Nuova Zelanda, Svezia, Finlandia, Danimarca, Australia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Islanda.
L’Italia è trentesima nella classifica generale, 27sima per vulnerabilità, ovvero l’esposizione e l’abilità di adattarsi agli effetti
negativi del cambiamento climatico, considerando sei settori fondamentali per la vita: cibo, acqua, salute, ecosistema, habitat
umano e infrastrutture. Il trend è crescente rispetto all’anno precedente, ovvero il nostro paese è sempre più a rischio.
La situazione è prevedibilmente simile in Europa. Il primo decennio del nuovo secolo è stato il più caldo registrato nel
continente, con una temperatura della superficie terrestre più alta di 1,3° C rispetto alla temperatura media in epoca
preindustriale. Le ondate di caldo sono aumentate in termini di frequenza e lunghezza, causando decine di migliaia di morti,
mentre le precipitazioni stanno diminuendo nelle regioni meridionali, ma sono in aumento nell’Europa settentrionale. L’Ue si è
impegnata a ridurre entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% al di sotto dei livelli del 1990, aumentando
l’efficienza energetica del 20% e incrementando la quota di consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili del 20%.
LE PREVISIONI: il rapporto distingue 8 scenari, in funzione del livello al quale la concentrazione atmosferica in gas a effetto serra
sarebbe stabilizzata da qui alla fine del secolo. Per ciascuno di questi scenari, un quadro delle riduzioni di emissioni da realizzare
da qui al 2050 e da qui al 2100, cosi come la probabilità che l’aumento di temperatura rispetto al periodo preindustriale resti
sotto un certo livello (1,5°,2°,3°,4°C) nel corso di questo secolo. In ciascuno di questi scenari la riduzione delle emissioni di CO2,
che proviene dalla combustione dei combustibili fossili, occupa un posto centrale.
Lo scenario meno vincolante è quello nel quale le emissioni continuano ad aumentare più o meno al ritmo attuale. In questo
caso, la probabilità di superare 4°C di aumento è “maggiore della probabilità inversa” e la lista delle catastrofi sociali ed
ecologiche che ne deriva è lunghissima e tutt'altro che rassicurante. Trattandosi della salute umana, ad esempio, il rapporto
prevede che “la combinazione di alta temperatura e umidità in alcune regioni durante alcuni momenti dell’anno comprometterà
le attività umane normali compresi la coltura alimentare e il lavoro all’esterno”. La produttività agricola, la pesca saranno
colpite molto duramente. Il declino della biodiversità accelera.
All’altra estremità dei possibili scenari, un numero molto ridotto di studi considera una stabilizzazione della concentrazione
atmosferica a 430 ppm di CO2. Per raggiungere tale obiettivo, trovandoci già a questo livello di emissioni, lo sforzo da realizzare
sarebbe estremamente vincolante e anche colossale: nel 2050 le emissioni mondiali dovrebbero avere un ribasso dal 70 al 95%
(rispetto al livello del 2010; almeno il 95 % nei paesi industriali); nel 2100, esse dovrebbero diminuire dal 110 a 120%. Il riassunto
dei decisori non dice più niente.
Questo scenario implica un riorientamento rivoluzionario in tutti i domini della vita sociale. È , pertanto, il solo che darebbe una
chance per non superare 1,5°C di riscaldamento, un obiettivo che numerosi scienziati (compreso il presidente del GIEC!)
considerano come necessario: restare sotto 1,5 °C di aumento non è concepibile eventualmente che nel quadro di una
stabilizzazione a 450 ppm, ma le chance sono minime (è “più improbabile che probabile”).
Questi scenari lasciano un (debole) margine per aumentare ancora un pò la quantità di gas a effetto serra diffuso nell’atmosfera
(dunque per bruciare ancora per un certo tempo una certa quantità di combustibili fossili). Neanche estremamente vincolanti.
Nel caso di una stabilizzazione a 450 ppm, ad esempio, le emissioni mondiali dovrebbero diminuire dal 42 al 57% da qui al 2050
e dal 78 al 118% da qui al 2100 (rispetto al 2010). Da adesso fino al 2050, la parte dell’energia “zero carbone” o a debole
intensità di carbone dovrebbe aumentare del 90% a livello mondiale (i vincoli sono analoghi per gli altri due scenari). Sapendo
che il 78% delle emissioni sono dovuti alla CO2 proveniente dalla combustione di combustibili fossili e che questa combustione è
la fonte dell’80% dell’energia utilizzata dall’umanità, si capisce la grandezza della difficoltà.
LE RISPOSTE NECESSARIE Certamente c’è una dimensione tecnica di questa difficoltà, ma vi sono soprattutto dimensioni sociali
e politiche. Il rapporto insiste sulla giusta ripartizione degli sforzi tra paesi (in funzione delle responsabilità storiche), sulla
ripartizione delle tecnologie, sulla necessità di una collaborazione internazionale, sull’importanza di combinare lotta contro il
riscaldamento e lotta contro la povertà, sugli imperativi etici di questa combinazione e la posta in gioco per l’avvenire del genere
umano. Questi sono i punti cruciali e sono tutti punti in contrasto alla logica del neoliberismo: mai un rapporto del GIEC aveva
deliberato un tale messaggio con tanta forza.
Nello stesso tempo è sulla difficoltà di ordine sociale e politico che il riassunto dei decisori è molto poco eloquente, quando
invece essa ha un peso decisivo; a una certo punto si legge: “la politica di attenuazione potrebbe svalutare gli attivi in energia
fossile e ridurre i redditi degli esportatori di combustibili fossili (..). la maggior parte degli scenari di attenuazione implicano dei
redditi diminuiti per i principali esportatori di carbone e di petrolio”.
In altri termini si dice che per non superare 2°C di riscaldamento, l’80% delle riserve conosciute di combustibile fossile dovrebbe
restare sotto terra e mai essere sfruttate; è opportuno sottolineare che queste riserve fanno già parte degli attivi di bilancio
delle compagnie petrolifere e dei principali Paesi produttori, oltre a determinare la quotazione in borsa delle stesse
multinazionali; non sfruttarle significherebbe la distruzione pura e semplice della maggior parte del capitale legato all’energia
fossile e di una quota del PIL mondiale pari a circa 1/5!!!.
Si capisce come mai di fronte a queste conclusioni siano stati attivati gruppi di “clima negazionisti” per prendere tempo e per
spostare la discussione su soluzioni possibili nel campo dell’attenuazione compatibile con i profitti dei padroni del carbone, del
petrolio e del gas naturale.
LE FINTE SOLUZIONI (PERICOLOSE) La cattura e il sequestro geologico del carbone (CCS) occupano nel V rapporto GIEC un posto
strategico; il rapporto dice che per restare sotto i 2°C di aumento la crescita economica globale si ridurrà di appena lo 0,06% per
anno; ma il rapporto dice anche che questa riduzione è calcolata nell’ipotesi di un dispiegamento massiccio della catturasequestro del carbone. Secondo il rapporto, da qui al 2030, la transizione energetica necessiterebbe di investimenti per
parecchie centinaia di miliardi di dollari ogni anno, a livello mondiale.
La maggioranza dei ricercatori che sviluppano modelli di attenuazione non considera questa possibilità. L’accumulazione fa parte
del paesaggio, cioè della legge della natura. Per questo, oltre la CCS, la maggior parte di loro introduce nelle loro strategie
l’estensione del nucleare e la combustione massiccia di biomasse. Sono per così dire i palliativi dell’accumulazione. Il riassunto
dei decisori menziona alcuni rischi di queste tecnologie, tra cui chiaramente la competizione con la produzione alimentare, nel
caso delle biomasse, ma il GIEC non fa che plagiare gli studi esistenti dimostrandosi dunque tributario degli interessi dominanti.
Soluzioni finanziarie. La conferenza sul clima COP21 a Parigi rivedrà gli accordi in scadenza del Protocollo di Kyoto. Se
l'orientamento rimane, come sembra dagli accordi preliminari, lo stesso di Kyoto ci troveremo di fronte a finte soluzioni che non
risolveranno il problema alla radice, bensì riprodurranno strumenti atti a sfruttare la situazione di emergenza per garantire le
logiche di accumulazione di capitale. Ricordiamo quali sono gli strumenti messi in atto dal Protocollo di Kyoto del 1997 (i
cosiddetti “meccanismi flessibili”):
- l’implementazione congiunta (Joint Implementation- JI): consente ai Paesi industrializzati e a quelli in transizione di stipulare
accordi per gestire in comune gli obblighi di riduzione. Ciò significa che l’Italia, o un altro stato europeo, può realizzare quote di
riduzioni in Paesi est-europei tramite accordi di cooperazione tecnologica che riducano le emissioni sul loro territorio.
- il fondo per lo sviluppo pulito (Clean Development Mechanism - Cdm): promuove accordi di cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo per il trasferimento di tecnologie pulite a basso impatto ambientale.
- il commercio di permessi (Emission Trading) secondo cui è possibile per un Paese (o un’impresa) acquistare o vendere quote
di anidride carbonica (“permessi di emissione”) da un altro Paese. Chi è in ritardo con i propri impegni può, cioè, accordarsi con
chi ha margini di emissione per “mettersi in pari”.
- REDD misure di contenimento delle emissioni di gas-serra legate alla deforestazione e alla degradazione forestale globali (nel
gergo Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation).
Queste sono false soluzioni di un’economia verde che cerca di mercificare ulteriormente la vita e la natura in vista di ulteriori
profitti. Il "capitale riverniciato di verde” ha prodotto di fatto la finanziarizzazione del clima e delle risorse ad esso legato
creando un prezzo e un mercato alla natura attraverso gli strumenti tipici della finanza (bolle speculative alimentate da grandi
iniezioni di capitale pubblico: vedi incentivi alle rinnovabili, ai biocombustibili, ai crediti di emissione, che hanno inondato il
mercato favorendo non l’obiettivo principale, la riduzione di gas climalteranti, ma lo scambio globale di azioni e bonus).
Soluzioni tecnologiche. Altrettanto fuorvianti e pericolose risultano le nuove soluzioni tecnologiche come la "geo-engineering,
gli organismi transgenici, gli agrocarburanti, la bioenergia industriale, la biologia sintetica, le nanotecnologie, il fracking, i
progetti nucleari, la produzione di energie con la termovalorizzazione” e tutti quei progetti che necessitano di megainfrastrutture “che non portano benefici alla popolazione e sono produttori netti di gas climalteranti” (come le mega dighe, solo
per fare l’esempio più clamoroso).
A tal proposito il testo di Daniel Tanuro “l’impossibile capitalismo verde - Il riscaldamento climatico e le ragioni dell'ecosocialismo”, oltre a molti altri articoli dello stesso autore (ingegnere agronomo belga), risulta illuminante.
LA GEOINGEGNERIA.
viene anche menzionata nei rapporti del Gruppo Intergovernativo degli Esperti sui Cambiamenti Climatici (GIECC): la
sintesi del primo tomo del 5° rapporto evidenzia che “sono stati proposti metodi che hanno l'obiettivo di alterare
deliberatamente il clima terrestre in modo tale da arrestare il cambiamento climatico. Si tratta della cosiddetta
geoingegneria”. Gli autori segnalano che questi metodi “potrebbero avere effetti collaterali e conseguenze a lungo
termine su scala mondiale”. A prima vista, la prudenza usata nel rapporto è ragionevole. Ma, nonostante questa, il fatto
che la geoingegneria venga citata dal GIECC è estremamente inquietante. Ciò significa che alcune ricette da apprendisti
stregoni iniziano ad essere considerate concretizzabili nel futuro.
La XX conferenza sul clima svoltasi a Lima nel 2014 ha tracciato il solco delle decisioni che verranno ratificate a Parigi; le linee
guida confermano le preoccupazioni in quanto ogni paese potrà determinare i propri impegni in materia di clima, senza che
questi ultimi tengano conto di ciò che chiedono la scienza, le popolazioni e le esigenze di giustizia, e senza quadro
regolamentare chiaro. Dirigenti politici, in particolare quelli degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e dei loro alleati, agiscono
nell’interesse delle grandi imprese inquinanti, determinati a deregolamentare innanzitutto il regime di governance
internazionale del cambiamento climatico. Così facendo minano la convenzione sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite
nelle sue fondamenta, indebolendo le regole necessarie dei paesi sviluppati e ignorando il loro obbligo legale e morale di
sbloccare i finanziamenti sufficienti e di trasferire le tecnologie.
A Lima l’espansione dell’utilizzazione dei mercati di carbone, che hanno di fatto fallito, è stata largamente incoraggiata. Gli
accordi preliminari prevedono anche l’utilizzazione di crediti di carbone derivati dalle foreste e dai suoli, fonte di devastazione
supplementare per le popolazioni contadine e forestali nel mondo, che impedisce le trasformazioni di cui abbiamo bisogno.
Sono stati completamente ignorati i bisogni delle popolazioni coinvolte nel mondo, escludendo ogni impegno vincolante in
materia di contributo finanziario, di adattamento, di perdita e danni e di trasferimento di tecnologia. La Conferenza di Lima non
ha saputo stabilire un ponte tra le azioni che i paesi devono prendere e le tecnologie e i finanziamenti necessari per permettere
alle popolazioni del Sud di adattarsi, di costruire la loro resilienza e di far fronte alla perdita e ai danni causati dagli impatti del
cambiamento climatico.
Altri accordi tra i grandi inquinatori precedono COP21: Stati Uniti e Cina, responsabili del 45% delle emissioni di CO2 mondiali,
hanno trovato una "storica" intesa per la riduzione di gas serra a margine del vertice Apec, svoltosi a Pechino nel 2014. L'intesa
tra il presidente cinese, Xi Jinping, e il presidente Usa Barack Obama porterà a una riduzione delle emissioni del 25-28% (rispetto
al 2005) entro il 2030. Come parte dell'intesa, Obama ha annunciato che gli Usa si sono impegnati per una riduzione del 26-28%
delle emissioni entro il 2025, mentre Pechino si impegna a diminuire il picco delle emissioni entro il 2030, se non prima. Per
raggiungere l'obiettivo Xi ha annunciato che le cosiddette fonti energetiche pulite, come l'energia solare e eolica, potrebbe
rappresentare il 20 per cento della produzione totale cinese entro il 2030. Nello stesso tempo però l’accordo contiene il
riferimento all’energia nucleare, al gas di scisto (utilizzato soprattutto negli USA) e alle “tecnologie carbonifere avanzate”, in altri
termini la cattura-sequestro geologica della CO2: le due grandi potenze carbonifere vogliono in realtà continuare a bruciare gli
enormi stocks di carbone, ma stoccando sottoterra la CO2 prodotta dalla combustione.
LA SOLUZIONE NON È MERAMENTE TECNOLOGICA.
Prima del Vertice di Copenaghen sul clima del 2009, due scienziati statunitensi hanno pubblicato su Scientific American un
articolo nel quale affermano che l’economia mondiale potrà abbandonare i combustibili fossili tra 20 o 30 anni. Per fare
questo, “basterebbe” produrre 3,8 milioni di aerogeneratori da 5 megawatt, costruire 89000 centrali solari fotovoltaiche e
termodinamiche, installare sui tetti degli edifici pannelli fotovoltaici e disporre di 900 centrali idroelettrich. La
contraddizione di questo tipo di proiezioni è che pretendono di affrontare e risolvere il problema della transizione
energetica, ma in realtà lo eludono. La questione, in effetti, non è immaginare in astratto un sistema energetico “100%
rinnovabili” (che evidentemente è possibile), ma quello di tracciare il cammino concreto per passare dal sistema attuale
basato per più del 80% nelle energie fossili ad un sistema basato esclusivamente sul vento, il sole, etc…Due sono però gli
imperativi da tenere in conto. In primo luogo che le emissioni globali si devono ridurre tra il 50 e l’85% da qui al 2050 (dal
80 al 95% nei paesi sviluppati) e, in secondo luogo, che questa riduzione dovrebbe cominciare al più tardi nel 2015.
Affinché il piano di transizione non sia mera finzione, gli autori dell’articolo su Scientific American avrebbero dovuto
rispondere alla seguente domanda: calcolando che il sistema energetico dipende per l’80% dai combustibili fossili la cui
combustione comporta inevitabilmente l’emissione di diossido di carbonio e di altri gas dall’effetto serra, come produrre
3,8 milioni di aerogeneratori, come costruire 89000 centrali solari, come fabbricare pannelli fotovoltaici da installare sui
tetti di tutti gli edifici e come costruire 900 dighe senza contraddire i due imperativi citati sopra?
Questa domanda non ha tante risposte possibili, ma una sola: è chiaro che l’aumento delle emissioni che deriverebbero
dagli investimenti supplementari richiesti per portare a termine la transizione energetica dovrebbe essere compensata da
una riduzione supplementare delle emissioni prodotte da altri settori dell’economia. Una parte sostanziale nel
raggiungere tale obiettivo la giocano sicuramente le misure di efficienza energetica. Questo, però, non permette di
ovviare al problema, visto che nella maggioranza dei casi un aumento dell’efficienza richiede comunque investimenti e
quindi necessita di energia che è fossile per l’80% del totale e dunque questo combanali ebbe un ulteriore aumento delle
emissioni che dovranno essere compensate a loro volta da altre riduzioni. E così via…
Quando si esaminano le proiezioni dei sistemi “100% rinnovabili”, si riscontra facilmente che è molto diffuso il grossolano
errore di ovviare il problema concreto. Per migliorare l’efficienza del sistema energetico, il rapporto Energy Revolution di
Greenpeace, per esempio, prevede, tra le altre cose, di trasformare 300 milioni di abitazioni in case passive nei paesi
dell’OCSE. Gli autori calcolano la riduzione di emissioni corrispondente, ma non tengono minimamente in conto l’aumento
di emissioni che sarebbe causato dalla produzione dei materiali isolanti, finestre a doppio vetro, pannelli solari, etc. In
altre parole, la percentuale di riduzione delle emissioni è lorda, non netta. Da qualsiasi parte si guardi il problema, si
giunge sempre alla stessa conclusione: per rispettare gli imperativi della stabilizzazione del clima, gli enormi investimenti
necessari per la transizione energetica dovranno provenire da una riduzione della domanda finale di energia, soprattutto
all'inizio ed in particolar modo nei paesi più ricchi. Quali riduzioni? Le Nazioni Unite dicono il 50% in Europa e il 75% negli
Stati Uniti. È una percentuale enorme ed è questa che da fastidio, visto che una diminuzione di questo tipo non sembra
realizzabile senza ridurre sensibilmente e per un periodo prolungato la produzione e il trasporto delle merci...significa
quindi che occorre una certa decrescita (in termini materiali, non di punti del PIL).
Non si può negare che questa decrescita materiale contrasti con l'accumulazione capitalista che, nonostante si misuri in
termini di valore, è difficilmente concepibile senza un certo incremento quantitativo di beni trasformati e trasportati. La
“dissociazione” tra l'aumento del PIL e il flusso di beni, in effetti, può solo essere relativa e ciò significa che in questo
punto si manifesta di nuovo l'incompatibilità fondamentale tra il produttivismo capitalista e i limiti del pianeta. Ed è
proprio questa incompatibilità ogni giorno più evidente il punto di partenza per ricercare soluzioni reali al problema.
analisi di Daniel Tanuro
LE SOLUZIONI NECESSARIE Abbiamo visto che la maggiore responsabilità del cambiamento climatico è attribuibile alla
combustione di combustibili di origine fossile; tuttavia, il ruolo dei combustibili fossili non è che un aspetto di una questione più
vasta: è la logica dell’accumulazione che è in gioco. La crescita infinita in un mondo finito, non è possibile. Per ridurre
drasticamente le emissioni da qui al 2050, sapendo che queste emissioni provengono prima di tutto dalla conversione
energetica, occorre per forza ridurre il consumo finale di energia, occorre farlo nella misura in cui ciò rimette in discussione il
“sempre più”. Sia chiaro: occorre ridurre la produzione materiale e i trasporti.
E’ possibile senza nuocere al benessere (aumentandolo, al contrario) se si sopprimono le produzioni inutili e nocive,
l’obsolescenza programmata, i trasporti inutili e inefficienti, ecc; è possibile senza pregiudicare il lavoro, (favorendolo, al
contrario) se si ridistribuisce il lavoro, la ricchezza, i saperi e le tecnologie. Ma ciascuna di queste ipotesi conduce
invariabilmente alla stessa conclusione: occorre superare l’attuale sistema di produzione.
Non parliamo quindi della proposta di decrescita felice, che anzi contiene aspetti pericolosi in quanto si concentra su una critica
quantitativa al consumismo e non al sistema produzione che lo determina. La decrescita prefigurata da Latouche (principale
teorico del movimento) implica un “altro” capitalismo, verde, dispotico, basato sulla programmazione autoritaria di consumi,
rifiuti, nascite, con una concezione patriarcale e punitiva. Non distingue tra chi deve ridurre e chi no; ricchi e poveri, potenti e
oppressi sono sullo stesso piano. La natura umana è identificata in assoluto con il sistema capitalistico e pertanto la soluzione
riguarda il mutamento della natura umana e del suo comportamento; risulta quindi una critica asettica alla crescita e allo
sviluppo umano e non al sistema di produzione come determinazione storica: l’elemento di conversione si basa su un
catastrofismo pedagogico centrato sulla conversione individuale e non sulla trasformazione collettiva della società.
La soluzione necessaria deve invece prevedere la costruzione di un fronte sociale ampio, condiviso, collettivo e non
individualista, che a partire dal grido d’allarme del GIEC possa lavorare a favore di un’alternativa che sia eco-sociale.
Non è una “lotta ecologica” nel senso di una sorta di lotta di lusso per quelle e quelli che non hanno troppi problemi sociali. È
una lotta per salvare le condizioni di esistenza su questo pianeta delle comunità umane ed extra-umane che lo abitano.
La costruzione di un fronte sociale largo deve prevedere un percorso articolato basato su:
- costruire consapevolezza: spiegare la gravità della situazione e delle sue cause in tutte le occasioni e gli ambiti sia quelli
direttamente aggancibili per affinità di tematiche sia quelli apparentemente distanti; è necessario un enorme lavoro di
educazione permanente, al quale dobbiamo partecipare attivamente.
- costruire conflittualità contro le grandi opere di investimento al servizio dell’industria fossile: nuovi aereoporti, nuovi gasdotti,
nuove autostrade, nuove trivellazioni, nuove miniere, la nuova e follia del gas di scisto, le opere di geoingegneria che sognano di
dotare la Terra di un termostato.. di cui loro avrebbero il controllo (a tal proposito Naomi Klein parla di necessaria contestazione
o “Blokadia” contro questo blocco strategico per la sopravvivenza del sistema: il livello attuale di sviluppo infrastrutturale
permette al capitale di continuare a bruciare le masse di combustibili fossili che ci mettono sulla strada di un riscaldamento di
6°C da qui al 2100).
- sostenere tutte le iniziative collettive, sociali e democratiche che rafforzano e fanno crescere i concetti di riappropriazione, di
solidarietà, di autogestione conflittuale per la costruzione di un’alternativa basata su relazioni eco-sociali altre rispetto a quelle
esistenti, a partire dalle esperienze concrete (dalle più semplici reti di acquisto GAS, alle forme più avanzate e sperimentali come
Spazio Fuori Mercato) all'interno di un percorso-progetto generale di trasformazione della società.
Questo percorso per essere credibile ed efficace verso la stabilizzazione del clima, deve porsi i seguenti obiettivi:
- l'espropriazione senza indennizzo delle aziende energetiche e della finanza. Trasformare l'energia ed il credito in beni comuni
è la condizione necessaria per elaborare un piano democratico finalizzato a produrre meno ed in base ai veri bisogni sociali, in
maniera decentralizzata e più condivisa;
- un piano intensivo di investimenti del settore pubblico nell'isolamento degli edifici e nell’efficienza energetica prima che in
fonti alternative sostenibili;
- la fine del primato del sistema di trasporto basato sulle automobili;
- la lotta contro l'obsolescenza programmata dei prodotti;
- la quantificazione e la restituzione del debito ecologico accumulato dai Paesi e dalle grandi aziende inquinatrici nei confronti
dei Paesi che hanno subito e subiscono maggiormente gli effetti del cambiamento climatico (o debito di carbonio), il saccheggio
di risorse (o passivi ambientali), lo status di discarica dei rifiuti dei paesi industrializzati, la biopirateria (o appropriazione
intellettuale delle conoscenze tradizionali legate alle sementi e all'utilizzo delle piante medicinali da parte dei laboratori dei
paesi industrializzati e dell'industria agro-alimentare moderna);
- la cancellazione di tutti i brevetti in ambito energetico e dei diritti di proprietà sulle sementi e sugli alimenti;
- la fine del ricatto lavoro a qualsiasi condizione o salute attraverso campagne contro le produzioni nocive e per il reddito di
cittadinanza incondizionato;
- la fine del ricatto lavoro a qualsiasi condizione o nessun diritto attraverso campagne per il diritto di cittadinanza e di libera
circolazione incondizionato;
- la fine del lavoro di riproduzione non pagato o di produzione sottopagato attraverso il sostegno alle campagne di
emancipazione e autodeterminazione delle donne e dei migranti;
- la localizzazione/territorializzazione della produzione e la sostituzione dell'agroindustria globalizzata con un agricoltura
contadina o agro-ecologia basata sul concetto di sovranità alimentare (vedi approfondimento successivo).
CAMBIAMENTO CLIMATICO E SISTEMA AGRICOLO
IL SISTEMA AGRICOLO COME CAUSA Si conosce poco il fatto che anche l'agricoltura contribuisce ai cambiamenti climatici ed è
responsabile del 14% delle emissioni mondiali di gas serra. Queste emissioni sono dovute principalmente a due gas, meno
conosciuti rispetto alla CO2:
- il metano, emesso dai ruminanti, ma anche da certe tecniche usate in risicoltura;
- il protossido d'azoto, legato all'uso di fertilizzanti azotati.
A queste emissioni, potremmo poi aggiungere quelle legate alla deforestazione, dal momento che spesso è motivata dalla
conversione di foreste in terreni agricoli. La deforestazione è all'origine del 20% delle emissioni mondiali di gas serra.
Agricoltura e deforestazione sono quindi responsabili di un terzo delle emissioni globali di gas serra.
Dal 1990 al 2013 le concentrazioni di metano e protossido di azoto hanno registrato percentuali di incremento rispettivamente
del 253% e del 121%. Il 40% di metano proviene da sorgenti naturali come le zone umide, il 60% da attività umane, come gli
allevamenti intensivi, le centrali fossili, le discariche e la combustione di biomassa.
LA FILIERA DELLA CARNE BOVINA
La filiera della carne bovina è quella con il più alto impatto ambientale. A confermarlo arriva un recente studio condotto
da un gruppo di ricercatori americani, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Gli
studiosi hanno esaminato le principali fonti di proteine per gli statunitensi, calcolando le risorse naturali ed energetiche
necessarie per ognuna. Dall’analisi è risultato che la produzione di carni bovine ha un’impronta ambientale fino a 10 volte
più alta rispetto a quella delle altre carni, delle uova e dei latticini.
Nello specifico, i bovini allevati per la produzione di carne richiedono fino a 28 volte più spazio e fino a 11 volte più acqua
rispetto alle mucche da latte, ai polli o ai maiali. Anche rispetto alle colture più comuni, i bovini necessitano di maggiori
risorse. Secondo i calcoli effettuati dai ricercatori statunitensi i bovini da carne richiedono fino a 160 volte più terra delle
patate, del riso e del grano.
Benché l’alto impatto sull’ambiente degli allevamenti bovini fosse noto da tempo, questo studio secondo gli autori è
importante perché non si fonda su generalizzazioni, bensì sui dati reali ed obiettivi forniti dal Dipartimento dell’Agricoltura
degli Stati Uniti. I ricercatori, coordinati dal professor Gidon Eshel del Bard College, hanno comparato l’impronta
ambientale e idrica di tutti i foraggi necessari al bestiame, dal fieno alla soia, la quantità di emissioni generata nel corso
dei processi digestivi, il consumo di suolo.
In particolare sono stati calcolati i quantitativi necessari ai diversi animali da allevamento per aumentare di un chilo. Dalla
somma di tutte le risorse consumate dalla nascita dell’animale alla tavola, si è ottenuta la produzione totale di emissioni di
gas serra di ogni razza. I bovini consumano molto ma hanno un basso tasso di conversione energetica, come illustra il
professor Eshel: solo una minima parte del cibo consumato dal bestiame finisce nel sangue. La maggior parte dell’energia
va persa. Gli scienziati hanno concluso che oltre il 60% dell’impatto ambientale degli allevamenti negli Stati Uniti è
imputabile ai bovini. Ne consegue che ridurre il consumo di carne bovina certamente avrebbe effetti più che positivi sulla
mitigazione del riscaldamento globale
Il sistema agricolo dominante basato sul modello dell’agricoltura industriale, come descritto nella parte iniziale del testo,
controlla estensioni agricole per miliardi di ettari che vengono trattati con pesticidi e altri composti derivati del petrolio. Gran
parte di questa terra non viene coltivata per l’alimentazione umana ma fondamentalmente per produrre mais e soia per il
bestiame domestico allevato in batteria, i cui derivati sono alla base della dieta ad alto input di materia ed energia del mondo
occidentale. Tale situazione viene spesso contrabbandata come un miracolo delle tecnologie avanzate impiegate nell’agricoltura
moderna, con l’alibi che queste sarebbero in grado di garantire un altissimo output di prodotto utile a sfamare l’intera
popolazione mondiale a prezzi accessibili. Va tuttavia osservato che questo sistema è caratterizzato da:
uso intensivo dei combustibili fossili;
problemi relativi allo smaltimento dei liquami
sovrasfruttamento delle risorse idriche e dei suoli
utilizzo intensivo di pesticidi e fertilizzanti
la riduzione della qualità nutrizionale e organolettica degli alimenti prodotti con metodi intensivi e transgenici
la continua erosione della biodiversità naturale e agricola
la fragilità intrinseca delle monocolture (epidemie)
In tal senso l’agricoltura industriale o agro-business si dimostra insostenibile. Il suo obiettivo è stato ed è unicamente quello di
arrivare ad un monopolio del mercato dei prodotti alimentari al costo di distruggere i sistemi agricoli tradizionali e le dinamiche
funzionali dell’ambiente.
AGRO-BUSINESS e OGM
«Controllate il petrolio e controllerete le nazioni. Controllate il cibo e controllerete i popoli» ex Segretario di Stato
americano Henry Kissinger
La storia dell’ingegneria genetica e dei brevetti sulle piante e sugli altri organismi viventi non può essere compresa senza
avere studiato la storia dell’evoluzione del potere in America nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale. George
Kennan, Henry Luce, Averell Harriman e, soprattutto, i quattro fratelli Rockefeller hanno creato il settore multinazionale
dell’agribusiness e hanno finanziato la “rivoluzione verde” nel campo agricolo dei Paesi in via di sviluppo, allo scopo, tra le
altre cose, di creare nuovi mercati per i loro prodotti petrolchimici – come i fertilizzanti – oltre che di imporre la
dipendenza dalle loro fonti energetiche. Le loro gesta sono inscindibili dalla storia attuale degli organismi geneticamente
modificati.
Fin dai primi anni del nuovo secolo, è apparso chiaro che solamente le quattro maggiori compagnie multinazionali
petrolchimiche avrebbero potuto recitare il ruolo di dominatrici nel settore dei brevetti dei prodotti alimentari di base –
grano, soia, riso, frumento, verdura, frutta e cotone – dai quali la maggior parte della popolazione mondiale dipende per
gli approvvigionamenti quotidiani di cibo, oltre che in quelli della creazione di nuovi ceppi di pollame geneticamente
modificato, resistente alle malattie – come l’“influenza aviaria”, causata dal virus mortale H5N1 – e di altre razze
geneticamente modificate di maiali e di bovini. Tre di queste quattro compagnie hanno relazioni decennali con l’istituto
del Pentagono che si occupa di ricerche nel settore delle armi chimiche; la quarta, ufficialmente svizzera, è in realtà
controllata da società anglo-americane; quindi, come per il petrolio, anche per gli OGM si deve parlare di un progetto di
dominio globale anglo-americano.
Nel maggio del 2003, prima di bombardare Baghdad, il Presidente degli Stati Uniti aveva deciso di far diventare quello
degli OGM un settore strategico, una priorità nella politica estera del Paese. L’Unione Europea, secondo produttore
agricolo mondiale, costituisce una barriera, seppur non omogenea, contro il progetto di espansione globale degli OGM:
dall’inizio del 2006, l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) ha cominciato a fare pressioni sull’Unione Europea,
affinché apra le porte a una massiccia proliferazione di OGM, tanto che il progetto della loro espansione sembra vicino al
raggiungimento del successo finale (vedi TTIP).
Il primo esperimento di massa di semi OGM del grano è stato effettuato agli inizi degli anni ’90, in un Paese la cui élite di
potere era già stata corrotta da tempo dalla famiglia Rockefeller e dalle sue banche di New York: l’Argentina.
da Agro-business. I Semi della Distruzione di F. William Engdahl
LE CONSEGUENZE SULL'AGRICOLTURA: Quali sono le conseguenze più evidenti del riscaldamento globale sull'agricoltura; dal
secondo capitolo del Quinto Rapporto IPCC si deducono:
- ondate di calore, siccità e desertificazione;
- salinizzazione delle terre;
- variazioni imprevedibili delle precipitazioni;
- riduzione delle riserve d'acqua in certi luoghi, inondazioni in altre regioni;
- sviluppo di parassiti e malattie.
Più nel dettaglio:
- Desertificazione (produttività). Coltivazioni e pascoli coprono attualmente circa il 30% degli 850 milioni di ettari in cui si
estende la regione mediterranea. L'attività agricola occupa oggi il 40% del terreno arabile, ma le terre destinate alla produzione
alimentare sono sempre più minacciate dalla mancanza di un'efficiente distribuzione idrica e dalla salinizzazione (l'aumento di
salinità nel terreno, collegato a scorrette pratiche di irrigazione).
La desertificazione avanza, e il suolo diviene inadatto ad ospitare la vita. A questo si aggiunga l'urbanizzazione, che "mangia"
terreno agricolo restituendo cemento: in Italia vengono bruciati così 500 chilometri quadrati di suolo coltivabile all'anno.
- Distribuzione delle risorse idriche (sicurezza alimentare). Ad esempio nel mediterraneo le già scarse disponibilità d'acqua sono
distribuite in modo disomogeneo nel territorio mediterraneo e concentrate per lo più nei paesi della sponda nord (Francia,
Spagna, Italia, Grecia). A sud, l'80% dell'acqua si trova in Egitto ed è utilizzata a scopo agricolo. Questa disparità geografica
provoca grossi problemi di dipendenza economica: i Paesi della sponda sud (quelli della costa africana) sono costretti a
importare alcuni prodotti, soprattutto i cereali nobili (grano, mais, frumento, riso) dai paesi della sponda nord, con conseguenti
problemi politici: un rincaro dei cereali può minare le già fragili economie di queste aree del mondo.
- Perdita della biodiversità. Eventi climatici "estremi" - come alluvioni e siccità - e la necessità di cambiare habitat (salendo di
quota per trovare un clima più fresco) rendono le colture più vulnerabili a parassiti e funghi: in Italia, per esempio, il mais
coltivato in alcune aree del Veneto durante le estati molto secche viene attaccato dalle aflatossine, naturali sostanze
cancerogene derivanti da un fungo (l'Aspergillus flavus) che attacca i raccolti. E le colture contaminate divengono inutilizzabili.
LA RIDUZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
Per quanto riguarda la riduzione della biodiversità, i dati del monitoraggio biologico (fonte IUCN) ci dicono che negli ultimi
100 anni, per un congruo numero di specie di vertebrati, invertebrati e piante, si è avuto un incremento del rischio di
estinzione dovuto a cause antropiche. Attualmente, il 12% delle specie di uccelli e il 25% delle specie di mammiferi del
mondo risultano “minacciati”, soprattutto per l’impatto ecologico dell’agricoltura. Le stime disponibili, inoltre, fanno
ipotizzare che, in assenza di un’adeguata strategia di intervento, i ritmi futuri di estinzione delle specie cresceranno di 10
volte rispetto ai ritmi attuali: tutti i dati convergono nell’indicare che siamo entrati nella sesta estinzione biologica di
massa. Va precisato che le morie di cui stiamo parlando non si verificano soltanto per un incremento della mortalità delle
popolazioni biologiche, ma anche per la preoccupante riduzione della loro natalità. Molti animali, per esempio, si
riproducono di meno per una serie di ragioni, e tra queste vi è il fortissimo impatto di un gruppo di molecole di sintesi
denominate “distruttori endocrini” che da molto tempo interessano i medici epidemiologi e gli zoologi perché
responsabili, sia nell’uomo, sia negli animali, di una serie di effetti patologici, incluso il cancro. Tali molecole minano gli
ormoni sessuali e alterano la normale funzione del sistema endocrino all’interno dell’organismo. L’effetto più importante
è una riduzione della fertilità dei maschi di molte specie di vertebrati, dagli storioni agli alligatori, fino ai felini e agli esseri
umani. Il problema, tuttavia, oggi viene anche dal rilascio in campo aperto di piante geneticamente modificate. La
letteratura scientifica ha documentato, attraverso studi di campo e di laboratorio, una serie di casi di rischi ecologici e
biologici associati alle colture ingegnerizzate. Per esempio, un’importante indagine comparativa, basata su test di
laboratorio effettuati su roditori, ha evidenziato che per tre mais ingegnerizzati (NK-603, MON-810 e MON-863) esistono
rischi biologici significativi dovuti ad alterazioni rilevate a livello dei reni, del fegato, del cuore, del surrene, della milza e
degli organi ematopoietici. Tuttavia, quello che oggi possiamo e dobbiamo dire con tutta onestà è, in fondo, ancora più
preoccupante. Nessuno studioso del mondo, infatti, ha la minima idea della portata degli effetti che le piante
geneticamente modificate potranno sortire su scala ecosistemica globale. La biotecnologia sta diventando una sorta di
totem alchemico, basato sul mito del controllo e del dominio dei sistemi biologici: un controllo e un dominio decisamente
infondati, dal momento che trascurano completamente la conoscenza dei loro effetti collaterali.
- Valore nutrizionale. I cambiamenti climatici starebbero influendo anche sul valore nutrizionale di cereali e foraggi. Le piante
assorbono dal suolo sali minerali preziosi per la sintesi di sostanze nutritive - come l'amido nel caso dei cereali. Un terreno
impoverito offrirà, a parità di raccolto, alimenti meno nutrienti per uomo e animali: le varietà di pianta tipiche di un territorio
sono gradualmente abbandonate, se non ritenute in grado di resistere al clima che cambia.
- Problemi socio-economici. A questi problemi si aggiungano la corsa all'accaparramento di grandi estensioni di terra coltivabile,
soprattutto in Africa, ad opera di grandi multinazionali straniere (land grabbing), e le migrazioni di milioni di persone alla ricerca
di sicurezza, stabilità e migliori condizioni di vita. Dal 2008 al 2014 sono state 157 milioni le persone costrette a lasciare le loro
case, principalmente dopo che tempeste e alluvioni le avevano spazzate via.
I dati raccolti dall’Internal Displacement Monitorino Centre (IDMC) si leggono nel rapporto “Migrazioni e cambiamento
climatico”, realizzato da CeSPI (Centro Studi Politica Internazionale), FOCSIV (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio
Internazionale Volontario) e WWF Italia, che analizza aspetti del global warming finora poco considerati, ma nondimeno
importanti in vista della vicina COP21 di Parigi.
Secondo l’IDMC l’85% delle cause di queste migrazioni sono proprio tempeste e alluvioni. In tutto è stato calcolato un aumento
della probabilità di doversi spostare, del 60% rispetto al 1975. Da cosa scappa però questa enorme massa di persone? Dal
cambiamento della frequenza e dell’intensità delle precipitazioni, causato da un aumento delle temperature dell’aria e della
superficie dei mari; dall’innalzamento del livello dei mari.
La guerra civile in Siria
Le cause politiche, storiche e culturali del conflitto ovviamente sono molte, ma secondo un recente studio della Columbia
University, pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences tra gli elementi scatenanti ve ne sarebbe
anche uno forse meno diretto, e proprio per questo più insidioso: la straordinaria ondata di siccità che ha colpito il paese
tra il 2006 e il 2010, provocato dal riscaldamento globale. Spiega Richard Seager, climatologo della Columbia e coautore
dello studio: “Quello che pensiamo è che, insieme a tutti gli altri fattori scatenanti, abbia aiutato a spingere gli eventi oltre
la soglia di non ritorno, fino a scatenare il conflitto. Un’ondata di siccità così grave inoltre è di certo stata resa possibile, o
quanto meno molto più probabile, dall’inaridimento della regione provocato dall’attività umana”.
Molte ricerche in effetti hanno evidenziato già in passato che gli eventi climatici estremi, come picchi di temperature e
siccità, possono aumentare il rischio che si verifichino episodi di violenza, sia intesi come atti isolati, che come vere e
proprie guerre. È per questo che in molti nella comunità scientifica temono che una delle conseguenze peggiori del
riscaldamento globale possa essere un’escalation di conflitti militari nelle regioni politicamente più instabili.
L'AGRICOLTURA COME SOLUZIONE Riportiamo di seguito l’opinione di Miguel Altieri, docente a Berkeley (università della
California) e considerato uno degli esponenti più autorevoli dell’agroecologia: la branca di studi che cerca di unire le esigenze
della produzione agricola con una maggiore tutela dell’ambiente: “Il modello della Green revolution, che avrebbe dovuto nutrire
il pianeta con tecnologia e OGM, non funziona. Oggi sarebbe già possibile sfamare tutti gli abitanti della terra, ma preferiamo
sprecare il cibo. Non si tratta quindi solo di tecniche, il problema è nel modello: il capitalismo può davvero risolvere il problema
della fame nel mondo?”.
Continua evidenziando dati importanti: “Oggi dal 50 al 75% del cibo, a seconda delle stime, è prodotto da contadini in piccoli
appezzamenti. Che però hanno a disposizione meno del 30% del terreno arabile mondiale, il 30% dell’acqua e il 20% dei
combustibili fossili, mentre il resto va alle grandi monocolture industriali. Cosa succederebbe se dessimo ai contadini il 50% dei
terreni agricoli?”.
Le piccole proprietà, se ben coltivate, hanno secondo Altieri una resa per metro quadro superiore a quella delle grandi
piantagioni: il segreto sta nell’utilizzo delle tecniche tradizionali, come la rotazione delle coltivazioni e lo sfruttamento delle
sinergie: “Una risaia tradizionale in Cina non produce solo cereali, ma anche pesce. I pesci poi si nutrono dei parassiti,
permettendo di non usare pesticidi. In questo modello l’uomo plasma un vero e proprio nuovo sistema ecologico, in cui non c’è
solo una specie edibile. Così basta un solo acro nell’area mediterranea (poco più di 4.046 metri quadri, meno della metà di un
ettaro) a nutrire una famiglia di cinque persone”.
“Eppure – continua Altieri – oggi il 90% delle facoltà di agraria non insegna l’agroecologia, e la stessa università in cui insegno da
quasi 35 anni dedica pochissimi fondi alle nostre ricerche”.
In America Latina e altrove i campesinos hanno incrementato la loro presenza culturale, sociale e politica a livello territoriale e si
sono organizzati nella rete mondiale de La Via Campesina ed altre forti organizzazioni, poiché hanno compreso che lo
smantellamento del complesso agroalimentare industriale, unito al ripristino dei sistemi alimentari locali, deve andare di pari
passo con la realizzazione di alternative agroecologiche valide.
I movimenti contadini hanno abbracciato l’agroecologia attraverso reti tra agricoltori che promuovono innovazioni e idee
agroecologiche per una serie di ragioni:
a) l’agroecologia è socialmente attivante, poiché la sua diffusione richiede una partecipazione costante da parte degli agricoltori
ed un sistema orizzontale di diffusione della conoscenza;
b) si tratta di un approccio basato su conoscenze tradizionali e promuove un dialogo di saperi con approcci scientifici più
occidentali (i sistemi agroecologici sono profondamente radicati nella razionalità ecologica dell’agricoltura tradizionale su piccola
scala);
c) promuove tecniche economicamente sostenibili, dando risalto all’uso di conoscenze indigene, agrobiodiversità e risorse locali,
e progettando sistemi chiusi che in tal modo non dipendono da input esterni;
d) l’agroecologia è solida dal punto di vista ecologico, in quanto non tenta di modificare i sistemi di produzione esistenti, ma
piuttosto cerca di ottimizzarne le prestazioni promuovendo diversificazione, sinergia ed efficienza.
L’espansione dell’agroecologia nel Sud del mondo ha avviato un interessante processo di innovazione cognitiva, tecnologica e
socio-politica, intimamente legato a nuovi scenari politici quali la nascita di governi progressisti e movimenti di resistenza
promossi da contadini e popolazioni indigene.
Anche in questo caso è importante l'aspetto relativo al nuovo paradigma scientifico e tecnologico agroecologico, ma da solo, è
bene sottolinearlo, non è sufficiente se non viene sviluppato mediante il sostegno e la spinta costante da parte di movimenti
sociali e processi politici.
Oggi ci sono territori sotto il controllo di organizzazioni contadine che praticano una sovranità alimentare basata
sull’agroecologia, governi che hanno definito politiche di promozione diretta dell’agroecologia, movimenti di consumatori che
sostengono gli agricoltori locali mediante meccanismi di mercato innovativi e solidali, servizi governativi di ricerca e assistenza
tecnica che prevedono l’agroecologia nei loro programmi, nonché organizzazioni scientifiche (ad esempio in America Latina) le
quali, lavorando a stretto contatto con le organizzazioni contadine, hanno messo il progresso scientifico agroecologico al servizio
dei movimenti rurali e della società nel suo complesso.
Questi processi devono però essere accompagnati da quelle grandi riforme, riguardanti politiche di indirizzo, istituzioni e agende
di sviluppo, in grado di assicurare che le alternative agroecologiche vengano adottate su vasta scala, siano accessibili in maniera
equa ed ampia, e si moltiplichino, cosicché il beneficio in termini di sovranità alimentare sostenibile si realizzi appieno.
Va anche riconosciuto che uno dei principali ostacoli alla diffusione dell’agro-ecologia è dovuto al fatto che potenti interessi
economici e istituzionali hanno sostenuto e sostengono scelte, soluzioni, attività di ricerca e sviluppo finalizzati all’approccio
agroindustriale convenzionale (vedi anche i nuovi accordi di libero commercio tra UE e USA: TTIP), influenzando, in numerose
occasioni, i programmi di ricerca di università pubbliche e centri di ricerca governativi, mentre ricerca e sviluppo finalizzati
all’agroecologia sono stati e continuano ad essere ignorati o addirittura ostracizzati in gran parte delle nazioni.
TTIP
Altro esempio delle azioni intraprese per perpetrare i meccanismi di accumulazione responsabili della crisi ecologica è
riconducibile ai nuovi accordi di libero scambio commerciale, in particolare l’accordo di Libero Scambio USA-UE (TTIP).
Frutto di trattative per lo più secretate risulta evidente l’interesse verso questo accordo da parte dell’agribusiness, che si
registra come la lobby più attiva nel condizionarne il profilo.
Le multinazionali alimentari, agro-commercianti e produttori di sementi avrebbero infatti avuto più contatti con l'ufficio
commerciale della Commissione rispetto ai lobbisti dell’industria farmaceutica e chimica, dell’industria finanziaria e
dell’auto messe insieme.
Dei 560 incontri con le lobby che DG Trade ha organizzato in preparazione dei negoziati, 520, cioè il 92%, hanno visto la
presenza dei lobbisti del mondo degli affari e delle industrie, mentre solo 26, cioè il 4%, si sono rivolti a gruppi di interesse
pubblico. Dunque per ogni incontro con un associazione di consumatori, ne sono stati organizzati altri 20 con aziende e
federazioni delle industrie.
Altre attività di lobby molto attive durante i negoziati hanno riguardato il settore IT, le telecomunicazioni, l’industria
automobilistica e l’ingegneria. Nel complesso i dati disponibili suggeriscono che l’impostazione del TTIP è stata
determinata in gran parte da aziende con sede negli Stati Uniti, in Germania e nel Regno Unito e da grandi organizzazioni
dei datori di lavoro europei, come BusinessEurope.
Avrebbe avuto particolare rilevanza anche il ruolo di Deutsche Bank e di TheCity (Regno Unito). Mentre le aziende della
Grecia e di gran parte dell’Europa Orientale risultavano del tutto assenti dai retroscena relativi al TTIP. Ciò suggerisce che,
secondo Corporate Europe,le imprese dei Paesi più poveri dell’UE avranno ben poco da guadagnare da questo accordo
commerciale.
L’agroecologia è una pratica ad elevata intensità di conoscenza, e quindi il suo sviluppo richiede investimenti in ricerca ed
istruzione, uniti alla diffusione di risultati e know-how mediante reti tra agricoltori. Dare priorità all’agroecologia come modello
di sviluppo rurale ridurrebbe anche la dipendenza da input agricoli industriali molto costosi, quali fitofarmaci e fertilizzanti di
sintesi, ma anche sementi geneticamente modificate (OGM).
Sono in atto cambiamenti nuovi ed inaspettati, mirati a ripristinare l’autosufficienza locale, conservare e rigenerare la risorsa
naturale agrobiodiversità, produrre alimenti sani per tutti con bassi livelli di input e legittimare le organizzazioni contadine. Detti
cambiamenti mettono direttamente in discussione le politiche di modernizzazione neoliberiste basate su agribusiness ed
esportazioni agricole, aprendo nel contempo nuovi percorsi politici per consentire alle società rurali di raggiungere la sovranità
alimentare e il diritto al cibo per tutti. Dopo un percorso lungo e tortuoso, l’agroecologia quale scienza, prassi e movimento è
stata finalmente riconosciuta da molti come approccio fondamentale per realizzare una nuova agricoltura del futuro:
un’agricoltura libera dalla dipendenza dal petrolio, amica della natura, resiliente ai cambiamenti climatici, socialmente giusta e
diversificata anche dal punto di vista eco-sociale.
Il modello dell'agroecologia basato sul concetto di sovranità (o autodeterminazione) alimentare oltre a rispondere a
immediati bisogni sociali delle popolazioni basati sull'autosostentamento e sul consapevole utilizzo delle risorse naturali a
disposizione, rappresenta una risposta concreta ed efficace al cambiamento climatico sia nella direzione della riduzione delle
emissioni climalteranti (attenuazione) prodotte dal settore agricolo sia nella direzione delle risposte necessarie a contenere
gli effetti negativi del riscaldamento globale (adattamento) su persone e natura.
BIBLIOGRAFIA E ALTRE FONTI
RISCALDAMENTO CLIMATICO: IL GRIDO DI ALLARME DEL GIEC di DANIEL TANURO
LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA: MISURE ANTICAPITALISTE O ALTERNATIVE “DIABOLICHE”. NON
ESISTONO ALTRE OPZIONI di DANIEL TANURO
COP 21, VERTICE DELLA MENZOGNA, DELL’AFFARE E DEL CRIMINE CLIMATICO di DANIEL TANURO
RAPPORTO SULL'ANDAMENTO DEI PREZZI DELLE COMMODITIES AGRICOLE (1972 – 2011) di CIA
LA CRISI ALIMENTARE DEL 2008 di VALERIA SODANO
“L’IMPOSSIBILE CAPITALISMO VERDE - IL RISCALDAMENTO CLIMATICO E LE RAGIONI DELL'ECO-SOCIALISMO”
di DANIEL TANURO
ECOLOGIA-MONDO E CRISI DEL CAPITALISMO. LA FINE DELLA NATURA A BUON MERCATO di JASON W.
MOORE
I PADRONI DEL CIBO di RAJ PATEL
(a cura d Simone Febbo, Tavolo sul Cambiamento climatico di Genuino Clandestino, 30-31 ott. 2015)