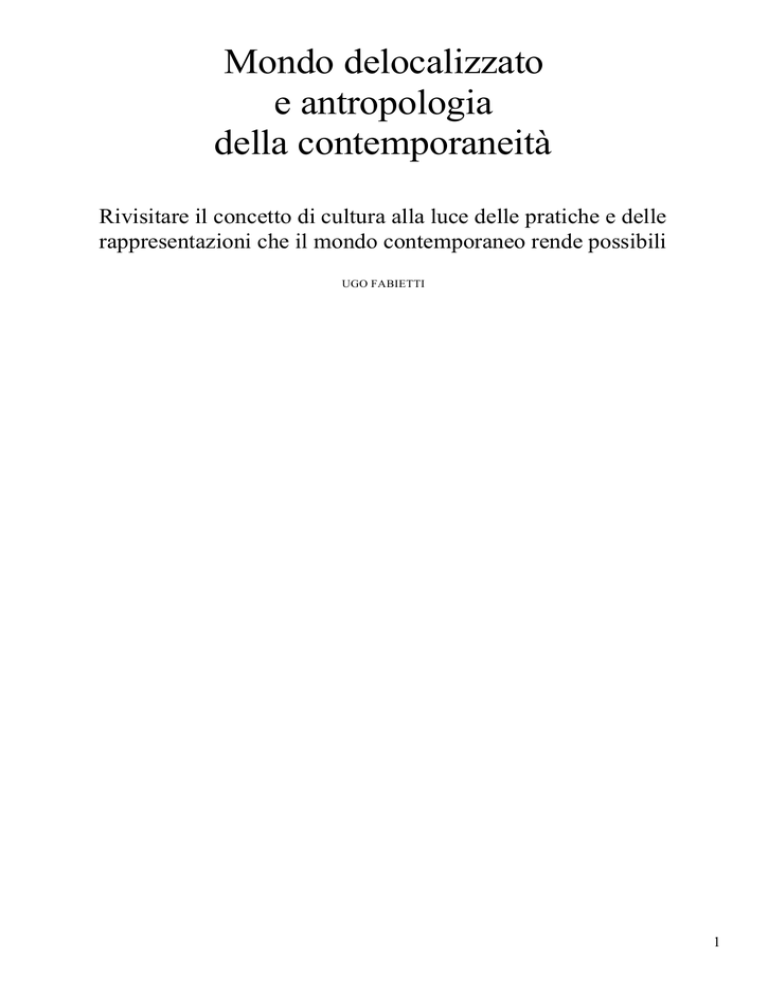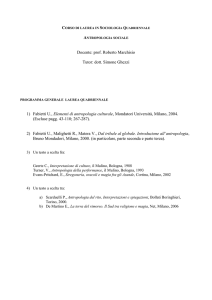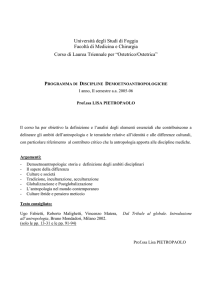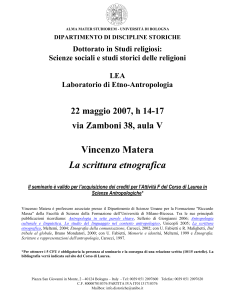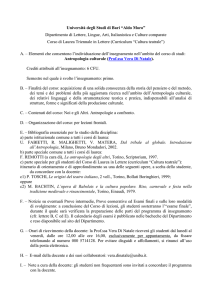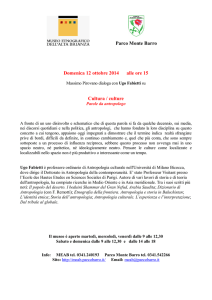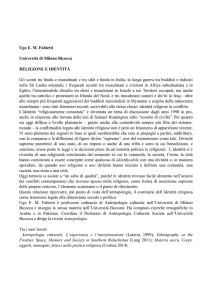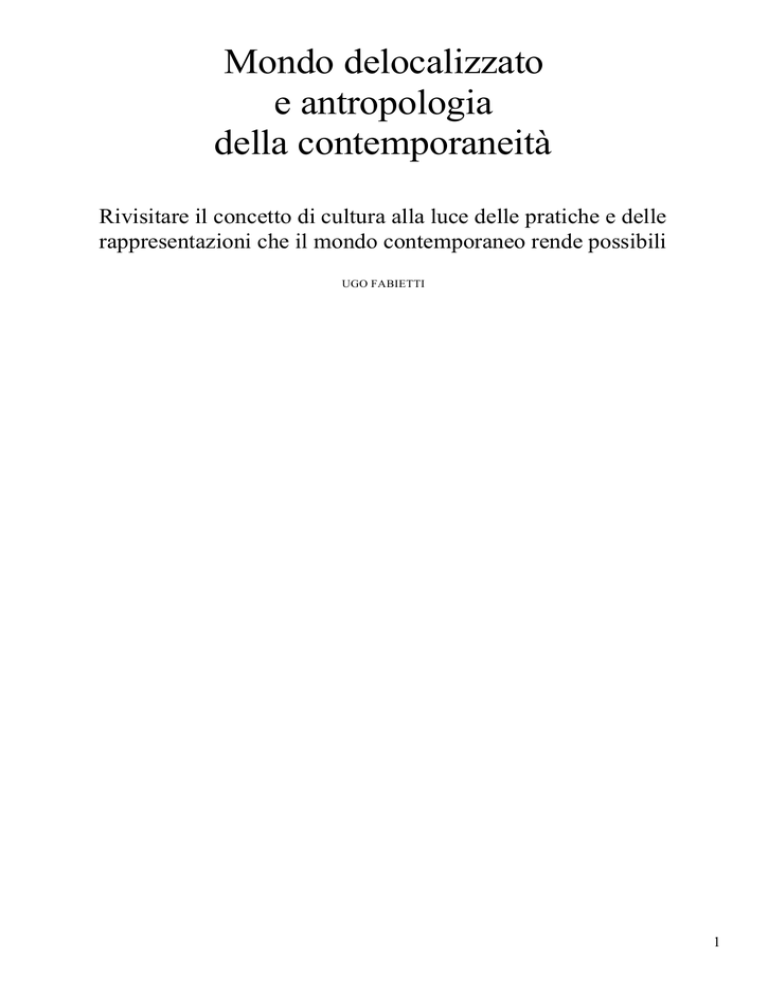
Mondo delocalizzato
e antropologia
della contemporaneità
Rivisitare il concetto di cultura alla luce delle pratiche e delle
rappresentazioni che il mondo contemporaneo rende possibili
UGO FABIETTI
1
Nel mondo attuale sembrano convivere due fenomeni dai risvolti drammatici, per certi aspetti opposti e,
tuttavia, complementari. Il primo è la delocalizzazione di un numero sempre maggiore di esseri umani
rispetto al loro territorio d'origine; il secondo è l'emergere di rappresentazioni legate al "territorio", al
"radicamento", alla "cultura". Effetto di una coercizione, come anche di una
libera
scelta,
la
delocalizzazione degli individui rispetto al territorio d'origine porta con se la "deterritorializzazione della
cultura", la fine potenziale di una situazione in cui, certo con qualche esagerazione, si poteva dire fino a non
molto tempo fa che l'equazione cultura-territorio-identità era il fatto saliente dell'esistenza di comunità reali.
Che la delocalizzazione degli individui e la rappresentazione enfatizzata del territorio d'origine costituiscano
fenomeni complementari è intuitivamente comprensibile. Come comprensibile è anche il fatto che tali
fenomeni si rivestano di drammaticità, quando la delocalizzazione diventa sradicamento coatto o scelta
obbligata e quando la nostalgia della “terra lontana” si trasforma nell'idea ossessiva della "patria perduta",
da riconquistarsi a qualsiasi prezzo e in qualunque modo. Non sta agli studiosi di scienze umane correggere
o prevenire direttamente gli esiti potenzialmente negativi di fenomeni come questi. Ma cercare di
comprenderli sì. E comprenderli significa necessariamente ripensare le categorie e i concetti che noi usiamo
quando li rappresentiamo.
Quale idea di cultura per l'antropologia?
Allo stato attuale pare esistere una divaricazione tra il linguaggio di un'antropologia che sta uscendo da un,'
lungo periodo di revisione teorico concettuale da un lato e, dall'altro, il linguaggio del senso comune, della
politica e dei media, che continua a parlare di "cultura" e di "culture" nello stesso modo in cui l'antropologia
ne parlava un tempo.
Riconsiderare i concetti dell'antropologia significa riportare l'attenzione su un nodo che riteniamo
«culturalmente» importante per il rapporto tra un sapere e il suo pubblico, visto che l'antropologia è stata,
dopotutto, la principale responsabile della divulgazione del modo in cui si parla oggi comunemente di
“cultura”.
Quello di “cultura” non è certo un concetto che non sia stato già ampiamente rivisitato e sottoposto a critica
da più parti, sino a dare la sensazione che esso sia ormai poco più che un ricordo del passato antropologico
[Wagner, 1981, tr. it. 1992].
Nei primi anni settanta Clifford Geertz scrisse che si trattava di un concetto ormai destituito di ogni efficacia
euristica e James Clifford [1988, tr. it. 1993] sostenne, qualche anno dopo, che per le sue aporie, lo scarso
potere referenziale e a causa dei falsi problemi teorici da esso posti, il concetto di cultura è un predicament,
una specie di "imbroglio" che tuttavia non è facile sbrogliare e del quale non ci si può sbarazzare tanto
facilmente.
L'immagine della cultura come predicament, come un "imbroglio", è del resto valutabile alla luce di queste
semplici e tutto sommato banali domande: "se una cultura è qualcosa di localizzato e di distinto da altre,
dove 'cominciai e dove 'finisce' una cultura?"; "se una cultura è descrivibile nelle sue componenti, posso
descriverla nella sua totalità?». In presenza degli attuali processi di delocalizzazione culturale possiamo
utilizzare ancora un concetto come quello di cultura? Se sì, a quali condizioni? Insomma: qual è il destino
della cultura in questo ''traffico'' di culture?
Forse è partendo da una breve "archeologia" del concetto e della sua utilizzazione che potremo valutare il
problema e rendere le cose un po' meno oscure. La tradizione antropologica, nonostante le plurime
definizioni dell'idea di cultura (Kluckhohon e Kroeber [1952, tr. it. 19721 ne contarono più di duecento nel
1952), è rimasta a lungo particolarmente affezionata a quella che ne diede Tylor nel 1871: "La cultura, o
civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell'insieme complesso che include la conoscenza, le
credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo
come membro di una società" [Tylor, 1871, tr. it. 19701.
2
Questa definizione, che chiameremo classica, costituisce un consistente punto di riferimento per tutti coloro
che, siano essi antropologi oppure no, pensano in termini "culturali»: la "cultura» è qualcosa di composito,
di complesso, che comprende fatti di ordine tanto materiale quanto spirituale, tanto di ordine pratico quanto
di ordine simbolico e che può essere descritto nei suoi contenuti. Sappiamo quindi già di che cosa stiamo
parlando quando diciamo cultura, e anche di come ne possiamo parlare. Questa familiarità non è il frutto
della frequentazione di un classico come Tylor, ma affonda, in un certo modo, nella nostra stessa storia
culturale, nell'idea di cultura come prodotto di una tradizione tipicamente euroccidentale. Se guardiamo
all'origine e se osserviamo gli ambiti di utilizzazione del concetto, scopriremo che tale origine e tale
utilizzazione si collocano in discorsi che implicano l'esistenza di relazioni di tipo egemonico, sia tuale che
politico, tra individui, gruppi e, appunto, "culture".
Dalla fine del diciottesimo secolo il termine "cultura" cominciò a essere usato in modo diverso rispetto a
come era stato impiegato sino ad allora. Alla cultura intesa in senso ciceroniano come cultura animi,
sinonimo cioè di crescita e di affinamento interiori, subentro un'accezione "collettiva" del termine.
Quest'ultimo cominciò, infatti, a designare qualcosa che non aveva più a che fare esclusivamente con
l'individuo, ma con popoli e nazioni. Ma due furono i modi in cui l'uso collettivo del termine si articolo:
quello particolarista e quello universalista.
Nonostante si trovino tracce di un uso "collettivo" del termine cultura già in Voltaire (Remotti, 19921),
furono i filosofi e i linguisti tedeschi del diciottesimo secolo a svilupparne l'utilizzazione e a connotarlo sul
piano semantico. Nella Germania della seconda metà del settecento, il termine Kultur aveva due significati.
Kant lo utilizzò ad esempio in senso universalista parlando della Francia come di un paese che, grazie ai
"lumi", era fonte di ispirazione culturale per l'intera umanità (modo universalista). Poco prima di lui Herder
ne aveva dato, invece, una flessione particolaristica, attribuendogli un significato più vicino all'uso che se ne
fa attualmente e che sconfina in un concetto con valenze etniche. Herder sosteneva infatti che i popoli
avessero ciascuno una specifica Kultur, e questo modo di vedere fu seguito da quei linguisti che, come von
Humboldt, ritenevano la lingua (Sprache) depositaria dello "spirito" (Geist) di un popolo (Volk). Il "punto di
vista tedesco" sulla cultura fu recepito dall'antropologia agli albori e da Tylor il quale, formulando la sua
definizione, si ispiro in parte alla visione universalista e, in parte, 8 quella particolarista, entrambe in
opposizione all'idea individualistica di cultura.
Sarebbe tuttavia sbagliato ritenere che tra la "cultura" intesa in senso ciceroniuno, "individualistico", e la
"cultura" degli antropologi, concepita come entità collettiva (tanto nell'accezione universalista quanto in
quella particolarista) non vi siano punti di contatto e di continuità. I concetti, anche quando sono utilizzati in
un nuovo contesto, quindi con un significato nuovo, tendono, infatti, a "portare con se" (mascherandolo) il
significato che i termini rivestivano nel contesto precedente. Questo non è un problema di semantica, ma di
modalità di "rappresentazione del mondo". È infatti importante sottolineare come nel classico concetto
antropologico di cultura, che costituisce comunque anche oggi un punto di riferimento "familiare" dei nostri
ragionamenti, siano presenti i significati peculiari di crescita e di cumulatività già presenti nell'accezione
individualistica del termine e siano tuttora "attivi", quando per esempio diciamo di qualcuno che è una
persona “colta”.
La crescita "culturale" di una persona è qui concepita tanto come una crescita interiore perseguibile
attraverso un processo autorillessivo, interiore, quanto, soprattutto, mediante l'acquisizione di nozioni, di
idee e di saperi ottenibili grazie a un'applicazione che comporta volontà, ponderatezza e intenzionalità Si
diventa colti, cioè persone dotate di cultura, cumulando esperienze suscettibili di produrre determinate
conoscenze in campo letterario, artistico e scientifico che possono essere in qualche modo utilizzate, esibite,
o che consentano di produrne di nuove. Più conoscenze accumuliamo, più saremo''colti'',"lavorati",
"plasmati", "costruiti".
Naturalmente accanto a quest'idea di cultura come mole di conoscenze manteniamo anche quella secondo la
quale la cultura di un indivùluo consiste nella Capacità di organizzare i rapporti tra le conoscenze stesse, di
utilizzare cioè queste ultime come una struttura dinamica e llessibUe per la comprensione e per il controllo
della realtà circostante.
3
Spostando l'uso del termine cultura da un contesto individuale a uno collettivo, I'antropologia ha, dunque,
mantenuto gli aspetti rappresentazionali posseduti da tale termine nel contesto precedente, specialmente
quelli relativi alle idee di cumulatività e di crescita. L'idea della cultura come qualcosa che è sottoposto a
processi di.crescita e di cumulatività è stata in questo modo mantenuta, anche se in riferimento all'umanità in
generale (accezione universalista) e al singolo popolo o nazione (accezione particolarista).
Il salto rappresentato dal passaggio dall'uso individualistico del concetto di cultura a quello collettivo fu,
quindi, grande e importante, ma portò irrimediabilmente con se le idee di crescita e di cumulatività
nell'accezione precedente del termine. La cultura umana, come quella di un singolo popolo o di una singola
comunità, appariva così come un patrimonio ottenuto cumulativamente e ulteriormente incrementabile. Che
effetti ebbe tutto ciò sul lavoro degli antropologi?
Tra reificazione e culturalismo
Dobbiamo per prima cosa ricordarci che fu una congiuntura della storia della società europea a far sì che il
concetto di cultura, usato in senso collettivo (universalista e particolarista), potesse essere assunto come idea
centrale nello studio dei popoli della terra. Fu, infatti, la crescita della società europea, e britannica in
particolare, a indurre gli intellettuali illuministi, liberali e riformisti della fine del diciottesimo secolo e della
prima metà del diciannovesimo a individuare, nell'andamento cumulativo della produzione generato dagli
sviluppi della rivoluzione industriale, il parametro interpretativo della "crescita culturale" di tutta l'umanità
(Burrows, 1966, Fabietti, 1998). Il fatto di considerare la civiltà industriale europea come il punto più
avanzato di un processo generale di evoluzione e di sviluppo comporto un'estensione del concetto di cultura
all'intero genere umano: ora si poteva, infatti, parlare di "cultura umana" ma, al tempo stesso, e dato che
l'etnografia forniva prove sempre più numerose dell'esistenza di popoli in possesso di forme di civiltà
considerate "inferiori" a quella europea, il concetto di cultura divenne applicabile anche a queste ultime,
poiché tali forme erano considerate come rappresentative di stadi "precedenti" dello sviluppo complessivo
della cultura umana.
Nonostante prevalesse in seguito l'utilizzazione in senso particolarista del concetto di cultura, anche nel
novecento l'idea di una cultura umana intesa come somma di tutte le acquisizioni in campo tecnologico e
intellettuale continuo a influenzare il discorso "implicito" delI'antropologia, che era poi quello della società
di cui essa era espressione. Per molti aspetti tale discorso non si distingueva da quello dell'antropologia del
secolo precedente perché portava con se l'assunto più o meno implicito che i popoli "altri" fossero "lontani"
nel tempo. Il fatto di poterli ricondurre a stadi differenti di sviluppo culturale creò, infatti, una
rappresentazione degli "altri", di tutti gli altri, come collocati a una distanza temporale, variabile a seconda
dello stadio di sviluppo raggiunto, dalla società e dalla"cultura" occidentali.
La crescita istituzionale dell'etnografia, lo studio di singoli gruppi localizzati e la prospettiva olistica, la
quale faceva delle comunità etnografiche entità àltamente integrate e coerenti sul piano interno, furono tutti
fattori che accentuarono decisamente questa accezione particolarista nell'uso del termine. Johannes Fabian
ha dimostrato come la temporalizzazione dell"'altro" da parte dell'antropologia, e quindi della società
europea (in realtà il suo "allontanamento nel tempo" dal soggetto occidentale) abbia consentito, anche dopo
il tramonto del paradigma evoluzionista, di perpetuare l'immagine degli "altri" come distanti da «noi" in
quanto "diversi" per il "grado" della loro "evoluzione" [Fabian, 1983, tr. it. 2000].
Se con il termine cultura si vuole indicare un'entità circoscritta, localizzata e descrivibile nei suoi
componenti è evidente che oggi tale concetto è, come si direbbe, "in crisi". L'insoddisfazione degli
antropologi derivante da un uso referenziale del concetto di cultura, cioè di un concetto con pretese di
esaustività e referenzialità sul piano descrittivo, è stata sottolineata in vari modi oltre a quelli di cui si è detto
all'inizio. Per esempio tramite l'idea di una"esagerazione della cultura", come l'ha chiamata James Boon
[1982]. Questa~esagerazione" di cui parla Boon, che ni antropologia ha costituito il prodotto di uno sforzo
mirante a costruire oggetti di riflessione che siano in qualche modo comparabili tanto tra loro quanto con
l'esperienza culturale dell'osservatore, può essere messa in relazione con la reificazione e con il
4
culturalismo. Sono, questi, due esiti di tale esagerazione, diversi tra loro ma che affondano entrambi le loro
radici nelle stesse dinamiche di "estremizzazione" implicite in tutte le "culture".
Il processo di reificazione delle culture può essere interno o esterno. Quello "esterno» coincide con una
esagerazione della cultura come quella che risulta da una descrizione etnografica. Quello "interno» consiste
invece nell'assegnazione, da parte di chi condivide certi codici e significati, di una natura extraculturale a
questi ultimi, ossia di entità sottratte al flusso comunicativo basato sulla negoziazione, sulla convenzione e
sull'accordo intorno a quei significati stessi, per i quali vengono ipostatizzati, eternizzati, e, quindi, sottratti
ai flussi negoziali che contrassegnano lo stesso mutamento culturale: la cultura viene cioè destoricizzata.
La reificazione "interna" di una cultura, quella operata cioè dai suoi stessi componenti, può essere posta in
relazione con il culturalismo, ossia con la tendenza a enfatizzare la dimensione culturale come elemento di
distinzione in campo ideologico, nonché etnico.
In questo caso la dimensione "culturale» viene particolarmente enfatizzata, o allo scopo di
autovalorizzazione, oppure al fine di ribadire le proprie differenze in rapporto a coloro dai quali ci si vuole
distinguere. Quasi sempre un atteggiamento "culturalista" si presenta unito a una qualche forma di etnicismo
e quindi di rivendicazione di "autenticità" (Fabietti, 1998b), cioè di unicità fondata sulla differenza. Come
però succede nel caso delle "lotte interetniche", la differenza è esasperata fino al punto che un solo aspetto
della "cultura" può diventare l'elemento su cui costruire una teoria della "differenza totale» tra etnie. Il
discorso culturalista cerca insomma di costruire una teoria della autenticità e quindi, al tempo stesso, della
differenza. In un mondo, tuttavia, dove il fattore del movimento e il "traffico delle culture» sembrano
prevalere sulla coincidenza di cultura, territorio e identità, possiamo ancora continuare a utilizzare il
concetto di cultura come se questo rinviasse a entità circoscritte nello spazio e nel tempo? Credo ci si trovi
oggi in una situazione davvero paradossale. Mentre gli antropologi hanno abbandonato l'idea che un simile
concetto possa indicarg qualcosa di scomponibile nei suoi elementi che, in quanto tali, possono essere
sottoposti a descrizione e classificazione, i "culturalisti», cioè tutti Coloro che producono discorsi
sull'autenticità variamente intesa (etnica, nazionale, e naturalmente "culturale»), continuano a parlare in
termini di cultura e di culture nello stesso modo in cui avrebbero potuto parlarne gli antropologi fino a
qualche decennio fa. Questa ripresa della "cultura» in chiave "culturalista" e naturalmente funzionale, ancora
una volta, a un discorso politico, che può assumere le sfumature dell'etnicismo in alcuni casi, del relativismo
esasperato in altri e dell'esercizio di un potere "culturale» egemonico in altri ancora. Tuttavia, se il concetto
di cultura può ancora implicare un'idea di differenza, per gli antropologi tale differenza non è più
concettualizzabile come una volta in forma tassonomica (cultura X, cultura Y, società X, etnia y ecc.) bensì,
dato il crescente processo di delocalizzazione e di globalizzazione, in termini di "interazioni» e di
"rifrazioni" intersoggettive e interculturali. Così Ulf Hannerz ha scritto che le culture dovrebbero essere
considerate come delle "strutture di significato che viaggiano su reti di comunicazione sociale non
interamente situate in alcun singolo territorio" (1992, tr. it. 1998). E Arjun Appadurai ha definito "panorama
etnico» "il panorama di persone che costituiscono il mondo mutevole in cui viviamo: turisti, immigrati,
profughi, esiliati, lavoratori stagionali e altri gruppi e persone in movimento... dato che molte persone e
gruppi hanno a che fare con la realtà di doversi muovere 0 con la fantasia di doversi muovere» [Appadurai,
1992, tr. it. 1996].
Le culture non sono più assegnabili a regioni, spazi, territori rigidamente definiti. Benché la dimensione
dello spostamento e del viaggio siano ancora fenomeni tutto sommato limitati, le migrazioni, gli esodi e le
diaspore sono processi sempre più rilevanti del mondo contemporaneo. Tali fenomeni non determinano
l'estinzione delle culture, ma la loro modificazione, il loro adattamento, il loro intreccio in una rete sempre
più "globale" lFeatherstone, 1992, tr. it. 1996; 1995, tr. it. 1998]. Dire che una cultura è deterritorializzata
non significa dire che è dispersa, spezzettata e che basterebbe "rimettere" coloro che la condividono nel
territorio d'origine per ritrovarla come era una volta. In realtà le culture, deterritorializzandosi, si reinventano
a contatto di altre culture. Chi pensa il contrario sono in genere coloro che guardano alla patria "perduta", o
alla patria "minacciata", come a un territorio nel quale la cultura dispersa possa ricompattarsi, ricostituirsi,
nel caso necessario isolarsi, ritrovando così la sua autenticità originaria o evitando di essere "contaminata".
È questo l'esito di una visione culturalista della cultura, di una sua reificazione.
5
Il ruolo fondamentale dell'immaginazione
Lo studio antropologico tende a focalizzarsi sulle rappresentazioni dei soggetti in relazione alle loro pratiche
che, proprio come le rappresentazioni (anche se non in maniera speculare), sono determinate dal loro essere
parte di un mondo sempre più globalizzato e delocalizzato. Lavorare sulle rappresentazioni (e sulle pratiche)
in un mondo globalizzato e deterritorializzato vuoi dire lavorare sull'immaginazione intesa come capacità di
immaginare altre possibilità. Ma questa possibilità di immaginare mondi diversi da quello in cui abitiamo è
diventata sempre più rilevante, al punto da essere parte integrante del nostro stesso mondo. Soprattutto è
veicolata da supporti di nuovo tipo come il cinema; la televisione, internet...
È chiaro il ruolo che la diffusione dei media su scala planetaria svolge in questo senso; ciò spiega anche
perché in molti paesi del Terzo mondo i media siano avversati da coloro che si proclamano "custodi della
tradizione". Ma non sono solo i giornali, la radio, la televisione, la "grande rete" ad alimentare
l'immaginazione. Anche gli spostamenti di parenti, vicini o conoscenti (e non solo i propri spostamenti)
innescano processi immaginativi capaci di connettere gli abitanti di un punto della terra con immagini
globali di quest'ultima.
Non bisogna credere che il fatto di poter immaginare vite diverse, "mondi" diversi, significhi avere vite
davvero diverse o comunque migliori. Resta però il fatto che gli esseri umani, anche negli angoli più
sperduti o meno avvantaggiati della terra, sono oggi in grado di pensare se stessi in contesti diversi da quelli
in cui vivono. Se l'immaginazione consiste, almeno in questo senso, nel rappresentarsi realtà che non sono
esperite nella pratica quotidiana, essa consente, tuttavia, di pensarsi in congiunzione ad altri soggetti come
soggetti aventi . lo stesso tipo di immaginario. Politiche, espressioni collettive, in altre parole "identità",
nascono da questo contesto 0 si rafforzano in esso come entità nuove, come "comunità immaginate".
Possiamo fare nostra quest'ultima espressione resa celebre dallo storico Benedici Anderson [1983, tr. it.
19961 e collegarla alla nozione di "contemporaneità» del filosofo Alfred Schutz. Così, forse, potremo capire
meglio cosa significhi questa accresciuta capacità degli esseri umani di pensarsi immaginativamente come
parte di un mondo più ampio condiviso con altri soggetti.
La diffusione di veicoli e supporti in grado di produrre rappresentazioni deterritorializzate del "se», produce
un effetto complessivo simile a quello individuato da Schutz: "L'essenza della situazione di contemporaneità
sta in questo, che l'alter ego non mi è dato in carne e d ossa, quindi in una immediatezza spaziale e
temporale, ma che ciononostante io so della sua coesistenza con me e del decorso contemporaneo dei suoi
vissuti di coscienza con i miei» [Schutz, 1960, tr. it. 1974].
È insomma nei mondi «nuovi" creati dall'immaginazione che gli individui riformulano le proprie identità e
le proprie culture. Il compito di uno studio delle culture in una prospettiva contemporanea dovrebbe essere
così quello di non limitare più il nostro progetto conoscitivo a delle realtà chiuse, circoscritte, localizzate,
con l'effetto di lasciare intendere (non necessariamente in maniera intenzionale o esplicita) che la vita di
coloro che vengono studiati sia quella vissuta "in seno alla tradizione». Se la realtà odierna è de-localizzata,
deterritorializzata, la prospettiva che faceva coincidere luogo e identità, territorio e cultura deve essere, se
non proprio abbandonata, profondamente rivista. Tuttavia il pensiero sociale mantiene questa
rappresentazione della cultura, la quale costituisce il punto di ancoraggio di tutte le identità che oggi, a torto
0 a ragione, proclamano il proprio diritto all'esistenza e al riconoscimento. Questo pensiero riattiva una
simile rappresentazione in tutti quei contesti dove una qualche "intenzione" sia interessata a produrre un
mondo costituito da isolati discreti quali le culture, le etnie, ecc. L'immaginazione non contribuisce quindi
soltanto a favorire una rappresentazione di se come di individui delocalizzati. L'immaginazione spinge anche
gli individui a immaginarsi come legati a un territorio, a una tradizione, a una cultura, generando così un
conflitto di rappresentazioni.
Le vite "immaginate», qualunque siano le rappresentazioni che le accompagnano, devono allora essere
tenute in considerazione dall'antropologia in quanto "sapere della contemporaneità".
6
In quanto tale l'antropologia, come del resto anche il senso comune, dovrebbe considerare il mondo nel suo
aspetto globale come "ecumene" attraversato (a interazioni culturali. In questa prospeitiva è possibile
indagare le realtà locali come frutto dell'intersecarsi di culture che sono a loro volta il prodotto della
deterritorializzazione, dove le identità e i significati si rivelano attraverso l'esistenza di nuovi "panorami
etnici".
In tutto questo il fattore dell'immaginazione ha un ruolo fondamentale. Non basta cioè limitarsi all'analisi
delle pratiche sociali, delle rappresentazioni culturali e delle istituzioni di cui è costituita la cultura di un
gruppo. Bisogna prestare attenzione a quelle idee che nascono dall'esistenza di comunità immaginate, che la
deterritorializzazio
ne, reale o di fantasia, tende a produrre sempre più grazie allo spostamento degli individui e attraverso i
media e gli altri mezzi di comunicazione "globale".
Oggi qualunque atto individuale è sempre più aperto alle scelte suggerite da questo tipo di immaginario, e
non solo da una serie definita, per quanto ampia possa essere, di modelli previsti dalla cultura specifica alla
quale degli indivie. dui «appartengono". Forse nulla più di questa poesia di un adolescente senegalese di
undici anni, Ibrabima Konaté, ridette la capacità odierna di immaginare vite "altre", dove il passato, il
presente e il futuro si toccano, dove è evocata la creatività che scaturisce dall'incontro tra lingue diverse, e
dove resta forte il desiderio di avere un luogo, di essere riconosciuti:
7
Parfois,
j'invente des chants très anciens
dans une langue
qui n'existe pas.
Et je marche dans les rues
avec mon chant.
Et alors je r egarde tout
comme s'il s'agissait d'un très
vieil ailleurs
où j'aurais ma place
où je serais connu de tous.
Bibliografia
Anderson,'B. (1983) Comunità immaginate, Manifestolibri, Roma, 1996
* Appadurai, A.(1992), Disgiunzione e differenza nell’economia culturale globale, in M. Featherstone (a
cura di), Cultura Globale, Seam, Roma, 1996.
Appadurai, A.(1992), Global Ethnoscapes Notes and Queries for a Transnational Anthropology. Working in
the Present, School of American Research Press, Santa Fe
Boon, F.A: (1982), Other Tribes Others Scribes. Symbolic Anthropology in hte Comparative Study of
Culture Histories, Religions and Texts, Cambridge University Press, Cambridge
Burrows, J (1966), Evolution and Society, Cambridge University Press, Cambridge
* Clifford, J.(1988), I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura ed arte nel XX secolo, Bollati
Boringhieri, Torino 1993.
Fabian, J. (1983), Il tempo è gli Altri. Le cronopolitiche dell'antropologia, L'Ancora, Napoli, 2000.
* Fabietti, U.(l984), Il popolo del deserto. I beduini Shammar de1 Gran Nefud, Arabia Saudita,
Laterza,Roma-Bari.
* Fabietti, U. (1991), Storia dell'antropolologia, Zanichelli, Bologna
* Fabietti, U. (1994), Sceicchi, beduini e .santi,Franco Angeli, Milano
Fabietti, U. (1997) Etnografia della frontiera. Antropologia e storia in Baluchistan, Meltemi,Roma.
Fabietti, U. (1998a) L’identità etnica, Carocci, Roma.
Fabietti, U. (l998b) (a cura di), Alle origini dell'antropologia, Bollati Boringineri, Torino.
Fabietti, U. (1999), Antropologia culturale. L’esperienza e l'interpretazione, Laterza, Roma-Bari.
Fabietti U. (1999), Realites, fictions et problèmes de comparaison. À propos de deux classiques de
l'anthropologie sociale. E.Leoch et R. Montagne, in F. Affergan (a cura di), La construction du savoir
anthropologique, Puf, Paris.
* Fabietti, U e. F. Remotti (l997), Dizionario di antropologia, Zanichelli Bologna.
8
Fabietti, U., R.;Malighetti e.V. Matera (i corso di stampa), Dal tribale al globale,Mondadori, Milano.
* Featherstone, M. (1992), (a cura di), Cultura globale, Seam, Roma;.1996.
* Featherstone, M. (1995), La cultura dislocata. Globalizzazione, postmodernismo, identità, Seam, Roma
1998
* Hannerz, U. (1992), La complessità culturale. L:organizzazione sociale del significato, Il Mulino,
Bologna, 1998
Kluckhohn;C.e , A.L. Kroeber (1952), Il concetto di cuitura, il Mulino,;Bologna, 1972.
* Remotti, F.(1992), Cultura, Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto per l'enciclopedia italiana.
Schütz, A (1960), La fenomenologia de mondo sociale, il Mulino,;Bologna, 1974
Tylor, E B. (1871), Cultura~primitiva, in P.Rossi, (a cura di), Il concetto di cultura, Torino, Einaudi, 1970
* Wagner, R. (1981), L’invenzione della cultura, Mursia ,Milano 1992.
9