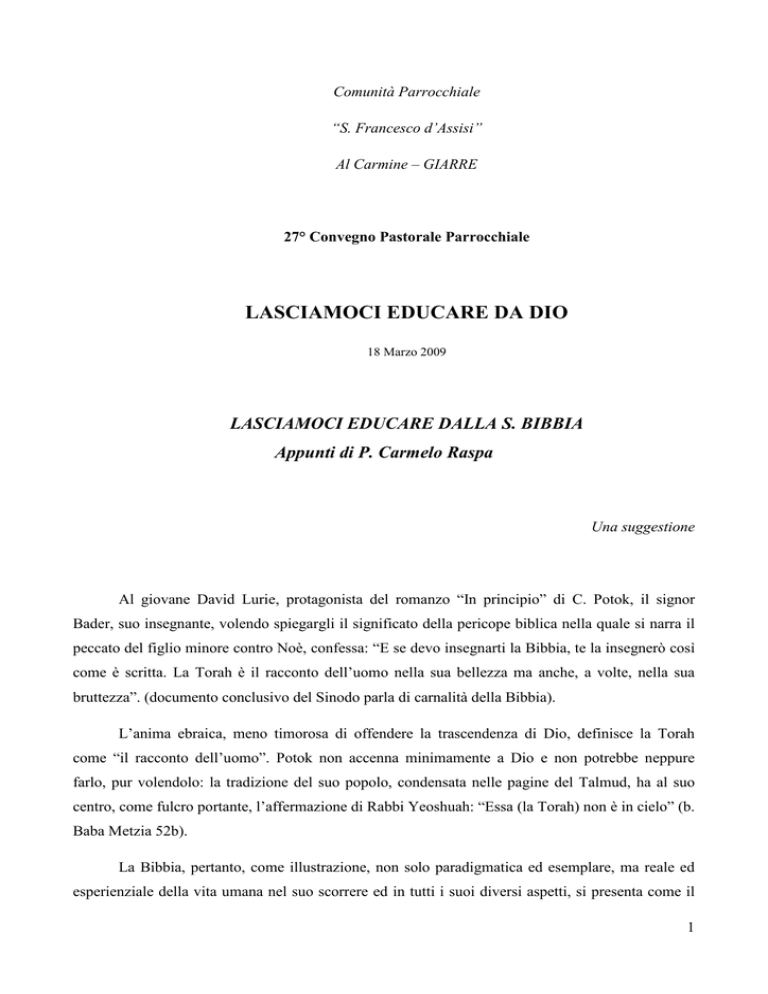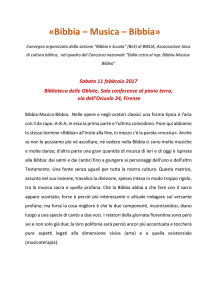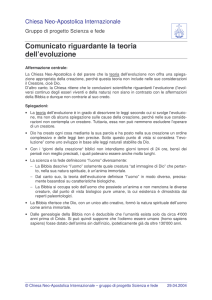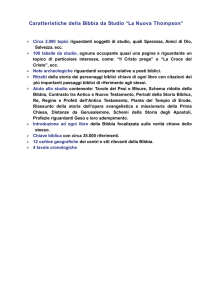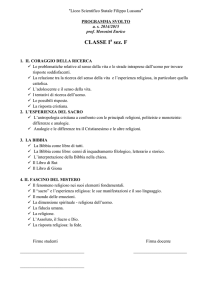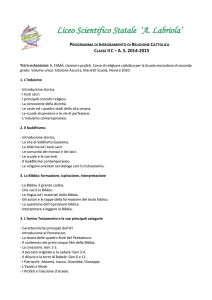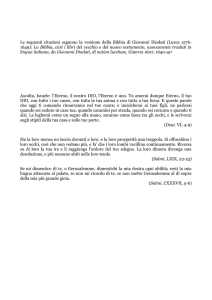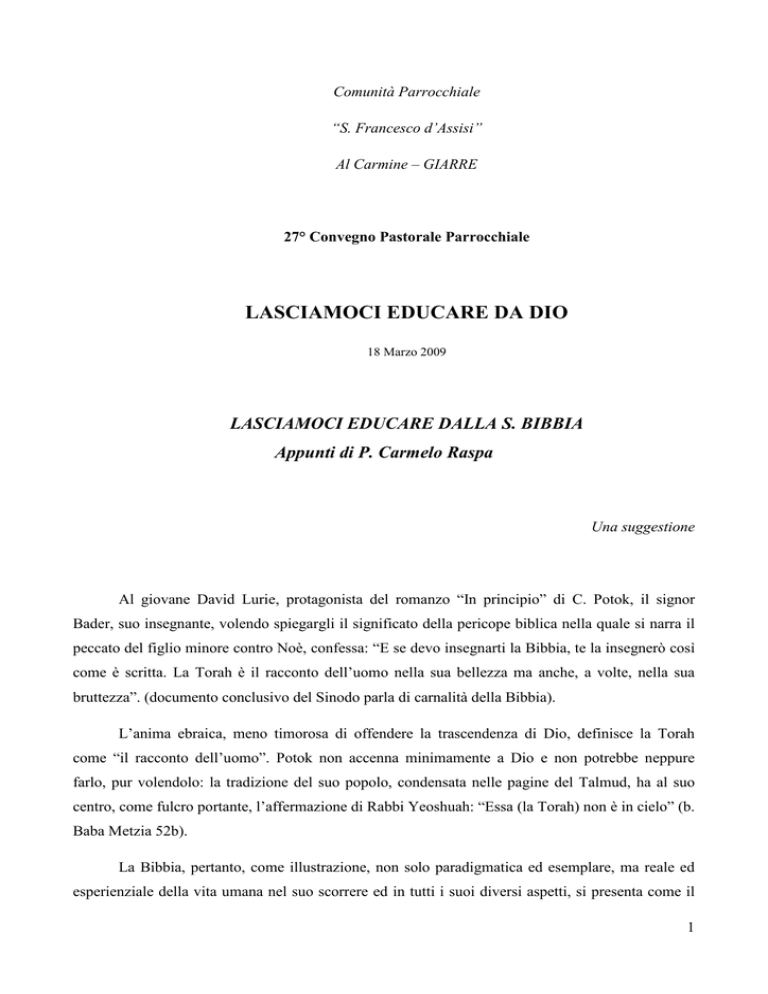
Comunità Parrocchiale
“S. Francesco d’Assisi”
Al Carmine – GIARRE
27° Convegno Pastorale Parrocchiale
LASCIAMOCI EDUCARE DA DIO
18 Marzo 2009
LASCIAMOCI EDUCARE DALLA S. BIBBIA
Appunti di P. Carmelo Raspa
Una suggestione
Al giovane David Lurie, protagonista del romanzo “In principio” di C. Potok, il signor
Bader, suo insegnante, volendo spiegargli il significato della pericope biblica nella quale si narra il
peccato del figlio minore contro Noè, confessa: “E se devo insegnarti la Bibbia, te la insegnerò così
come è scritta. La Torah è il racconto dell’uomo nella sua bellezza ma anche, a volte, nella sua
bruttezza”. (documento conclusivo del Sinodo parla di carnalità della Bibbia).
L’anima ebraica, meno timorosa di offendere la trascendenza di Dio, definisce la Torah
come “il racconto dell’uomo”. Potok non accenna minimamente a Dio e non potrebbe neppure
farlo, pur volendolo: la tradizione del suo popolo, condensata nelle pagine del Talmud, ha al suo
centro, come fulcro portante, l’affermazione di Rabbi Yeoshuah: “Essa (la Torah) non è in cielo” (b.
Baba Metzia 52b).
La Bibbia, pertanto, come illustrazione, non solo paradigmatica ed esemplare, ma reale ed
esperienziale della vita umana nel suo scorrere ed in tutti i suoi diversi aspetti, si presenta come il
1
grande codice dell’umanità, e non solo dell’Occidente, al pari dei poemi epici mesopotamici
(Gilgamesh), greci (Iliade e Odissea), romani (Eneide), arabi (Le mille e una notte), indiani
(Mahābhārata e il Rāmāyaṇa): libro dell’uomo che dell’uomo narra, come tutti questi elencati. E se
si discute del genere letterario, bisogna notare che non c’è poema epico che non contenga al suo
interno l’elegia o il treno o la satira: così la Bibbia, come tutti gli altri
La sua diversità le è conferita dalla specificità che le attribuiscono i credenti, ebrei e
cristiani, pur con delle notevoli differenze: se è, infatti, Parola di Dio per entrambi, per i primi, gli
ebrei, essa è donata agli uomini e consegnata alla loro interpretazione, per i secondi essa, pur nella
molteplicità delle ermeneutiche, permane nella sua normatività di Parola rivelata. Per questi ultimi,
inoltre, essa trova la sua incarnazione in Gesù di Nazareth, rivelazione ultima e definitiva di Dio
agli uomini. La kenosis della Parola nella carne di Gesù prima e nel corpo della Scrittura poi
impedisce qualsiasi aggiunta o sottrazione ad essa, ciò che l’ebraismo pure conserva, ma nella
libertà, data dalla malleabilità vocalica dell’ebraico, di leggere ed interpretare il testo in una
pluralità semantica che rifugge da ogni dogmatismo preconfezionato: la Chiesa cattolica possiede
delle verità di fede che confessa scaturite dalla Bibbia stessa e ad esse rimanda nella lettura del testo
sacro. L’ebraismo, dal canto suo, ha domande ed una halakhah che, nel momento in cui è fissata, è
suscettibile di cambiamento al fine di essere attualizzata in un mondo che cambia: ripetere
pedissequamente, senza innovare, non è nell’ebraismo segno di intelligenza, ma di ottusità, se non
addirittura di grettezza mentale.
Della Torah Gesù è stato un innovatore secondo il significato ebraico del termine, uno cioè
che esplicita uno dei tanti sensi impliciti della Torah, che vengono alla luce grazie all’abilità
interpretativa del maestro in sé e nel suo configgere con le interpretazioni altrui.
Ecco perché la Bibbia, che racchiude le parole dei patriarchi, di Mosè, dei profeti, di Gesù e
degli Apostoli, non insegna una dottrina morale, non abilita ad una teologia intesa come discorso su
Dio né tanto meno ad una teodicea, un’apologia dell’operato divino, non fornisce ricette per la
felicità, non presenta un programma di meditazione per il benessere della mente e del corpo.
Cos’è allora la Bibbia e da chi, per chi e a che scopo è stata scritta? è la domanda che si
pongono gli studiosi, tra cui P. Gibert, che afferma: “C’è anche un enigma sul quale io lavoro da
vent’anni: chi scriveva la Bibbia? Come? Dove? Per chi? Noi abbiamo il nostro testo biblico e, di
fronte, abbiamo i luoghi in cui si reputa si siano svolti gli avvenimenti raccontati nel testo. Noi
cerchiamo di stabilire un legame tra i due o, al contrario, siamo obbligati a constatare che non c’è,
2
perché tra i due si frappongono alcune domande. Per me, è una delle maggiori difficoltà”. Stessa
questione è affrontata nel libretto “La Bible dévoilée” di I. Finkelstein e N. A. Silberman.
La questione esegetica e storica investe la domanda esistenziale del credente: questa parola
della Bibbia è parola dell’uomo o parola di Dio o entrambi? E perché non dà risposte sempre
chiare? Cosa vuole insegnarci? Domande che si pongono nell’atto stesso in cui la Bibbia è presa in
mano con l’intenzione, buona certamente, di imparare da essa qualcosa per la vita e per la fede.
Siamo perciò destinati a restare senza risposte? Il buon Potok, nel romanzo citato all’inizio, mette in
bocca al padre di David, il nostro alunno, il ricordo di un ammonizione del fratello morto in guerra:
“Ma voglio farti sapere una cosa che mi disse una volta mio fratello David, riposi in pace. Disse che
è essenziale imparare non solo le risposte importanti, ma anche le domande importanti. Soprattutto
è importante imparare le domande per le quali forse non esistono buone risposte. Dobbiamo
imparare a convivere con le domande, diceva. Sono felice che il signor Bader sia un buon
insegnante e sono felice che ti dica onestamente che non ha una risposta per tutte le tue domande”.
La sapienza della Bibbia
Il libro biblico dei Proverbi si presenta, nei primi nove capitoli, come un’apostrofe rivolta
dal sapiente al suo discepolo. E poiché l’insegnamento in materia religiosa, nella tradizione ebraica,
spetta al padre ed alla madre, quest’ultima presente soprattutto nei primi anni di vita anche del figlio
maschio come pedagoga della fede, ecco che di essi il sapiente assume le fattezze: “Ascolta, figlio
mio, l’istruzione di tuo padre e non disprezzare l’insegnamento di tua madre” (Prov 1,8).
L’imperativo che apre l’esortazione è un’allusione esplicita a Dt 6,4-8.20-25, ove compare la stessa
coppia padre-figlio e l’esortazione a imparare e mettere in pratica i comandamenti del Signore: sono
questi la sapienza declamata dal libro dei Proverbi, sapienza personificata, presente all’inizio della
creazione e che chiama gli uomini a conoscere il bene e ad evitare il male. Il nesso tra Sapienza e
Torah è ravvisabile in Dt 4,1-8. La conoscenza del bene e il rifuggire dal male sono i temi che
stanno alla base della redazione del racconto jahwista del peccato e della caduta in Gen 3, temi
richiamati attraverso le figure letterarie della coppia uomo-donna, speculare a quella di padre-madre
nel libro dei Proverbi, in quanto in Gen 4 Adamo ed Eva diventeranno padre e madre di Caino ed
Abele, del frutto della conoscenza del bene e del male e dell’albero della vita. Conoscere il bene ed
evitare il male, quindi non averne esperienza, si condensano in quel timore del Signore che il libro
3
dei Proverbi proclama essere l’inizio della Sapienza : 1,7; 8,13 per il rapporto della Sapienza con il
fuggire il male.
La Torah-Sapienza è una ricompensa per se stessa: se questo è l’insegnamento dei rabbini,
esso affonda le sue radici nell’ottimismo di alcuni Salmi, particolarmente il 119 (118), che celebra
la bellezza della Legge e protesta la gioia fiduciosa di chi è certo di ottenere da Dio la ricompensa
giusta e dovuta per l’osservanza dei precetti. Eppure, un’invocazione attraversa lo stesso Salmo:
nell’angoscia, nell’umiliazione della prova, nel pericolo l’orante ricorda a Dio il suo amore per i
comandamenti e conclude la sua preghiera con un accorato, se non si vuole dire disperato, “cerca il
tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti”. I Salmi rivolgono il suo imperativo a
Dio stesso: “Signore, ascolta nella mia voce” (Sal 130 (129)). L’uomo chiede a Dio di ascoltare sul
filo di quella stessa Sapienza-Torah che egli ascolta, rumina, meditandola a voce alta, mette in
pratica e si sforza di vivere. L’uomo dalla Bibbia impara il linguaggio di Dio per parlare a Dio, così
come Dio impara la lingua degli uomini per parlare agli uomini. E’ il miracolo insito in ogni
alleanza d’amore, sino a quando i linguaggi non divengono intercambiabili e l’uno assume e parla
con la lingua dell’altro e viceversa, senza confusione, ma nell’accoglienza e comprensione
reciproca, nella traduzione, nella propria originalità, della diversità specifica dell’altro.
Questa Sapienza, che è la Legge, insegna perciò a mettere in pratica i comandamenti per se
stessi e non per ottenerne una ricompensa. Ma ecco che la giustizia dell’uomo è infranta: se le opere
della legge non possono vantare nulla dinanzi a Dio, che ne è della sua fede? Qohelet lamenta
l’unica sorte del saggio e del folle (Qo 2,14), pur preferendo la sapienza alla stoltezza, mentre i testi
deuterocanonici di Sapienza e Siracide, nati nell’ambito del giudaismo alessandrino, il primo per
origine, il secondo per traduzione, pongono la retribuzione del giusto ed il castigo dell’empio alla
resurrezione finale, come fa pure il Libro dei Maccabei. Sono tutti sforzi, interni alla Bibbia stessa,
tesi a superare l’émpasse di una fedeltà alla Torah che non apre alla speranza della redenzione.
Anche sull’alba della resurrezione vi è il silenzio delle donne, le quali, per paura, scappano via dal
sepolcro vuoto e non riferisco a nessuno circa le parole del giovanetto che esse hanno visto ed
ascoltato all’ingresso del sepolcro stesso.
Bibbia e sofferenza
4
Questa Sapienza-Torah risulta inefficace dinanzi al mistero della sofferenza, del dolore e
della morte. I suoi schemi vengono sconvolti dalla lacerante esperienza del limite e della fragilità
umana. Giobbe è il portavoce di tutti i giusti sofferenti di ogni luogo e tempo che protestano a Dio
la loro rettitudine e fedeltà nell’osservanza dei comandamenti ed esprimono con rabbia
l’incomprensibilità del loro soffrire, contro la promessa stessa di Dio (Gb 31). Al Servo sofferente
del quarto carme di Is 52,13-53,12 è riservata addirittura la morte: la promessa di una discendenza
gli è data come ricompensa per il suo consegnarsi al sacrificio, ma egli non la vede nel tempo del
suo dolore. I Salmi imprecano contro Dio: e l’orante, nella sventura, chiede a Dio dove sia, se
dorma, come un prode assopito dal vino, se si sia dimenticato, se non tenga conto della sincerità del
suo popolo. Il perché del dolore e della morte lo esprime Gesù nell’agonia del Getsemani, dove si
consuma una morte incomprensibile a chi la vive e a chi vi assiste: può un padre mandare il figlio
incontro ai suoi uccisori?
Si incontrano allora domande più grandi: può Dio volere la sofferenza dei suoi figli? Perché
non agisce, perché non interviene? Non è egli forse l’Onnipotente? Dove sta allora la sua forza, la
sua onnipotenza? Che senso ha la sofferenza accettata perché è volontà di Dio? La volontà di Dio
può essere il dolore e la morte dei suoi figli se Egli stesso ha parlato di ed è Provvidenza? Può la
malattia essere condanna per il peccato, se peccato e sofferenza fisica sono state da Lui stesso
disgiunte?
La tradizione ebraica ricorre allo zimzoum, un ritrarsi di Dio per lasciar posto alla
responsabilità dell’uomo nel ricomporre i frammenti di un mondo disgregato da ricondurre
all’unità. Con ciò stesso Egli fonda la libertà e l’autonomia dell’uomo e della storia. Di riflesso
anche la natura viene ad essere caratterizzata come indipendente ed autonoma nell’ottica della
libertà. Una libertà rischiosa che prevede il limite, la sofferenza e la morte. Dio cessa di essere il
Dio tappabuchi e, in un mondo divenuto adulto, si presenta come l’Agnello ferito, nelle cui piaghe
gli uomini feriti possono abitare. Lo scandalo dell’onnipotenza che non interviene è spiegato dalla
legge suprema che l’amore maturo attua nel suo stesso avverarsi: la libertà, difficile a viversi e a
portarsi. Come non ricadere nell’idolatria di una divinità onnipotente quando si muore? Ma la
divinità onnipotente chiede il sangue, come nel caso della legatura di Isacco, il Dio dal nome
impronunciabile, ciò che è proprio dell’amore, il timore di dire la sacralità del nome, il Dio amante
della vita invia l’angelo a trattenere la mano del padre stesa a uccidere il figlio e a consolare, con il
silenzio, il figlio che, nell’ora del combattimento doloroso, chiede al padre se sia possibile non bere
il calice. Ed è alla conformazione a queste icone di personalità dignitose nel dolore, a questi uomini
e a queste donne, che, nell’attimo della morte, non hanno cosificato Dio, riducendolo ad un mago,
5
che, nel peccato, come Davide, sono stati capaci di trasparenza, che la Bibbia educa. Non più,
dunque, una sofferenza ed una morte voluta da Dio, ma un dolore immenso al quale Dio partecipa
abbracciando l’uomo e la donna che soffrono, piangendo con essi, nella verità, che può sembrare
crudele, ma in realtà è matura, di un amore che non salva dalla croce per non ridurre l’amato ad un
burattino, la vita ad una rappresentazione e l’amore ad una farsa.
D. Hartmann, talmudista ebreo, rinuncia ad una teodicea, ad un’apologetica della volontà
incomprensibile di Dio: preferisce un’osservanza fedele dei precetti per se stessi, senza la speranza
mondana o ultramondana di una redenzione. La Torah è vita di per se stessa: e la halakhah serve
forse a proteggerci da Dio stesso, nelle cui mani è terribile cadere (Eb 10,31). La prova di Dio è il
suo stesso amore libero e liberante. (vd. la posizione dei lineamenta non accettabile)
Bibbia e preghiera
La Bibbia educa nel silenzio quando la si ascolta, educa nella parola quando di essa gli
uomini confrontano le loro interpretazioni, educa quando è posta al vaglio della critica degli
studiosi, educa quando dai confronti ad essa si ritorna nel silenzio, educa nella sua proclamazione
liturgica. Non vi è educazione che non passi attraverso la relazione. La bibbia educa a rifuggire dal
solipsismo. La pienezza della relazione tra Dio e i cristiani e tra i cristiani tra loro si attua nella
Celebrazione Eucaristica domenicale. Giustino ci ricorda come i primi cristiani si radunassero nel
giorno detto del Sole per celebrare l’eucaristia, della quale fornisce una dettagliata descrizione in
tutte le sue parti: il Giorno del Signore è giorno dedicato all’ascolto delle Memorie dei Profeti e
degli Apostoli, alla narrazione delle meraviglie operate da Dio e alla lode della Chiesa. Una
celebrazione che abbia un respiro lungo e sereno e che abbracci tutta la comunità, uomini, donne,
bambini, convocati, come al tempo di Esdra e Neemia e poi degli Apostoli, per ascoltare la Parola
del Signore, è ben auspicabile. “Meno Messe e più Messa”: uno slogan antico, che dovrebbe
risuonare ancor oggi, in questo tempo di tentazione di un liturgismo prolisso ed inefficace. La
semplicità, la sobrietà e la bellezza della Celebrazione Eucaristica domenicale permetterebbero il
risuonare in essa come in un coro armonico delle voci di Dio e degli uomini (vd. Lineamenta). Il
tempo lungo della Celebrazione Eucaristica è da consacrarsi all’ascolto di interi capitoli dei libri
biblici scelti ed alla risposta gioiosa, nel canto, dell’assemblea.
6
L’omelia è il calare la Parola nella vita: per questa va preparata e curata, sia dal punto di
vista formale sia da quello contenutistico. Essa non deve sovrapporsi alla Parola, ma farla risaltare.
Per questo è bene che i presbitero prepari la sua omelia durante tutta la settimana, con studio e
preghiera. Il sabato sera, poi, il presbitero si preparerà al giorno del Signore nel silenzio fecondo
dell’attesa, evitando di uscire; la comunità, a sua volta, rispetterà la solitudine del presbitero,
riempita dalla Parola, il sabato sera, e non lo chiamerà in occupazioni che potrebbero distrarlo. Il
silenzio della sera del sabato si rivive l’esperienza dell’intimità tra dio e il suo popolo in maniera
anche fisica: lo esige la carnalità della Parola, che non a caso diventa carne e sangue nella
Celebrazione.
Ancora: lectio divina e preghiera dei Salmi (Ufficio delle Ore) sono da riproporre.
Bibbia misura della fede
La Bibbia è misura della fede: la Parola scarnifica, giunge al punto di divisione delle midolla
e delle giunture, come ricorda la Lettera agli Ebrei 4,12, lasciando l’uomo nella sua nudità. Una
nudità che di lui dice tutto: gioie, dolori, speranze, delusioni. L’uomo nudo è l’uomo nella pienezza
della sua esistenza. Egli è là: ed è il là a definirlo dinanzi a se stesso, gli altri, Dio. È un uomo che
cerca, che chiede e che bussa, che osa. Ed è così che è trovato dalla Parola e che nella Parola si
ritrova.
(Bibbia ed ecumenismo: ritrovarsi nella fede. Bibbia e culture altre: il coraggio di
sperimentare l’innovazione, di parlare il linguaggio del diverso, di condividere=duplice verso del
condividere)
La Parola di Dio non insegna una morale, ma la responsabilità della vita vissuta in pienezza
e la bellezza “funzionale” (Gestalt) di tutti i suoi aspetti.
La Bibbia educa ad amare la propria vita, i suoi tempi, le sue attese, le realizzazioni, gli
incontri e gli eventi, nella compagnia di un Dio che si è fatto vicino, che si fa con l’uomo e che
lascia l’uomo, come Abramo, camminare dinanzi a Lui.
7
Parola di Dio e sofferenza, volontà di Dio;
Parola di Dio e culture;
Parola di Dio ed Eucaristia;
Parola di Dio come misura della fede: la formazione dei preti;
Parola di Dio fatto di Chiesa, comunitario;
Parola di Dio e dialogo ecumenico e interreligioso;
393-397 Potok, In principio
8