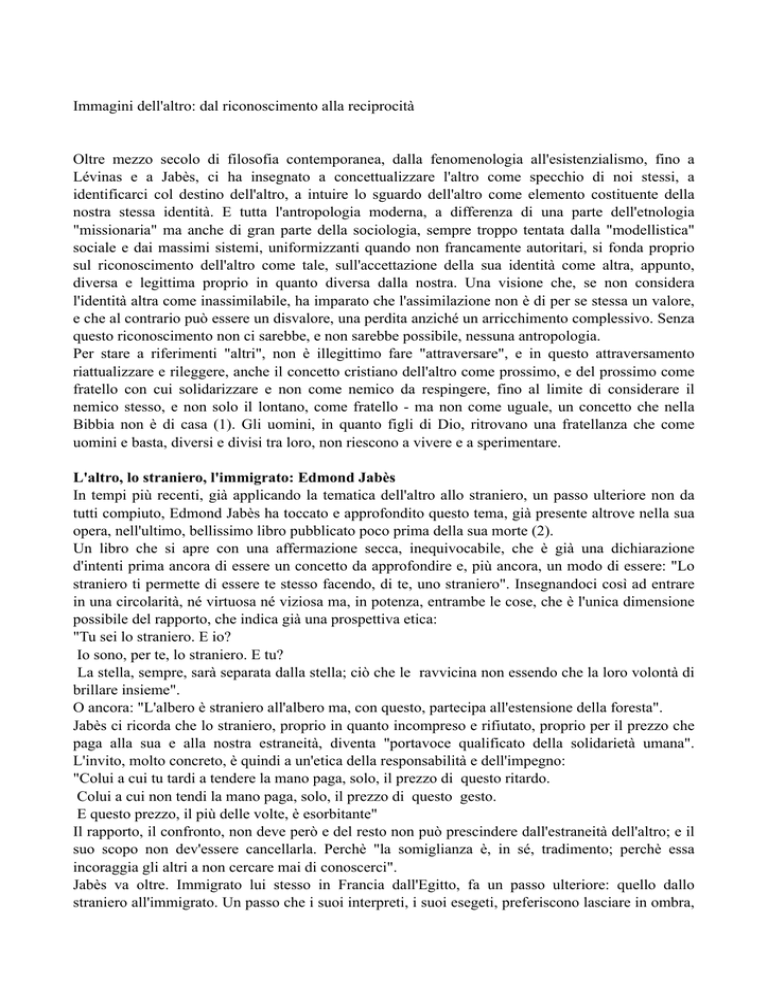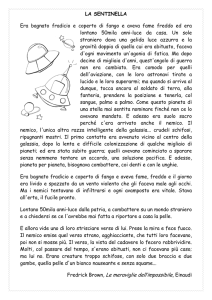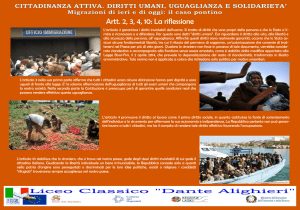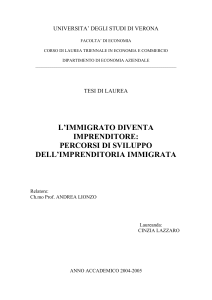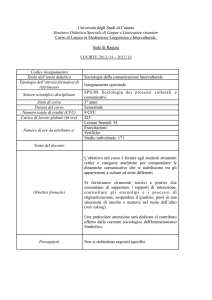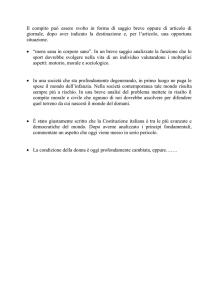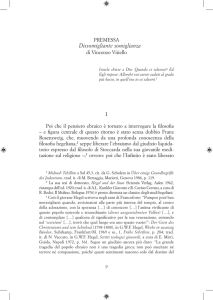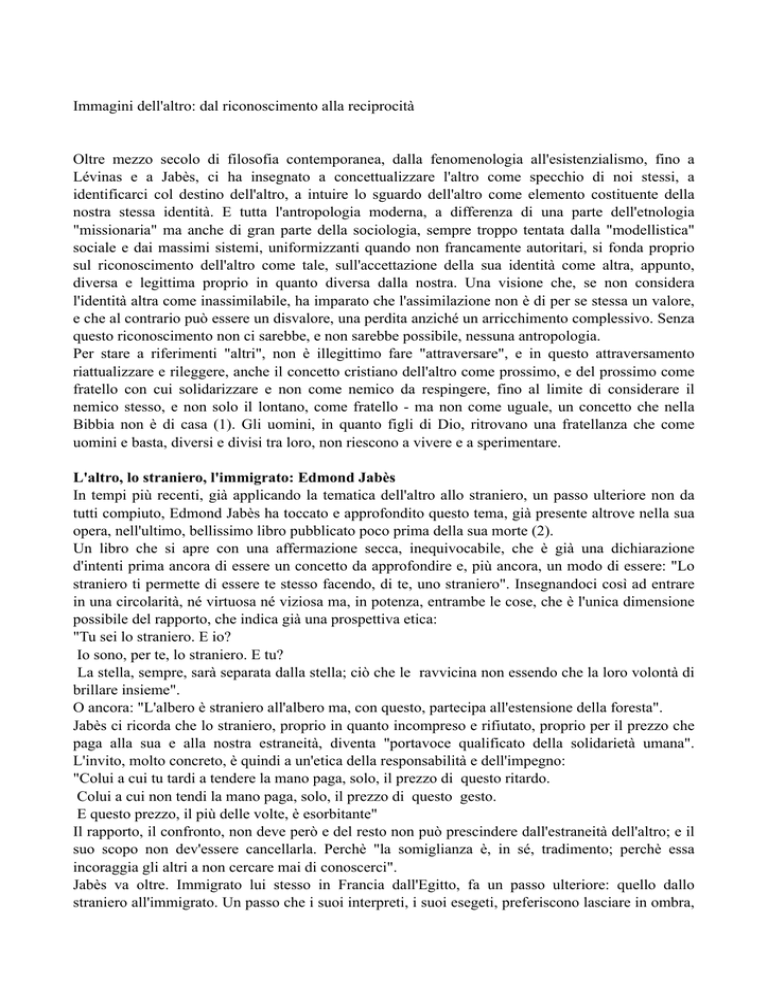
Immagini dell'altro: dal riconoscimento alla reciprocità
Oltre mezzo secolo di filosofia contemporanea, dalla fenomenologia all'esistenzialismo, fino a
Lévinas e a Jabès, ci ha insegnato a concettualizzare l'altro come specchio di noi stessi, a
identificarci col destino dell'altro, a intuire lo sguardo dell'altro come elemento costituente della
nostra stessa identità. E tutta l'antropologia moderna, a differenza di una parte dell'etnologia
"missionaria" ma anche di gran parte della sociologia, sempre troppo tentata dalla "modellistica"
sociale e dai massimi sistemi, uniformizzanti quando non francamente autoritari, si fonda proprio
sul riconoscimento dell'altro come tale, sull'accettazione della sua identità come altra, appunto,
diversa e legittima proprio in quanto diversa dalla nostra. Una visione che, se non considera
l'identità altra come inassimilabile, ha imparato che l'assimilazione non è di per se stessa un valore,
e che al contrario può essere un disvalore, una perdita anziché un arricchimento complessivo. Senza
questo riconoscimento non ci sarebbe, e non sarebbe possibile, nessuna antropologia.
Per stare a riferimenti "altri", non è illegittimo fare "attraversare", e in questo attraversamento
riattualizzare e rileggere, anche il concetto cristiano dell'altro come prossimo, e del prossimo come
fratello con cui solidarizzare e non come nemico da respingere, fino al limite di considerare il
nemico stesso, e non solo il lontano, come fratello - ma non come uguale, un concetto che nella
Bibbia non è di casa (1). Gli uomini, in quanto figli di Dio, ritrovano una fratellanza che come
uomini e basta, diversi e divisi tra loro, non riescono a vivere e a sperimentare.
L'altro, lo straniero, l'immigrato: Edmond Jabès
In tempi più recenti, già applicando la tematica dell'altro allo straniero, un passo ulteriore non da
tutti compiuto, Edmond Jabès ha toccato e approfondito questo tema, già presente altrove nella sua
opera, nell'ultimo, bellissimo libro pubblicato poco prima della sua morte (2).
Un libro che si apre con una affermazione secca, inequivocabile, che è già una dichiarazione
d'intenti prima ancora di essere un concetto da approfondire e, più ancora, un modo di essere: "Lo
straniero ti permette di essere te stesso facendo, di te, uno straniero". Insegnandoci così ad entrare
in una circolarità, né virtuosa né viziosa ma, in potenza, entrambe le cose, che è l'unica dimensione
possibile del rapporto, che indica già una prospettiva etica:
"Tu sei lo straniero. E io?
Io sono, per te, lo straniero. E tu?
La stella, sempre, sarà separata dalla stella; ciò che le ravvicina non essendo che la loro volontà di
brillare insieme".
O ancora: "L'albero è straniero all'albero ma, con questo, partecipa all'estensione della foresta". Jabès ci ricorda che lo straniero, proprio in quanto incompreso e rifiutato, proprio per il prezzo che
paga alla sua e alla nostra estraneità, diventa "portavoce qualificato della solidarietà umana".
L'invito, molto concreto, è quindi a un'etica della responsabilità e dell'impegno:
"Colui a cui tu tardi a tendere la mano paga, solo, il prezzo di questo ritardo.
Colui a cui non tendi la mano paga, solo, il prezzo di questo gesto.
E questo prezzo, il più delle volte, è esorbitante"
Il rapporto, il confronto, non deve però e del resto non può prescindere dall'estraneità dell'altro; e il
suo scopo non dev'essere cancellarla. Perchè "la somiglianza è, in sé, tradimento; perchè essa
incoraggia gli altri a non cercare mai di conoscerci".
Jabès va oltre. Immigrato lui stesso in Francia dall'Egitto, fa un passo ulteriore: quello dallo
straniero all'immigrato. Un passo che i suoi interpreti, i suoi esegeti, preferiscono lasciare in ombra,
limitandosi a vaghe identificazioni dell'altro, dello straniero, con se stessi, con l'uomo, con il
filosofo, il poeta, quando non con Dio stesso. E' più facile, evidentemente, e più comodo lasciare
questi concetti, altrimenti impegnativi, nel cielo della metafisica. Fa parte del resto dell'incapacità e
della reticenza del mondo accademico al pensare (e all'agire) interdisciplinare - più banalmente, al
guardarsi intorno (3). Una capacità che Jabès, al contrario, già nel suo stile di scrittura, coltivava.
Il problema dell'identità, della necessità della salvaguardia della propria identità, si riferisce
innanzitutto a lui, all'immigrato:
"L'immigrato ansioso di non essere più considerato come uno straniero sa che, il suo desiderio
esaudito, cessa, nello stesso tempo, di essere se stesso, non essendo, ormai, che la brutta copia di un
modello sospetto?
Lo straniero è, forse, colui che acconsente a pagare, modesto o esorbitante, il prezzo della sua
estraneità.
Il prezzo pagato, dunque, per restarlo; cioè, per ciascuno di noi, di essere se stesso".
E' qui che Jabès introduce una storia che è la sua propria storia, quella di un egiziano che amava
perdutamente la cultura e la poesia francese ma, una volta esiliato in Francia, non sa ritrovare
questo amore se non rivolgendosi al deserto delle sue origini, ritrovando nel suo silenzio la
risonanza per le parole che ha appreso:
"Ti ricordi della storia, nello stesso tempo comica e drammatica, di quell'Africano, entusiasta,
sentimentale, il cui amore per la Francia era così espansivo che dormiva, la notte, nella nostra
bandiera, fino al giorno in cui fu, da dei vicini che vedevano, nel suo gesto, un oltraggio alla loro
patria, bassamente denunciato alle autorità di polizia?".
Troviamo qui tutto il dramma dell'incontro, del confronto e dello scontro tra culture, che
l'immigrato incarna ma che noi viviamo con lui, per la nostra parte e per la nostra capacità di
comprensione, per la nostra responsabilità. Perchè anche noi siamo stranieri a nostra volta. Una
constatazione che fa dire a Jabès, in un gioco di parole intraducibile nella sua pienezza: "L'étranger?
L'étrange-je?". C'è chi traduce "estran-io". Potremmo dire, letteralmente, alter ego. Una politica per l'altro
Se scendiamo (o saliamo, secondo i punti di vista) dalla filosofia alla politica, il passaggio da una
concezione alta dell'altro a una considerazione altrettanto alta dello straniero, è meno scontato.
Tutta la politologia, da Tucidide a Carl Schmitt che l'ha compiutamente teorizzata (4), passando per
Machiavelli e Hobbes, si regge sulla contrapposizione amico-nemico.
Il politico si è abituato a sfruttare questa contrapposizione quasi "naturale" per i suoi fini interni di
governo della polis. Ma, ancora di più, ha imparato a costruirla e ad alimentarla artificialmente
quando naturalmente non c'è. Molto dell'astuzia politica è in questo. E le condanne e le diffidenze
del pensiero religioso nei suoi confronti si spiegano forse anche così.
Quando poi l'altro, il nemico di ieri, si sposta nel nostro territorio e si mescola a noi, le cose si
complicano ulteriormente. Il fenomeno rende più difficili, e nello stesso tempo più urgenti e
necessarie, le distinzioni. L'identità sociale (e non solo) a questo punto è in crisi. Non capisce più,
non distingue più. E nello stesso tempo sente il bisogno di reagire. E' quanto stiamo vivendo noi, in
Europa, oggi. E' il terreno di confronto e l'orizzonte di domani.
Immagini dell'altro: lo specchio infedele
Già è difficile capire l'altro. Figuriamoci accettarlo. Del resto già l'immagine che ci facciamo
dell'altro è sovente distorta: perchè tendiamo a interpretarlo secondo categorie familiari - familiari a
noi- ma non necessariamente esplicative della sua condizione. Ce ne accorgiamo, ed è questa la
funzione più bella dell'altro, quella che più ci aiuta a comprendere noi stessi, quando è l'altro a
tentare di interpretare e giudicare noi. Soprattutto quando il confronto è con culture radicalmente
diverse; totalmente altre, per dirla in linguaggio filosofico. Quando prima dell'interpretazione e del
giudizio si manifesta, più forte di ogni altra cosa, la curiosità, la sorpresa, la scoperta e la
descrizione tra l'attonito e il meravigliato.
Per gli indigeni d'America, al tempo della Conquista, gli invasori bianchi furono addirittura
scambiati per quanto di più altro ci si possa immaginare: per dei morti, o degli inviati del regno dei
morti - e proprio a causa del loro pallore, essendo il bianco il colore dei morti e quindi dei
"revenants". Caddero in questo equivoco, almeno in un primo momento, anche a causa dei loro miti
ancestrali, gli stessi leggendari capi delle popolazioni che tra le prime incontrarono gli spagnoli:
come l'imperatore azteco Montecuhzoma, stando alla versione data da Cortés del suo incontro con
lui, e come il capo inca Atahualpa (5). E reazioni analoghe sono attestate anche in Nuova Zelanda,
in Melanesia e in generale in tutta l'Oceania (6).
L'incontro, e il tentativo di comprensione secondo le proprie categorie, può produrre osservazioni
comiche ma non per questo meno puntuali, e tanto più ciò accade quanto più la distanza relativa tra
le culture che si incontrano si amplia, come accade quando è un selvaggio, un "primitivo" ad
accostarsi o a essere portato nel cuore della civiltà occidentale (7). In un caso in particolare, noto
all'antropologia, quello di Ishi, l'ultimo indiano Yahi sopravvissuto all'estinzione della sua comunità
e "assorbito" dalla civiltà americana (8),esempio estremo di un incontro tra culture radicalmente
diverse, di un uomo passato direttamente "dall'età della pietra al ventesimo secolo", il meccanismo
è ancora più evidente e più ricco di insegnamenti.
Tuttavia questo procedimento del pensiero è sempre, più o meno inconsciamente, in attività. E
sarebbe per noi un esercizio istruttivo se imparassimo qualche volta a cercare di fare tabula rasa in
noi stessi, delle nostre conoscenze, per cercare di vederci come potrebbe vederci un immigrato
africano appena uscito, con poche e malcerte cognizioni apprese per lo più attraverso immagini
veicolate dai mass media, dalla stazione ferroviaria di una qualsiasi delle nostre città. Capiremmo
qualcosa di noi, in particolare dei nostri lati peggiori. E ci stupiremmo meno degli equivoci culturali
che il nostro comportamento esteriore (siamo nella civiltà dell'immagine, dopotutto- e l'abbiamo
voluta noi) induce sui nostri interlocutori.
La costruzione di una società plurale
Se non siamo capaci di identificarci con l'altro (l'esercizio è del resto difficile, e soggetto comunque
a non pochi limiti), può essere utile imparare almeno a lasciarci interrogare dallo sguardo dell'altro,
ad ascoltarlo, a leggerlo (9). E a nostra volta a interrogarlo. Senza sentimenti di superiorità ma
anche senza sensi di colpa che si tramutano in inferiorità de facto, in accettazione acritica di ciò che
talvolta è inaccettabile, e ugualmente senza fingere ugualitarismi che non ci sono. Partendo, questo sì, dal riconoscimento della reciproca diversità. Ma non necessariamente dandole
uguale valore: questo è relativismo culturale - un atteggiamento diffuso, ma non necessariamente il
migliore e, al di là dei giudizi morali, il più adatto per capirsi. Il dialogo è sovente più efficace e più
costruttivo se si svolge tra identità forti - tanto forti da avere avuto il coraggio e il desiderio di
intavolare un dialogo. Accade lo stesso in amore, del resto. E il dialogo vero non può esserne del
tutto privo. La sim-patia, nel suo profondo significato etimologico che richiama la capacità e la
sensibilità di soffire con l'altro, di vibrare al ritmo delle sue sensazioni, anche e soprattutto di quelle
dolorose, nel caso del rapporto tra culture è una categoria scientifica, un elemento indispensabile
del "metodo".
Quel che è certo è che il confronto tra culture non può nascere come competizione. Perchè nel caso
dell'immigrazione sarebbe una competizione squilibrata, truccata. Delle due culture che si
confrontano e che competono una è infatti dominante e gioca sul suo terreno; l'altra, dominata, non
foss'altro che per schiaccianti questioni di numero, gioca invece sul terreno altrui: è, per così dire, in
trasferta - il contesto le è nemico. Non è difficile immaginare quale possa essere il vincente, se è la
forza ad essere il metro. Anche se, in prospettiva, ogni risultato del genere sarebbe una sconfitta per
tutti.
Il confronto può avere molti esiti: dall'assimilazione acritica allo scontro aperto (che significa poi
xenofobia e razzismo), dal dialogo interculturale in un contesto "plurale", di mutuo riconoscimento,
all'appiattimento sottoculturale (10). Quale gioco giocare, per quale scopo, dipenderà, per molta
parte, dalla volontà degli attori. Di tutti, quindi: delle culture immigrate e della società che le
accoglie. Con responsabilità equamente distribuite. Le condizioni per una società plurale non sono però un dato, tanto meno qualcosa di definito e di
definitivamente acquisito. Essa presuppone riconoscimento e reciprocità, dell'altro e tra gli altri, i
tanti altri che, individualmente e collettivamente, costituiscono i soggetti, gli attori sociali di questo
processo. Una considerazione che ha una valenza tutta particolare, per esempio, nei rapporti
interreligiosi, e più specificamente nel più critico tra di essi, il rapporto tra cristianesimo e Islam.
Ma che va inevitabilmente applicata a tutto il contesto sociale, nella sua complessa globalità.
Forse dovremmo "tornare all'antico", ricordando con Seneca (11), e con una saggezza che viene da
ancora più lontano, che "siamo nati per vivere in società". E che "la nostra società è molto simile a
una volta di pietre; essa cadrebbe se le pietre non si sostenessero a vicenda, sostenendo così tutta la
volta". Lette in un contesto di pluralità culturale, queste parole assumono una coloritura inusuale: si
ammodernano e ci spiazzano, ma non perdono in verità. Magari meglio ancora se affiancate dalla
cautela anti-autoritaria di un Berdiaev, per il quale "è l'uomo che è un organismo, di cui la società è
un organo, e non viceversa". E così per i soggetti collettivi intermedi: per le comunità etniche, per
esempio. La prospettiva storica può aiutarci a superare timori legittimi e non infondati, interrogativi che sono
di tutti. Secondo Braudel (12), persino quando l'altro è il barbaro invasore, armato e nemico - non
dunque un relativamente innocuo immigrato - e quando apparentemente è uscito vincitore, più che
dal confronto, dallo scontro, "il barbaro trionfa soltanto nel corto termine. Ben presto è assorbito
dalla civiltà soggiogata". Per dirla con un'altra sua efficace espressione, "la porta di casa si richiude
alle spalle del barbaro". Noi, anche se qualcuno li chiama i nuovi barbari, non abbiamo a che fare
che con degli immigrati, disarmati e in numero modesto, con nessuna ambizione e in ogni caso con
nessuna possibilità di presa del potere e, in fin dei conti, non più barbari di noi, o forse solo in
maniera diversa. Timori di crollo della civiltà, di fine impero, sono dunque eccessivi e fuorvianti, buoni solo per la
demagogia volgare delle vigilie elettorali. Se la civiltà occidentale, o l'Europa, dovesse mai crollare,
sarà per ben altri motivi che per la presenza di un gruppo anche consistente di immigrati di varia
provenienza; sarà per logiche e contraddizioni tutte interne, semmai. E anzi, se l'Europa ha davvero
paura che qualche milione di immigrati possa snaturarne la cultura, è proprio questa paura, allora, il
sintomo di una debolezza, in primo luogo culturale, preoccupante - ed è di questa paura che bisogna
semmai avere paura, è essa che va curata. Sapendo che la soluzione non potrebbe essere
semplicemente la cacciata degli immigrati: non sarebbe risolutivo. Essi sono solo il sintomo che
rende visibile l'indebolimento dell'organismo, non la malattia. Si pongono, è inevitabile, nuovi problemi. Forse più grandi di quelli presenti nelle società
monoculturali; anche se in fondo, al di là di una certa soglia dimensionale, nessuna società lo è mai
stata veramente - nemmeno l'occidente medievale cristiano, che qualche volta si cita ad esempio.
Ma che si pongano nuovi problemi non è una novità nella storia dell'uomo. Come non lo è la
responsabilità di cercare nuove soluzioni. E' il suo mestiere. Il suo impegno. Il suo destino.
Stefano Allievi
(1) E nemmeno nell'antropologia del resto: "la semplice proclamazione dell'uguaglianza naturale fra
tutti gli uomini e della fratellanza che deve unirli senza distinzione di razza o di cultura, ha qualcosa
di deludente perchè trascura una diversità di fatto, che si impone all'osservazione, e di cui non
basta dire che non concerne il problema di fondo perchè si sia teoricamente e praticamente
autorizzati a fare come se non esistesse" (C. Lévi-Strauss, Razza e storia e altri studi di
antropologia, Einaudi, 1967)
(2) E. Jabès, Un étranger avec, sous le bras, un livre de petit format, Gallimard, 1989 (trad. it., Uno
straniero con, sotto il braccio, un libro di piccolo formato, SE, 1990). La traduzione, in questa sede,
è responsabilità mia
(3) Si veda il fascicolo, per altri versi stimolante, di Aut Aut, n. 241, 1991, dedicato interamente a
Jabès
(4) C. Schmitt, Le categorie del politico, il Mulino, 1972
(5) M. Leon-Portilla, El reverso della Conquista, cit. in G. Mazzoleni, Il diverso e l'uguale, Bulzoni,
1975
(6) G. Mazzoleni, cit.
(7) Un esempio tra i meno noti, rispetto ai selvaggi portati in tournée nel periodo coloniale, da cui
tanti illuministi presero spunto, si trova nei resoconti del viaggio in Europa di un capo delle Samoa
agli inizi del secolo (Il papalaghi - Discorsi del Capo Tuiavii di Tiavea delle isole Samoa,
Longanesi, 1981). Si tratta, se non proprio di un amabile falso letterario, di materiale
abbondantemente rielaborato, che ci aiuta comunque a vederci "con gli occhi dell'altro"
(8) Il fatto a cui ci riferiamo è raccontato nel libro, commovente e bellissimo, di T. Kroeber, Ishi un
uomo tra due mondi - La storia dell'ultimo indiano Yahi, Jaca Book, 1985, che merita una lettura
non superficiale
(9) Segnaliamo per esempio, i soli apparsi per ora in italiano, mentre altrove questo genere di
testimonianza è già un genere letterario, i libri di P. Khouma, Io, venditore di elefanti, Garzanti,
1990, e quello di S. Methnani, Immigrato, Theoria, 1990
(10) Per le condizioni e un tentativo di definizione della "società plurale" rimando al mio La sfida
dell'immigrazione, EMI, 1991
(11) L. A. Seneca, Lettere a Lucilio, Rizzoli, 1983
(12) F. Braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII), vol. I, Le strutture del
quotidiano, Einaudi, 1982
Presentazione