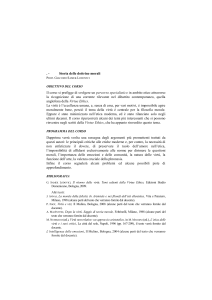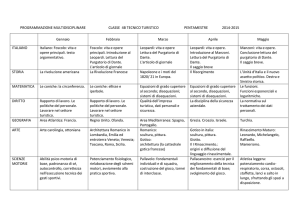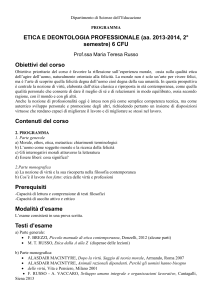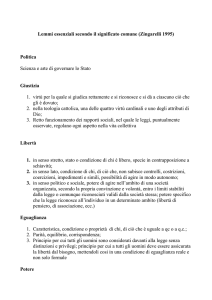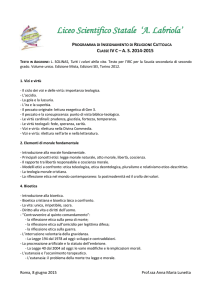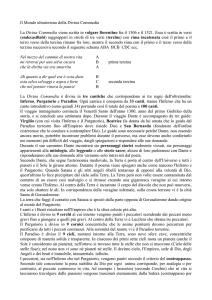LE BEATITUDINI EVANGELICHE E I PECCATI CAPITALI DEL PURGATORIO
Dalla Introduzione a Purg di Anna Maria
Chiavacci Leonardi.
È questo il punto essenziale, che caratterizza tutte queste anime, spesso gravemente peccatrici.
Ognuna di loro ha avuto un momento, spesso l'ultimo, di abbandono a Dio. Ricordiamo Buonconte:
«nel nome di Maria fini', e quivi / caddi...»; o Sapia: «Pace volli con Dio in su lo stremo / de la mia
vita...», Non le loro virtù le hanno salvate, come non i peccati hanno perduto gli altri.
Ora questo rivolgimento, o conversione – secondo il termine della teologia cristiana –, modifica
l'uomo dall'interno (e per questo la figura umana appare, come dicemmo, ben diversa che nella prima
cantica). Esso produce in quelle anime una qualità specifica, un carattere che sembra contrassegnare
tutta la cantica dantesca. Se si tenta di definirlo, si potrà chiamarlo – col termine più spesso da Dante
usato – dolcezza.
Ricordiamo l'attacco del racconto, sulla solitaria spiaggia: «Dolce color d'orïental zaffiro...», e
l'entrata nell'ultimo luogo del viaggio, nella divina foresta dell'Eden: «Un'aura dolce, sanza
mutamento / avere in sé, mi feria per la fronte / non di più colpo che soave vento».
Fra questi due estremi corre un continuo di atti, voci, aspetti, definiti dalla dolcezza nelle sue
molteplici variazioni, per quanto riguarda sia le forme sensibili sia gli atteggiamenti dell'animo.
Il Purgatorio dantesco è dolce nel suo aspetto e, negli animi dei suoi abitanti, mite. Nessuno di loro
pretende o accampa diritti, si ritiene grande o comunque autosufficiente; ma chiede e prega
umilmente l'aiuto altrui. Tutto il paesaggio che li circonda, e le similitudini che li raffigurano, si
accordano a questo tono fondamentale: ricordiamo le pecorelle, «timidette», «semplici e quete»; i
colombi, «queti, sanza mostrar l'usato orgoglio»; le capre, che «si stanno ruminando manse», cioè
mansuete. Anche gli atti stessi delle persone ritengono di questa comune qualità. Il Gabriele
dell'Annunciazione nel X canto apparirà «intagliato in un atto soave», e così è presentata Maria
sulla soglia del tempio: «e una donna, in su l'entrar, con atto / dolce di madre...».
Sovranamente dolci sono poi le musiche che percorrono, di balzo in balzo, tutta la montagna. Fin
dall'inizio, sulla spiaggia, così risuona il canto di Casella: «... cominciò elli allor sì dolcemente, /
che la dolcezza ancor dentro mi suona»; ma ricordiamo ancora la celebre apertura del canto VIII,
quando un'anima si leva a cantare l'inno di Compieta: «con sì dolci note, / che fece me a me uscir di
mente»; o l'ultima musica udita nel sacro monte, nella selva dell'Eden: «E una melodia dolce correva
/ per l'aere luminoso...». Ma gli esempi sono molto più numerosi, ripetendosi i canti via via ad ogni
passo del cammino, quasi segno d'identità del nuovo regno di fronte all'Inferno: «ché quivi per canti
/ s'entra, e là giù per lamenti feroci».
Qual è dunque, per porci la domanda interpretativa di cui sopra si diceva, l'idea che informa questo
mondo? Da che fonte discendono i tratti che abbiamo tentato di descrivere?
Se ci domandiamo in quale momento della storia della civiltà occidentale tali caratteri decisivi –
quella conversione del cuore, quella mansuetudine e umiltà come valori primari – vennero a
sostituire violentemente l'etica codificata dal mondo greco-romano, non sarà difficile riconoscere il
testo che sta alla base di questo mutamento: è la tavola delle Beatitudini evangeliche nel Discorso
della montagna (Matth. 5, 3-10), il manifesto, se così può dirsi, del mondo cristiano di fronte
all'antico.
Ora noi pensiamo che il vero punto dirimente tra le due cantiche dantesche – che è poi la grande
invenzione di Dante nel crearle – stia proprio in ciò: Dante ha ordinato l'Inferno sotto il segno
dell'etica classica, ma ha posto il Purgatorio sotto il segno delle Beatitudini evangeliche che di fatto
scandiscono la salita delle sette cornici –, quelle Beatitudini che dell'etica antica rappresentano un
totale superamento.
Se si guarda alla struttura, cioè allo schema delle ripartizioni di peccatori e pene, è ben noto che
l'Inferno è suddiviso secondo l'Etica Nicomachea – come Virgilio dice esplicitamente nella
spiegazione offerta nel canto XI – e come la giustizia è il massimo valore dell'etica antica, così
l'ingiustizia (l'ingiuria) ne è il massimo disvalore (Inf. XI 21-3); il Purgatorio invece è suddiviso
secondo i sette peccati capitali, che sono classificazione cristiana, introdotta da Giovanni Cassiano
nel secolo V e poi ripresa da Gregorio Magno e da Tommaso; il criterio di gerarchia fra di essi è
dato in questo regno – secondo la spiegazione fornita nel canto XVII – non dalla giustizia, ma
dall'amore. Solo l'amore è qui la misura del peccato.
Questo impianto già ci avverte della diversità radicale che corre fra i due mondi. Ma esso resta
ancora all'esterno, è appunto soltanto una struttura.
Quello che più conta, e che in genere non è avvertito, è la differenza qualitativa che passa tra i due
ordini (e che produce appunto la diversità straordinaria tra le due cantiche). Di qua importano –
cioè danno il senso spirituale a tutta la cantica – non tanto i sette peccati, ma le sette Beatitudini. Al
di qua di quella riva non c'è un'altra morale, ma qualcosa che la trascende e in certo senso la
vanifica. È lo spirito evangelico, che travolse quello etico dell'antichità (e che in ogni caso è oltre la
morale, quella cristiana stessa). Quel mondo infatti finisce là dove sono proclamati beati gli umili, i
piangenti, i pacifici, i perseguitati. In quel mondo regnano la giustizia e la magnanimità, in questo
la misericordia e l'umiltà.
Ponendo ad ogni balzo la proclamazione di una delle Beatitudini, e gli esempi della virtù ad essa
corrispondente, Dante ci ha dato il vero filo conduttore per intendere il suo Purgatorio. Se guardiamo
alle virtù presentate, ci accorgiamo infatti che esse non sono le virtù etiche – nessuna delle undici
virtù aristoteliche, citate nel Convivio, è qui presente – ma piuttosto l'atteggiamento dell'animo che
corrisponde alla beatitudine dichiarata (umiltà, misericordia, pace, sollecitudine nel bene, distacco
dal denaro e dal cibo, castità). Le une e le altre insieme – Beatitudini e virtù – intonano la cantica,
condizionandone l'atmosfera, i gesti e le parole dei suoi abitanti, e il colore stesso del suo cielo.
Delle antiche virtù, persino la giustizia – cardine dell'etica antica e massima delle quattro virtù
cardinali cristiane – è assente da questa tavola. Le virtù delle Beatitudini, o virtù spirituali – come
possiamo chiamarle, per distinguerle da quelle morali –, vanno infatti tutte molto al di là della
giustizia. I pacifici qui non sono coloro che non eccedono nell'ira, ma coloro che perdonano le offese,
anche mortali (l'esempio principe sarà quello del martire Stefano, che prega per i suoi persecutori);
la virtù opposta all'avarizia non è la sobrietà, ma la povertà estrema della stalla di Betlemme; i
misericordiosi non sono quelli che danno «con pronta liberalitate» (Conv. I, viii 2), ma coloro che
danno anche la vita per gli amici, come Pilade, o per i nemici, come il Cristo.
Ogni virtù del Purgatorio ha questo segno di oltranza; qui siamo nel regno del gratuito, che non
misura, che non dà «a ciascuno il suo», ma molto di più. Pensiamo a Manfredi: «Orribil furon li
peccati miei...»; a Buonconte, salvato «per una lagrimetta»; a Forese, giunto così in alto nel monte
grazie al «pianger dirotto» della moglie. Questa è nel Purgatorio la regola, non l'eccezione.
La grande invenzione dei pentiti dell'ultim'ora che aprono la serie dei salvati – raccolti nella prima
regione della montagna, una zona di attesa che è stata chiamata Antipurgatorio – offre in realtà
come l'insegna, il titolo a tutta la cantica, dove i convertiti tardi, «in su lo stremo de la vita», sono la
maggioranza.
Se tali sono, per definizione, i peccatori dell'Antipurgatorio – tra i quali Manfredi e Buonconte,
Belacqua, Iacopo del Cassero e Pia dei Tolomei – anche nelle balze superiori incontriamo la stessa
tipologia. Così tra i superbi Provenzan Salvani, pentito all'«orlo de la vita»; tra gli invidiosi Sapia,
che fece pace con Dio e in su lo stremo» della sua esistenza; tra gli avari papa Adriano V, la cui
conversione «fu tarda», solo dell'ultimo mese; tra i golosi Forese, peccatore fino all'ultimo, come
Dante sa bene, tanto che si stupisce di trovarlo già così in alto. Appare certo che Dante vuol
sottolineare questo carattere via via per tutta la cantica, quasi a porlo sempre sotto gli occhi del
lettore.
Ma che cosa significa il pentimento tardo, addirittura estremo, se non appunto la gratuità totale del
perdono? E la poca importanza del peccato, anche grave, anche durato un'intera vita? Certo non a
caso Dante ha scelto e proposto tali situazioni, tipicamente antietiche ed evangeliche: la parabola
dei lavoratori dell'ultim'ora (Matth. 20, 1-16), che da sempre ha scandalizzato i benpensanti, è
evidentemente la norma ispiratrice di questa serie, elemento chiave su cui non si è finora abbastanza
riflettuto.
Ma un secondo tema resta da indicare, strettamente connesso a questo: la richiesta della preghiera
dei vivi, che tutte le anime – senza eccezione – rivolgono a Dante lungo le balze del Purgatorio. Essa
fa da motivo principe parallelo a quello che nell'Inferno è la richiesta della fama, o memoria tra gli
uomini. Sono le due richieste fondamentali delle due cantiche, che ben ne riflettono i lineamenti: la
fama è infatti uno dei primi valori del mondo antico (la cosa più importante per un mondo limitato
alla terra e al tempo storico), ma in quest'altro mondo si chiede la preghiera altrui per ottenere la
vita eterna – valore che ha senso solo in una dimensione oltreumana, e di riconosciuta insufficienza.