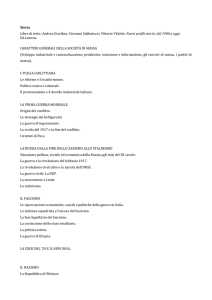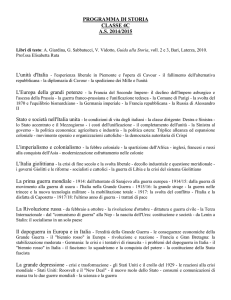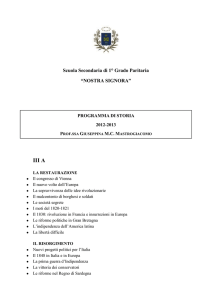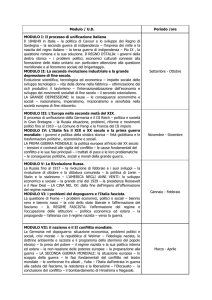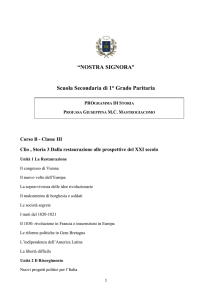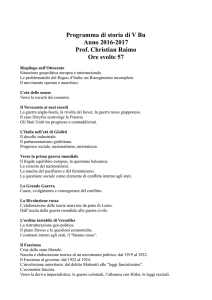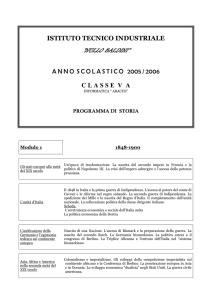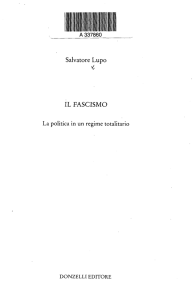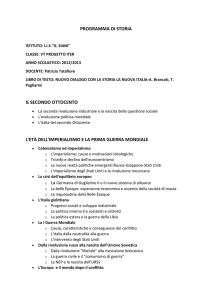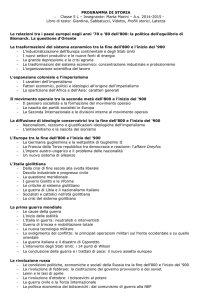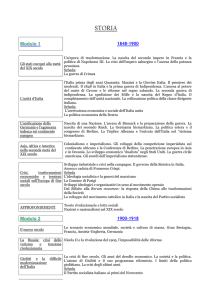Convegno nazionale di studi
nel Settantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione
1914-1944.
L’Italia nella guerra europea dei trent’anni
Firenze, 21-22-23 Maggio 2014
Aula Magna di Palazzo Fenzi – via San Gallo 10
con il patrocinio di
Regione Toscana
Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo
Progetto scientifico e coordinamento organizzativo: Simone Neri Serneri (coord.), Roberto
Bianchi, Fulvio Conti, Filippo Focardi, Mario Giuseppe Rossi, Silvia Salvatici, Luigi Tomassini
Istituto Storico della Resistenza in Toscana
via G. Carducci 5/37 - 50121 Firenze tel. 055 284296
[email protected] – www.istoresistenzatoscana.it
PROGRAMMA DEI LAVORI
Mercoledì 21 maggio 2014. Ore 10.30 – 13.00
Presiede Mario G. Rossi, Isrt-Università di Firenze
Saluti di
Alberto Tesi, Rettore Università di Firenze
Sara Nocentini, Assessore alla Cultura Regione
Toscana
Anna Benvenuti, Direttore Sagas
Valerio Onida, Presidente Insmli
RELAZIONI INTRODUTTIVE. L’Italia in Europa
Marcello Flores, Insmli - Università di Siena
Culture e pratiche della violenza
Pieter Lagrou, Université Libre de Bruxelles
Ripensare l’Europa nella guerra dei trent’anni
Dibattito
Mercoledì 21 maggio 2014. Ore 15.00 – 18.30
PRIMA SESSIONE. In conflitto per l’ordine politico
Presiede Filippo Focardi, Università di Padova
Maurizio Fioravanti, Università di Firenze
Il problema dell’ordine politico nella cultura
costituzionale del Novecento
Leonardo Rapone, Università della Tuscia
Rivoluzione, reazione, rivoluzione passiva
Paolo Soddu, Università di Torino
Dall’interventismo democratico alla rivoluzione
democratica?
Dianella Gagliani, Università di Bologna
Dalla nazione alla civiltà fascista
Dibattito
Giovedì 22 maggio 2014. Ore 9.00 – 13.00
SECONDA SESSIONE. Strategie della violenza
Presiede Marco Palla, Università di Firenze
Luca Baldissara, Università di Pisa
Lo stato della guerra. La "nazione organizzata" e
l'estensione della violenza
Giulia Albanese, Università di Padova
Il fascismo e la politica della violenza
Lucia Ceci, Università di Roma “Tor Vergata”
La Chiesa e la politica armata
Simone Neri Serneri, Isrt - Università di Siena
La scelta delle armi: volontari interventisti, militanti
antifascisti, partigiani combattenti
Dibattito
Giovedì 22 maggio 2014. Ore 15.00 – 18.30
TERZA SESSIONE. L’Italia in Europa. L’Europa in Italia
Presiede Fulvio Conti, Università di Firenze
Mariuccia Salvati, Università di Bologna
Culture del lavoro tra due dopoguerra: dal ghildismo
alle human relations
Javier Rodrigo Sanchez, Universitat Autònoma de
Barcelona
Circolazione di culture fasciste
Gianpasquale Santomassimo, Università di Siena
Eclissi e rinascita della democrazia negli anni
dell'antifascismo
Marco Bresciani, Università di Pisa
Giustizia e Libertà come osservatorio e laboratorio
della guerra civile europea
Dibattito
Venerdì 23 maggio 2014. Ore 9.00 – 13.00
QUARTA SESSIONE. Economie di guerra e stato sociale
Presiede Luigi Tomassini, Università di Bologna
Alessio Gagliardi, Università di Bologna
Per rifondare lo Stato: progetti corporativi tra
fascismo e antifascismo
Stefano Musso, Università di Torino
Lavoro e sindacato nell’economia fascista
Giuseppe Berta, Università Bocconi, Milano
La rappresentanza degli interessi imprenditoriali dal
liberismo al corporativismo
Giovanni Federico, Università di Pisa
Le conseguenze economiche dell’imperialismo
italiano
Stefano Cavazza, Università di Bologna
Consumi e stato sociale tra fascismo e antifascismo
Dibattito
Venerdì 23 maggio 2014. Ore 15.00 – 18.30
QUINTA SESSIONE. Culture sociali della modernità
Presiede Simone Neri Serneri, Isrt-Università di
Siena
Massimo Baioni, Università di Siena
Patriottismi in conflitto. Guerre di memorie e
rifondazione dell’italianità
Paul Corner, Università di Siena
Società e autorità: il caso italiano nell’Europa della
prima metà del Novecento
Maddalena Carli, Università di Teramo
Il fascismo in cerca della modernità
Paolo Capuzzo, Università di Bologna
"Un nuovo tipo umano": lavoro e consumo nella
società di massa
Dibattito e conclusione del convegno
AVVERTENZA
Tutti i testi riprodotti nel presente opuscolo sono provvisori e non possono
essere citati o riprodotti anche parzialmente senza esplicito consenso degli
autori e dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana.
RELAZIONI INTRODUTTIVE. L'Italia in Europa
Mercoledì 21 maggio, ore 10.30 – 13.00
MARCELLO FLORES, Insmli- Università di Siena
Culture e pratiche della violenza
Nel novembre 1935, due mesi dopo l’approvazione delle leggi di Norimberga, un mese dopo
l’aggressione dell’Italia fascista all’Etiopia e nel mezzo della purga che espelleva dal partito comunista
sovietico trecentomila iscritti, alla vigilia dei processi di Mosca e del Grande Terrore, il neurochirurgo
portoghese Antonio Egas Moniz praticava nell’ospedale Santa Marta di Lisbona la prima lobotomia, per
curare i suoi pazienti psichiatrici eccessivamente violenti o depressi. Questa innovazione, che nel 1949
procurò al suo autore il premio Nobel, ebbe luogo nel mezzo del periodo più violento della storia
d’Europa, di quella “guerra europea dei trent’anni”, che identifica il titolo del nostro convegno. Ma non
era la violenza in quanto tale a fare paura e a volere essere controllata, ma la violenza immotivata,
ingiustificata, la violenza arbitraria o almeno giudicata come tale pur se commessa da persone che si
riteneva non avessero completamente il libero arbitrio perché malate. Era la violenza individuale a fare
paura, non la violenza seriale dei massacri collettivi e delle guerre totali.
La medicina aveva dovuto fare i conti con la violenza da sempre, e le guerre avevano sempre costituito
un terreno propizio per il suo progresso. Nel corso della prima guerra mondiale, come è noto, la
chirurgia fece passi da gigante, ma non meno importante fu il riconoscimento delle nevrosi da guerra e
soprattutto degli shock da granata. Come scrisse un ufficiale medico britannico sul fronte francese:
“Dopo un violento shock emotivo, accompagnato o no da commozione fisica e ferite, il soldato
coraggioso diventa un codardo. E’ amputato del suo coraggio guerriero. Quando sente i cannoni ha
paura, trema e non può nascondere né controllare il proprio turbamento. E’ stato preso da una sorta di
anofilassi emotiva; non può più resistere vittoriosamente all’agonia del campo di battaglia. E’ un
invalido morale, mancante di coraggio.”1
Era la smentita, e cioè il capovolgimento, dell’entusiasmo con cui erano andati a combattere nella
prima guerra mondiale tantissimi giovani di tutta Europa, e che aveva fatto dire a Giuseppe Prezzolini
nell’agosto 1914: “Il mistero della generazione di un nuovo mondo si compie. Forze oscure scaturite
dalla profondità dell’essere sono al travaglio ed il parto avviene tra rivi mostruosi di sangue e gemiti
che fanno fremere. Noi non guarderemo soltanto al dolore. Salute al nuovo mondo! Ci darà la guerra
quello che molti delle nostre generazioni hanno atteso da una rivoluzione? L’animo è colmo di fronte
alla totalità del fatto che si compie e non possiamo dubitare del domani. La civiltà non muore!
Indietreggia per prendere un nuovo slancio. Si tuffa nella barbarie per rinvigorirsi.” 2
Sentimenti analoghi albergano nel cuore e nella penna di poeti e artisti di ogni paese. Il poeta Julian
Grenfell, educato a Eton e Cambridge, era già sotto le armi, in india, quando scoppia il conflitto
mondiale. Scrive alla famiglia: “Adoro la guerra. E’ come un grande picnic senza la mancanza di scopo di
un picnic. Non sono mai stato così bene e così felice… Qui siamo nel centro incandescente di tutto
questo. E non vorrei essere da nessun’altra parte neppure per un milione di sterline e la Regina di
Saba”3. Il 13 maggio 1915, mentre The Times pubblicava il suo poema «Into Battle», Grenfell veniva
ferito alla testa vicino Ypres, e moriva due settimane più tardi. Il pittore tedesco Otto Dix, che avrebbe
condiviso presto le esperienze pittoriche del dadaismo, doveva ammettere più tardi: “Dovevo avere
quella esperienza… Sono un uomo di realtà. Devo vedere ogni cosa. Ho bisogno di sperimentare
l’abisso della vita. Per questo andai volontario.”4. E il suo compatriota e collega Max Beckmann:
1
André Leri, Shell-Shock, Commotional and Emotional Aspects, London, 1919, p.118
Giuseppe Prezzolini, Facciamo la guerra, “La Voce”, 28 agosto 1914
3
Julian Henry Francis Grenfell, Into Battle, “The Times”, 12 May 1915
4
citato in Iain Boyd Whyte, Otto Dix’s Germany: From Wilhelmine Reich to East/West Divide, in Otto Dix, London 1992, p.28
2
“Quando la morte è ovunque, si vive più intensamente… Oscillo continuamente tra la grande gioia per
ogni cosa nuova che vedo, e la depressione per la perdita della mia individualità, e un profondo senso
ironico di me stesso e del mondo.”5 E il francese Louis Aragon, giovane aiutante medico, doveva
scrivere subito dopo la guerra: “Amammo la guerra come una negra. E con quale emozione… Non
abbiamo mai sufficientemente rimpianto questo stato eccezionale. Sacrifico volentieri l’umanità allo
spaventoso. Il sole della paura è un infuso incomparabile. La guerra, malgrado i suoi piccoli veleni, ha la
grandezza del vento.”6
Questo richiamo al punto di vista dei poeti-soldato non è solo per ricordare che molti di loro, almeno
chi sopravvisse, divennero già nel corso della guerra ostili alla «inutile strage». Ma perché la poesia fu
un’arma poderosa nel rafforzare ed esaltare il patriottismo e nel trasformarlo rapidamente in un
ardente nazionalismo. Nel solo primo mese di guerra in Germania e Gran Bretagna soltanto vennero
pubblicati cinquantamila poemi. Nella poesia è possibile ritrovare alcuni caratteri che distinguono le
culture della violenza che si costruivano e fronteggiavano alla vigilia del conflitto mondiale.
Permettendoci di affrontare un primo grande interrogativo che continuano a porsi gli studiosi della
violenza: che legame c’è tra essa e le strutture politiche e sociali del paese dove avvengono?
Nel giugno 1914 esce in Inghilterra il primo numero della rivista Blast (raffica, esplosione), diretta dal
poeta Wyndham Lewis, che aveva raggruppato attorno a essa una banda eterogenea di anti-futuristi, in
risposta alla pubblicazione in inglese del manifesto futurista avvenuta a inizio giugno e alla
presentazione fattane da Marinetti che, dopo aver affascinato anche le avanguardie inglesi tra il 1910 e
1913 le aveva irritate, spingendo appunto Lewis e i suoi sodali a costituire un nuovo movimento, il
vorticismo, di cui Blast costituiva per l’appunto il manifesto.
Detto in modo eccessivamente schematico, l’obiettivo di Lewis e dei suoi collaboratori – tra cui Ezra
Pound che aveva inventato il termine vorticismo e che, presentando la rivista a James Joyce, la
descriveva come un giornale prevalentemente d’arte «con me a scrivere poemi» – era quello di
contrastare l’anima bellicosa e guerriera del futurismo, puntando a estetizzare il fascino per l’energia e
per la velocità e a produrre un’arte violenta, non un’arte inneggiante alla violenza e alla guerra come
era avvenuto col futurismo.
In realtà i poeti-guerrieri britannici non seguiranno l’estetica del vorticismo e dell’avanguardia ma
piuttosto i canoni del pastoralismo della poesia georgiana tradizionale, che costituiva, come ha
raccontato ormai quasi quarant’anni fa Paul Fussell, un’antitesi stilistica alla calamità della guerra, un
codice estetico che la negava per cercare un conforto spirituale alla sua necessità. Coloro che andarono
a morire «per il re e per la patria» (Rupert Brooke autore di The Soldier e Wilfred Owen di 1914, tra gli
altri) erano inorriditi dalla violenza e dal militarismo espressi dai futuristi; mentre i loro colleghi e
coetanei austro-tedeschi vedevano nell’espressionismo la possibilità di raccontare emozioni
drammatiche e sentimenti intensi senza tornare al sentimentalismo romantico e senza cadere nella
violenza fredda del futurismo o nel disprezzo per le masse del modernismo.
La poesia di quegli anni ci permette di capire che “la nozione di un carattere nazionale fondamentale è
sia inutile sia ideologicamente sospetta per dar conto delle differenze poetiche” mentre è necessario
analizzare “le loro tradizioni poetiche, le comunità culturali, i luoghi di pubblicazione, i fattori
economici e istituzionali e altre consuetudini storiche”7.
Spazzato via, grazie alla poesia, l’equivoco sempre ricorrente – e a inizio Novecento in modo prevalente
– di nazioni e popoli «predisposti» più di altri alla violenza, e ricordato come l’entusiasmo per la guerra
e la celebrazione del patriottismo abbracciassero le culture di tutti i partecipanti al conflitto, si può
passare a indicare gli interrogativi fondamentali cui si può provare a rispondere con una rapida sintesi
di alcune esperienze storiche tra le due guerre:
5
citato da Carla Schulz-Hoffmann, War, Apocalypse, and the ‘Purification of the World’, in The Romantic Spirit in German
Art, 1790-1990, London, 1994, p. 198
6
“Littérature”, n. 15, 1920
7
Margot Norris, Teaching World War I Poetry: Comparatively, «College Literature», vol. 32, No. 3, Summer 2005, p. 138
-
la violenza di cui parliamo e le culture che la sorreggono sono legate allo stato o provengono
dalla società in funzione prevalentemente antiistituzionale?
- che rapporto ha la violenza con la modernità, ne è una sua caratteristica intrinseca?
- che rapporto ha la violenza con le strutture politiche (la democrazia) o con le strutture sociali (la
sicurezza, il welfare)?
- quali sono le cause principali della violenza e chi ne è l’obiettivo?
Certamente, tra il 1914 e il 1944 la violenza ha un carattere epocale, che non può essere ridotto tutto
alla prima guerra mondiale, che pure ha svolto un ruolo preminente nell’accrescerla, diffonderla e,
soprattutto, modificarla. La violenza statale, fino ad allora, si esplicava contro i movimenti di protesta,
in forme spesso anche dure, legittimate dal mantenimento dell’ordine. E la violenza dei movimenti
radicali di destra e di sinistra, pur se proiettata nell’illusione (o nella speranza) di un mutamento
sostanziale del regime politico, in realtà ne restava largamente all’interno. L’esaltazione della violenza
contro la società borghese e decadente (da parte socialista e anarco-sindacalista) s’intreccia già prima
della guerra con quella di un nazionalismo di tipo nuovo, di cui Corradini e Marinetti sono due simboli
diversi ma convergenti. Al congresso costitutivo dell’Associazione nazionalistica a Firenze, nel dicembre
1910, il primo aveva dichiarato: “come il socialismo insegnò al proletariato il valore della lotta di classe,
così noi dobbiamo insegnare all'Italia il valore della lotta internazionale.
Ma la lotta internazionale è la
guerra?
Ebbene, sia la guerra!
E il nazionalismo susciti in Italia la volontà della guerra vittoriosa.”8 E
Marinetti, appena qualche mese prima, nella 2a serata futurista al Teatro Lirico a Milano del 15
febbraio, gridava che “La Guerra, Futurismo intensificato, non ucciderà mai la Guerra, come sperano i
passatisti, ma ucciderà il passatismo. La Guerra è la sintesi culminante e perfetta del progresso
(velocità aggressiva + semplificazione violenta degli sforzi verso il benessere). La Guerra è una
imposizione fulminea di coraggio, di energia e d'intelligenza a tutti.”9
Nel momento in cui è lo stato, con la guerra, ad assumersi la responsabilità di una violenza totale, essa
diventa un terreno di coltura che perdurerà anche dopo la fine del conflitto, porta a un mutamento del
carattere stesso della violenza che si rivolge sempre più verso i civili, in cui il nemico non è più lo stato
avverso ma un intero popolo. Nel contesto della guerra vanno a fondersi diverse esperienze: l’eredità
del socialdarwinismo, e cioè di teorie razziste pseudoscientifiche che hanno classificato
gerarchicamente l’umanità intera, e del colonialismo, che ne è stato la pratica attuazione da parte degli
appetiti espansionistici europei; le ideologie di ribellione e rivolta (dal socialismo, all’anarcosindacalismo, al nazionalismo) che vedono nel parlamentarismo liberale e nella sua crisi l’incarnazione
di quella democrazia che va combattuta e sostituita con una palingenesi totale fondata sulla classe,
sulla nazione, o sul loro intreccio (la nazione «proletaria» che si muove finalmente con la guerra di
Libia); le pulsioni all’affermazione della propria identità etnica sia come purificazione demografica
dall’altro nel proprio territorio sia come aspirazione a uno stato etnicamente omogeneo.
La violenza che si manifesta nei Balcani e nell’impero ottomano nel corso del primo conflitto mondiale
(già largamente anticipata nelle guerre balcaniche) e che trova nel genocidio degli armeni il suo
culmine di brutalità, non è un fenomeno isolato, anche se quella dimensione sembra irraggiungibile
altrove (come nello «stupro del Belgio» compiuto dalle armate tedesche). La radicalizzazione della
violenza nel corso della guerra e i suoi effetti brutalizzanti si fanno sentire dai paesi baltici all’Ucraina e
alla Polonia anche e soprattutto dopo la fine del conflitto, così come di nuovo nei Balcani e nel Medio
oriente, dove le popolazioni civili subiscono – con massacri, deportazioni, spostamenti coatti e
«scambi» demografici – una violenza spesso analoga o peggiore di quella degli anni di guerra.
8
Enrico Corradini, Classi proletarie: socialismo; nazioni proletarie: nazionalismo, in Il nazionalismo italiano, Atti del
congresso di Firenze, Quattrini, Firenze, 1911, p. 33
9
Luigi Scrivo, Sintesi del futurismo. Storia e documenti, Bulzoni, Roma, 1968, p. 115
È la violenza della guerra, in ogni modo, a caratterizzare in modo nuovo quella che ha luogo – ovunque
– nel dopoguerra. È possibile classificarla in qualche modo? Ian Kershaw10 ha sostenuto che gli effetti
della guerra sono stati scarsi nelle culture politiche dove vi erano stabili e radicate strutture, valori e
mentalità democratiche, come in Gran Bretagna in primo luogo ma sostanzialmente in tutti i paesi
vincitori a eccezione dell’Italia. Lì, infatti, l’assenza di logiche di rivoluzione e controrivoluzione, la
mancanza di dispute territoriali, le ambizioni imperiali già soddisfatte e il senso identitario nazionale
fondato più sul costituzionalismo e sullo stato che sulla etnicità e la cultura, avrebbero impedito quel
diffondersi di violenza che ebbe luogo in quei paesi (Germania, Austria, Polonia, Ungheria,
Cecoslovacchia, Romania, Jugoslavia) dove il nazionalismo etnoculturale, intrecciato spesso a un senso
di superiorità nazionale e a una discriminazione delle minoranze, trovava spazio sia dove si piangeva la
perdita dell’impero sia dove si festeggiava l’indipendenza acquisita.
È l’intreccio di più elementi – l’esito disastroso della guerra, il collasso dello stato, l’instabilità politica,
la disputa territoriale in aree etnicamente composite mentre le dinamiche della modernizzazione si
fanno sentire non solo oggettivamente, ma nel bisogno soggettivo di partecipazione delle masse – a
favorire la violenza. Che, dove può, trova le minoranze come capro espiatorio o individua un nemico
«interno» favorendo la rapida deriva da guerra civile europea (tra stati) a guerra civile permanente
negli stati europei per tornare poi, alla fine degli anni Trenta, alla guerra civile europea totale.
In Italia, come ci diranno certamente le relazioni che se ne occuperanno più in profondità, il
risentimento nazionalista frustrato e le speranze utopiche fallite del mondo socialista favoriranno il
terreno politico e culturale per l’affermarsi della violenza fascista. È la politicizzazione della violenza e il
suo ancorarsi a un conflitto ideologico sempre più aspro che rende nuovi e diversi i conflitti postbellici
anche dove il loro carattere etnoculturale è ancora abbastanza marcato.
Sarebbe errato, tuttavia, ancorare soltanto alla violenza gli effetti della guerra (della prima come della
seconda). Come ha ricordato quasi vent’anni fa Geoff Eley, infatti, “è solo dopo il 1918 che la
democrazia acquista una diffusione generale come modello di politica o di sistema di governo (e allora
con molta incertezza e provvisorietà come mostreranno gli anni Venti), ricevendo un ulteriore e vitale
incremento nella sua diffusione internazionale dopo il 1945”.11
I regimi costituzionali che si creano nel primo dopoguerra, ex novo dal disfacimento degli imperi o
come correzione profonda dei regimi liberali di prima del conflitto, sono estremamente fragili (tranne
che in Gran Bretagna, Francia, Olanda e paesi scandinavi) perché si fondano su un compromesso, che
rende la sovranità parlamentare debole e alla lunga inefficace, dietro cui non c’è nessun movimento i
cui valori siano pienamente democratici e costituzionali. Alla violenza dei movimenti rivoluzionari si
affianca quella dello stato anche nella sua nuova versione quasi democratica. La guerra, infatti, ha
favorito i comportamenti illiberali e violenti nella sfera pubblica e ha legittimato l’uso della violenza. In
Germania, così, lo scontro tra rivoluzione e controrivoluzione è anche quello, armato, tra
socialdemocratici e comunisti, che culmina nella settimana di sangue berlinese e nell’assassinio di Rosa
Luxemburg e Karl Liebknecht. Il potere statale si rafforza parallelamente ai movimenti antisistema
dentro la società, proprio mentre quella che i sociologi hanno chiamato la «istituzionalizzazione dello
stato» comporta una crescente penetrazione dello stato nella società. Nei nuovi stati indipendenti
dell’Europa centrale il nuovo insediamento democratico (parlamento, sindacati, libertà civili e welfare)
è accompagnato invece dalla limitazione della sfera pubblica in nome dell’ordine e della protezione che
lascia sulla difensiva (Cecoslovacchia e Jugoslavia) o sconfitti (Ungheria) o ghettizzati (Polonia) i
movimenti sociali. E dove il nazionalismo, alimentato dalla presenza di minoranze etnoculturali o, come
nel caso della Polonia, dall’aggressione «rivoluzionaria» sovietica del 1920, diventa la cultura stessa
delle nuove costituzioni.
10
Ian Kershaw, War and Political Violence in Twentieth-Century Europe, in «Contemporary European History», Vol. 14, No. 1
(Feb. 2005), pp. 107-123
11
Geoff Eley, War and the Twentieth-Century State, «Daedalus», Vol. 124, No. 2 (Spring 1995), p. 161
Se si escludono le democrazie pre-guerra, quindi, anche dove la democrazia, con tutti i limiti possibili,
ha costituito l’esito del conflitto mondiale, le culture della violenza hanno continuato a sussistere e
spesso a prosperare. Come cultura della rivoluzione e della sovversione antisistema, come cultura
etno-nazionalistica di discriminazione delle minoranze, come cultura burocratica dello stato moderno e
dei suoi apparati. Sono queste ideologie, nel loro insieme, che utilizzando l’eredità della guerra e le
contingenze contraddittorie e turbolente del dopoguerra, sanciscono la nascita di una moderna idea di
violenza politica, ben diversa da quella di prima del conflitto. Con il fallimento dell’ipotesi
rivoluzionaria, riemerge nel dopoguerra il modello autoritario come risposta generale alla
modernizzazione: tanto negli stati appena costituitisi in modo indipendente quanto nei paesi usciti
sconfitti dalla guerra.
E’ in questi che potremmo chiamare, con una terminologia di fine ‘900, stati di transizione, che i partiti
trovano maggiore difficoltà a proporsi come collettori di istanze unitarie e universali; che le istituzioni
non riescono a superare il loro carattere duale e antagonista (ad esempio tra parlamento ed esecutivo,
tra forze armate e parlamento, tra notabili e partiti); che lo stato non riesce a controllare e incanalare
le ideologie di mobilitazione e conflitto che accompagnano l’allargamento del suffragio. La violenza è
l’eredità più forte e traumatica che la guerra ha lasciato, un connotato al tempo stesso culturale e
comportamentale che viene sempre più vissuto come naturale e necessario. I movimenti fascisti
saranno quelli maggiormente capaci – in Italia all’inizio degli anni ’20 e in Germania all’inizio degli anni
’30 – a rivolgersi a queste moderne constituencies e a coinvolgere così, accanto ai militanti, ampi strati
di popolazione irrequieta e impaurita pronta a dare fiducia a un qualsivoglia progetto autoritario
vincente. Nella crisi del dopoguerra, il bisogno di totalità che accompagna la modernità diventa ancora
più forte, e si connota dei tratti ereditati dalla guerra: gerarchia e cameratismo, immagine del capo e
fascino dell’istituzione totale, elitismo e disprezzo delle masse, voglia di potere e disumanizzazione
dell’avversario. E’ su queste linee che si crea l’organizzazione politica e paramilitare del fascismo, che fa
della glorificazione della violenza – democratizzata dalla guerra – uno dei suoi tratti maggiormente
distintivi.
L’insistenza sui valori «maschili» di coraggio e disciplina da parte dei movimenti nazionalisti e fascisti,
attrae l’elettorato conservatore: che vede come una minaccia alla propria esistenza e ai propri privilegi
l’avanzata della democrazia sotto l’aspetto di miglioramenti per gli operai, le donne, le minoranze
nazionali. Il fascismo cresce nella modernità creata dalla guerra e la sua violenza si manifesta in modo
tutt’altro che irrazionale. L’agenda rivoluzionaria del fascismo si presenta con il volto di una
modernizzazione generazionale che alimenta tensioni e disordini ma propone integrazione e ordine.
Saranno i regimi totalitari, nel loro insieme, a consegnare la violenza come uno dei tratti costitutivi
dell’epoca tra le due guerre. Accanto al fascismo italiano e al nazionalsocialismo tedesco non si può
dimenticare, in questo ambito, l’esperienza e l’eredità della rivoluzione bolscevica e del comunismo
sovietico. Se negli anni Trenta il regime stalinista sarà avvolto in quello che Katerina Clark ha chiamato
un «ecosistema di violenza»12, in cui si trovano all’opera contemporaneamente i fattori ambientali
specifici della Russia e gli aspetti della modernizzazione di natura più universale, non si può
dimenticare che una “forma di «radicalizzazione cumulativa» avvolse il sistema e l’individuo con ondate
di quasi continua violenza dalla prima guerra mondiale alla caduta dell’impero zarista attraverso la
guerra civile, la collettivizzazione e il Grande Terrore.”13
Era stato in particolar modo il linguaggio della guerra civile e la cultura che si forma in essa,
direttamente legata e conseguente alla rivoluzione d’Ottobre, a costruire la mentalità che informa da
allora i quadri dirigenti e militanti del partito e dello stato, individuando nel «nemico» dello stato
l’obiettivo contro cui la violenza può dispiegarsi con ogni mezzo. Quel nemico che, già nel corso della
prima guerra mondiale, era stato alla base dei sentimenti espressi dai poeti-guerrieri. “Edward Thomas
12
13
Katerina Clark, Petersburg: Crucible of Cultural Revolution, Cambridge UP, Cambridge, Mass.,1995, p. ix–x
Lynne Viola, The Question of the Perpetrator in Soviet History, in «Slavic Review», Vol. 72, No. 1 (Spring 2013), p. 16
aveva terminato il suo poema con il verso «Come amiamo noi stessi noi odiamo il nostro nemico». Ci si
potrebbe ragionevolmente aspettare che l’amore fosse l’ispirazione della poesia patriottica, ma l’odio
sembra essere la forza più potente.”14
È in questo carattere ideologico moderno della violenza, che prevede e giustifica l’uccisione in nome
della razza, della classe, dello stato-nazione, e che vede i nemici etnici o di classe come permanenti,
impossibili da rieducare, in questa nuova identità totalitaria del potere, che sta la radice di
quell’universo concentrazionario che rappresentò il vertice più tragico e impensabile della violenza
esplosa e radicata in Europa con la prima guerra mondiale.
PIETER LAGROU, Université Libre de Bruxelles
Ripensare l’Europa nella guerra dei trent’anni
I trent’anni che separano il 1914 dal 1944 sono caratterizzati da un intenso confronto fra concezioni
opposte della politica moderna. L’Europa sembrava condividere durante i decenni precedenti il 1914
una diagnosi sulle cause e le soluzioni dell’ instabilità politica. La democrazia borghese basata sul
suffragio limitato viziava la politica dei governi nazionali. Il suffragio universale avrebbe portato
giustizia ed efficacia nella politica interna. L’esistenza di imperi multinazionali e l’inadeguatezza del
tracciato delle frontiere impedivano l’emergere di un sistema europeo di stati nazionali legittimi e
stabili che solo il pieno rispetto del diritto dei popoli all’autodeterminazione avrebbero permesso.
La primavera del suffragio universale e del diritto dei popoli all’autodeterminazione dopo il 1918 fu di
brevissima durata. Entrambe le soluzioni furono all’origine di nuove instabilità che né i sistemi politici
nazionali né la nuova struttura europea della Società delle Nazioni riuscivano a controllare. Il fallimento
drammatico della fede democratica del Novecento nella combinazione del suffragio universale e
dell’autodeterminazione dopo il 1918 impediva la sua semplice rinascita nel 1944. La questione delle
minoranze nazionali non era un problema minore dell’autodeterminazione che un insieme di trattati
internazionali poteva risolvere, ma una sfida al cuore del sistema europeo, che fu risolto con un
impiego massiccio della violenza e spostamenti di popolazioni senza precedenti. Le sperimentazioni del
suffragio universale avevano insegnato che l’elettorato popolare doveva essere inquadrato da partiti di
massa efficaci e disciplinati, capaci di offrire un insieme di servizi al di là della mera rappresentanza
politica. Soprattutto, la sopravvivenza della democrazia dipendeva dalla capacità dei governi di
produrre stabilità economica e giustizia sociale, uno Stato assistenziale che era apparso incompatibile
con la democrazia parlamentare, dagli anni 1870 agli anni 1930.
La “guerra dei trent’anni” non fu dunque solo un confronto fra una prospettiva autoritaria e una
democratica ereditata dall’Ottocento, nel quale l’ultima uscì come vincitrice. La democrazia moderna
era un compromesso precario e provvisorio fra principi oppositi: la sovranità del popolo e i diritti
individuali; nazionalità ed universalità. La guerra dei trent’anni ha contribuito non poco a ridefinire il
contenuto delle nostre concezioni della democrazia contemporanea in un compromesso non meno
precario e provvisorio oggi di quanto lo fosse nel 1914 o nel 1944.
PRIMA SESSIONE. In conflitto per l'ordine politico
Mercoledì 21 maggio, ore 15.00 – 18.30
Presiede: Filippo Focardi, Università di Padova
14
Elizabeth A. Marsland, The Nation’s Cause. French, English and German Poetry of the First World War, Routledge, London,
1991, p. 63
MAURIZIO FIORAVANTI, Università di Firenze
Il problema dell'ordine politico nella cultura costituzionale del Novecento
1.Premessa. L’oggetto della ricerca. L’oggetto : cosa s’intende per “ cultura costituzionale “. La
delimitazione temporale : dalla stagione del tardo Stato liberale alla stagione in cui si apre il processo
costituente democratico. Un trentennio che contiene in sé il ventennio fascista, in modo da poter
raffrontare il progetto autoritario maturato nel ventennio sia con il segmento del trentennio che lo
precede, ovvero con la cultura costituzionale del tardo Stato liberale, sia con il segmento del trentennio
che lo segue, ovvero con la cultura costituzionale che preannuncia l’esito in senso democratico.
2. Il punto di partenza : lo Stato legislativo di diritto. E’ la forma di Stato dominante in Europa, ed anche
in Italia, tra Otto e Novecento. La cultura costituzionale che sorregge questa forma di Stato viene
reperita in un testo in questo senso assolutamente esemplare : il “ Diritto pubblico italiano “ di Santi
Romano ( 1914 ). I punti qualificanti sono tre : la genesi dello Stato, la garanzia dei diritti, il primato
della legge, tutti accomunati dalla critica alla Rivoluzione, ai paradigmi contrattualistici e
giusnaturalistici, ad ogni logica che pretenda di essere costruttiva di ordine politico partendo dal basso,
in senso costituente. Percezione della “ crisi “ di questo sistema, ma anche fiducia nella stabilità dello
Stato liberale di diritto, da riformare ma non da superare. Il valore ritenuto irrinunciabile della “ forza
oggettiva “ del diritto, che in concreto significa permanente dominio dello Stato sugli interessi
organizzati.
3. Il progetto autoritario. E’ il progetto che matura a partire dalla metà degli anni Venti, e che noi
riferiamo alla figura di Alfredo Rocco. Complessità della problematica della “ sovranità dello Stato “ e
del rapporto tra le elaborazioni in proposito della scuola giuridica nazionale e il progetto autoritario di
Rocco. Prevale però a nostro giudizio la discontinuità, che consiste essenzialmente nella ricerca del
principio di unità politica fuori dai confini tradizionali dello Stato nazionale, direttamente nella società,
in mezzo agli interessi organizzati, per ricondurli ad un’unità superiore, in modo da poterli considerare
come un unico complesso di “ forze “, che operano sotto la guida di un “ Capo riconosciuto” , come
recita la nota relazione al disegno di legge del 1925. E’ questo il nuovo ordine politico, presentato come
un fatto, cui conformare le regole del parlamentarismo fino a quel momento operanti. Non è più un
semplice irrobustimento dello Stato. E’ proprio un altro modo di pensare l’ordine politico, come fatto
di dominio organizzato nella società, che alla lunga si autorappresenterà, libero da ogni regola.
4. Il progetto democratico. C’è anche una terza cultura costituzionale. Non quella statalistica
tradizionale di Orlando e di Santi Romano. Non quella nuova, ma in senso decisamente autoritario, di
Alfredo Rocco. Il personaggio emblematico per questa terza soluzione è Costantino Mortati, in
particolare con la sua dottrina della costituzione in senso materiale ( 1940 ). Indicandolo a capofila del
“ progetto democratico “ non s’intende dire che Mortati nel 1940 preannuncia la Costituente
democratica. S’intende dire che Mortati fornisce un modello di ordine politico che trascende il regime
fascista, utilizzabile anche oltre, come in effetti accadde alla Costituente. Mortati come Rocco non
crede più alla rappresentazione dell’ordine politico nella figura tradizionale dello Stato. Come Rocco,
ricerca il principio dell’ordine politico direttamente nella società. Ma mentre Rocco cerca e trova nella
società il fatto nuovo della organizzazione delle masse attorno al “ Capo riconosciuto “ Mortati cerca e
trova, nello stesso luogo, la dimensione della norma fondamentale. E’ una differenza grande : non più
un fatto cui conformare l’ordinamento, ma una norma, un dover essere che vincola gli stessi detentori
del potere. Sarà in questo senso brevemente illustrato senso e significato della dottrina della
costituzione in senso materiale.
5. Il punto di arrivo : lo Stato costituzionale . Brevi considerazioni conclusive sulla cultura costituzionale
che sorregge la Costituente e la successiva battaglia per l’attuazione della Costituzione. Suo legame
profondo con la dottrina mortatiana della Costituzione come indirizzo fondamentale, pensata e
costruita nel corso degli anni Trenta, in rapporto alla ricerca della dimensione “ materiale “ della legge
fondamentale.
LEONARDO RAPONE, Università della Tuscia
Rivoluzione, reazione, rivoluzione passiva
Il trittico che figura nel titolo rimanda di tutta evidenza a categorie analitiche e interpretative proprie
dell’apparato concettuale e della cultura politica dei comunisti. Nell’ambito di un convegno in cui si
intende saggiare il potenziale esplicativo, in relazione alla situazione italiana, di una categoria sintetica
che abbraccia in una visione d’insieme il periodo 1914-1944, si è pensato di ripercorrere uno sviluppo
di pensieri culminante anch’esso in una categoria che ambiva a fornire una chiave di lettura
complessiva del periodo apertosi con la Prima guerra mondiale, quella appunto di rivoluzione passiva.
Naturalmente, non fosse altro che per il fatto di essere stata elaborata da Gramsci nella prima metà
degli anni Trenta, la categoria della rivoluzione passiva è inassimilabile a quella di guerra dei trent’anni;
più che il nesso tra due guerre esplora il nesso tra guerra, crisi e possibile assestamento su nuove basi
dei quadri economici e sociali; più che con la guerra dei trent’anni si misura semmai, per ricorrere ad
un’altra espressione fortunata, con la crisi dei vent’anni.
La categoria della rivoluzione passiva presuppone il rovesciamento, sotto il peso dei fatti, di quella
visione dello sviluppo storico imperniata sull’attualità della rivoluzione, che si era formata nel corso
della guerra in ambito socialista, già prima della rivoluzione bolscevica. Elementi di quella visione
vengono però recuperati nell’analisi della crisi di autorità apertasi con la guerra, caratterizzata dallo
sgretolamento delle precedenti forme di controllo sociale in seguito ai processi di mobilitazione
collettiva, per effetto dei quali la stessa reazione sociale e politica assume caratteristiche particolari,
che suggeriscono la necessità di analizzare il fascismo dall’angolo visuale delle soluzioni che esso offre
al problema dell’organizzazione delle masse. Mentre questa linea di pensiero sarà sviluppata
compiutamente nel filone interpretativo che condurrà Togliatti a proporre una rappresentazione del
regime fascista speculare a quella dello Stato autoritario di masse teorizzato da Rocco, Gramsci sposta
l’attenzione sui processi di riorganizzazione dell’economia e di ridefinizione del rapporto tra il politico e
l’economico che si accennano sotto l’armatura giuridica del fascismo.
Come si arriva a ricomprendere il fascismo nello schema interpretativo della rivoluzione passiva,
originariamente pensato per altre epoche storiche? e quale visone del corporativismo, e in generale dei
propositi razionalizzatori (propositi, assai più che successi effettivamente conseguiti) di disciplinamento
statale delle forze economiche, motiva quell’inclusione? Si risponderà a questi interrogativi attraverso
un metodo di lettura delle note dei Quaderni del carcere che ripercorre lo sviluppo del pensiero in base
alla successione cronologica della redazione dei testi, secondo il filo delle modificazioni che si
determinano attraverso i successivi passaggi: il solo che permette di cogliere la dinamica di una
riflessione in progress, così come ce la rivela un’opera che non ha la compattezza di un libro e che
l’interprete non può trattare come se fosse possibile estrarne una unità virtuale di concezione di cui
mancano i presupposti. Infine si rifletterà sul senso di un’analisi del corporativismo dall’angolo visuale
non tanto della questione della proprietà, ma di quella dei tentativi di modernizzazione dell’apparato
industriale italiano (il che rimanda alla presenza nella galassia corporativa del filone tecnocratico che si
esprimerà nei rimpianti sulla rivoluzione mancata), e sulle ragioni per cui, in una prospettiva che resta
comunque irrinunciabilmente anticapitalistica e basata sui fondamenti teorici del marxismo,
l’attenzione si appunti sui conati modernizzatori di ispirazione fascista, sino a farne il perno
dell’interpretazione degli sviluppi in atto nell’Italia degli anni Trenta.
PAOLO SODDU, Università di Torino
Dall’interventismo democratico alla rivoluzione democratica?
Nel corso del Novecento italiano ha operato una cultura politica democratica tout court, tesa fin dalle
origini a oltrepassare il campo delle religioni politiche e a superare i confini nazionali, traducendo in
italiano le profonde e decisive trasformazioni che alimentarono la presenza dei democratici in
Occidente.
Le radici di quella cultura erano anche in questo caso nel rivolgimento provocato dalla Grande Guerra
che, dalla dissoluzione del radicalismo italiano, vide faticosamente prendere forma un ripensamento
profondo le cui origini erano nell’interventismo democratico - e segnatamente nelle pagine del
quindicinale «Volontà» - e nelle brevi ma intensissime esperienze di Giovanni Amendola e di Piero
Gobetti. Il ripensamento delle culture liberali e democratiche si proponeva di individuare una soluzione
al problema storico dell’Italia unita alternativa rispetto a quella affermatasi con la dittatura fascista.
Aspirava, infatti, a realizzare quello che si rivelò l’impossibile superamento dei confini liberali per
giungere all’immersione piena nell’inclusiva dimensione democratica pluralista.
Quelle esperienze furono alla base della proposta dei democratici del Partito d’azione, con la loro
lettura tutt’affatto originale della guerra civile europea e delle trasformazioni che produsse in
Occidente. In più essi vi portarono uno sguardo più ampio, che oltrepassava l’Europa e abbracciava
l’esperienza del New Deal, intravista come la svolta effettiva dei sistemi democratici, che andava
reinterpretata nella costruzione dell’Italia democratica succeduta alla dittatura fascista.
Al perseguimento dell’obiettivo di una democrazia compiuta, all’interno della quale il conflitto fosse
vitale espressione della vivacità del paese e non forza distruttiva antisistema, spesero le loro risorse
politiche nel primo quarantennio della Repubblica, fino al decisivo contributo dato alla rivitalizzazione
della presidenza della Repubblica negli anni di Pertini.
DIANELLA GAGLIANI, Università di Bologna
Dalla nazione alla civiltà fascista
L’idea di nazione era centrale nell’universo ideologico del fascismo e nella fase iniziale ne costituiva
addirittura il perno o, ancor di più, l’unico punto di riferimento programmatico, a detta degli stessi
maggiori esponenti del fascismo.
Il fascismo, il cui scopo dichiarato era “governare la nazione” con il “programma necessario ad
assicurare la grandezza materiale e morale del popolo italiano”, andò ben presto sempre più
indirizzandosi verso una definizione ‘esclusivista’ di nazione che superava quella del nazionalismo
autoritario e illiberale. ‘Nazione’ e ‘Rivoluzione’, non dovendo essere disgiunte, condussero a una
tensione (e pratica) totalitaria che sarebbe andata ben oltre un qualsivoglia ipernazionalismo. La
nazione non poteva essere che fascista e a questo connubio si devono far risalire l’allargarsi del campo
dell’”antinazione” a frange inizialmente non investite dalla furia dello squadrismo e la stessa
costruzione della dittatura.
Che il fascismo sia stato o non sia stato una rivoluzione qui poco importa. Per noi è importante
sottolineare, all’interno del mondo fascista, il nodo della relazione tra ‘nazione’ e ‘rivoluzione’ e tra
‘nazione’ e ‘civiltà’, termine quest’ultimo che si sarebbe sviluppato negli anni Trenta specialmente
dopo la conquista dell’Etiopia e la formazione dell’impero. A questo nodo, ovvero alla preminenza da
conferire all’uno o all’altro termine, si possono connettere l’accentuazione bellicista e le vere e proprie
aggressioni belliche (fino alla dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna, e oltre), sia la politica
di ‘purificazione razziale’, sia una peculiare politica gendered, sia le costruzioni ideologiche geopolitiche
imperiali ed europee, sia, anche, la destituzione del dittatore il 25 luglio 1943, sia, per finire, le diverse
scelte di collaborazione o alleanza con la Germania nazista dopo l’8 settembre per quanti si ritrovarono
con Salò. Naturalmente anche in connessione con le vicende storiche più generali.
Si darà conto sommariamente, oltre che delle costanti di fondo dell’ideologia fascista, di quelli che si
individuano come passaggi significativi, quando non vere e proprie svolte.
SECONDA SESSIONE. Strategie della violenza
Giovedì 22 maggio 2014,. ore 9.00 – 13.00
Presiede Marco Palla, Università di Firenze
GIULIA ALBANESE, Università di Padova
Il fascismo e la politica della violenza
Se la storiografia degli ultimi vent’anni ha evidenziato l’importanza del rapporto tra prima guerra
mondiale e sviluppo delle pratiche e delle politiche della violenza, l’esperienza fascista italiana si
presenta come un caso fondamentale di analisi di un rinnovato rapporto tra violenza e politica
nell’Europa tra le due guerre.
Se, per un verso, si può osservare che il ciclo movimento-regime corrisponde allo sviluppo temporale di
radicalizzazione e sviluppo di movimenti paramilitari e stabilizzazione cui si assiste in molti contesti
dell’Europa occidentale e orientale, la costituzione del governo Mussolini e le specifiche forme di
“normalizzazione” della violenza movimentista e di costruzione di un apparato repressivo costituiscono
un modello fondamentale per il resto dell’Europa e segnano la nascita di un nuovo tipo di regime
autoritario.
Sarà proprio per la capacità di gestire una ambigua continuità istituzionale – formale – con il regime
liberale, malgrado una profonda rottura ideologica e delle pratiche politiche, in cui il rapporto con la
violenza spicca come una componente fondamentale, che il regime fascista costituirà almeno fino agli
anni trenta, un modello per le destre conservatrici, reazionarie e rivoluzionarie del resto di Europa. In
questo contesto, tuttavia, malgrado la gran quantità di studi sulla violenza nelle diverse fasi in cui
tradizionalmente si articola la storia del fascismo in Italia (origini, regime, Rsi), la storiografia ha finora
mancato l’obiettivo di realizzare una lettura complessiva delle continuità e delle discontinuità, tanto a
livello ideologico, che delle pratiche politiche, della violenza nel fascismo e di collocare questa storia
generale nel più ampio contesto europeo.
LUCIA CECI, Università di Roma “Tor Vergata”
La Chiesa e la politica armata
Domande di partenza
Le domande di partenza del mio intervento possono essere sintetizzate in questi termini: quali sono le
riflessioni della Chiesa sulla politica che si fa con le armi nell’arco temporale 1914-1944? Quali
orientamenti maturano dinanzi alla realtà di conflitti sempre più estesi e violenti? E’ possibile
rintracciare nella Chiesa la percezione di uno scontro armato per l’ordine politico europeo (o globale)
su un arco trentennale?
Osservazione preliminare, che delimita e precisa i confini del mio intervento: per individuare le reali
linee di forza, nella evidente impossibilità, in questa sede, di una trattazione esaustiva, lo sguardo è
rivolto anzitutto a Roma e agli orientamenti proposti dal papato. D’altra parte una riflessione basata
unicamente sulle enunciazioni dottrinali rischia di risultare se non fuorviante troppo parziale perché lo
hiatus tra dottrina e azione politica rappresenta uno dei nodi interpretativi più delicati per la
storiografia sul movimento cattolico in età contemporanea. Nel mio intervento tento quindi di
delineare le categorie e le scansioni più rilevanti attraverso cui si sviluppa la riflessione sulla politica che
si fa con le armi nel magistero ecclesiastico, cercando di verificare se e come tale riflessione viene
recepita tra i cattolici in Italia.
Categorie prevalenti
Principi che regolano, in questi decenni, i giudizi, le scelte, le indicazioni elaborate a Roma rispetto alla
politica armata: principio di presunzione a favore dell’autorità politica, che rappresenta l’estensione a
un caso specifico, la guerra, dell’altro essenziale principio che sancisce il dovere d’obbedienza da parte
dei cattolici agli ordini delle autorità costituite. Il dovere di obbedire all’autorità civile è richiamato in
tutti i momenti di crisi politica (per l’Italia caso della crisi aventiniana e 25 luglio 1943) e in occasione
dei conflitti internazionali.
L’affermazione di una indifferenza teorica dinanzi alla natura dei regimi politici e la tendenza a
giudicare un governo o un movimento politico sulla base dell’atteggiamento da esso manifestato nei
confronti degli obiettivi di salvaguardia e di espansione del cattolicesimo conferiscono alla Chiesa una
malleabilità che si presta a frequenti oscillazioni, a scelte che appaiono spesso spregiudicate proprio
perché poco in linea con i principi asseriti sul piano teorico. Ma è proprio il sostanziale atteggiamento
di realpolitik, che impedisce una piena e definitiva identificazione con le ragioni di una parte politica.
Cesure?
Un momento di cesura si consuma, nelle prospettive della Santa Sede, a partire dal 1934-1935, con
l’ingresso dell’Urss nella Società delle nazioni, il VII congresso del Comintern e, soprattutto, la guerra
civile spagnola. La prospettiva di uno scontro bipolare su scala globale si ridimensiona nell’anno finale
del pontificato di Pio XI, anche se, fino alla caduta della Francia, in Vaticano si ripone una fiducia
arrischiata sulla possibilità di far leva su Mussolini per arginare la forza espansiva del Comintern e
l’aggressività della Germania nazista.
Ideologie di guerra
Nella messa a fuoco degli interrogativi di partenza del mio intervento, è utile individuare quali sono le
categorie che orientano, nel periodo considerato, il giudizio sulla guerra e i modelli di comportamento
rispetto ad essa: dottrina della «guerra giusta», precisazioni offerte dalla cultura intransigente (guerra
come castigo inviato da Dio per far espiare alle società e agli Stati le colpe collettive, vale a dire il loro
rifiuto di riconoscere al magistero ecclesiastico quel ruolo di direzione suprema che non può non
competergli). Tali letture si intrecciano con la visione globale della storia moderna, vista come una
lunga sequela di rovine a partire dalla rottura introdotta in Europa dalla ribellione luterana e sono
proposte dal magistero ecclesiastico a partire da Pio IX sino all’intero pontificato di Pio XII.
Continuità e discontinuità di questi paradigmi in occasione della IGM, nel dibattito sul disarmo del
primo dopoguerra, nelle guerre fasciste, nella elaborazione del diritto alla rivolta da parte di una
componente significativa, ma estremamente minoritaria del cattolicesimo italiano.
Conclusioni
Non è possibile rintracciare una specifica lettura cattolica della politica armata che abbia una
periodizzazione su scala trentennale. Ci furono oscillazioni e casi individuali anche molto significativi; ci
fu una polarizzazione drammatica nel periodo centrale degli anni Trenta. Ma con linee di forza, con un
prima e un dopo che hanno caratteristiche diverse e periodizzazioni più lunghe.
SIMONE NERI SERNERI, Isrt - Università di Siena
La scelta delle armi: volontari interventisti, militanti antifascisti, partigiani
combattenti
In Italia all’indomani del primo conflitto mondiale la capacità del movimento fascista di coniugare
vittoriosamente il nesso tra guerra e rivoluzione, ovvero tra lotta politica e potenza militare, sanzionò
definitivamente tanto il fallimento del progetto interventista democratico, affidato prima alla
mobilitazione dei volontari e poi all’esercito nazionale, quanto quello dell’insurrezionalismo
rivoluzionario di ispirazione classista.
Nel corso degli anni Venti, l’eterogeneo campo antifascista non espresse alcun progetto di
mobilitazione politico-militare coerente ed efficace, giacché quello degli Arditi del Popolo non riuscì a
definirsi e consolidarsi in tempi utili e le altre iniziative restarono nei limiti della difesa contingente.
Fu soltanto al tornante degli anni Trenta che, pur con specificità ideologiche e programmatiche
evidenti e tra loro assai distanti, sia la neonata organizzazione di Giustizia e Libertà sia il clandestino
partito comunista definirono gradualmente delle strategie politiche finalizzate all’abbattimento
violento del regime fascista attraverso lo sviluppo di un processo insurrezionale, sostanzialmente
ancorato al modello dell’insurrezionalismo urbano di ispirazione bolscevica.
La convergenza di fatto attorno al progetto di un’insurrezione antifascista fu, come è noto,
ulteriormente sollecitata dall’evolversi della situazione europea e si manifestò quindi nell’esperienza
dell’intervento nella guerra civile spagnola, dall’antifascismo italiano – e da giellisti e comunisti in
particolare – considerato una conferma delle potenzialità e dunque il concreto avvio di quel progetto
insurrezionale.
A fronte del dispiegarsi del conflitto mondiale, quel progetto dapprima non riuscì a inserirsi
fattivamente nelle dinamiche delle alleanze internazionali, né a determinare la caduta del regime
fascista facendo leva sul malcontento interno. Tuttavia, creò le condizioni perché anche in Italia, come
già altrove, proprio l’occupazione nazista divenisse la condizione finalmente scatenante di una
mobilitazione politico-militare antifascista, peraltro sviluppatasi con modalità, scansioni temporali e
obiettivi sensibilmente diversi da quelli originariamente prospettati.
TERZA SESSIONE. L'Italia in Europa. L'Europa in Italia
Giovedì 22 maggio, ore 15.00 – 18.30
Presiede: Fulvio Conti, Università di Firenze
MARIUCCIA SALVATI, Università di Bologna
Culture del lavoro tra due dopoguerra: dal ghildismo alle human relations
Dopo una breve premessa sul significato - oggi - della comparazione tra il primo e il secondo
dopoguerra del ‘900 in materia di culture del lavoro, l’intervento assume come paradigmatica la
biografia di Camillo Pellizzi. Tre sono i momenti posti sotto osservazione per mettere in risalto
continuità e rotture:
a) il primo dopoguerra e gli anni 1920-24, quando CP, a Londra (dove inizia a insegnare Italiano a
University College, rimanendovi fino al 1939), si impegna perché venga accolta una versione
ghildista dell’avvento del fascismo, cercando un dialogo con figure note e meno note del
fabianesimo inglese e del sindacalismo internazionale, viste come particolarmente adatte a
interpretare i tempi del cambiamento invocati dal fascismo;
b) il secondo momento sono gli anni Trenta, quando, in parallelo con la diffusione europea della
proposta corporativa, l’interesse di Camillo Pellizzi per le tematiche lavoriste assume una
torsione elitista (le corporazioni come serbatoio di classe dirigente) e giurisprudenziale (“Rivista
del Lavoro”);
c) il terzo momento è il secondo dopoguerra, quando, dopo un bilancio ex post del fascismo
imperniato sulla centralità della rivoluzione corporativa (Una rivoluzione mancata, 1949), CP è
riammesso nel 1950 all’insegnamento nell’università italiana sulla sola cattedra di sociologia
allora esistente (a Firenze). Nel decennio successivo, sebbene i suoi studi personali siano
orientati verso la metodologia, e il suo convincimento politico sia definibile come moderato
(non fascista, ma certo non filo americano…), la sua attività di docente si concentra sulla
formazione di una leva di ricercatori interessati, in stretto contatto con il productivity drive
dell’European Recovery Programme, ad accogliere in Italia il mainstream statunitense a favore
delle human relations, corrispettivo sociologico del nuovo ciclo industriale e politico.
JAVIER RODRIGO SANCHEZ, Universitat Autònoma de Barcelona
Circolazione di culture fasciste
Che la comparazione tra fenomeni storici sia utile anche nei casi in cui il risultato finale ci restituisce
enormi differenze tra gli elementi messi a confronto è – o dovrebbe essere – scontato nel lavoro dello
storico. Il caso della comparazione tra regimi fascisti sembra tuttavia smentire, a volte, questa
premessa.
Il mio punto di partenza sarà la Spagna uscita dalla Guerra Civile. Alcuni dei più apprezzati studiosi del
fascismo, nell’osservare più le evoluzioni e gli sviluppi del regime franchista che le sue origini,
nell’interpretare le differenze all’interno del potere dittatoriale come vere e proprie famiglie
contrapposte – quasi come partiti politici –, o nell’interpretare come impermeabili e non condivisibili
elementi identitari de facto comuni – come il cattolicesimo –: nel negare, insomma, l'appartenenza
della Spagna alla “famiglia fascista” hanno costruito un’immagine ideale, irraggiungibile ed irreale del
fascismo, sottovalutando invece il suo peso reale come identità politica eterogenea, come struttura di
potere, e infine come fenomeno politico coerente col suo contesto: come un vero e proprio blocco
storico. Come cercherò di dimostrare, il dibattito sulla Spagna come un fascismo non è tanto un
dibattito sulla Spagna, ma sul fascismo.
Attualmente la comparazione di elementi identitari e culture politiche che si trasformano in fascismo,
che si fascistizzano o che alimentano i movimenti e i regimi fascisti si sta rivelando estremamente
fruttuosa. Essa è forse lo strumento più utile per risolvere i problemi derivati dall’elaborazione di
modelli chiusi. Si è ormai fatta molta strada nell’identificazione di elementi comuni (ultranazionalismo,
organicismo, rigenerazione, violenza) e contesti analoghi (crisi della civiltà liberale, circolazione di
culture fasciste, guerra). Così i fascismi, sia nelle fasi nascenti sia durante la loro istituzionalizzazione,
dimostrarono la ferma volontà di ridefinire i parametri identitari della società. Con l’espansione fascista
in un’epoca cruciale per comprendere la natura del fascismo, quella della sua mondializzazione, a
cavallo delle occupazioni territoriali tedesche durante la seconda guerra mondiale in territori come la
Croazia, la Francia, l’Ungheria o la Romania, i fascismi raggiunsero grazie al contesto favorevole della
guerra totale il loro apice e, probabilmente, il grado più alto di perfezione e di confluenza tra teoria e
prassi.
Tutte queste esperienze sommate tra di loro e analizzate insieme, sebbene dotate di tradizioni proprie
esercitarono un alto grado di influenza esterna e contribuirono a creare un panorama di espansione del
fascismo in Europa. In special modo la guerra totale incentivò una dinamica circolare di radicalizzazione
nei regimi fascisti: negli anni venti in Italia e Germania, tra il 1937 e il 1942 in Spagna, e nel 1939, ma
soprattutto a partire dal 1942-43, in tutta Europa.
Ma questi processi non possono essere spiegati solo con una prospettiva esterna che non includa le
singole realtà nazionali. Buona parte di questi problemi deriva dalla natura del dibattito principale,
ossia quello sul significato del fascismo e di come affrontarlo dal punto di vista teorico. È altrettanto
vero che nella ricerca di un modello, di una teoria generale, di un fascismo generico, sono state
dimenticate alcune esperienze storiche concrete che avrebbero contribuito ad arricchire lo stesso
modello senza riempire il discorso di prefissi o suffissi (para-, proto-, -zzato). Considerare il fascismo
una collezione di negazioni, un modello ideale o un fotogramma fisso di condizioni sine qua non lo
fossilizza in paradigmi e classificazioni. Se lo consideriamo, invece, non come un modello ma come una
convergenza di esperienze storiche definite e un processo costruttivo tendente alla realizzazione di un
progetto preciso di stato, la sua chiave di lettura dovrebbe consistere nell’osservazione delle
esperienze concrete nel tempo e nel contesto in cui ebbero luogo. Da questo punto di vista,
l’interpretazione per la comprensione comparativa del fascismo probabilmente risiede nel concetto di
fascistizzazione: né la Germania del 1933 né l’Italia del 1922, risulta quasi ovvio dirlo, erano dittature
fasciste ma piuttosto Paesi che si fascistizzarono.
GIANPASQUALE SANTOMASSIMO, Università di Siena
Eclissi e rinascita della democrazia negli anni dell'antifascismo
Negli anni tra le due guerre ciò che si intendeva per democrazia conobbe un arretramento spaventoso,
o addirittura un inabissamento: netta inversione di tendenza rispetto a quella che era apparsa la
direttrice dello sviluppo delle società in Occidente.
In sintesi, si può dire che la “democrazia” apparve a moltissimi incapace di difendere i borghesi dal
pericolo comunista, e incapace di difendere le classi lavoratrici dalla minaccia fascista. E sembrava
esercitare una scarsissima capacità di attrazione.
Ma in realtà nel corso degli anni Trenta, e proprio nel quadro di quel clima incombente di "morte della
democrazia" che sembra caratterizzare l'epoca, si avvia la formazione di qualcosa di nuovo, che
retrospettivamente possiamo definire costruzione di una libera democrazia su nuove basi,
reinvenzione radicale di un concetto usurato.
Le istituzioni libere trovano, acquisiscono, sempre faticosamente, a volte lentamente, un contenuto
democratico, che in molte realtà è necessariamente eversivo rispetto a vecchi assetti consolidati e
prima intangibili (il nodo delle riforme agrarie, ad esempio), e scoprono un ruolo nuovo dell'intervento
statale prima escluso in forme così massicce e pervasive.
E' l'orizzonte culturale che retrospettivamente abbiamo definito keynesismo, che ha negli Stati Uniti la
sua incubatrice più esplicita attraverso l'esperienza complessiva del New Deal, e che pone
implicitamente le basi del Welfare State del secondo dopoguerra. In Europa è decisiva l'esperienza
particolare dei Fronti popolari, tanto nelle vittorie e nelle acquisizioni quanto nelle sconfitte,
drammaticamente persuasive.
Il dato storico più importante era che per la prima volta la democrazia parlamentare trovava o
consolidava in Europa una base di massa, superando la diffusa estraneità popolare alle forme delle
libere istituzioni, che aveva generato situazioni senza apparente via di uscita come nella repubblica di
Weimar degli ultimi anni. Il che era possibile, è il caso di ripetere, solo perché quel principio usciva
dall'astrattezza e trovava nuovi contenuti.
MARCO BRESCIANI – Università di Pisa
Giustizia e libertà come osservatorio e laboratorio della guerra civile europea
Questa relazione si propone di delineare alcune coordinate interpretative nella storia intellettuale del
gruppo antifascista rivoluzionario di Giustizia e Libertà all'interno del contesto francese, europeo e
globale tra l'inizio degli anni Trenta e la metà degli anni Quaranta. La peculiarità dell'antifascismo
rivoluzionario, teso a "imparare dal nemico", e la specificità della condizione dell'esilio, fondata su una
sorta di "privilegio epistemologico", consentirono ai giellisti di misurarsi a fondo con le dinamiche
politiche del loro tempo.
Sulla base di queste premesse storico-metodologiche, intendo seguire alcuni dei molteplici fili delle
riflessioni e delle discussioni che attraversarono GL, in un serrato confronto con la cultura francese ed
europea. Farò particolare riferimento a due concetti chiave, quello di "guerra civile europea" e quello
di "era delle tirannie", con l'intento di riflettere sulla validità euristica e sulla pluralità semantica di
questi strumenti analitici, tuttora utilizzati dalla storiografia. Si trattava di due chiavi di lettura
compatibili ma non coincidenti, che rimandavano a matrici originarie diverse: la "guerra civile europea"
alla riflessione sulla nazione, l'"era delle tirannie" alla riflessione sul socialismo. La prima definiva una
prospettiva ideologica funzionale ad una legittimazione della lotta antifascista su una nuova scala; la
seconda sollevava il problema della natura dello Stato tanto rispetto al quadro politico del presente
quanto del futuro.
La categoria di "guerra civile europea", elaborata da Rosselli sull'onda della conquista nazista del
potere in Germania e della conseguente espansione europea del "fascismo", consentì a GL di
complicare e arricchire il suo originario rapporto con la tradizione nazionale democratica, in una
duplice direzione: da un lato, ampliando la consapevolezza della dimensione europea della crisi e della
sua chiave di soluzione rivoluzionaria; dall'altro, imponendo di fronte alla sfida europea del fascismo e
del nazismo di recuperare e ripensare la tradizione nazionale in senso radicalmente democratico.
D'altro canto, attraverso la categoria di "era delle tirannie", fatta propria e variamente reinterpretata
sulla base dell'opera dello storico francese Elie Halévy, GL riuscì a mettere a fuoco - non senza
oscillazioni e contraddizioni - la diversità degli esiti politici di quella crisi europea, e la novità dei regimi
a cui aveva condotto. Partendo infatti da una riflessione complessa sulle ambivalenze del socialismo,
che distingueva tra le sue spinte libertarie e quelle autoritarie, i giellisti, da diverse angolature,
cercarono di analizzare la questione del totalitarismo, e le problematiche connessioni storiche tra i
regimi staliniano, fascista e nazista.
QUARTA SESSIONE. Economie di guerra e stato sociale
Venerdì 23 maggio, ore 9.00 – 13.00
Presiede: Luigi Tomassini, Università di Bologna
ALESSIO GAGLIARDI, Università di Bologna
Per rifondare lo Stato: progetti corporativi tra fascismo e antifascismo
Il corporativismo è il tema che maggiormente impegnò, dalla metà degli anni Venti, il dibattito
culturale dell’Italia fascista. E il corporativismo – inteso come progetto di superamento dei meccanismi
della rappresentanza dello Stato liberale e realizzazione di una società armonica, non più divisa dalla
contrapposizione di classe – fu l’architrave di quel nuovo modello di organizzazione sociale, la «terza
via» fascista, che il regime indicò, agli italiani e agli europei, come meta della propria presunta
rivoluzione. La vicenda del corporativismo e dei progetti corporativi di rifondazione dello Stato e
intervento nell’economia, tuttavia, non è racchiusa esclusivamente nella storia del fascismo, ma
intreccia anche la formazione di quella prospettiva politica antifascista in cui convergono le diverse
culture e organizzazioni che si oppongono alla dittatura. Se consideriamo l’antifascismo non solo un
insieme di gruppi politici diversi per matrici ideali e piattaforme programmatiche, ma, seppur con
discontinuità, anche un soggetto collettivo definito da alcune comuni finalità strategiche, esso ci
appare non una semplice reazione al fascismo ma una più complessiva risposta antiautoritaria e
democratica alle sfide poste dai processi di modernizzazione politica e dalla politicizzazione di massa
sin dall’inizio del Novecento.
Fascismo e antifascismo, in questo senso, sono geneticamente connessi a quella «crisi dello Stato» che
i giuristi più attenti segnalano già sul finire del primo decennio del secolo, e che vede nella crescita e
nel maggior rilievo degli interessi organizzati un fattore di disgregazione della legittimità dello Stato e di
incrinatura del funzionamento della pubblica amministrazione. È nel confronto con le conseguenze di
quella crisi, e nella sempre più forte consapevolezza della necessità di una rifondazione dello Stato, per
assorbire le spinte disgreganti prodotte dalle nuove forme di mobilitazione politica e organizzazione dei
gruppi sociali, che si formano le culture politiche dei soggetti che danno vita alla lunga «guerra civile»
italiana.
È all’interno di queste coordinate che bisogna inserire l’evoluzione della riflessione sul corporativismo e
della progettazione di riforme corporatiste dello Stato e dell’economia negli anni tra le due guerre
mondiali. È possibile individuare diverse fasi del confronto e scontro tra fascismo e antifascismo
intorno a questo nodo. Negli anni a cavallo tra il primo dopoguerra e l’avvento del fascismo si aprì una
fase progettuale per la valorizzazione dei canali di rappresentanza della società all’interno dello stato,
che vide impegnati componenti significative della dirigenza politica e amministrativa dello Stato
liberale e che coinvolse la riflessione di un ampio arco di forze politiche e culturali, da alcuni importanti
settori del socialismo riformista al primo fascismo. I primi anni del fascismo al potere si posero almeno
in parte in continuità con questa fase.
Alla metà degli anni Venti prese compiutamente forma il progetto corporativo di Alfredo Rocco (l’unico
ad avere piena realizzazione), che introdusse rilevanti discontinuità: da un lato si impose una versione
statalista-autoritaria, che voleva riaffermare il comando dello Stato sui corpi sociali, privandoli della
loro autonomia e, al tempo stesso, come avevano con largo anticipo intuito le menti più lucide
dell’antifascismo, svuotando gli organismi di resistenza economica (i sindacati e le cooperative) creati
dal movimenti operaio e incorporandoli negli ingranaggi del nuovo apparato istituzionale; dall’altro, il
carattere corporativo divenne, nella costruzione ideologica del regime, uno degli attributi dello «stato
nuovo» e si venne in questo modo ad affermare nei fatti l’identificazione di corporativismo e fascismo.
Nei primi anni Trenta, con l’istituzione delle corporazioni da parte dello Stato fascista, ebbe luogo il
rilancio del tema del corporativismo, con effetti rilevanti sulla politica culturale del regime e, seppure in
misura minore, sull’architettura dello Stato fascista. A esso l’antifascismo rispose con analisi spesso
lucide e spregiudicate, con cui si sforzò di comprendere le caratteristiche originali e innovative del
progetto dell’avversario. Al tempo stesso, anche sulla scia di quelle analisi, mise al centro della propria
agenda il nesso tra libertà politiche e giustizia sociale e, in alcune sue voci autorevoli, si interrogò sulla
possibilità di pensare un corporativismo democratico come soluzione alla crisi dello Stato e strumento
di un nuovo modello di rappresentanza e cittadinanza. Un’esperienza, questa, che consegnò all’Italia
del post1945 un’eredità complessa.
STEFANO MUSSO – Università di Torino
Lavoro e sindacato nell'economia fascista
A partire dal confuso e contraddittorio programma di San Sepolcro, intriso di sindacalismo
rivoluzionario rimodellato dal produttivismo nazionalista, il fascismo divenuto regime produsse una
retorica secondo la quale gli interessi superiori della nazione dovevano prevalere sugli egoismi di
classe. Poiché gli interessi della nazione stavano nella forza economica in quanto base della sua forza
militare, ed essendo pertanto la produzione il valore massimo da salvaguardare, nella dialettica degli
interessi furono quelli del lavoro a essere sacrificati, non quelli dell’impresa. Nel quinquennio
successivo alla presa del potere il salario reale fu riportato ai livelli dell’anteguerra, annullando le
conquiste del biennio rosso e ripristinando i differenziali di reddito tra le classi sociali, in particolare tra
operai e piccola borghesia, che erano stati ridotti dalle mobilitazioni del movimento operaio e
dall’inflazione.
Questo intervento sulla redistribuzione del reddito si accompagnò alla sottrazione di competenze al
sindacato fascista, che fu tenuto a bada nelle sue componenti movimentiste anche per tranquillizzare il
ceto imprenditoriale, timoroso che un sindacato affiliato al partito al potere e guidato da ex
sindacalisti rivoluzionari potesse alterare le dinamiche della rappresentanza tripartita sperimentate
nella mobilitazione industriale con un eccessivo sostegno del governo a una delle parti. Pagato il suo
debito nei confronti della borghesia industriale con le privatizzazioni della fase liberista, ricompensata
la piccola borghesia con la deflazione di quota novanta e con l’ampliamento del pubblico impiego,
sperimentata la capacità di controllo delle pulsioni movimentiste, il regime operò sul finire della grande
crisi una progressiva svolta nel suo atteggiamento nei confronti del sindacato, attribuendogli funzioni e
competenze prima negate. Tale nuovo indirizzo avrebbe raggiunto il culmine nella repubblica di Salò,
quando il canto del cigno del fascismo produsse il decreto sulla socializzazione delle imprese e
l’istituzione della corporazione integrale. Il più ampio ruolo assegnato alla principale organizzazione di
massa del regime nella seconda metà degli anni trenta, da ricondursi alle accresciute esigenze di
consenso al profilarsi delle avventure belliche, si sostanziò di provvedimenti legislativi e statuizioni
contrattuali favorevoli al lavoro dipendente. Tuttavia, norme e miglioramenti, anche nei sistemi
previdenziali, mostrarono un ampio divario tra piano formale e piano sostanziale, a motivo dei
rapporti di forza tra capitale e lavoro sfavorevoli al secondo, per via della negazione delle libertà di
organizzazione e azione. Il divario tra spirito delle norme e concrete applicazioni fu parzialmente
occultato dalla propaganda di regime, di cui il sindacato si fece fidato strumento: il consenso era in
larga parte ricercato attraverso le promesse relative al nuovo ordine sociale che sarebbe scaturito al
termine della guerra vittoriosa.
GIUSEPPE BERTA - Università Bocconi, Milano
La rappresentanza degli interessi imprenditoriali dal liberismo al corporativismo
È convenzione far risalire la nascita della Confindustria al 1910, quando una rete di associazioni
imprenditoriali del Nord Italia, capitanate dalla Lega Industriale di Torino, costituirono la
Confederazione (non ancora generale) dell’industria italiana. In realtà, si trattava di un labile organismo
di coordinamento, come testimoniato dalla scelta di attribuire al nuovo organismo lo stesso
presidente, Louis Bonnefon Craponne, e lo stesso segretario, Gino Olivetti, della Lega torinese, che di
fatto assunse su di sé anche quella funzione di rappresentanza più generale. Durante la prima guerra
mondiale, la Confindustria cessò di fatto di esistere.
Essa venne rifondata alla fine del conflitto, nel febbraio 1919, da Dante Ferraris (che era stato, sì, prima
della guerra presidente della Lega Industriale), ma che soprattutto durante le ostilità era stato il
principale rappresentante degli imprenditori all’interno del Comitato di Mobilitazione industriale.
Ferraris volle rifondare la nuova Confindustria (che questa volta si fregiava anche della qualifica di
“generale”) unificando in un unico organo di rappresentanza tanto le associazioni imprenditoriali
caratterizzate da una funzione prevalentemente sindacale quanto quelle legata alla tutela economica,
come la Assonime.
La Confindustria rinasceva all’interno di una traccia corporativa, per corroborare lo schema del
Governo Nitti che voleva associare all’esecutivo le principali categorie economiche. Non a caso, Ferraris
dopo aver lanciato la rinnovata Confindustria, entrò a far parte del governo con la responsabilità del
neonato Ministero dell’industria (cui si affiancherà in seguito quello del Lavoro), distaccandosi dal
vecchio Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Ferraris aveva in mente un modello di corporatismo pluralista destinato a non realizzarsi mai. Infatti, il
declino dell’Italia liberale trascinò con sé anche la forma del pluralismo della rappresentanza degli
interessi, sostituita dal regime dal 1925-26 in avanti, con un corporativismo di stato, che sarebbe
diventata la vera cifra confindustriale durante il fascismo.
Essa costituisce l’impronta profonda che sarebbe stata trasferita anche all’Italia repubblicana,
lasciandole in dotazione un’architettura contrattuale che ne doveva caratterizzare la storia successiva.
GIOVANNI FEDERICO, Università di Pisa
Le conseguenze economiche dell’imperialismo italiano
La relazione svilupperà le argomentazioni seguenti:
1) Introduzione: l'Italia nell'economia internazionale negli anni fra le due guerre
Analisi comparativa dell'andamento del GDP e del commercio estero
2) Imperialismo ed autarchia: due facce della stessa medaglia?
Breve cronologia delle discussioni politiche e richiamo alle politiche di preferenza imperiale UK e
Francia, rimarcando la peculiarità italiana della colonizzazione demografica
3) Costi e benefici dell'impero
Analisi dei costi della politica imperiale a carico del bilancio statale e breve cenno alle (fallite) iniziative
imprenditoriali e colonizzatrici nelle colonie
4) Autarchia, imperialismo e commercio estero italiano
Analisi dei cambiamenti nella composizione e nella destinazione dei flussi commerciali negli anni Trenta
5) Conclusioni: un bilancio economico
STEFANO CAVAZZA, Università di Bologna
Consumi e stato sociale tra fascismo e antifascismo
Il tema consumi e stato sociale verrà analizzato muovendo da tre premesse generali. La prima
riconduce la crisi politica italiano del primo dopoguerra alle tensioni generate dall'avvento della società
di massa in Europa. La seconda considera l'Italia nel quadro dello sviluppo europeo dei consumi
constatando la presenza di tendenze di sviluppo simile a quella degli altri paesi europei, pur in
presenza di di squilibri sociali ed economici più accentuati. La terza premessa riguarda la necessità di
uno sguardo comparativo per inquadrare le politiche messe in atto dal fascismo italiano all'interno del
fascismo europeo.
In questo contesto la relazione illustrerà le caratteristiche di sviluppo dei consumi nel periodo tra le
due guerre mettendo in luce i limiti di tali sviluppo, ma anche l'influenza esercitata dai modelli di
consumi che l'industria culturale rendeva noti al pubblico. In particolare l'attenzione si concentrerà
sulla tensione potenziali tra la diffusione di questi modelli e la politica fascista volta ad offrire accesso
collettivo a nuovi beni di consumo (es. mediante il Dopolavoro) e ci si interrogherà sulla scorta del
confronto con altre esperienze (es. Germania nazista) sulla effettiva portata dello sviluppo del consumo
durante il ventennio.
In secondo luogo la relazione prenderà in esame le implicazioni delle politiche sociali messe in campo
dal fascismo.
In terzo luogo la relazione cercherà di problematizzare il rapporto tra consumi, politiche sociali e
costruzione del consenso riflettendo anche sulla ricezione da parte dell'antifascismo di tali politiche.
In conclusione il paper cercherà di problematizzare il problema della continuità e discontinuità nel
passaggio al dopoguerra.
QUINTA SESSIONE. Culture sociali della modernità
Venerdì 23 maggio, ore 15.00 – 18.30
Presiede: Simone Neri Serneri, Isrt – Università di Siena
MASSIMO BAIONI - Università di Siena
Patriottismi in conflitto. Guerre e memorie e rifondazione dell'italianità
L’intervento si sofferma sul campo di tensione rappresentato dalla memoria del Risorgimento e della
Grande guerra, visto come uno snodo cruciale anche rispetto alle trasformazioni che investono i temi
del patriottismo e dell’italianità tra i due conflitti mondiali.
Nella guerra civile del 1943-45, come è noto, lo scontro militare e politico si estese alla sfera dei simboli
e delle letture del passato, incidendo in profondità nell’idea di patria chiamata a rifondare il senso di
appartenenza nazionale. Ma la frattura che si consuma in quei mesi ha radici più lontane nel tempo: ed
è proprio la Grande guerra a delinearne un primo passaggio decisivo. La propaganda interventista
spinge il richiamo alla nazione fino agli estremi del “ricatto” patriottico e alla demonizzazione
sistematica del “nemico interno”. Se il dopoguerra rilancia interpretazioni, simbologie, rituali la cui
interna conflittualità era già stata sperimentata nel cinquantennio liberale, lo scenario pare ora
distinguersi per un surplus di violenza (anche verbale) e di antagonismo radicale, sotto l’effetto delle
implicazioni varie sortite dalla guerra. L’“ideologizzazione” del mito della nazione e la sua curvatura
totalitaria e militarista volute dal fascismo producono una lacerazione destinata a lasciare tracce visibili
nel tessuto culturale e morale del paese.
D’altra parte, sugli anni del conflitto e dell’immediato dopoguerra il lavoro di ricerca sui miti patriottici,
sulle loro evoluzioni e sui loro usi pubblici richiede ulteriori approfondimenti, anche per evitare di
schiacciare l’interpretazione solo sugli esiti del fascismo: in quella fase sopravvivono nelle culture
politiche italiane elaborazioni non univoche, contaminazioni di vecchio e nuovo nazionalismo, attese
diversificate sui possibili esiti prodotti dal trauma bellico e dalle sue molteplici conseguenze. Il percorso
appare più articolato e complesso di quanto suggerisca la tesi di una sostanziale continuità del
“discorso” patriottico e nazionalista tra l’epoca risorgimentale e il ventennio fascista. Persino negli anni
del regime non è dato riscontrare un “pensiero unico” nel rapporto con la storia recente, ben
documentabile specialmente nel caso del Risorgimento: affiora viceversa una dialettica interna che
rinvia alla conformazione eclettica della cultura fascista. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il
variegato universo antifascista, diviso sulla valutazione del passato prossimo e sulla possibilità di
attingere al deposito di memorie, miti e simboli come risorsa da usare nella lotta politica e come
progetto di rifondazione del sentimento nazionale.
Ne deriva di fatto una situazione in movimento, dentro la quale sono riconoscibili interpretazioni
trasversali che, senza esaurirsi automaticamente nell’antitesi fascismo-antifascismo, approdano a
posizioni variamente revisioniste sul passato, destinate ad avere un qualche peso anche negli assetti
postbellici.
Si tratta semmai di scavare più a fondo su alcune questioni:
- precisare le periodizzazioni interne che scandiscono il rapporto con il passato nell’arco del trentennio
in questione;
- approfondire gli sviluppi e i nessi tra i diversi piani e strumenti in cui quel rapporto si articola
(storiografia, discorso pubblico, rappresentazioni, ecc.);
verificare se sui molteplici versanti dello schieramento politico affiorano o meno approcci
“moderni” alla rilettura della storia e alla sua traduzione concreta in termini di organizzazione e
mobilitazione delle masse intorno a un patriottismo rinnovato.
PAUL CORNER - Università di Siena
Società e autorità: il caso italiano nell'Europa della prima metà del Novecento
Premessa: Warfare-Welfare.
I problemi legati alla legittimazione del potere, dell'autorità, diventano evidenti per tutti i paesi
belligeranti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Vengono rese palesi le forti tensioni fra l'esercizio
della disciplina sociale necessaria per il proseguimento del conflitto e le necessità, presso la
popolazione, di un consenso per la guerra. In effetti, in tutti i paesi belligeranti si vedono qualche
segnale di queste tensioni, in quanto la legislazione speciale che caratterizza il conflitto viene spesso
accompagnata da misure che mirano a proteggere la popolazione civile dagli effetti più dannosi della
guerra sul fronte interno. Il binomio 'Warfare-welfare' riassume molto bene i nuovi compiti che
vengono assunti dagli stati in conflitto. Nella Gran Bretagna, ad esempio, si vede non solo l'estensione
dell'orario di lavoro nelle fabbriche e la chiusura dei pubs alle 10 di sera per evitare i riflessi
dell'ubriachezza sulla produzione bellica, ma anche una maggiore attenzione da parte dello stato alle
condizione di salute della popolazione e ad una più equa distribuzione di sacrifici fra le classi sociali.
Consenso e coercizione: quadrare il cerchio.
I nuovi compiti dello stato, messi in evidenza dalla Prima Guerra Mondiale, sono al centro delle
politiche del periodo fra le due guerra. In molti paesi europei, ma in particolare nei paesi che
potrebbero essere compresi nella categoria di 'paesi totalitari', il rapporto fra la disciplina sociale,
realizzata con la repressione e la coercizione, e il consenso di massa, visibile, almeno in apparenze,
nelle piazze gremite di gente osannante il leader, rappresenta il nodo centrale del funzionamento del
potere. Un modo di affrontare il problema del consenso che è proposto in tutti i regimi repressivi del
periodo fra le guerra è quello della creazione dell'Uomo nuovo. La logica è semplice: se, nel rapporto
fra potere e popolo, il potere non può cambiarsi (senza rinunciare ad essere il potere), l'altra parte del
rapporto – il popolo – deve cambiarsi. L'Uomo nuovo dovrebbe rispecchiare tutti i valori del regime ed
essere pertanto in perfetto sintonia con il regime. Il paper prende come chiave di lettura del mutevole
rapporto fra società ed autorità nel periodo in questione proprio il 'fallimento' dei regimi di realizzare
questo obbiettivo di trasformazione antropologica. Il fallimento mette in luce, in realtà, le grandi
difficoltà che hanno i regimi nel tradurre, sul lungo periodo, il controllo sociale in consenso sociale –
cioè di riuscire a riconciliare le tensioni fra la coercizione e il consenso. Anche nella Germania nazista,
dove il consenso per il regime sembra solido fino al 1942, gli storici hanno sottolineato gli elementi di
instabilità, in particolare nel campo economico, che reggevano quel consenso.
Per molto tempo discussa in termine di un semplice binario – o dissenso o consenso, oppure, a volte, o
repressione o consenso – la questione del rapporto fra popolazione e potere viene ora affrontata con
uno spectrum di atteggiamenti molto meno netto. Non più semplice vittima della coercizione, alla
gente viene restituita agency, anche nel contesto della repressione. Mentre la repressione non viene
messo in dubbio e i tentativi di tutti i regimi di guadagnare il consenso della popolazione sono sempre
indagati con attenzione, le ricerche più recenti insistono sulle ambiguità e sulle ambivalenze nelle
risposte della popolazione nei confronti dei regimi, sottolineando le 'zone grigie' dei sentimenti
popolari di fronte all'autorità. L'accento è messo sulle strategie di sopravvivenza di gran parte della
popolazione, con particolare attenzione ai diversi modi in cui la gente cerca di svincolarsi dai tentativi
del regime di 'colonizzare la vita quotidiana.' Temi come la complicità, la collusione, la collaborazione
emergono qui, ma anche quelli come la non-compliance, l'ostruzionismo, e la resistenza passiva.
Non a caso, nei due regimi che mirano più alla creazione dell'Uomo nuovo – quello fascista e quello
sovietico – nella seconda metà degli anni '30 ci sono crescenti segni di instabilità, indice del fatto che i
nuovi stati totalitari non sono riusciti a trovare una soluzione perdurante ai nuovi compiti che lo stato
moderno è chiamato a svolgere.
MADDALENA CARLI, Università di Teramo
Il fascismo in cerca della modernità
Conservatrice, autoritaria, totalitaria: le differenti aggettivazioni che le sono state attribuite nel corso
degli anni, testimoniano delle difficoltà sollevate dalla modernità quando il suo uso ha a che fare con il
fascismo. Entrato a fatica nel panorama degli studi sull’entre-deux-guerres italiano, il concetto è ancora
circondato da cautele, prudenze, precisazioni; non solo perché la costellazione dei suoi significati
sconferma il principale assunto del paradigma antifascista (l’indole reazionaria del fascismo), ma anche
in quanto la sua associazione con la dittatura di Benito Mussolini sembra mettere in discussione uno
tra gli impliciti più duraturi dell’Illuminismo tardo settecentesco: l’idea che l’esperienza della modernità
possa essere meccanicamente identificata con il progresso. Eppure, proprio attorno a una
«riprogettazione della modernità» – gravemente compromessa dai devastanti esiti della Grande
Guerra – il movimento fascista ha mosso i primi passi e ha ottenuto gli iniziali consensi: per quanto
estranei alla tradizione dell’89, i linguaggi e le ritualità della «nuova politica» di cui i suoi leader si sono
fatti portatori sono stati un tentativo di rispondere alla crisi primonovecentesca della cultura e della
società europee.
Come un consistente ed eterogeneo insieme di ricerche ha ampiamente dimostrato, dall’indagine degli
aspetti moderni dipende del resto la possibilità di pervenire a una interpretazione generale del
fascismo; una interpretazione capace di definirne il funzionamento e gli assetti di potere e di
confrontarsi con l’orizzonte progettuale della rivoluzione antropologica alla base dell’utopia totalitaria.
Senza addentrarmi nelle varie stagioni di un dibattito efficacemente ricostruito in altre sedi, dedicherò
il mio intervento a uno dei settori in cui il contributo culturale del regime fascista ha raggiunto risultati
particolarmente originali e che è stato oggetto, negli ultimi trent’anni, di un rinnovato interesse
storiografico: la produzione e la diffusione delle immagini. Che spiegazioni è possibile dare della natura
fortemente visiva della cultura fascista? E della presenza pervasiva, quasi ossessiva, delle forme
simboliche nei rituali e nelle liturgie di massa promossi durante il ventennio? Che tipo di relazioni si
possono stabilire tra il fascismo e il modernismo? Proverò a interloquire con i principali interrogativi
sollevati dalla teoria post-moderna a partire dallo straordinario cantiere rappresentato
dall’organizzazione e dall’allestimento delle mostre fasciste degli anni Trenta, nella convinzione che nel
potere generatore e rigeneratore attribuito alle immagini risieda una delle chiavi di comprensione
dell’uomo nuovo del fascismo e, al tempo stesso, una delle peculiarità della modernità fascista e la sua
principale differenza con la post-modernità.
PAOLO CAPUZZO, Università di Bologna
"Un nuovo tipo umano": lavoro e consumo nella società di massa
L’aspetto di maggiore originalità del quaderno 22, Americanismo e fordismo, risiede nella capacità di
considerare lavoro e consumo nelle loro profonde connessioni che compongono un fenomeno sociale
unitario e definiscono un “nuovo tipo umano”. Il paper si articola in tre sezioni che discutono,
rispettivamente: il modello fordista americano; le difficoltà della sua traduzione nell’Italia fascista e i
problemi della costruzione di un nuovo tipo umano nella società socialista.
Si inizierà con una riconsiderazione di alcuni temi del quaderno 22, in particolare riguardo al rapporto
tra l’aumento della produttività, reso possibile dalla razionalizzazione del sistema industriale, e la
necessità di un più compiuto controllo sul complesso della vita operaia imposto dalla nuova
organizzazione del lavoro. Si passerà successivamente a discutere le tesi gramsciane sull’impossibilità
dell’importazione del fordismo in Italia che si inscrivono nella sua generale interpretazione del fascismo
e al ruolo determinante che in esso riveste la piccola borghesia improduttiva. Si guarderà infine al
modello sovietico, alla particolare combinazione di lavoro e consumo che in esso viene teorizzata e
praticata e alle sue implicazioni sociali.
L’interesse di Gramsci per gli aspetti sociali e culturali della trasformazione rivoluzionaria e il suo
ricorso al freudismo per interpretare le difficoltà di adattamento antropologico al cambiamento dei
modelli produttivi erano parte di una riflessione sulla difficile costruzione dell’egemonia nella società
industriale avanzata di cui Gramsci riconosceva i limiti tanto nel contesto capitalista che in quello del
“cesarismo progressivo”; mentre alla metà degli anni Trenta poteva sembrargli paradossalmente il
fascismo capace di una tenuta precaria, ma certamente più duratura di quanto previsto.
Se l’analisi gramsciana del rapporto tra lavoro e consumo nella società industriale avanzata apriva uno
squarcio originale sulle contraddizioni della società di massa, essa sottovalutava tuttavia la forza
dell’americanismo come costruzione egemonica che per dispiegarsi compiutamente avrebbe tuttavia
richiesto che i fuochi della guerra civile europea si consumassero fino in fondo.