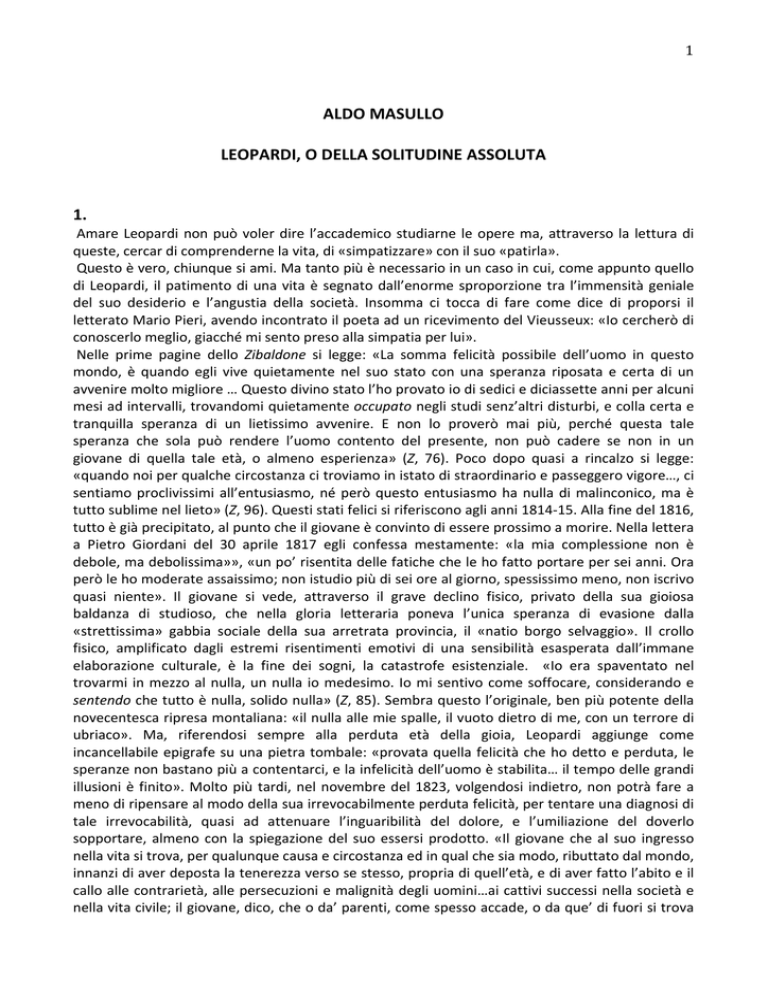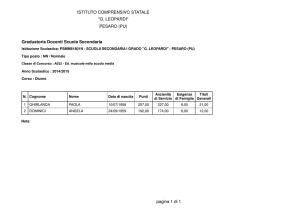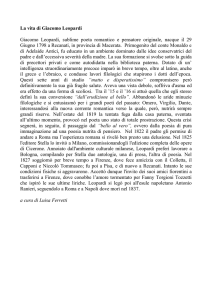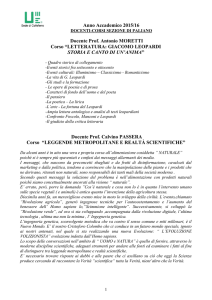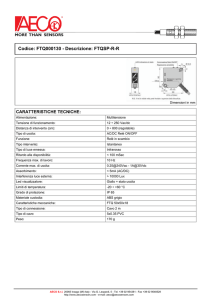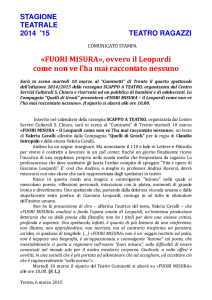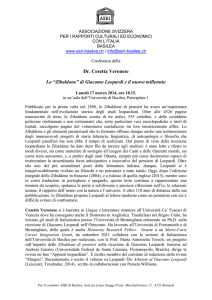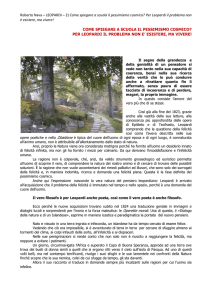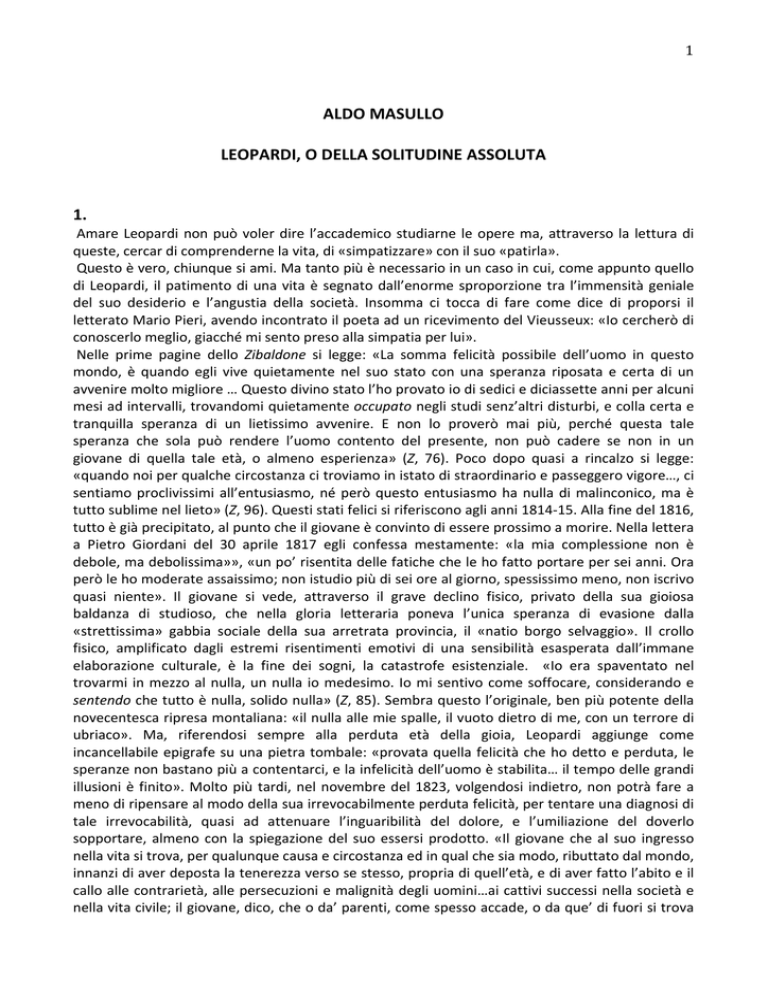
1
ALDO MASULLO LEOPARDI, O DELLA SOLITUDINE ASSOLUTA 1. Amare Leopardi non può voler dire l’accademico studiarne le opere ma, attraverso la lettura di queste, cercar di comprenderne la vita, di «simpatizzare» con il suo «patirla». Questo è vero, chiunque si ami. Ma tanto più è necessario in un caso in cui, come appunto quello di Leopardi, il patimento di una vita è segnato dall’enorme sproporzione tra l’immensità geniale del suo desiderio e l’angustia della società. Insomma ci tocca di fare come dice di proporsi il letterato Mario Pieri, avendo incontrato il poeta ad un ricevimento del Vieusseux: «Io cercherò di conoscerlo meglio, giacché mi sento preso alla simpatia per lui». Nelle prime pagine dello Zibaldone si legge: «La somma felicità possibile dell’uomo in questo mondo, è quando egli vive quietamente nel suo stato con una speranza riposata e certa di un avvenire molto migliore … Questo divino stato l’ho provato io di sedici e diciassette anni per alcuni mesi ad intervalli, trovandomi quietamente occupato negli studi senz’altri disturbi, e colla certa e tranquilla speranza di un lietissimo avvenire. E non lo proverò mai più, perché questa tale speranza che sola può rendere l’uomo contento del presente, non può cadere se non in un giovane di quella tale età, o almeno esperienza» (Z, 76). Poco dopo quasi a rincalzo si legge: «quando noi per qualche circostanza ci troviamo in istato di straordinario e passeggero vigore…, ci sentiamo proclivissimi all’entusiasmo, né però questo entusiasmo ha nulla di malinconico, ma è tutto sublime nel lieto» (Z, 96). Questi stati felici si riferiscono agli anni 1814‐15. Alla fine del 1816, tutto è già precipitato, al punto che il giovane è convinto di essere prossimo a morire. Nella lettera a Pietro Giordani del 30 aprile 1817 egli confessa mestamente: «la mia complessione non è debole, ma debolissima»», «un po’ risentita delle fatiche che le ho fatto portare per sei anni. Ora però le ho moderate assaissimo; non istudio più di sei ore al giorno, spessissimo meno, non iscrivo quasi niente». Il giovane si vede, attraverso il grave declino fisico, privato della sua gioiosa baldanza di studioso, che nella gloria letteraria poneva l’unica speranza di evasione dalla «strettissima» gabbia sociale della sua arretrata provincia, il «natio borgo selvaggio». Il crollo fisico, amplificato dagli estremi risentimenti emotivi di una sensibilità esasperata dall’immane elaborazione culturale, è la fine dei sogni, la catastrofe esistenziale. «Io era spaventato nel trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io medesimo. Io mi sentivo come soffocare, considerando e sentendo che tutto è nulla, solido nulla» (Z, 85). Sembra questo l’originale, ben più potente della novecentesca ripresa montaliana: «il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco». Ma, riferendosi sempre alla perduta età della gioia, Leopardi aggiunge come incancellabile epigrafe su una pietra tombale: «provata quella felicità che ho detto e perduta, le speranze non bastano più a contentarci, e la infelicità dell’uomo è stabilita… il tempo delle grandi illusioni è finito». Molto più tardi, nel novembre del 1823, volgendosi indietro, non potrà fare a meno di ripensare al modo della sua irrevocabilmente perduta felicità, per tentare una diagnosi di tale irrevocabilità, quasi ad attenuare l’inguaribilità del dolore, e l’umiliazione del doverlo sopportare, almeno con la spiegazione del suo essersi prodotto. «Il giovane che al suo ingresso nella vita si trova, per qualunque causa e circostanza ed in qual che sia modo, ributtato dal mondo, innanzi di aver deposta la tenerezza verso se stesso, propria di quell’età, e di aver fatto l’abito e il callo alle contrarietà, alle persecuzioni e malignità degli uomini…ai cattivi successi nella società e nella vita civile; il giovane, dico, che o da’ parenti, come spesso accade, o da que’ di fuori si trova 2
ributtato ed escluso dalla vita, e serrata la strada ai godimenti (di qualsiasi sorta) o più che agli altri o al comune de’ giovani non suole accadere; o tanto che tali ostacoli vengano ad essere straordinarii e ad avere maggior forza che non sogliono, a causa di una sua non ordinaria sensibilità, immaginazione, suscettibilità, delicatezza di spirito e d’indole, vita interna, e quindi straordinaria tenerezza verso se stesso, maggiore amor proprio, maggiore smania e bisogno di felicità e di godimento, maggiore delicatezza sopra ogni offesa, ogni danno, ogn’ingiuria, ogni disprezzo, ogni puntura ed ogni lesione del suo amor proprio, un tal giovane trasporta e rivolge bene spesso tutto l’ardore e la morale e fisica forza o generale della sua età, o particolare della sua indole, o l’uno e l’altro insieme… ei la rivolge a procurarsi l’infelicità, l’inattività, la morte morale. Egli diviene misantropo di se stesso e il suo maggior nemico, egli vuol soffrire…» (Z, 3837‐3838). A venticinque anni Leopardi ha lucidamente capito di essere, come oggi si potrebbe dire, un sublime disadattato: sublime, perché di questo disadattamento egli fa la sua forza. Più tardi sentenzierà orgogliosamente in uno dei Pensieri, il LXXXII: «Nessuno diventa uomo innanzi di aver fatto una grande esperienza di sé, la quale rivelando lui a se medesimo, e determinando l’opinione sua intorno a se stesso, determina in qualche modo la fortuna e lo stato suo nella vita». Appunto l’esperienza di sé, l’attenzione mai sospesa ai multiformi atti della sua vita, anzi si potrebbe dire della «natura» che è in lui, «natura poetica», intreccio di «fatti desideri passioni», così come nel 1821 viene precisata l’idea di natura (Z, 1842), Leopardi aveva a diciannove anni deciso di registrare, iniziando a raccoglierle nello Zibaldone, le riflessioni che sul suo vivere veniva facendo mentre esso si svolgeva, e in tale impresa proseguì con alterna compattezza fino all’età di trentaquattro. Il primo ancor lontano segnale dell’approssimarsi di questa interruzione, quasi la raggiunta convinzione che non vale la pena di prestare scrupolosa, quasi puntigliosa attenzione ai momenti del proprio vivere, rivelatisi in fondo tutti uguali, tutti infelici, è l’urlo del 1826. «Tutto è male. Cioè tutto quello che è, è male; che ciascuna cosa esista è un male; l’esistenza è un male e ordinata al male; il fine dell’universo è il male; l’ordine e lo stato, le leggi, l’andamento naturale dell’universo non sono altro che male, né diretto ad altro che al male. Non v’è altro bene che il non essere … » (Z, 4174). La prova fattuale che tutto è male sta nella rilevazione che l’infelicità è generale, senza eccezione alcuna. «Non gli uomini solamente, ma l’intero genere umano fu e sarà sempre infelice per necessità. Non il genere umano solamente ma tutti gli animali. Non gli animali soltanto ma tutti gli altri esseri al loro modo. Non gl’individui, ma le specie, i generi, i regni, i globi, i sistemi, i mondi». Questa convinzione ora Leopardi chiama il suo «sistema». In esso la riduzione illuministica del principio di certezza cartesiano, spostato dalla logica al senso, si applica alla felicità. Nel Dialogo di Timandro ed Eleandro è detto perentoriamente: «Io giudico quanto a me di essere infelice, e in questo so che non m’inganno». Qui si coglie la legittimazione filosofica della scelta d’impegnarsi nei lucidissimi Dialoghi, scritti in gran parte nel 1924. Non è forse nella centralità della mente a sé il principio della dialogicità, come per primo vide Platone, parlando del logo come «interno dialogo dell’anima con sé»? L’esito metafisico del pessimismo ormai cosmico è, nel 1827, il più radicale materialismo. Il che vuol dire che il pensare e il sentire non possono avere origine e sede che nella materia. Leopardi adesso insiste: «La materia può pensare, la materia pensa e sente» (Z, 4251‐3). Si tratta, come più avanti si vedrà, di un materialismo sui generis, perché non tanto, come l’anno prima sembrava, viene dedotto dalla constatazione della generale infelicità, quanto è pensiero originario, immediatamente sentito. Non si tratta di un’astratta dimostrazione, ma di una concretissima esperienza. Non siamo sedotti da un’idea ma obbligati da un fatto. «Un fatto, perché noi sentiamo corporalmente il pensiero». In altri termini «chi nega il pensiero alla materia, nega un fatto, contrasta all’evidenza» (Z, 4288‐9). 3
Adesso la riduzione illuministica del cartesiano principio di certezza si applica direttamente alla materia: non l’io penso ma il corporale senso certifica l’esserci. Così la materia diventa principio di soggettività, sensus sui. 2. Sembra che Leopardi ora, sotto l’inesausta pressione della vita, oltrepassata in certo modo la catastrofe esistenziale del 1817, abbia adesso messo a tacere la problematicità del pensiero tematizzata nel 1820 e dintorni. Allora, egli si chiedeva: «Come può essere che la materia senta e si dolga e si disperi della sua nullità? E questo certo e profondo sentimento … come non dovrà essere una prova materiale che quella sostanza che lo concepisce e lo sperimenta è di un’altra natura? Perché il sentire la nullità di tutte le cose sensibili e materiali suppone essenzialmente una facoltà di sentire e comprendere oggetti di natura diversa e contrari, ora questa facoltà come potrà essere nella materia? E si noti ch’io qui non parlo di cosa che si concepisca con la ragione, perché infatti la ragione è la facoltà più materiale che sussista in noi, … ma parlo di un sentimento ingenito e proprio dell’animo nostro … La natura non è materiale come la ragione» (Z, 106‐7). Nel 1823 l’idea di questo sentimento diviene culminante. La sua formulazione si arricchisce d nuove implicazioni: «La vita è il sentimento dell’esistenza. Questo è tutto in quella parte dell’uomo che noi chiamiamo spirituale» (Z, 3923]. Certo «in un corpo forte … le sensazioni materiali sono più forti, ma non perciò veramente più vive, anzi meno perché più tengono del materiale, e la materia (cioè quella parte delle cose e dell’uomo che noi più peculiarmente chiamiamo materia) non vive, e il materiale non può essere vivo, e non ha a che far colla vita, ma solo colla esistenza, la quale considerata senza vita non è capace né di amor proprio né d’infelicità» (Z, 3924). All’opposto, «l’azione e la passione dello spirito» sono «la vita propriamente detta» (Z, 3925). Molto concisamente potrebbe riassumersi: l’esistenza è l’esserci, natura; la vita è il sapere di esserci, spirito. «La natura non è vita, ma esistenza, e a questa tende, non a quella» (Z, 3936). Ovvero, meglio spiegato, «quello che noi chiamiamo natura non è principalmente altro che l’esistenza, l’essere, la vita sensitiva o non sensitiva, delle cose» (Z, 3814). Ma, se l’esserci è il proprio della natura, di cosa è il proprio la vita nella stretta accezione di sapere di esserci? La risposta è amaramente perentoria: «Non v’è cosa più contro natura, di quella spiritualizzazione delle cose umane e dell’uomo, ch’è essenzial compagna, effetto, sostanza della civiltà» (Z, 3934). La vita è, ad opera della civiltà, la complicazione del puro e semplice esserci ch’è la materia, anzi più precisamente la sua «organizzazione» (Z, 3925). Nel 1823 dunque le pedine in gioco sulla scacchiera della riflessione leopardiana sono già tutte schierate e logicamente connesse. Da una parte la natura, cioè la materia, il nudo esistere, dall’altra parte invece la vita, il «patir» l’esistere appropriandosene in vista d’un proprio sé, prendendo forma nel linguaggio dell’io, crescendo nel «pensare, riflettere, ragionare, immaginare», chiudendosi in quell’«amor proprio» da cui nasce «l’infelicità» (Z, 3922‐3)! L’incivilimento non è che il processo di «spiritualizzazione» dell’uomo e dunque il principio della sua infelicità, tra sogni e illusioni che la ragione sociale costruisce, sempre più vincolando negl’inganni la naturale libertà, e poi la ragione critica demolisce, svelando la verità ma con la distruzione delle illusioni rendendo ancor più infelice la vita dell’uomo. Questa tragica contraddizione della storia è variamente connotata dai lettori di Leopardi: «dialettica dell’illuminismo» (Antonio Negri); «paradiso costruito sul fondamento di ciò che annienta» (Emanuele Severino); «immunizzazione», la quale «medica, inoculando un virus che a lungo andare uccide» (Roberto Esposito). All’esito di un tale aberrante esercizio della ragione s’inabissa l’ultima modernità. In queste pagine il pensiero leopardiano attinge il suo esito teorico più originale. Nel 1817 si erano lette sue argomentazioni sull’immortalità dell’anima di franco tono spiritualistico, mentre nel 1826 4
e nel 1827 si succederanno prese di posizione più semplicisticamente materialistiche. Nel 1823 invece, alla vigilia dell’ardita impresa delle Operette morali, quasi prova di pienamente conseguita maturità riflessiva, il pensiero si muove libero dalle varie impalcature metafisiche, spiritualistiche o materialistiche che siano, né si abbandona alle ambiguità del sensismo alla moda, ma assume una schietta impostazione fenomenologica, incentrata in una radicale idea di «paticità», per usare un termine a me molto caro. Scrive Leopardi: «Così non v’ha né vi può aver momento alcuno senza vero patimento, benché possa parer che ve n’abbia (perocché il patimento venendo ad essere perpetuo, il vivente ci si avvezza per modo in sin da’ primi istanti del vivere, che pargli di non sentirlo, e di non avvedersene)» (Z, 3550). Qui le contraddizioni in cui ci s’impiglia coprono una verità che il poeta non può consentirsi di pensare perché a sua volta ben più gravemente contraddirebbe l’impianto stesso della sua filosofia. Una prima evidente contraddizione è che, se a volte il patimento non lo si avvertisse, sol perché ad esso ci si sarebbe avvezzati, ciò non potrebbe valere per i «primi istanti del vivere», quando di certo il tempo per avvezzarsi non si è ancora avuto. Una seconda e più seria contraddizione è che, se in forza dell’abitudine, il patimento non venisse avvertito, si dovrebbe parlare di un patire non patito! Si manifesta qui il vizio logico che accompagnerà la filosofia europea ancora a lungo: la pretesa che al sentire occorra un sopravvenuto intervento conoscitivo per diventare cosciente; come se il «sentire» stesso non fosse appunto l’essere in qualche modo coscienti di una modificazione di sé ad opera del mondo o di se stessi. Leopardi, da ottimo conoscitore del greco antico ben sapeva che in questa, che è la lingua dell’originaria filosofia, il verbo πάσχειν significa «vivere» in modo transitivo, e dunque «patire» non solo nel senso del «soffrire» ma in quello generale del «provare», sicché il suo derivato πάθος, alla lettera il «patimento», il «provato», il «vissuto» (il diltheyano Erlebnis), non vuol dire solo «sofferenza», ma in generale «avvertimento», «intuizione emozionale». Dunque è vero che nell’uomo «non v’ha né vi può aver momento senza patimento» poiché, eccetto che nel sonno, nello svenimento o nel coma, non c’è vita che non sia avvertita, «sentita», di cui non si abbia «senso», ovvero sia pur confusa coscienza. Ma tutto ciò per Leopardi non può voler dire che la vita coincida con il sentire, con ogni sentire, compresi dunque il piacere e la gioia, perché allora si contraddirebbe la tesi stessa su cui si regge il suo «sistema» filosofico, l’universale infelicità. Per lui la vita, ogni momento della vita, coincidono seccamente con il dolore. 3. Fermo su questo punto, al filosofare del poeta sembra non resti che consegnarsi al semplicistico materialismo dell’epoca. Ancora nel 1823 egli asseriva che «la materia non è capace di vita (cioè di vita interna), e una cosa, un’azione, una sensazione, quanto più è materiale, tanto meno è viva» (Z, 3924). Ora, nel 1827, si è arreso. Il 9 marzo scrive: «La materia può pensare, la materia pensa e sente» [Z, 4251). Il 18 settembre egli come di rincalzo introduce una precisazione. Il tono ora è perentorio. Per quanto sembri un «paradosso», «che la materia pensi è un fatto. Un fatto, perché noi pensiamo, e noi non sappiamo, non conosciamo di essere, non possiamo conoscere, concepire altro che materia. Un fatto perché noi veggiamo che le modificazioni del pensiero dipendono totalmente dalle sensazioni, dallo stato del nostro fisico; che l’animo nostro corrisponde in tutto alle varietà e alle variazioni del nostro corpo. Un fatto, perché noi sentiamo corporalmente il pensiero» (Z, 4288, già cit.). Qui con sorprendente evidenza si scopre che i termini della professione materialistica di Leopardi sono profondamente diversi da quel che sembrava. Non sulla materia, indefinito e astratto 5
oggetto di metafisici discorsi, verte la riflessione di lui, ma sul corpo vivente, sulla naturale animalità dell’uomo, che l’incivilimento ha «spiritualizzato» fino a farlo capace di nascondersi la sua stessa fattualità, e così condannandolo all’infelicità nell’impari scontro con l’invincibile fatto del cieco gioco delle forze del mondo. La banale metafisica materialistica, e con essa l’alienante metafisica spiritualistica, in un mutamento di paradigma epistemico che maturerà soltanto alla fine del secolo dileguano dinanzi all’intravista novità di un’antropologia incentrata sulla fenomenologia del corpo vivente, non del freddo e incomprensibile Körper ma dell’appassionato e labirintico Leib. Nel novembre del 1828, Leopardi annota: «All’uomo sensibile e immaginoso, che viva, come io sono vissuto gran tempo, sentendo di continuo ed immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo doppi. Egli vedrà cogli occhi una torre, una campagna; udrà con gli orecchi un suono d’una campana, e nel tempo stesso coll’immaginazione vedrà un’altra torre, un’altra campagna, un altro suono. In questo secondo genere di oggetti sta tutto il bello e il piacevole della vita. Trista quella vita (ed è pur tale la vita comunemente) che non vede, non ode, non sente se non che oggetti semplici, quelli soli di cui gli occhi, gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono le sensazioni» (Z., 4418). E’ evidente che nell’incessante flusso della riflessione leopardiana lo scontro finale non è tra le vecchie categorie dello spiritualismo e del materialismo, bensì tra l’immanenza e la trascendenza: non, si badi bene, la stupida immanenza di chi vede soltanto il sensibile o la vana trascendenza di chi pretende di veder dietro questo mondo, finto, un altro mondo, vero. A scontrarsi adesso è, contro tutti, un immanentismo critico, ben consapevole che la certificazione dell’immanenza suppone il potere, esso stesso immanente, di trascenderla. E’ il potere immanente nel corporale sentire il pensiero, in cui si generano l’immaginare e l’ideare ossia gli atti produttivi del «secondo genere di oggetti». Attraverso questi, che la nostra mente fa e disfa, noi diamo forme ai nostri desideri di gloria o, se si vuole, di felicità e scopriamo la nostra miseria. Ma lo scontro finale si conclude con la sentenza estrema, inappellabile, contro la natura. Se la natura ci stringe da ogni parte con le catene infrangibili dell’immanenza, in cui tutto il reale si riduce al gioco meccanico delle forze materiali, non v’è male che possa addebitarsi a questo o a quell’uomo, a questo o quel gruppo di uomini, neanche alla pur contestata società, ma unica responsabile va riconosciuta la natura. Il che poi è tautologico, nient’altro essendo la natura che appunto il cieco gioco meccanico delle forze materiali. La «natura» del Dialogo con l’islandese dice a chiare lettere la sua indifferenza, ossia la cecità delle forze in gioco: «Sappi che … sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro che alla felicità degli uomini o all’infelicità; come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei». Questa tragica verità otto anni dopo, nel 1836, rimbalza e con un’inaudita veemenza lirica esplode nella conclusiva poesia Alla ginestra: «Nobil natura … /… mostra sé nel soffrir, né gli odii e l’ire / fraterne, ancor più gravi / d’ogni altro danno, accresce / alle miserie sue, l’uomo incolpando / del suo dolor, ma dà la colpa a quella / che veramente è rea, che de’ mortali / madre è di parto e di voler matrigna». Altra risposta a questa assurda sfida, l’uomo di nobile natura non può dare: egli, «congiunta esser pensando, / siccome è il vero, ed ordinata in pria / l’umana compagnia, / tutti fra sé confederati estima / gli uomini, e tutti abbraccia / con vero amor, porgendo / valida e pronta ed aspettando aita / negli alterni perigli e nelle angosce / della guerra comune». Qui da capo sembra che restino taciute le domande sulle contraddizioni di fondo. Non è la nobiltà di qualcuno il prodotto della medesima natura, della «natura matrigna»? Non sono suoi prodotti gl’individui che pur si stimano «umana compagnia, tutti fra sé confederati»? Sono le stesse domande che Leopardi s’era poste in varia forma altre volte. Nel 1826, per esempio, aveva 6
osservato che «contraddizioni innumerabili, evidenti e continue si trovano nella natura» e aveva denunciato che la natura «è l’autrice unica delle difese e delle offese, del male e del rimedio; e qual delle due sia il male e quale il rimedio nel [suo] modo di vedere non si sa». A proposito dell’incomprensibile logica della natura, l’infelice Giacomo con caustica ironia aveva ricordato un suo medico. Questi «mi trattava con purganti continui, ed intendendo che lo stomaco ne era molto debilitato, mi ordinava l’uso di decozioni di china e di altri attonanti per fortificarlo e minorare l’azione dei purganti, senza però interrompere l’uso di questi. Ma, diceva io umilmente, l’azione dei purganti non sarebbe minorata senz’altro, se io ne prendessi di meno efficaci o in minore dose, quando pur debba continuare d’usarli?» (Z, 4205). Contro la prepotenza della cieca natura, così come contro l’arroganza della boria ignorante, invano si leva l’intimidita domanda della logica elementare! 4. Il drammatico confronto tra l’uomo e la natura «matrigna» nella complessa messa in scena leopardiana si avvia al suo gran finale etico. Se la contraddittoria indifferenza della natura per il dolore delle sue creature è un innegabile fatto, la capitale imputazione ad essa dell’universale infelicità allevia l’uomo da possibili sensi di colpa. L’individuo è solo contro tutte le fallaci forme di ordine, imposte non solo dalla casualità della sovrumana natura, ma pure dalla non meno malefica casualità delle istituzioni dell’umanità aggregata, sempre figlia della natura. Leopardi nel 1829 protesta: «La mia filosofia, non solo non è conducente alla misantropia, come può parere a chi l’accusa superficialmente … , ma di sua natura esclude la misantropia, di sua natura tende a sanare, a spegnere quel mal umore che tanti e tanti … portano cordialmente a’ loro simili … a causa del male che, giustamente o ingiustamente, essi, come tutti gli altri, ricevono dagli altri uomini. La mia filosofia fa rea d’ogni cosa la natura, e discolpando gli uomini, totalmente, rivolge l’odio, o se non altro il lamento, a principio più alto, all’origine vera de’ mali de’ viventi» (Z, 4428). Sono ormai lontane le analisi, acutissime, registrate in vari blocchi di pensieri, di carattere politico e sociologico, presenti nello Zibaldone nelle pagine degli anni 1821 e 1823, ricche di riflessioni critiche sulla natura e la società, sull’insuperabile contraddizione, in politica, tra l’esigenza dell’unità di comando e l’opposto principio della uguaglianza. Il poeta, che nel 1820 aveva scritto: «la libertà dipende da un’armonia delle parti» (Z, 114), nel 1821 completava: «Come l’uguaglianza è incompatibile con uno stato, il cui principio è l’unità, da cui vengono necessariamente le gerarchie, così la disuguaglianza è incompatibile con quello stato, il cui principio è l’opposto dell’unità, cioè il potere diviso fra ciascheduno, ossia la libertà e democrazia» (Z, 567). Sono qui bene evidenti la consonanza e quasi l’eco d’un tagliente pensiero, formulato da Bruno quasi due secoli prima: «Non è armonia e concordia, dov’è unità, dove un essere vuole assorbire tutto l’essere, ma dov’è ordine e analogia di cose diverse, dove ogni cosa serve la sua natura» (Degli eroici furori, I, iv). Ma ugualmente lontane sono le preziose considerazioni sulla «società stretta», «contraria alla natura e [alla] ragione» (Z, 3930), nonché la frontale polemica contro Benjamin Constant, mai nominato, rovesciando la cui celebre tesi Leopardi condanna come «stretta», riduttiva della libertà, la società non degli antichi ma dei moderni. Archiviate sono pure le graffianti pagine del Discorso del 1824 sulle élites delle «società strette» e contro il mal «costume d’indifferenza verso se stessi e verso gli altri», proprio degl’italiani. La filosofia antropologica ora essa sola è al centro dell’interesse appassionato di Leopardi. Il corporale sentire resta la chiave di volta del suo pensiero maturo. Esso, ben più che i pur variamente rilevati cenni alla ricorsività della storia, ne attesta la nient’affatto superficiale suggestione vichiana. Vico aveva mostrato che dei nostri primissimi antenati «la natura era, in tale stato, d’uomini tutti robuste forze di corpo, che, urlando, brontolando, spiegavano le loro violentissime passioni»: insomma le loro «menti di nulla erano astratte, di nulla erano 7
assottigliate, perché erano tutte immerse ne’ sensi, tutte rintuzzate dalle passioni, tutte seppellite ne’ corpi». Rimane tuttavia tra le due impostazioni un’incolmabile distanza. Secondo la narrazione vichiana l’umanizzazione avviene nel passaggio dalla semplice corporalità del pre‐umano alla complessa espressività della civile cultura, dunque in un alveo decisamente sociologico. Per Leopardi invece l’umanizzazione si compie nel seno della natura stessa, è l’esito della evoluzione biologica. Qui egli si attiene a Rousseau: «l’uomo va visto così come lo ha formato la natura attraverso tutti i cambiamenti che la successione dei tempi e delle cose ha dovuto produrre nella sua costituzione originaria» (Discours sur l’origine de l’inégalité, préface). L’umano proviene da un corporal sentire che, come s’è detto, matura e si autonomizza nel senso di sé, nella strutturale paticità dell’uomo naturale, prima cioè indipendentemente da ogni stato sociale: è un fenomeno di quella che Bruno aveva chiamata la «istoria della natura, la quale è inscritta in noi medesimi» (De l’infinito, universo e mondi, proem. epist.). Per questa costitutiva indipendenza dalla relazione sociale, il corporal sentire assume nel lavorio critico dell’ultimo Leopardi il ruolo fondamentale e gli consente di accantonare gli sconfortanti esiti delle analisi socio‐politiche. Attraverso i giri di una tormentata ricerca egli si ritrova con la sua ispirazione di fondo, la solitudine. Il filosofo che vive nel mondo «si gitta naturalmente a speculare sopra gli uomini nei suoi rapporti scambievoli, e su se stesso nei suoi rapporti cogli uomini». Al contrario al filosofo solitario «interessa la speculazione di se stesso come se stesso» (Z, 4138). Insomma «si può dire che il filosofo … coll’abito della vita sociale non può quasi a meno di non essere un filosofo di società (o psicologo, o politico ec.)», mentre «coll’abito della solitudine riesce necessariamente un metafisico» (Z, 4139). Dell’uomo, corpo naturale che sente e pensa, dunque dell’individuo, non si può parlare che a partire da lui, dal suo pensare e prima ancora dal suo sentire, e non può perciò parlarne se non il suo stesso pensare sentendo. La filosofia nel suo rigore «metafisico» non può dunque essere se non un aggirarsi nella solitudine, il dialogo di un individuo umano con sé. Nell’ultimo dialogo, di Tristano e di un amico, del 1833, non esistono più vie di fuga possibili. Tristano è perentorio: «Io, quanto a me, con licenza vostra e del secolo, sono infelicissimo, e tale mi credo». All’amico non resta che concordare: «Se uno sia felice o infelice individualmente, nessuno è giudice se non la persona stessa, e il giudizio di questa non può fallare». Il corpo dell’individuo sente se stesso e pensa il suo sentirsi e, di nessun altro corpo se non del suo essendo il «corporal pensiero», diviene consapevole dell’esclusività del suo sé, i cui confini nessuno può varcare. In effetti di un proprio dolore corporeo si può parlare, ma non farlo sentire ad altri. Di fronte a ciò la ragione avverte fino in fondo la sua impotenza. La solitudine non è una situazione occasionale, ma la stessa costitutiva umanità di ogni individuo. Qui finalmente si scopre il centro riposto del pensiero di Leopardi, il suo nocciolo duro: «E’ cosa notata che il grande dolore (come ogni grande passione) non ha linguaggio esterno. Io aggiungo che non ne ha neppure interno […], l’uomo nel grande dolore non è capace di circoscrivere, di determinare a se stesso nessuna idea, nessun sentimento relativo al suggetto della sua passione, la quale idea o sentimento egli possa esprimere a se medesimo». La vita della mente è per natura originariamente il sentirsi ch’è prima d’ogni sentimento e pensiero, condizione per il dialogo con sé e poi con gli altri. Il dolore devasta tutto ciò che dall’originario si è sviluppato, la trama delle storie e dei ragionamenti, e lascia confuso e muto l’originario sentirsi, la vita stessa, la nuda vita dell’uomo naturale. Qui, come Cesare Luporini rilevò nelle sue ultime «decifrazioni» del poeta, «la comunicazione intersoggettiva (che sempre ha costituito problema per Leopardi) riceve un chiaro ancoraggio primordiale» ed i ritornanti termini di «comunicazione ed espressione» «ora si fissano in questo tipo di naturalità del tutto prioritaria rispetto agli interventi successivi dell’ “arte” (cioè della ragione)». 8
L’estremo dolore spezza il dialogo dell’individuo umano con sé. Tutte le relazioni sociali sono, per così dire, sovrastrutturali. Strutturale nell’individuo è la solitudine. Così, ancor nel Dialogo di Tristano e di un amico è la rivelazione estrema: «Ogni immaginazione piacevole, ogni pensiero dell’avvenire, ch’io fo, come accade, nella mia solitudine, e con cui vo passando il tempo, consiste nella morte, e di là non sa uscire». Nella Ginestra alla potenza devastante della natura materiale non si oppongono società organizzate e istituzionali alleanze ma lo spontaneo «accompagnarsi» d’individui l’un l‘altro estranei, accomunati solo dal sentimento della vita minacciata, in uno slancio di reciproca pietà che «tutti abbraccia con vero amor». La salvezza, se c’è, non viene dagli Stati o dalle moltitudini, ma dalla scossa di una situazione estrema che nella comunità delle solitudini rivela all’individuo la sua umana natura. La riflessione filosofica può giungere a rilevare la solitudine, anzi a «dedurne» la necessità: può debitamente convertire in categoria pensata, logico‐trascendentale, un puro fatto, la vissuta insuperabilità della solitudine. Ma il filosofo, l'uomo che riflette criticamente, non può far nulla più di questo: nulla più che prendere coscienza della solitudine radicale come «autenticità» della vita che egli vive; nulla più che «idealizzare» la solitudine, determinarne un'astratta oggettività comunicabile, spiegare a sé e agli altri che senza solitudine non v'è umanità, corrispondenza del proprio apparire al proprio essere. Soltanto la parola poetica, pura da pretese scientistiche o moralistiche, vive ‐ patisce ‐ la solitudine autentica e ne è l'epifania, l’apparire del senso. La sofferenza della solitudine infatti non può dire l'indicibile che essa è. Tuttavia, per non lasciarsi ridurre al silenzio, si fa parola poetica. Così, rompendo l'ordine del comune dire, lacerando la trama dei significati convenuti, non curandosi del «sociale» ufficio del comunicare, essa si libera. Anziché tacere grida, convoca le altre solitudini, le avverte che nessuna di esse è l'unica, ma ognuna nella sua unicità è piena del suo senso, perciò è «sacra». Il filosofo scopre la solitudine autentica. Ma l'uomo, che patisce la sua vita, da solo non sa reggerne il peso. Lo soccorre la poesia, con cui una solitudine chiama le altre, come se ognuna potesse nella solidarietà delle altre trovare la salvezza dalla disperazione. La poesia è grazia. Essa ‐ suggerisce Thomas Dumm ‐ semplicemente ci dice «come essere soli insieme». Non è forse questo che di Leopardi, impotente infine la sua filosofica prosa, con amorosa pietà la parola poetica canta? «Passero solitario … cantando vai»! 9
NOTE Le referenze bibliografiche sono qui di seguito segnalate nell’ordine in cui sono richiamate nel testo. Le citazioni da Leopardi si riferiscono a Tutte le opere, intr. e cura di Walter Binni, con la collab. di Enrico Ghidetti, 2 voll., Sansoni, Firenze [1965], rist. 1993. In particolare, le citazioni dallo Zibaldone, che occupa l’intero vol. 2°, sono siglate con Z seguita dal numero o numeri della o delle pagine secondo l’autografo leopardiano. Antonio Negri, Lenta ginestra, Mimesis Eteropia, Milano 2001, p. 59, nota. Emanuele Severino, Il nulla e la poesia [1990], Rizzoli, Milano 2010, p. 279. Roberto Esposito, Pensiero vivente, Einaudi, Torino 2010, p. 113. Giordano Bruno, Degli eroici furori, I, iv, in Opere italiane, a cura di Aquilecchia, rev. Ordine, Utet, Torino 2007, vol. 2°, p.592. Giordano Bruno, De l’infinito, universo e mondi (proem. epist.), ibid., p. 25. J.‐J. Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité (préface), in Du contrat sociale, etc., Garnier, Paris 1954, p. 33. Cesare Luporini, Decifrare Leopardi, a cura di S.Landucci, introd. di Fabiana Cacciapuoti, G.Macchiaroli, Napoli 1998, p. 206. Thomas Dumm, Apologia della solitudine, trad. di C.D’amico, Bollati Boringhieri, Torino 2010, p. 181.