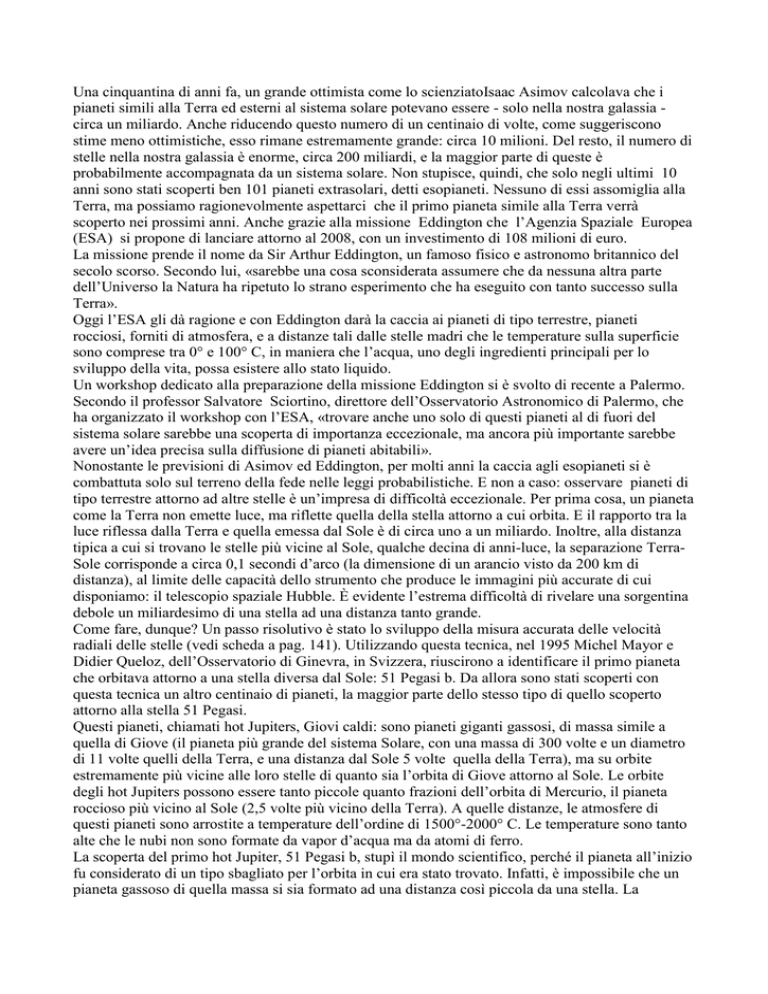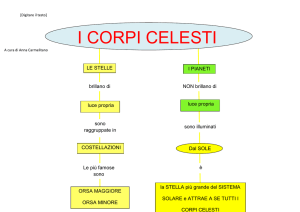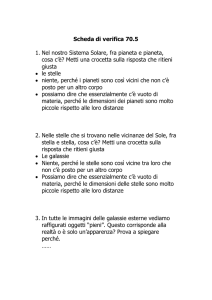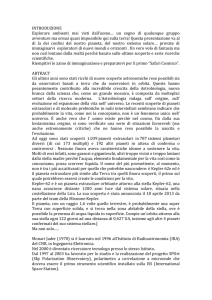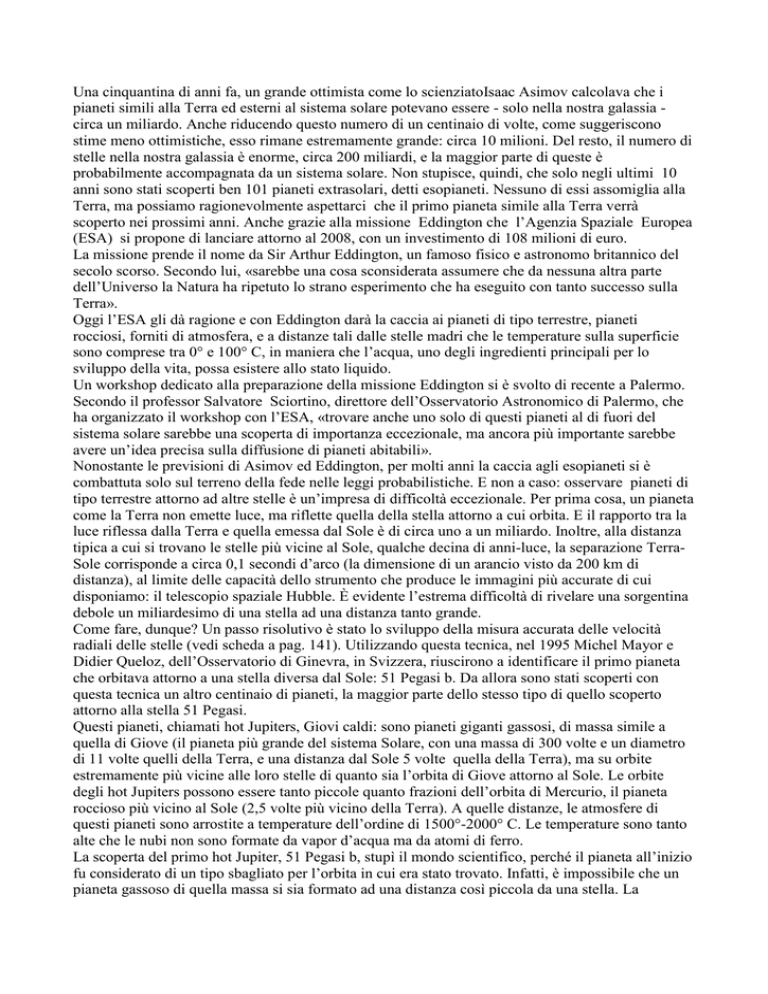
Una cinquantina di anni fa, un grande ottimista come lo scienziatoIsaac Asimov calcolava che i
pianeti simili alla Terra ed esterni al sistema solare potevano essere - solo nella nostra galassia circa un miliardo. Anche riducendo questo numero di un centinaio di volte, come suggeriscono
stime meno ottimistiche, esso rimane estremamente grande: circa 10 milioni. Del resto, il numero di
stelle nella nostra galassia è enorme, circa 200 miliardi, e la maggior parte di queste è
probabilmente accompagnata da un sistema solare. Non stupisce, quindi, che solo negli ultimi 10
anni sono stati scoperti ben 101 pianeti extrasolari, detti esopianeti. Nessuno di essi assomiglia alla
Terra, ma possiamo ragionevolmente aspettarci che il primo pianeta simile alla Terra verrà
scoperto nei prossimi anni. Anche grazie alla missione Eddington che l’Agenzia Spaziale Europea
(ESA) si propone di lanciare attorno al 2008, con un investimento di 108 milioni di euro.
La missione prende il nome da Sir Arthur Eddington, un famoso fisico e astronomo britannico del
secolo scorso. Secondo lui, «sarebbe una cosa sconsiderata assumere che da nessuna altra parte
dell’Universo la Natura ha ripetuto lo strano esperimento che ha eseguito con tanto successo sulla
Terra».
Oggi l’ESA gli dà ragione e con Eddington darà la caccia ai pianeti di tipo terrestre, pianeti
rocciosi, forniti di atmosfera, e a distanze tali dalle stelle madri che le temperature sulla superficie
sono comprese tra 0° e 100° C, in maniera che l’acqua, uno degli ingredienti principali per lo
sviluppo della vita, possa esistere allo stato liquido.
Un workshop dedicato alla preparazione della missione Eddington si è svolto di recente a Palermo.
Secondo il professor Salvatore Sciortino, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Palermo, che
ha organizzato il workshop con l’ESA, «trovare anche uno solo di questi pianeti al di fuori del
sistema solare sarebbe una scoperta di importanza eccezionale, ma ancora più importante sarebbe
avere un’idea precisa sulla diffusione di pianeti abitabili».
Nonostante le previsioni di Asimov ed Eddington, per molti anni la caccia agli esopianeti si è
combattuta solo sul terreno della fede nelle leggi probabilistiche. E non a caso: osservare pianeti di
tipo terrestre attorno ad altre stelle è un’impresa di difficoltà eccezionale. Per prima cosa, un pianeta
come la Terra non emette luce, ma riflette quella della stella attorno a cui orbita. E il rapporto tra la
luce riflessa dalla Terra e quella emessa dal Sole è di circa uno a un miliardo. Inoltre, alla distanza
tipica a cui si trovano le stelle più vicine al Sole, qualche decina di anni-luce, la separazione TerraSole corrisponde a circa 0,1 secondi d’arco (la dimensione di un arancio visto da 200 km di
distanza), al limite delle capacità dello strumento che produce le immagini più accurate di cui
disponiamo: il telescopio spaziale Hubble. È evidente l’estrema difficoltà di rivelare una sorgentina
debole un miliardesimo di una stella ad una distanza tanto grande.
Come fare, dunque? Un passo risolutivo è stato lo sviluppo della misura accurata delle velocità
radiali delle stelle (vedi scheda a pag. 141). Utilizzando questa tecnica, nel 1995 Michel Mayor e
Didier Queloz, dell’Osservatorio di Ginevra, in Svizzera, riuscirono a identificare il primo pianeta
che orbitava attorno a una stella diversa dal Sole: 51 Pegasi b. Da allora sono stati scoperti con
questa tecnica un altro centinaio di pianeti, la maggior parte dello stesso tipo di quello scoperto
attorno alla stella 51 Pegasi.
Questi pianeti, chiamati hot Jupiters, Giovi caldi: sono pianeti giganti gassosi, di massa simile a
quella di Giove (il pianeta più grande del sistema Solare, con una massa di 300 volte e un diametro
di 11 volte quelli della Terra, e una distanza dal Sole 5 volte quella della Terra), ma su orbite
estremamente più vicine alle loro stelle di quanto sia l’orbita di Giove attorno al Sole. Le orbite
degli hot Jupiters possono essere tanto piccole quanto frazioni dell’orbita di Mercurio, il pianeta
roccioso più vicino al Sole (2,5 volte più vicino della Terra). A quelle distanze, le atmosfere di
questi pianeti sono arrostite a temperature dell’ordine di 1500°-2000° C. Le temperature sono tanto
alte che le nubi non sono formate da vapor d’acqua ma da atomi di ferro.
La scoperta del primo hot Jupiter, 51 Pegasi b, stupì il mondo scientifico, perché il pianeta all’inizio
fu considerato di un tipo sbagliato per l’orbita in cui era stato trovato. Infatti, è impossibile che un
pianeta gassoso di quella massa si sia formato ad una distanza così piccola da una stella. La
soluzione del dilemma che 51 Pegasi b si è formato molto più lontano, e si è poi avvicinato alla
stella madre nel corso di milioni di anni, a causa delle forze mareali tra esso e la stella.
Uno degli ultimi hot Jupiters è stato scoperto attorno alla stella HD219542B da un team di
astronomi italiani guidato da Raffaele Gratton dell’Osservatorio di Padova, utilizzando lo
spettrografo ad alta risoluzione Galileo del Telescopio Nazionale Galileo (TNG) alle Canarie.
Questo pianeta è il primo sia per il TNG che per l’Italia. Ma come ha fatto l’équipe di Padova,
l’unica in Italia a compiere ricerche di questo genere, a scoprire il nuovo pianeta? Rinunciate
all’idea romantica dell’astronomo con l’occhio attaccato all’oculare del telescopio. Gli astronomi
hanno analizzato minuziosamente al computer una serie di immagini e spettri (strisce colorate sulle
composizione chimica di una stella), deducendo da essi la presenza del pianeta.
Racconta Silvano Desidera, uno dei protagonisti della scoperta: «Il pianeta che abbiamo individuato
ha la massa di Saturno, ma è ad una distanza dalla sua stella intermedia tra quelle di Mercurio e di
Venere dal Sole». Aggiunge il collega Francesco Marzari: «La scoperta è particolarmente
interessante perché è un pianeta relativamente piccolo rispetto a quelli finora osservati. Potrebbe
essere simile ai pianeti esterni del sistema solare, composti da un nucleo solido e un involucro
gassoso».
Gli hot Jupiters sembrano piuttosto rari: solo il 5% delle stelle osservate ha mostrato la presenza di
questo tipo di pianeti. Molto più comuni potrebbero essere pianeti gioviani su orbite analoghe a
quella di Giove, ma sono più difficili da scoprire. L’orbita di Giove è circa 100 volte più grande di
quelle degli hot Jupiters, e il suo periodo è di circa 12 anni: un osservatore dovrebbe monitorare un
sistema stellare per molti anni prima di accorgersi di un pianeta come Giove. Tanto che la prima
scoperta di un pianeta analogo a Giove risale solo a un anno fa.
Utilizzando la tecnica delle velocità radiali è stato possibile scoprire molti pianeti, ma nessuno si è
rivelato simile alla Terra. E anche le somiglianze con Giove sono limitate. Le loro orbite, in
particolare, rappresentano un enigma per gli astronomi: gran parte dei pianeti scoperti orbitano con
traiettorie ellittiche (mentre quelli del Sistema solare hanno forma quasi circolare) e sono molto
vicini alla loro stella (vedi statistiche a pagina 128). Ma proprio queste anomalie potrebbero
rivelarsi preziose per ricostruire come nascono i pianeti.
Le teorie principali affermano che all’inizio vi sia una palla di gas che ruota su se stessa: la parte
centrale, più calda, diventerà una stella, mentre la materia più esterna e meno densa assumerà una
formazione appiattita. Secondo la teoria della crescita del nucleo, detriti di roccia e polvere
aumentano di dimensione a causa della gravità che attrae sempre più polveri e rocce fino a formare
un pianeta in alcuni milioni di anni. Secondo il modello dell’instabilità, invece, i pianeti si formano
in un migliaio d’anni per la forza di gravità esercitata da regioni di gas più denso. Queste due
teorie, tuttavia, non spiegano perché gli esopianeti siano quasi tutti della massa di Giove e non di
dimensioni diverse e perché siano così vicini alle stelle madri. Secondo gli astronomi, è probabile
che i pianeti giganti si formino lontani dalla stella, e poi scivolino più vicino a causa della loro
interazione con il disco di accrescimento. Ma cosa li ferma? L’unico modo per risolvere questi
quesiti è assistere in diretta alla nascita di un pianeta. Ed è proprio questo l’obiettivo di nuovi
telescopi che funzionano a lunghezze d’onda di un mm, capaci di penetrare nelle dense nubi di gas e
polveri che circondano questi sistemi, permettendo di osservare i dischi di accrescimento. Come
l’osservatorio Alma (Atacama Large Millimeter Array), in Cile, che con 64 antenne da 12 metri
permetterà di osservare come nascono i pianeti.
Per scoprire quelli di tipo terrestre, invece, dovremo attendere il pieno sviluppo di una nuova
tecnica, quella dei transiti (vedi scheda a pag. 141). Mentre un pianeta come Giove causa la perdita
di circa 1/100 della luce della stella quando gli transita davanti, un pianeta terrestre causa una
perdita di luce molto più piccola, una parte su 10mila. Fare misure così precise è la sfida delle
missioni Eddington e Kepler (vedi sotto).
Finora abbiamo parlato di metodi indiretti per scoprire i pianeti extra-solari. Ma l’ideale sarebbe
ottenere immagini dirette di pianeti attorno ad altre stelle, per poterne esaminare nel dettaglio la
composizione chimica e lo stato fisico. Un’impresa eccezionalmente difficile, vista le distanze in
gioco, tuttavia gli scienziati hanno immaginato almeno una maniera per tentare di risolvere questo
problema: utilizzare tecniche interferometriche (vedi scheda a pag. 141). Questa è la scommessa
alla base di due imprese scientifiche in cui gli scienziati italiani hanno un ruolo di primo piano.
La prima è rappresentata dal Large Binocular Telescope (LBT), tuttora in costruzione (vedere
scheda a lato). La seconda impresa consiste nell’utilizzare in modalità interferometrica i 4 telescopi
da 8 metri che compongono l’osservatorio VLT (Very large telescope) dell’ESO (Osservatorio del
sud Europa), con base in Germania e telescopio in Cile. Purtroppo entrambi gli strumenti, che
dovrebbero cominciare a produrre dati tra alcuni anni, hanno due grossi limiti: le osservazioni
vengono eseguite attraverso l’atmosfera terrestre che degrada le immagini; inoltre, da Terra è
impossibile fare osservazioni sensibili nell’infrarosso, dove il contrasto tra luce della stella e luce
riflessa dal pianeta è il minimo possibile, poiché gli stessi telescopi emettono radiazione infrarossa.
Queste limitazioni si possono superare inviando i telescopi nello spazio: è l’obiettivo delle missioni
Darwin e Terrestrial Planet Finder (TPF).
Darwin vuole rispondere alla domanda più affascinante che gli uomini si sono mai posti: esiste la
vita da qualche altra parte dell’Universo? Per rispondere all’interrogativo è stata concepita una
tecnologia degna di un libro di fantascienza.
Darwin si compone di una flotta di 8 satelliti che viaggiano in formazione: sei telescopi da 1,5 m di
diametro formano i lati di un esagono, al centro del quale viaggia il modulo dove i fasci di luce
raccolti dai singoli telescopi vengono combinati nella modalità interferometrica. L’ottavo satellite
trasmette i dati verso la Terra. Per far funzionare l’esperimento, i 6 telescopi e il modulo centrale
devono viaggiare in formazione rigorosa: basterebbe un disallineamento di un decimilionesimo di
mm tra un telescopio e l’altro per rovinare le osservazioni. Gli ingegneri dell’ESA confidano di
risolvere il problema con un sistema di correzione della rotta simile a quello dei Gps.
Darwin misurerà la composizione dell’atmosfera sui pianeti extrasolari utilizzando uno
spettrografo. La luce stellare riflessa da questi pianeti sarà scomposta nei suoi colori e verranno
cercate le righe di assorbimento o di emissione caratteristiche di vari elementi presenti nell’aria.
L’elemento più facile da rivelare nelle atmosfere dei pianeti terrestri del sistema solare (Venere e
Marte oltre alla Terra) è l’anidride carbonica.
L’osservazione di righe dell’anidride carbonica negli spettri di Darwin testimonierebbe la presenza
di un’atmosfera attorno ai pianeti osservati. Inoltre, mentre le atmosfere di Marte e Venere sono
dominate dall’anidride carbonica, l’atmosfera terrestre porta le tracce della presenza di vita: il
metano, prodotto dai batteri, e l’ossigeno, prodotto dalle piante. Il vapor d’acqua è un altro
costituente fondamentale dell’atmosfera di un pianeta su cui la vita è sviluppata. Scoprire le righe di
questi gas negli spettri suggerirebbe che sul pianeta in esame qualche forma di vita è germinata.
E il TPF? Farà osservazioni dettagliate di pianeti abitabili alla ricerca dei traccianti della vita nelle
loro atmosfere. La Nasa non ha ancora deciso che tipo di tecnologia utilizzare per la missione. Una
prima ipotesi prevede l’uso di diversi telescopi infrarossi di 3 metri di diametro configurati come un
interferometro e distanziati di qualche decina di metri. La seconda opzione è un unico telescopio
ottico di 6,5-8 metri al fuoco del quale è posto un coronografo. Questo strumento blocca la luce
della stella brillante, tramite un dischetto di materiale opaco che ne occulta l’immagine, così che
oggetti deboli vicini possono essere osservati.
I programmi dell’ESA e della NASA siano complementari. Le prime due missioni, Kepler e
Eddington, utilizzano la tecnica dei transiti e mirano a scoprire i primi pianeti abitabili al di fuori
del sistema solare. Le seconde due missioni, SIM e Gaia, utilizzeranno una tecnica diversa,
l’astrometria di alta precisione. I pianeti abitabili saranno infine i bersagli delle ultime due missioni,
TPF e Darwin, che osserveranno nel dettaglio questi pianeti eseguendo spettri delle loro atmosfere
alla ricerca dei traccianti della vita. Per capire, conclude Sciortino «se il nostro sistema solare
rappresenta la norma o una rara eccezione».
Fabrizio Fiore